La fisica del groviglio. Per garantire la sicurezza delle nostre carte
|
|
|
- Albano Petrucci
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 frontiere La fisica del groviglio Attenzione, parliamo di entanglement. Un fenomeno che sembra ai confini della fantascienza, ma è invece al cuore della meccanica quantistica. Ed è pronto a riservarci brillanti sorprese. Francesca E. Magni Per garantire la sicurezza delle nostre carte di credito, presto le banche potranno rivolgersi non più alle forze dell ordine, ma alla fisica e in particolare a fenomeni quantistici chiamati principio di sovrapposizione ed entanglement. Proprio in Italia, in questi ultimi anni sono già stati realizzati prototipi in grado di fornire carte di credito sicure, inattaccabili da hacker e ladri informatici. L entanglement è un fenomeno fisico che riguarda principalmente (ma non solo) il mondo microscopico (dal miliardesimo di metro in giù), quello degli atomi, degli elettroni e dei fotoni, i piccolissimi pacchetti di energia che compongono la luce. È il mondo descritto da una teoria fisica relativamente giovane, la meccanica quantistica o teoria dei quanti. Consideriamo per esempio due fotoni che vengano emessi insieme da uno stesso atomo e che si allontanino l uno dall altro fino a raggiungere quasi i confini dell Universo (se mai esistono!). L entanglement dice che il sistema dei due fotoni si comporta come un sistema unico, indipendentemente da quanto essi distino tra di loro. Questo significa che se succede qualcosa al 16 aprile 2011
2 Se state ballando abbracciati a qualcuno che scivola su una buccia di banana cadrete anche voi, perché siete legati : ai fotoni entangled succede un po la stessa cosa, anche se li possiamo trovare in due discoteche diverse primo (per esempio essere avvistato, rivelato da un osservatore), anche il secondo ne sarà inevitabilmente influenzato. Se state ballando abbracciati a qualcuno che scivola su una buccia di banana, cadrete anche voi, perché siete legati. Ecco, ai fotoni entangled succede un po la stessa cosa, anche se li possiamo trovare in due discoteche diverse: non appena ne vediamo inciampare uno, siamo sicuri che anche l altro starà facendo uno scivolone. Il termine entanglement è stato inventato nel 1926 da un padre della meccanica quantistica, il premio Nobel austriaco Erwin Schrödinger: lo si potrebbe tradurre come groviglio, intreccio, legame, non-separabilità, ma gli scienziati preferiscono lasciarlo in inglese. Particelle ubique Le frasi che ho appena scritto contengono qualcosa di molto strano per noi, esseri macroscopici abituati a considerare gli oggetti separati da distanze spaziali come oggetti distinti e dirò di più abituati a essere in un posto solo in un determinato momento. A pensare, cioè, che l ubiquità appartenga solo alle divinità e ai personaggi dei giochi di ruolo. Invece stiamo scoprendo che appartiene anche ai sistemi fisici reali, quelli entangled appunto, costituiti da sottosistemi che possono essere contemporaneamente in due posizioni distinte, non importa quanto lontane tra di loro, e che però non possono essere considerati indipendenti. Tornando all esempio dei nostri due fotoni, abbiamo detto che essi costituiscono un sistema unico, con un unica identità: i due fotoni sono solo due suoi sottosistemi, anche se poi a noi esseri umani si manifestano come due click diversi su due strumenti di misura separati. Barbara Rosenthal Questa caratteristica, in termini tecnici, si chiama non località, ed è il contrario della località, secondo la quale due fenomeni spazio-temporali distinti non si possono influenzare l un l altro se non dopo un certo intervallo di tempo. In altre parole, la misura effettuata sullo stato di un determinato fotone o particella non può influenzare lo stato di un altra particella in maniera istantanea, perché le informazioni tra due corpi separati non possono trasmettersi a una velocità maggiore di quella della luce. Insomma, per la località, le due misure devono essere indipendenti l una dall altra, possono agire solo localmente. La non località invece prevede che la misura dello stato di una particella possa determinare immediatamente lo stato della seconda, anche in assenza di interazioni macroscopiche. Il gatto di Wheeler A questo punto bisogna introdurre un altro concetto importante che, insieme a quello della non località, rappresenta la base teorica per interpretare l entanglement: il principio di sovrapposizione degli stati. Per stato di un fotone o di un elettrone, per esempio, si intende l insieme costituito dai valori delle grandezze fisiche che lo descrivono, come posizione spazio-temporale, quantità di moto, polarizzazione, fase, spin ecc. Due o più fotoni con polarizzazioni diverse sono in O Il fisico Matteo Paris, dell'università di Milano, esperto di Quantum Information. aprile
3 Il gatto di Schrödinger Il famoso gatto nacque nel 1935 dalla mente di Erwin Schrödinger, che non accettava il concetto di sovrapposizione degli stati della meccanica quantistica che invece convinceva altri scienziati come Bohr, Heisenberg, Born, tutti sostenitori della cosiddetta Interpretazione di Copenaghen. Schrödinger immaginò un gatto rinchiuso in una scatola, in balìa di una catena di reazioni in grado di ucciderlo e generata dal decadimento radioattivo di una quantità piccolissima di materia. In questo esperimento mentale, quindi, la vita del gatto macroscopico dipende da un fenomeno quantistico microscopico. L interpretazione di Copenaghen afferma che prima di aprire la scatola gli atomi della sostanza radioattiva sono in una sovrapposizione di stati, che collassano in uno stato solo quando l osservatore compie la misura. Secondo Schrödinger, però, in questo modo anche il gatto, prima di aprire la scatola, si troverebbe nella sovrapposizione di tutti i possibili stati, quindi sia morto sia vivo! Per il fisico questo era un bel paradosso e lo è davvero se si ragiona secondo la logica classica, che è una logica di tipo aut-aut. In meccanica quantistica bisogna invece adottare un nuovo tipo di logica et-et, che sembra strana perché non la incontriamo mai nella nostra vita quotidiana. stati diversi, come due o più elettroni in posizioni diverse e così via. Per generare in modo sperimentale due o più particelle entangled ci sono vari metodi, come quelli che utilizzano gli interferometri o i cristalli semiriflettenti o i circuiti superconduttivi e altro ancora (rimandiamo la descrizione degli aspetti sperimentali ai due testi consigliati in bibliografia). Le particelle entangled assumono sempre lo stato del sistema globale, che è la somma, o meglio la sovrapposizione, di tutti i possibili stati della combinazione di tutte le particelle. Qui c è lo zampino del famoso gatto di Schrödinger e mi spiego subito: i due fotoni citati all inizio (quelli emessi da uno stesso atomo) possono essere avvistati in due posizioni diverse, una al confine A dell Universo e l altra al confine Z. Quando misureremo la loro posizione, uno sarà nello stato A e l altro nello stato Z, ma possiamo dire già prima della misura quale dei due fotoni si troverà in A e quale in Z? Questa domanda non ha senso, perché secondo la meccanica quantistica i due fotoni, prima di essere avvistati, si trovano nello stato A+Z, che è quello dell entità complessiva che li contiene. Quindi i due fotoni si trovano in una sovrapposizione di stati: sono in entrambe le posizioni, sia in A sia in Z (e lo stesso vale per le loro polarizzazioni, per fare un altro esempio di stato). Un po come il gatto di Schrödinger che, prima di aprire la scatola, è sia vivo sia morto; l esempio che ho appena citato si chiama gatto di Wheeler se si considerano (in maniera del tutto immaginaria!) due gatti A e Z al posto di fotoni o elettroni. Un po di storia (e di filosofia) Dicevamo che l entanglement è un fenomeno che si spiega nell ambito della meccanica quantistica. Il primo a nominare il termine quanto fu Max Planck nel 1900, quando ipotizzò che l energia potesse essere scambiata solo sotto forme discrete, i pacchetti di energia, cioè come tante pillolette distinte una dall altra e non come uno sciroppo, che si versa con continuità. L ipotesi di Planck, per quanto azzardata, si è dimostrata corretta. È grazie a questa ipotesi che si sono spiegati fenomeni incomprensibili per la fisica classica, come la 18 aprile 2011
4 radiazione emessa da un corpo nero o l effetto fotoelettrico. La storia della meccanica quantistica contiene concetti che vennero considerati paradossali dai primi scienziati che li incontrarono e che sono stati fonte di accesi dibattiti filosofici. Del resto tutta la fisica, anche quella classica, è piena di elementi non intuitivi, come ha mostrato lo psicologo Paolo Bozzi con i suoi esperimenti narrati nel libro Fisica ingenua (Garzanti, 1998). In uno di questi esperimenti si facevano vedere a un campione di persone due filmati diversi di una pallina che cadeva, la prima volta a velocità costante e la seconda con un moto uniformemente accelerato (il moto che avviene in natura, nel vuoto). Alla domanda su quale dei due video rappresentasse il modo corretto di caduta dei corpi, la maggioranza dei partecipanti allo studio rispondeva indicando il moto sbagliato, cioè il primo, proprio come aveva predetto Aristotele! Lo stesso Aristotele che sosteneva, fidandosi del proprio ragionamento intuitivo, che il moto nel vuoto era impossibile e che il Sole girava intorno alla Terra immobile. Il primato di Galileo Il primo a introdurre elementi controintuitivi in fisica fu il primo a fare fisica sperimentale e cioè Galileo, che si fidava più della risposta della natura che di quella della propria mente. Con il primo principio della dinamica, Galileo andò contro la convinzione, accettata da tutti fino ad allora, che per mantenere un corpo in movimento ci fosse bisogno di una spinta continua: nel vuoto, un corpo non aveva bisogno di nessuna forza per muoversi a velocità costante. Dunque il movimento nel vuoto esisteva. E nel vuoto i corpi di massa diversa che cadevano da una stessa altezza impiegavano lo stesso tempo: cadevano insieme. Più controintuitivo di così! Matematica contro intuizione Ma torniamo alla meccanica quantistica: l entanglement stesso va fortemente contro le convinzioni del senso comune. Ed ecco un altro esempio: se la teoria della relatività di Einstein ha cambiato la concezione classica del tempo, dimostrando che gli intervalli di tempo dipendono dallo stato di moto di chi li misura, la teoria quantistica ha rimesso in discussione il ruolo stesso dell osservatore esterno in un esperimento, La storia della meccanica quantistica contiene concetti considerati paradossali dai primi scienziati che li incontrarono e che sono stati fonte di accesi dibattiti filosofici; del resto, tutta la fisica è piena di elementi non intuitivi affermando che la sua azione disturba irrimediabilmente la misura. Partendo da questi presupposti è naturale che la meccanica quantistica abbia implicazioni filosofiche importantissime, considerate a tal punto rivoluzionarie che lo stesso Einstein non le accettò mai. Valgano solo due esempi: il primo è la negazione del principio di realtà o realismo, secondo il quale una quantità possiede valori definiti in maniera indipendente dal fatto di essere stata misurata o meno: alla domanda «se un albero cade e nessuno lo vede è caduto davvero?», il realista risponde «sì», mentre il fisico quantistico risponde «questa domanda non ha senso, lo sapremo solo quando lo vedremo». Anzi, per portare alle estreme conseguenze la metafora della sovrapposizione di stati, egli potrebbe rispondere «l albero è sia in piedi sia caduto fino a quando non lo andiamo a vedere». Il secondo esempio è la negazione della validità della relazione di causa-effetto che la nostra mente associa all evoluzione di un fenomeno fisico e che è considerata alla base del fare scienza: nell entanglement, infatti, una particella cambia il suo stato istantaneamente, senza che una causa abbia avuto il tempo di provocare quell effetto. Le nostre concezioni intuitive sul comportamento dei fenomeni fisici sono dunque inadeguate, ma per fortuna siamo riusciti a ideare una matematica che li descrive adeguatamente. Insomma, se p Dettaglio dell'interferometro utilizzato dal gruppo di Matteo Paris per stimare l'entanglement. Cortesia Matteo Paris aprile
5 Il teletrasporto quantistico Il teletrasporto esiste, ma non ha nulla a che vedere con Star Trek. Parliamo di teletrasporto quantistico, che non trasporta materia, ma informazione. Proprio come i nostri fax, che trasferiscono immagini riproducendole da un foglio all altro. Più in dettaglio, il teletrasporto quantistico consiste in una duplicazione a distanza dello stato di una particella da un luogo a un altro, come per esempio lo stato di polarizzazione da un fotone a un altro. I primi stati di fotoni teletrasportati si devono a due gruppi di ricerca internazionali diretti rispettivamente da Francesco De Martini dell Università Sapienza di Roma e da Anton Zeilinger. Quest ultimo, nel 2004, ha ottenuto un teletrasporto di 600 metri attraverso una fibra ottica, da una parte all altra del Danubio. A maggio del 2010, in Cina, i ricercatori dell Hefei National Laboratory for Physical Sciences hanno raggiunto i 16 km e senza l aiuto di fibre ottiche! Nel 2006, inoltre, all Istituto Niels Bohr di Copenhagen alcuni ricercatori hanno teletrasportato uno stato collettivo da un gruppo di circa un trilione di atomi a un altro. Il teletrasporto applicato agli atomi e cioè alla materia è un processo molto fragile rispetto a quello sui fotoni, a causa del cosiddetto processo detto di decoerenza, che per colpa delle interazioni con l ambiente distrugge gli effetti quantistici, entanglement compreso. l intuizione non ci aiuta, la matematica sì. Ecco allora che possiamo considerare la meccanica quantistica come una teoria matematica alternativa a quella classica, che riesce a descrivere e a predire il comportamento di sistemi fisici che contengono elementi non intuitivi. Fotoni alle Canarie Proprio la matematica è stata fondamentale per la verifica sperimentale dell entanglement, resa possibile dal contributo teorico formulato dal fisico irlandese John Bell nel Secondo il teorema di Bell è possibile distinguere se un fenomeno è locale (quindi classico) oppure no (quindi non classico, entangled) grazie a una disuguaglianza matematica che coinvolge la somma dei risultati possibili di un esperimento. Qui entrano in gioco calcoli probabilistici che danno risultati diversi a seconda che la natura permetta o non permetta l entanglement. Se i valori misurati negli esperimenti rispettano la disuguaglianza, vince la località, se invece la violano, ha la meglio la non località. Bisogna inoltre ribadire che, al contrario di quelle classiche, le correlazioni quantistiche non comportano più il cosiddetto realismo. Gli esperimenti che hanno mostrato la violazione della disuguaglianza di Bell risalgono agli anni settanta e furono realizzati da John F. Clauser e Stuart Freedman dell Università della California a Berkeley e da Ed S. Frey e Randal C. Thomson della Texas A&M University. Negli anni ottanta, infine, il fisico francese Alain Aspect ha ottenuto le conferme sperimentali decisive a sostegno del carattere non locale della meccanica quantistica. Altre conferme sono venute anche dal laboratorio di Anton Zeilinger (Università di Vienna), che nel 2007 ha creato coppie di fotoni entangled a 144 km uno dall altro, precisamente alle Canarie: dall isola di La Palma fino a Tenerife! Il 10 marzo 2010 Aspect, Clauser e Zeilinger hanno vinto il premio Wolf per la Fisica, il secondo in quanto a prestigio dopo il premio Nobel. Tecnologia quantistica Chi è arrivato a leggere fino a qui potrebbe avere l impressione che l entanglement sia un fenomeno che riguarda la fisica pura, quella teorica, e che non abbia ripercussioni sulla nostra vita di tutti i giorni. Invece non è affatto così. L entanglement è anche alla base di importanti svolte tecnologiche, come ci ha raccontato il professor Matteo Paris del Dipartimento di fisica dell Università di Milano. «L entanglement è una risorsa cruciale. Ci sono innovazioni tecnologiche che possono essere realizzate solo sfruttando questo fenomeno fisico, come il teletrasporto (cioè il trasferimento delle proprietà di un elemento della materia a un altro che è distante dal primo)». E ancora: «I fisici utilizzano l entanglement per migliorare la trasmissione, l elaborazione e lo stoccaggio delle informazioni e il principio di sovrapposizione per sviluppare tecnologie emergenti come la crittografia, utile per garantire la privacy dei dati trasmessi in Internet. Ci sono già in commercio campioni di numeri casuali (utili alle banche o alle 20 aprile 2011
6 Parole chiave Polarizzazione Il piano di oscillazione del campo elettrico e magnetico che costituisce la luce. Interferometro Strumento sperimentale che tramite le figure di interferenza evidenzia i comportamenti quantistici delle particelle. Spazio di Hilbert Si tratta di un ente matematico: in termini tecnici è uno spazio vettoriale lineare normato e completo. In fisica, lo spazio di Hilbert viene definito sull insieme dei numeri complessi e permette di rappresentare matematicamente gli stati dei sistemi quantistici, tramite i suoi vettori. L entanglement è una risorsa cruciale: ci sono innovazioni tecnologiche che possono essere realizzate solo sfruttando questo fenomeno fisico In rete! Per approfondire A.D. Aczel, Entanglement, Raffaello Cortina Editore, Milano C. Orzel, La fisica spiegata al mio cane, Aliberti editore, Roma Il prof. sul web Sito di Matteo Paris: una sezione è dedicata ad approfondimenti divulgativi. Quantum information Pagine web di alcuni gruppi di ricerca italiani La candela quantistica Sito del progetto di ricerca europeo sulla ridefinizione dell unità di misura dell intensità luminosa con strumenti della tecnologia quantistica. aziende per creare codici sicuri per le carte di credito) che non sono ottenuti da algoritmi, ma direttamente da un sistema quantistico in cui un fotone attraversa uno specchio semiriflettente. In questo modo i numeri sono generati dalla natura stessa, che ha leggi intrinsecamente casuali e così il sistema è assolutamente sicuro! Un altra applicazione della tecnologia quantistica sono le sorgenti a singolo fotone (dispositivi che emettono impulsi di radiazione luminosa contenenti un unico fotone, NdR) utili per la ridefinizione della candela, l unità di misura dell intensità luminosa nel Sistema internazionale». Misurare l entanglement Matteo Paris si occupa di Quantum Information, una disciplina che riguarda sia i fondamenti teorici della fisica quantistica sia le applicazioni all avanguardia nel campo delle nuove tecnologie. Il suo ultimo lavoro, pubblicato sulla rivista Physical Review Letters e svolto in collaborazione con l Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inrim) e la Fondazione Isi di Torino, ha fornito una stima dell entanglement che, per la prima volta, ha raggiunto la massima precisione consentita dalle leggi di natura. «Poiché le prestazioni nella trasmissione e manipolazione di informazioni, per esempio in fibra ottica, migliorano con luce non classica e in particolare con luce entangled», sottolinea Paris, «è di fondamentale importanza saper quantificare l entanglement in modo da poter sfruttare a pieno nella pratica le sue potenzialità. Senza poter fare valutazioni quantitative precise, infatti, nessun sistema è utilizzabile concretamente». D altra parte, secondo la meccanica quantistica, l entanglement presente in un sistema fisico non è una quantità direttamente misurabile ed è necessario individuare una strategia per stimarne il valore in maniera indiretta: è esattamente questo che Paris e il suo gruppo hanno fatto. Tramite un interferometro hanno generato stati di due fotoni con entanglement variabile e hanno poi stimato l entanglement preparando diversi possibili cammini per i fotoni e misurando quanto e come questi si distribuivano tra i diversi percorsi. Alla domanda «è possibile capire davvero la meccanica quantistica?» Paris risponde in maniera un po provocatoria: «Be' bisognerebbe conoscere gli spazi di Hilbert». Subito dopo, però, aggiunge un famoso commento del fisico israeliano Asher Peres, uno dei padri della Quantum information: «Quantum phenomena do not occur in a Hilbert space. They occur in a laboratory». - multimedia Francesca E. Magni laureata in fisica, insegnante e pubblicista. Ha collaborato e collabora con riviste di comunicazione della scienza sia cartacee sia online. Cura il blog lineediscienza linxedizioni.it. aprile
Sulla nascita di questo libro. Introduzione 1
 Indice Sulla nascita di questo libro V Introduzione 1 1 Luce e materia 7 Che cos è veramente la luce? 7 Ma qui che cosa oscilla? 9 Che cosa sono la frequenza e la lunghezza d onda della luce? 11 Che cos
Indice Sulla nascita di questo libro V Introduzione 1 1 Luce e materia 7 Che cos è veramente la luce? 7 Ma qui che cosa oscilla? 9 Che cosa sono la frequenza e la lunghezza d onda della luce? 11 Che cos
Il gatto di Schroedinger: vivo, morto, o...?
 Il gatto di Schroedinger: vivo, morto, o...? Lorenzo Maccone Dip. Fisica, INFN Pavia, Universita' di Pavia www.qubit.it maccone@unipv.it Di cosa parlero? Di cosa parlero? Mostrero' come Stranezza della
Il gatto di Schroedinger: vivo, morto, o...? Lorenzo Maccone Dip. Fisica, INFN Pavia, Universita' di Pavia www.qubit.it maccone@unipv.it Di cosa parlero? Di cosa parlero? Mostrero' come Stranezza della
LA RIVOLUZIONE QUANTISTICA
 LA RIVOLUZIONE QUANTISTICA Franco Prati Università dell Insubria - Como NINDA URUK Il pane dei Sumeri Ricerca scientifica ed epistemologia 5 dicembre 2012 Congresso Internazionale dei Fisici in onore di
LA RIVOLUZIONE QUANTISTICA Franco Prati Università dell Insubria - Como NINDA URUK Il pane dei Sumeri Ricerca scientifica ed epistemologia 5 dicembre 2012 Congresso Internazionale dei Fisici in onore di
Il paradosso del which way? : onda o particella? Lo decido io! giorgio lulli
 Il paradosso del which way? : onda o particella? Lo decido io! giorgio lulli Ci domandiamo qui: cosa accade se nell esperimento più bello cerchiamo di sapere da che parte (which way?) è passato l elettrone?
Il paradosso del which way? : onda o particella? Lo decido io! giorgio lulli Ci domandiamo qui: cosa accade se nell esperimento più bello cerchiamo di sapere da che parte (which way?) è passato l elettrone?
Premi Nobel per la Fisica Accademia delle Scienze di Torino 10 dicembre 2012 Presentazione di Alessandro Bottino
 Premi Nobel per la Fisica 01 Serge Haroche, David J. Wineland Accademia delle Scienze di Torino 10 dicembre 01 Presentazione di Alessandro Bottino Serge Haroche Collège de France, and École Normale Supérieure,
Premi Nobel per la Fisica 01 Serge Haroche, David J. Wineland Accademia delle Scienze di Torino 10 dicembre 01 Presentazione di Alessandro Bottino Serge Haroche Collège de France, and École Normale Supérieure,
I.I.S. N. BOBBIO DI CARIGNANO - PROGRAMMAZIONE PER L A. S
 DISCIPLINA: FISICA (Indirizzo linguistico) CLASSE: QUINTA COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI Le cariche elettriche Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l esperimento è inteso
DISCIPLINA: FISICA (Indirizzo linguistico) CLASSE: QUINTA COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI Le cariche elettriche Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l esperimento è inteso
02. La Probabilità Classica e la Probabilità Quantistica
 02. 02.c La probabilità quantistica Un gatto di Schrödinger 02. Contenuti. slide#3 Max Born Germania, 1882-1970 John Stuart Bell Irtlanda del Nord, 1928-1990 M. Born fu uno dei padri della Meccanica Quantistica
02. 02.c La probabilità quantistica Un gatto di Schrödinger 02. Contenuti. slide#3 Max Born Germania, 1882-1970 John Stuart Bell Irtlanda del Nord, 1928-1990 M. Born fu uno dei padri della Meccanica Quantistica
FAM. Entanglement. Christian Ferrari. Liceo di Locarno
 FAM Entanglement Christian Ferrari Liceo di Locarno Spazio di Hilbert: gli stati puri 1 Lo spazio di Hilbert per modelizzare sistemi a due particelle quantistiche è H = H 1 H 2 dove H 1 e H 2 descrivono
FAM Entanglement Christian Ferrari Liceo di Locarno Spazio di Hilbert: gli stati puri 1 Lo spazio di Hilbert per modelizzare sistemi a due particelle quantistiche è H = H 1 H 2 dove H 1 e H 2 descrivono
Oltre le metriche tradizionali: come muoversi in uno spazio di possibilità e incertezza imparando a coglierne i vantaggi
 Oltre le metriche tradizionali: come muoversi in uno spazio di possibilità e incertezza imparando a coglierne i vantaggi SEDE: Blend Tower - Piazza IV Novembre, 7 (Mi) - Ore 18.00-20.00 DATA: 19 ottobre
Oltre le metriche tradizionali: come muoversi in uno spazio di possibilità e incertezza imparando a coglierne i vantaggi SEDE: Blend Tower - Piazza IV Novembre, 7 (Mi) - Ore 18.00-20.00 DATA: 19 ottobre
Relatività Ristretta e Meccanica Quantistica: alcuni esperimenti cruciali. Lezione 1. Genova, 12,13,19,20 Gennaio 2016
 Relatività Ristretta e Meccanica Quantistica: alcuni esperimenti cruciali Lezione 1 Genova, 12,13,19,20 Gennaio 2016 Prof. Marco Pallavicini Università di Genova Dipartimento di Fisica Istituto Nazionale
Relatività Ristretta e Meccanica Quantistica: alcuni esperimenti cruciali Lezione 1 Genova, 12,13,19,20 Gennaio 2016 Prof. Marco Pallavicini Università di Genova Dipartimento di Fisica Istituto Nazionale
LFN Incontri di Fisica anni di nonlocalità in meccanica quan;s;ca: dal paradosso EPR alle disuguaglianze di Bell, e oltre
 LFN Incontri di Fisica 2014 50 anni di nonlocalità in meccanica quan;s;ca: dal paradosso EPR alle disuguaglianze di Bell, e oltre La meccanica quantistica È la teoria che utilizziamo per descrivere atomi,
LFN Incontri di Fisica 2014 50 anni di nonlocalità in meccanica quan;s;ca: dal paradosso EPR alle disuguaglianze di Bell, e oltre La meccanica quantistica È la teoria che utilizziamo per descrivere atomi,
Lezione 3. Principi generali della Meccanica Cinematica, Statica e Dinamica
 Lezione 3 Principi generali della Meccanica Cinematica, Statica e Dinamica Premessa L Universo in cui viviamo costituisce un sistema dinamico, cioè un sistema in evoluzione nel tempo secondo opportune
Lezione 3 Principi generali della Meccanica Cinematica, Statica e Dinamica Premessa L Universo in cui viviamo costituisce un sistema dinamico, cioè un sistema in evoluzione nel tempo secondo opportune
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA III a PARTE
 LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA III a PARTE Prof. V.Lubicz Dualità onda-particella - Esperimenti ideali di interferenza con pallottole, onde ed elettroni - Principio di indeterminazione La Meccanica Quantistica
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA III a PARTE Prof. V.Lubicz Dualità onda-particella - Esperimenti ideali di interferenza con pallottole, onde ed elettroni - Principio di indeterminazione La Meccanica Quantistica
Verifica del Principio di Indeterminazione di Heisenberg. x v x cost
 Verifica del Principio di Indeterminazione di Heisenberg x v x cost Il Principio di Indeterminazione di Heisenberg e uno dei principi su cui si fonda la Meccanica Quantistica (MQ) La MQ e la teoria che
Verifica del Principio di Indeterminazione di Heisenberg x v x cost Il Principio di Indeterminazione di Heisenberg e uno dei principi su cui si fonda la Meccanica Quantistica (MQ) La MQ e la teoria che
LE ONDE E I FONDAMENTI DELLA TEORIA QUANTISTICA
 LE ONDE E I FONDAMENTI DELLA TEORIA QUANTISTICA I PROBLEMI DEL MODELLO PLANETARIO F Secondo Rutherford l elettrone si muoverebbe sulla sua orbita in equilibrio tra la forza elettrica di attrazione del
LE ONDE E I FONDAMENTI DELLA TEORIA QUANTISTICA I PROBLEMI DEL MODELLO PLANETARIO F Secondo Rutherford l elettrone si muoverebbe sulla sua orbita in equilibrio tra la forza elettrica di attrazione del
Teoria Atomica di Dalton
 Teoria Atomica di Dalton Il concetto moderno della materia si origina nel 1806 con la teoria atomica di John Dalton: Ogni elementoè composto di atomi. Gli atomi di un dato elemento sono uguali. Gli atomi
Teoria Atomica di Dalton Il concetto moderno della materia si origina nel 1806 con la teoria atomica di John Dalton: Ogni elementoè composto di atomi. Gli atomi di un dato elemento sono uguali. Gli atomi
Settimana 4 La Meccanica Quantistica Gli inizi Planck, Einstein, Bohr De Broglie: le particelle sono anche onde
 Relatività e Meccanica Quantistica: concetti e idee Relativity and Quantum Mechanics: concepts and ideas Settimana 4 La Meccanica Quantistica Gli inizi Planck, Einstein, Bohr De Broglie: le particelle
Relatività e Meccanica Quantistica: concetti e idee Relativity and Quantum Mechanics: concepts and ideas Settimana 4 La Meccanica Quantistica Gli inizi Planck, Einstein, Bohr De Broglie: le particelle
QUANTITA DI MOTO Corso di Fisica per Farmacia, Facoltà di Farmacia, Università G. D Annunzio, Cosimo Del Gratta 2006
 QUANTITA DI MOTO DEFINIZIONE(1) m v Si chiama quantità di moto di un punto materiale il prodotto della sua massa per la sua velocità p = m v La quantità di moto è una grandezza vettoriale La dimensione
QUANTITA DI MOTO DEFINIZIONE(1) m v Si chiama quantità di moto di un punto materiale il prodotto della sua massa per la sua velocità p = m v La quantità di moto è una grandezza vettoriale La dimensione
L'entanglement, da sorgente dei paradossi della meccanica quantistica a risorsa per le nascenti tecnologie quantistiche
 L'entanglement, da sorgente dei paradossi della meccanica quantistica a risorsa per le nascenti tecnologie quantistiche Il mondo classico: la nostra vita quotidiana Un pallone quantistico: il fullerene
L'entanglement, da sorgente dei paradossi della meccanica quantistica a risorsa per le nascenti tecnologie quantistiche Il mondo classico: la nostra vita quotidiana Un pallone quantistico: il fullerene
Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici
 Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici Il presente documento individua le conoscenze, abilità e competenze che lo studente dovrà aver acquisito al termine
Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici Il presente documento individua le conoscenze, abilità e competenze che lo studente dovrà aver acquisito al termine
La relatività generale. Lezioni d'autore
 La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
ELENCO ANALITICO DEGLI ARGOMENTI
 PROGRAMMA PER ESAMI DI IDONEITÀ ALLA CLASSE II FISICA dipartimento e contiene gli argomenti essenziali per l accesso al II anno di corso. INTRODUZIONE ALLA FISICA: GRANDEZZE E MISURE Metodo scientifico,
PROGRAMMA PER ESAMI DI IDONEITÀ ALLA CLASSE II FISICA dipartimento e contiene gli argomenti essenziali per l accesso al II anno di corso. INTRODUZIONE ALLA FISICA: GRANDEZZE E MISURE Metodo scientifico,
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA MORESCHI
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA MORESCHI Programmazione didattica annuale Materia: FISICA classi: PRIMO BIENNIO LICEO SCIENTIFICO a.s. 2017/2018 Finalità: Obiettivo dello studio della fisica è
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA MORESCHI Programmazione didattica annuale Materia: FISICA classi: PRIMO BIENNIO LICEO SCIENTIFICO a.s. 2017/2018 Finalità: Obiettivo dello studio della fisica è
Meccanica classica. Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dip. DiSAAT - Ing. Francesco Santoro Corso di Fisica
 Meccanica classica A differenza della cinematica in cui i moti sono descritti solo geometricamente attraverso l uso dei vettori posizione, velocità ed accelerazione, nella dinamica vengono analizzate le
Meccanica classica A differenza della cinematica in cui i moti sono descritti solo geometricamente attraverso l uso dei vettori posizione, velocità ed accelerazione, nella dinamica vengono analizzate le
A cura di Luigi Maximilian Caligiuri
 A cura di Luigi Maximilian Caligiuri L obiettivo più importante della fisica contemporanea è sicuramente l unificazione della Teoria della Relatività e della Meccanica Quantistica di Einstein. È anche
A cura di Luigi Maximilian Caligiuri L obiettivo più importante della fisica contemporanea è sicuramente l unificazione della Teoria della Relatività e della Meccanica Quantistica di Einstein. È anche
Relatività e Meccanica Quantistica: concetti e idee. Relativity and Quantum Mechanics: concepts and ideas. Carlo Cosmelli
 Relatività e Meccanica Quantistica: concetti e idee Relativity and Quantum Mechanics: concepts and ideas Settimana 1 - Il punto della situazione Lezione 1.1 Carlo Cosmelli 1 Il XX secolo, nascono due nuove
Relatività e Meccanica Quantistica: concetti e idee Relativity and Quantum Mechanics: concepts and ideas Settimana 1 - Il punto della situazione Lezione 1.1 Carlo Cosmelli 1 Il XX secolo, nascono due nuove
La Fisica Quasi Moderna La Meccanica Quantistica Classica. Particelle a velocità Molto inferiore alla luce
 La Fisica Quasi Moderna La Meccanica Quantistica Classica Particelle a velocità Molto inferiore alla luce Sommario Il Macinino di Newton Ma perché esiste il Mondo? Una deviazione: fisica e matematica La
La Fisica Quasi Moderna La Meccanica Quantistica Classica Particelle a velocità Molto inferiore alla luce Sommario Il Macinino di Newton Ma perché esiste il Mondo? Una deviazione: fisica e matematica La
Generalità delle onde elettromagnetiche
 Generalità delle onde elettromagnetiche Ampiezza massima: E max (B max ) Lunghezza d onda: (m) E max (B max ) Periodo: (s) Frequenza: = 1 (s-1 ) Numero d onda: = 1 (m-1 ) = v Velocità della luce nel vuoto
Generalità delle onde elettromagnetiche Ampiezza massima: E max (B max ) Lunghezza d onda: (m) E max (B max ) Periodo: (s) Frequenza: = 1 (s-1 ) Numero d onda: = 1 (m-1 ) = v Velocità della luce nel vuoto
Interferenza di elettroni e! Principio di Indeterminazione
 Interferenza di elettroni e! Principio di Indeterminazione Paolo Pendenza Corso PAS, 10 luglio 2014 Anche nelle scienze non si possono scoprire nuove terre se non si è pronti a lasciarsi indietro il porto
Interferenza di elettroni e! Principio di Indeterminazione Paolo Pendenza Corso PAS, 10 luglio 2014 Anche nelle scienze non si possono scoprire nuove terre se non si è pronti a lasciarsi indietro il porto
DOMANDE PER CAPIRE LA FISICA
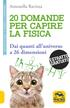 INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
Lezioni di Meccanica Quantistica
 Luigi E. Picasso Lezioni di Meccanica Quantistica seconda edizione Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2015 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com
Luigi E. Picasso Lezioni di Meccanica Quantistica seconda edizione Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2015 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com
L atomo di Bohr e i raggi X
 L atomo di Bohr e i raggi X Corsi laboratorio per le scuole superiori gennaio 017 Prof. Federico Boscherini Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Bologna federico.boscherini@unibo.it www.unibo.it/docenti/federico.boscherini
L atomo di Bohr e i raggi X Corsi laboratorio per le scuole superiori gennaio 017 Prof. Federico Boscherini Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Bologna federico.boscherini@unibo.it www.unibo.it/docenti/federico.boscherini
Modelli atomici. Teoria atomica Dalton (1803) La materia non è continua, ma costituita da particelle.
 Modelli atomici Teoria atomica Dalton (1803) La materia non è continua, ma costituita da particelle. Presupposti 1. Legge di Lavoisier della conservazione della massa: in una reazione chimica nulla si
Modelli atomici Teoria atomica Dalton (1803) La materia non è continua, ma costituita da particelle. Presupposti 1. Legge di Lavoisier della conservazione della massa: in una reazione chimica nulla si
Le Grandezze Fisiche e la loro Misura
 FISICA: Le Grandezze Fisiche e la loro Misura Giancarlo Zancanella (2009) 1 1 Le Grandezze Fisiche Si chiamano grandezze fisiche le proprietà dei corpi che possono essere misurate La forma, la bellezza
FISICA: Le Grandezze Fisiche e la loro Misura Giancarlo Zancanella (2009) 1 1 Le Grandezze Fisiche Si chiamano grandezze fisiche le proprietà dei corpi che possono essere misurate La forma, la bellezza
CENNI DI EPISTEMOLOGIA. Giulia Cavalli
 CENNI DI EPISTEMOLOGIA Giulia Cavalli Epistemologia Concezioni sviluppate dalla scienza su come l uomo conosce (la natura, i limiti, le condizioni della conoscenza), sulle nostre rappresentazioni della
CENNI DI EPISTEMOLOGIA Giulia Cavalli Epistemologia Concezioni sviluppate dalla scienza su come l uomo conosce (la natura, i limiti, le condizioni della conoscenza), sulle nostre rappresentazioni della
Una formulazione equivalente è Il moto di un singolo punto materiale isolato è rettilineo uniforme (o è fermo):
 I PRINCIPI DELLA MECCANICA In queste note i principi della dinamica vengono formulati utilizzando soltanto le definizioni di accelerazione e velocità istantanee della Cinematica. Le lettere in grassetto
I PRINCIPI DELLA MECCANICA In queste note i principi della dinamica vengono formulati utilizzando soltanto le definizioni di accelerazione e velocità istantanee della Cinematica. Le lettere in grassetto
Principi di Fisica per filosofi. a.a carlo cosmelli
 per filosofi a.a. - carlo cosmelli L argomento EPR 6.. L argomento EPR La versione O: (fin troppo facile, in realtà poco comprensibile e fuorviante). ) Consideriamo un sistema fisico composto da due parti
per filosofi a.a. - carlo cosmelli L argomento EPR 6.. L argomento EPR La versione O: (fin troppo facile, in realtà poco comprensibile e fuorviante). ) Consideriamo un sistema fisico composto da due parti
Recenti Scoperte Scientifiche in Ottica
 Recenti Scoperte Scientifiche in Ottica Luca Salasnich Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei, Università di Padova, Italy Padova, 26 Maggio 2014 Secondo Meeting di Ottica e Optometria a Padova
Recenti Scoperte Scientifiche in Ottica Luca Salasnich Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei, Università di Padova, Italy Padova, 26 Maggio 2014 Secondo Meeting di Ottica e Optometria a Padova
Interferenze quantistiche
 FAM Interferenze quantistiche Christian Ferrari Liceo di Locarno Cenni storici 1 Anni 1920: messa in evidenza di uno strano comportamento degli oggetti del mondo microscopico. Esperienze con la luce in
FAM Interferenze quantistiche Christian Ferrari Liceo di Locarno Cenni storici 1 Anni 1920: messa in evidenza di uno strano comportamento degli oggetti del mondo microscopico. Esperienze con la luce in
Vincenzo Branchina. Rivoluzioni Scientifiche. Fisica Quantistica. Università di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia
 Vincenzo Branchina Rivoluzioni Scientifiche Fisica Quantistica Università di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Giarre, 5 Marzo 2015 Nuova Meccanica Quantistica: Equazione di Schrodinger (1925)
Vincenzo Branchina Rivoluzioni Scientifiche Fisica Quantistica Università di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Giarre, 5 Marzo 2015 Nuova Meccanica Quantistica: Equazione di Schrodinger (1925)
Modelli per il processo di misura. in Meccanica Quantistica
 Modelli per il processo di misura in Meccanica Quantistica Problemi imbarazzanti descrizione dei processi che avvengono alla frontiera tra microscopico e macroscopico e dei processi di interazione tra
Modelli per il processo di misura in Meccanica Quantistica Problemi imbarazzanti descrizione dei processi che avvengono alla frontiera tra microscopico e macroscopico e dei processi di interazione tra
Capitolo 8 La struttura dell atomo
 Capitolo 8 La struttura dell atomo 1. La doppia natura della luce 2. La «luce» degli atomi 3. L atomo di Bohr 4. La doppia natura dell elettrone 5. L elettrone e la meccanica quantistica 6. L equazione
Capitolo 8 La struttura dell atomo 1. La doppia natura della luce 2. La «luce» degli atomi 3. L atomo di Bohr 4. La doppia natura dell elettrone 5. L elettrone e la meccanica quantistica 6. L equazione
Principi di Fisica per filosofi. a.a carlo cosmelli QM - EPR
 per filosofi a.a. 009-00 carlo cosmelli QM - EPR L argomento EPR. La notazione di Dirac Ogni sistema fisico è descritto dalla relativa funzione d onda ψ(r,t) ψ Consideriamo un generico stato ψ ottenuto
per filosofi a.a. 009-00 carlo cosmelli QM - EPR L argomento EPR. La notazione di Dirac Ogni sistema fisico è descritto dalla relativa funzione d onda ψ(r,t) ψ Consideriamo un generico stato ψ ottenuto
7 - Il dualismo onda particella e la sua indeterminazione
 7 - Il dualismo onda particella e la sua indeterminazione Se è vero che la particella in un istante, si trova in preciso punto e l istante successivo potrebbe trovarsi in un qualunque altro punto dell
7 - Il dualismo onda particella e la sua indeterminazione Se è vero che la particella in un istante, si trova in preciso punto e l istante successivo potrebbe trovarsi in un qualunque altro punto dell
L Universo in un lancio di dadi. Come il principio di indeterminazione di Heisenberg ha portato alla fine del determinismo scientifico
 L Universo in un lancio di dadi Come il principio di indeterminazione di Heisenberg ha portato alla fine del determinismo scientifico Abà Anna classe V BS Un precursore: David Hume «L idea di causa ed
L Universo in un lancio di dadi Come il principio di indeterminazione di Heisenberg ha portato alla fine del determinismo scientifico Abà Anna classe V BS Un precursore: David Hume «L idea di causa ed
MODULO BIMESTRALE N.1:Le Grandezze in Fisica
 CLASSE PRIMAFISICA MODULO BIMESTRALE N.1:Le Grandezze in Fisica Conoscere il concetto di grandezza, di misura, di unità di misura, di equivalenza e gli strumenti matematici per valutare le grandezze. ABILITA
CLASSE PRIMAFISICA MODULO BIMESTRALE N.1:Le Grandezze in Fisica Conoscere il concetto di grandezza, di misura, di unità di misura, di equivalenza e gli strumenti matematici per valutare le grandezze. ABILITA
Le forze. Cos è una forza? in quiete. in moto
 Le forze Ricorda che quando parli di: - corpo: ti stai riferendo all oggetto che stai studiando; - deformazione. significa che il corpo che stai studiando cambia forma (come quando pesti una scatola di
Le forze Ricorda che quando parli di: - corpo: ti stai riferendo all oggetto che stai studiando; - deformazione. significa che il corpo che stai studiando cambia forma (come quando pesti una scatola di
Liceo delle Scienze Umane Fabrizio De André Dipartimento di Matematica e Fisica Programma di FISICA: Triennio a.s
 Liceo delle Scienze Umane Fabrizio De André Dipartimento di Matematica e Fisica Programma di FISICA: Triennio a.s. 2016-17 Competenze: primo biennio Conoscere i concetti fondamentali della fisica, le leggi
Liceo delle Scienze Umane Fabrizio De André Dipartimento di Matematica e Fisica Programma di FISICA: Triennio a.s. 2016-17 Competenze: primo biennio Conoscere i concetti fondamentali della fisica, le leggi
Il metodo scientifico
 La Fisica è una scienza grazie a Galileo che a suo fondamento pose il metodo scientifico 1 Il metodo scientifico La Natura è complessa: non basta osservarla per capirla Intuizione di Galileo: bisogna porre
La Fisica è una scienza grazie a Galileo che a suo fondamento pose il metodo scientifico 1 Il metodo scientifico La Natura è complessa: non basta osservarla per capirla Intuizione di Galileo: bisogna porre
Teoria Atomica Moderna. Chimica generale ed Inorganica: Chimica Generale. sorgenti di emissione di luce. E = hν. νλ = c. E = mc 2
 sorgenti di emissione di luce E = hν νλ = c E = mc 2 FIGURA 9-9 Spettro atomico, o a righe, dell elio Spettri Atomici: emissione, assorbimento FIGURA 9-10 La serie di Balmer per gli atomi di idrogeno
sorgenti di emissione di luce E = hν νλ = c E = mc 2 FIGURA 9-9 Spettro atomico, o a righe, dell elio Spettri Atomici: emissione, assorbimento FIGURA 9-10 La serie di Balmer per gli atomi di idrogeno
Introduzione alla meccanica quantistica. Vincenzo Barone
 Accademia delle Scienze di Torino 9 novembre 2017 Introduzione alla meccanica quantistica Vincenzo Barone barone@to.infn.it Parte I: Le basi della meccanica quantistica (questioni didattiche) Parte II:
Accademia delle Scienze di Torino 9 novembre 2017 Introduzione alla meccanica quantistica Vincenzo Barone barone@to.infn.it Parte I: Le basi della meccanica quantistica (questioni didattiche) Parte II:
4. I principi della meccanica
 1 Leggi del moto 4. I principi della meccanica Come si è visto la cinematica studia il moto dal punto di vista descrittivo, ma non si sofferma sulle cause di esso. Ciò è compito della dinamica. Alla base
1 Leggi del moto 4. I principi della meccanica Come si è visto la cinematica studia il moto dal punto di vista descrittivo, ma non si sofferma sulle cause di esso. Ciò è compito della dinamica. Alla base
Modello atomico ad orbitali e numeri quantici
 Modello atomico ad orbitali e numeri quantici Il modello atomico di Bohr permette di scrivere correttamente la configurazione elettronica di un atomo ma ha dei limiti che sono stati superati con l introduzione
Modello atomico ad orbitali e numeri quantici Il modello atomico di Bohr permette di scrivere correttamente la configurazione elettronica di un atomo ma ha dei limiti che sono stati superati con l introduzione
Unità 2. La teoria quantistica
 Unità 2 La teoria quantistica L'effetto fotoelettrico Nel 1902 il fisico P. Lenard studiò l'effetto fotoelettrico. Esso è l'emissione di elettroni da parte di un metallo su cui incide un'onda elettromagnetica.
Unità 2 La teoria quantistica L'effetto fotoelettrico Nel 1902 il fisico P. Lenard studiò l'effetto fotoelettrico. Esso è l'emissione di elettroni da parte di un metallo su cui incide un'onda elettromagnetica.
Incontriamo la Fisica: la Meccanica Quantistica. Stefano Spagocci, GACB
 Incontriamo la Fisica: la Meccanica Quantistica Stefano Spagocci, GACB Newton e Laplace Secondo la concezione di Newton e Laplace, specificate le condizioni iniziali (posizioni e velocità), il moto di
Incontriamo la Fisica: la Meccanica Quantistica Stefano Spagocci, GACB Newton e Laplace Secondo la concezione di Newton e Laplace, specificate le condizioni iniziali (posizioni e velocità), il moto di
L Induzione Elettromagnetica. Fabio Bevilacqua Dipartimento di Fisica A.Volta Università di Pavia
 L Induzione Elettromagnetica Fabio Bevilacqua Dipartimento di Fisica A.Volta Università di Pavia Il fenomeno Uno straordinario fenomeno avviene quando un filo conduttore è mosso in vicinanza di un magnete:
L Induzione Elettromagnetica Fabio Bevilacqua Dipartimento di Fisica A.Volta Università di Pavia Il fenomeno Uno straordinario fenomeno avviene quando un filo conduttore è mosso in vicinanza di un magnete:
Sistema arciere-arco
 Sistema arciere-arco Consideriamo un ragazzo su uno sateboard mentre cade. Oltre alla forza peso che gestisce il moto verso il basso durante la caduta, nella direzione orizzontale al terreno avremo che
Sistema arciere-arco Consideriamo un ragazzo su uno sateboard mentre cade. Oltre alla forza peso che gestisce il moto verso il basso durante la caduta, nella direzione orizzontale al terreno avremo che
Questo simbolo significa che è disponibile una scheda preparata per presentare l esperimento
 IL CAMPO ELETTRICO Questo simbolo significa che l esperimento si può realizzare con materiali o strumenti presenti nel nostro laboratorio Questo simbolo significa che l esperimento si può realizzare anche
IL CAMPO ELETTRICO Questo simbolo significa che l esperimento si può realizzare con materiali o strumenti presenti nel nostro laboratorio Questo simbolo significa che l esperimento si può realizzare anche
Programmazione modulare
 Programmazione modulare 2016-2017 Indirizzo: BIENNIO Disciplina: FISICA Classe: I a D - I a E - I a F Ore settimanali previste: 3 (2 ore di teoria 1 ora di Laboratorio) Titolo Modulo Contenuti Conoscenze
Programmazione modulare 2016-2017 Indirizzo: BIENNIO Disciplina: FISICA Classe: I a D - I a E - I a F Ore settimanali previste: 3 (2 ore di teoria 1 ora di Laboratorio) Titolo Modulo Contenuti Conoscenze
TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA
 TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA EVOLUZIONE DELLE TEORIE FISICHE Meccanica Classica Principio di Relatività Galileiano Meccanica Newtoniana Gravitazione (Newton) Costante Universale G = 6,67*10^-11Nm^2/Kg^2
TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA EVOLUZIONE DELLE TEORIE FISICHE Meccanica Classica Principio di Relatività Galileiano Meccanica Newtoniana Gravitazione (Newton) Costante Universale G = 6,67*10^-11Nm^2/Kg^2
Una vita per la meccanica quantistica. Alice Salvadori Liceo Scientifico G. Ulivi 5G
 Una vita per la meccanica quantistica Alice Salvadori Liceo Scientifico G. Ulivi 5G Introduzione Vita Quali meriti? Meccanica quantistica Il principio di indeterminazione Implicazioni filosofiche Nuovo
Una vita per la meccanica quantistica Alice Salvadori Liceo Scientifico G. Ulivi 5G Introduzione Vita Quali meriti? Meccanica quantistica Il principio di indeterminazione Implicazioni filosofiche Nuovo
COMPUTER QUANTISTICO, CRITTOGRAFIA QUANTISTICA E TELETRASPORTO
 COMPUTER QUANTISTICO, CRITTOGRAFIA QUANTISTICA E TELETRASPORTO MECCANICA QUANTISTICA E NON LOCALITÀ : L ENTANGLEMENT La Meccanica Quantistica, per particolari misurazioni eseguite su due particelle lontane,
COMPUTER QUANTISTICO, CRITTOGRAFIA QUANTISTICA E TELETRASPORTO MECCANICA QUANTISTICA E NON LOCALITÀ : L ENTANGLEMENT La Meccanica Quantistica, per particolari misurazioni eseguite su due particelle lontane,
Insegnare relatività. nel XXI secolo
 Insegnare relatività nel XXI secolo E s p a n s i o n e d e l l ' U n i v e r s o e l e g g e d i H u b b l e La legge di Hubble Studiando distanze e moto delle galassie si trova che quelle più vicine
Insegnare relatività nel XXI secolo E s p a n s i o n e d e l l ' U n i v e r s o e l e g g e d i H u b b l e La legge di Hubble Studiando distanze e moto delle galassie si trova che quelle più vicine
Programma della I parte
 Programma della I parte Cenni alla meccanica quantistica: il modello dell atomo Dall atomo ai cristalli: statistica di Fermi-Dirac, il modello a bande di energia, popolazione delle bande, livello di Fermi
Programma della I parte Cenni alla meccanica quantistica: il modello dell atomo Dall atomo ai cristalli: statistica di Fermi-Dirac, il modello a bande di energia, popolazione delle bande, livello di Fermi
Effetti relativistici e quantistici
 Effetti relativistici e quantistici Dott. Fabiano Nart Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti E. Fermi www.gdsdolomiti.org info.gdsdolomiti@gmail.com Museo Scienze Naturali Bolzano, 24/05/2016 Dott.
Effetti relativistici e quantistici Dott. Fabiano Nart Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti E. Fermi www.gdsdolomiti.org info.gdsdolomiti@gmail.com Museo Scienze Naturali Bolzano, 24/05/2016 Dott.
FISICA ( MODERNA ) E PROBABILITÀ
 Fare scienza con il computer FISICA ( MODERNA ) E PROBABILITÀ Giorgio Pastore (pastore@ts.infn.it) Maria Peressi (peressi@ts.infn.it) 3 febbraio 2011 L'imprevedibilità di alcuni fenomeni fisici può essere
Fare scienza con il computer FISICA ( MODERNA ) E PROBABILITÀ Giorgio Pastore (pastore@ts.infn.it) Maria Peressi (peressi@ts.infn.it) 3 febbraio 2011 L'imprevedibilità di alcuni fenomeni fisici può essere
Università Primo Levi
 Università Primo Levi Primo Levi 2013 Le forze fondamentali e la fisica dei quanta INAF Osservatorio Astronomico di Bologna via Ranzani, 1 40127 - Bologna - Italia Tel, 051-2095721 Fax, 051-2095700 http://www.bo.astro.it/~bedogni/primolevi
Università Primo Levi Primo Levi 2013 Le forze fondamentali e la fisica dei quanta INAF Osservatorio Astronomico di Bologna via Ranzani, 1 40127 - Bologna - Italia Tel, 051-2095721 Fax, 051-2095700 http://www.bo.astro.it/~bedogni/primolevi
Fisica Quantistica. 1. Comportamento quantistico. 2. Effetto fotoelettrico. 3. Dualismo onda-corpuscolo. 4. Principio di indeterminazione
 Fisica Quantistica by Prof.ssa Paola Giacconi 1. Comportamento quantistico 2. Effetto fotoelettrico 3. Dualismo onda-corpuscolo 4. Principio di indeterminazione 1. COMPORTAMENTO QUANTISTICO La meccanica
Fisica Quantistica by Prof.ssa Paola Giacconi 1. Comportamento quantistico 2. Effetto fotoelettrico 3. Dualismo onda-corpuscolo 4. Principio di indeterminazione 1. COMPORTAMENTO QUANTISTICO La meccanica
Le Meraviglie della Fisica Quantistica
 Le Meraviglie della Fisica Quantistica Roberto Passante Dipartimento di Scienze Fisiche ed Astronomiche, Università di Palermo ITI Mottura, Caltanissetta, 24 Ottobre 2007 La Fisica Classica Galileo Galilei
Le Meraviglie della Fisica Quantistica Roberto Passante Dipartimento di Scienze Fisiche ed Astronomiche, Università di Palermo ITI Mottura, Caltanissetta, 24 Ottobre 2007 La Fisica Classica Galileo Galilei
Indice. Meccanica. Le grandezze fsiche. Il moto in una dimensione. Il moto in due dimensioni. Le forze e l equilibrio III
 Indice Meccanica 1 2 3 4 Le grandezze fsiche 1 Grandezze fsiche 2 2 Il Sistema Internazionale di Unità 3 3 Notazione scientifca e approssimazioni 5 4 L intervallo di tempo 9 5 La lunghezza 9 6 La massa
Indice Meccanica 1 2 3 4 Le grandezze fsiche 1 Grandezze fsiche 2 2 Il Sistema Internazionale di Unità 3 3 Notazione scientifca e approssimazioni 5 4 L intervallo di tempo 9 5 La lunghezza 9 6 La massa
A cura di Luigi Maximilian Caligiuri
 POSTFAZIONE A cura di Luigi Maximilian Caligiuri L obiettivo più importante della fisica contemporanea è sicuramente l unificazione della Teoria della Relatività e della Meccanica Quantistica di Einstein.
POSTFAZIONE A cura di Luigi Maximilian Caligiuri L obiettivo più importante della fisica contemporanea è sicuramente l unificazione della Teoria della Relatività e della Meccanica Quantistica di Einstein.
Lezione 6. Forze attive e passive. L interazione gravitazionale. L interazione elettromagnetica. WWW.SLIDETUBE.IT
 Lezione 6 Forze attive e passive. L interazione gravitazionale. L interazione elettromagnetica. Classificazione delle Forze Distinguiamo tra: Forze attive Forze passive Forze attive Le 4 forze fondamentali:
Lezione 6 Forze attive e passive. L interazione gravitazionale. L interazione elettromagnetica. Classificazione delle Forze Distinguiamo tra: Forze attive Forze passive Forze attive Le 4 forze fondamentali:
Fisica Moderna e contemporanea
 Fisica Moderna e contemporanea SSIS Puglia Prof. Luigi Schiavulli luigi.schiavulli@ba.infn.it Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin 02/02/2006 1 Sommario Quadro riassuntivo sulla Fisica
Fisica Moderna e contemporanea SSIS Puglia Prof. Luigi Schiavulli luigi.schiavulli@ba.infn.it Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin 02/02/2006 1 Sommario Quadro riassuntivo sulla Fisica
Elementi di Teoria degli Errori
 1 Elementi di Teoria degli Errori Corso di Esperimentazioni di Fisica I Laurea triennale in Astronomia Queste dispense sono state elaborate utilizzando diverso materiale didattico disponibile in letteratura.
1 Elementi di Teoria degli Errori Corso di Esperimentazioni di Fisica I Laurea triennale in Astronomia Queste dispense sono state elaborate utilizzando diverso materiale didattico disponibile in letteratura.
Carlo Cosmelli. La visione del mondo della Relatività e della Meccanica Quantistica. Settimana 4. Lezione 4.1 La Meccanica Quantistica Gli inizi
 La visione del mondo della Relatività e della Meccanica Quantistica Settimana 4 Lezione 4.1 La Meccanica Quantistica Gli inizi Carlo Cosmelli 1 Anno 1900: fatti che non tornano, che non si spiegano Il
La visione del mondo della Relatività e della Meccanica Quantistica Settimana 4 Lezione 4.1 La Meccanica Quantistica Gli inizi Carlo Cosmelli 1 Anno 1900: fatti che non tornano, che non si spiegano Il
Istituti Paritari PIO XII
 Istituti Paritari PIO XII RMTD545007 Amministrazione Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali 00159 ROMA - via Galla Placidia, 63 RMTL395001 Costruzioni, Ambiente e territorio Tel 064381465 Fax
Istituti Paritari PIO XII RMTD545007 Amministrazione Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali 00159 ROMA - via Galla Placidia, 63 RMTL395001 Costruzioni, Ambiente e territorio Tel 064381465 Fax
Roma, 30 ottobre 2017 COMUNICATO STAMPA
 COMUNICATO STAMPA Roma, 30 ottobre 2017 Onda e particella: i due volti della fisica quantistica per la prima volta connessi con l'azione a distanza tra fotoni Nel Quantum Information Lab della Sapienza,
COMUNICATO STAMPA Roma, 30 ottobre 2017 Onda e particella: i due volti della fisica quantistica per la prima volta connessi con l'azione a distanza tra fotoni Nel Quantum Information Lab della Sapienza,
Esperimenti which path? e interferenza quantistica. Giorgio Lulli CNR-IMM Bologna
 Esperimenti which path? e interferenza quantistica Giorgio Lulli CNR-IMM Bologna Riepilogando l EPB (secondo Merli, Missiroli e Pozzi) ogni elettrone singolo viene sempre rivelato come particella Il cosiddetto
Esperimenti which path? e interferenza quantistica Giorgio Lulli CNR-IMM Bologna Riepilogando l EPB (secondo Merli, Missiroli e Pozzi) ogni elettrone singolo viene sempre rivelato come particella Il cosiddetto
Contenuti dei moduli di Fisica Classica
 Contenuti dei moduli di Fisica Classica meccanica del punto meccanica dei sistemi (termodinamica) Corso di fisica sperimentale. In che senso? Metodo scientifico: la base di ogni conoscenza è l esperimento
Contenuti dei moduli di Fisica Classica meccanica del punto meccanica dei sistemi (termodinamica) Corso di fisica sperimentale. In che senso? Metodo scientifico: la base di ogni conoscenza è l esperimento
Lezione 20: Atomi e molecole
 Lezione 20 - pag.1 Lezione 20: Atomi e molecole 20.1. Il punto della situazione Abbiamo visto, nella lezione precedente, come il modello atomico sia in grado di spiegare la grande varietà di sostanze che
Lezione 20 - pag.1 Lezione 20: Atomi e molecole 20.1. Il punto della situazione Abbiamo visto, nella lezione precedente, come il modello atomico sia in grado di spiegare la grande varietà di sostanze che
ALBERT EINSTEIN LA TEORIA della RELATIVITA U.T.E
 INGRESSO NELLA RELATIVITA 1) La nuova Fisica dei fenomeni elettrici e magnetici. - Scoperta e misura della carica elettrica positiva e negativa Le leggi della elettricità e magnetismo - Cariche opposte
INGRESSO NELLA RELATIVITA 1) La nuova Fisica dei fenomeni elettrici e magnetici. - Scoperta e misura della carica elettrica positiva e negativa Le leggi della elettricità e magnetismo - Cariche opposte
OSSERVATORI diversi forniscono descrizioni diverse di un fenomeno
 LA RELATIVITÀ OSSERVATORI diversi forniscono descrizioni diverse di un fenomeno Cosa cambia? Ciò che osservo Cosa NON cambia? Le leggi fisiche... Davvero? Tutto è relativo? NO COS È RELATIVO? Il moto......
LA RELATIVITÀ OSSERVATORI diversi forniscono descrizioni diverse di un fenomeno Cosa cambia? Ciò che osservo Cosa NON cambia? Le leggi fisiche... Davvero? Tutto è relativo? NO COS È RELATIVO? Il moto......
PIANO DI LAVORO Anno Scolastico 2018/2019
 Istituto d Istruzione Superiore Veronese- Marconi Chioggia (Ve) PIANO DI LAVORO Anno Scolastico 2018/2019 Disciplina: FISICA Classe 5 B Indirizzo: Scienze Umane Insegnante: Agatea Valeria SITUAZIONE INIZIALE
Istituto d Istruzione Superiore Veronese- Marconi Chioggia (Ve) PIANO DI LAVORO Anno Scolastico 2018/2019 Disciplina: FISICA Classe 5 B Indirizzo: Scienze Umane Insegnante: Agatea Valeria SITUAZIONE INIZIALE
Esploriamo la chimica
 1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 8 La struttura dell atomo 1. La doppia natura della luce 2. L atomo di Bohr 3. Il modello atomico
1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 8 La struttura dell atomo 1. La doppia natura della luce 2. L atomo di Bohr 3. Il modello atomico
CHIMICAMENTE. Lezioni del prof. Puletti Classe II B
 CHIMICAMENTE Lezioni del prof. Puletti Classe II B Scuola Media PIO X Artigianelli A.S. 2011-2012 PERCORSO - cos è la materia e da cosa è costituita - le particelle atomiche fondamentali: protoni, neutroni
CHIMICAMENTE Lezioni del prof. Puletti Classe II B Scuola Media PIO X Artigianelli A.S. 2011-2012 PERCORSO - cos è la materia e da cosa è costituita - le particelle atomiche fondamentali: protoni, neutroni
Vedere è sapere immagini e suggestioni dal nanomondo
 Vedere è sapere immagini e suggestioni dal nanomondo Andrea Donarini Istituto di Fisica Teorica, Università di Ratisbona, Germania 7 nm Quanto è grande un nanometro? Molecola d acqua DNA Anticorpo Virus
Vedere è sapere immagini e suggestioni dal nanomondo Andrea Donarini Istituto di Fisica Teorica, Università di Ratisbona, Germania 7 nm Quanto è grande un nanometro? Molecola d acqua DNA Anticorpo Virus
6. Le distribuzioni di probabilità in meccanica quantistica
 6. Le distribuzioni di probabilità in meccanica quantistica I nodi concettuali La meccanica quantistica prevede la probabilità con cui si manifestano i fenomeni. L obiettivo della teoria non è quello di
6. Le distribuzioni di probabilità in meccanica quantistica I nodi concettuali La meccanica quantistica prevede la probabilità con cui si manifestano i fenomeni. L obiettivo della teoria non è quello di
INDICE 1. LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA
 INDICE 1. LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 1.1 Modelli atomici... 1 1.2 Il problema delle dimensioni atomiche e del collasso per irraggiamento 4 1.3 Difficoltà connesse con i calori specifici... 7 1.4 L
INDICE 1. LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 1.1 Modelli atomici... 1 1.2 Il problema delle dimensioni atomiche e del collasso per irraggiamento 4 1.3 Difficoltà connesse con i calori specifici... 7 1.4 L
Quanti erano e quanti sono l ABC e un po di D della Meccanica Quantistica
 Quanti erano e quanti sono l ABC e un po di D della Meccanica Quantistica Seconda e ultima parte La Torre del Sole, Brembate di Sopra (BG) - 4 Aprile 2019 Andrea Castelli, Ph.D. LOfficina del Planetario
Quanti erano e quanti sono l ABC e un po di D della Meccanica Quantistica Seconda e ultima parte La Torre del Sole, Brembate di Sopra (BG) - 4 Aprile 2019 Andrea Castelli, Ph.D. LOfficina del Planetario
La Fisica della materia
 La Fisica della materia La materia è fatta di atomi. Non si possono spiegare le proprietà della materia senza spiegare come sono fatti gli atomi e come funzionano le interazioni tra atomi. Le scale di
La Fisica della materia La materia è fatta di atomi. Non si possono spiegare le proprietà della materia senza spiegare come sono fatti gli atomi e come funzionano le interazioni tra atomi. Le scale di
La nascita della fisica moderna. (un racconto di inizio 900)
 La nascita della fisica moderna (un racconto di inizio 900) Sviluppo storico della fisica tra fine 800 e il 1927 Fisica sperimentale fine 800 Fisica teorica fine 800 1900 1905 1911 1913 1916 1924 1925-1927
La nascita della fisica moderna (un racconto di inizio 900) Sviluppo storico della fisica tra fine 800 e il 1927 Fisica sperimentale fine 800 Fisica teorica fine 800 1900 1905 1911 1913 1916 1924 1925-1927
I principi della termodinamica:
 Termodinamica Livelli energetici atomici Laser cooling: principi Evaporative cooling: principi p Applicazioni: Test dei fondamenti della meccanica quantistica Misure di precisione Creazione di stati esotici
Termodinamica Livelli energetici atomici Laser cooling: principi Evaporative cooling: principi p Applicazioni: Test dei fondamenti della meccanica quantistica Misure di precisione Creazione di stati esotici
Magnete. Campo magnetico. Fenomeni magnetici. Esempio. Esempio. Che cos è un magnete? FENOMENI MAGNETICI
 Magnete FENOMENI MAGNETICI Che cos è un magnete? Un magnete è un materiale in grado di attrarre pezzi di ferro Prof. Crosetto Silvio 2 Prof. Crosetto Silvio Quando si avvicina ad un pezzo di magnetite
Magnete FENOMENI MAGNETICI Che cos è un magnete? Un magnete è un materiale in grado di attrarre pezzi di ferro Prof. Crosetto Silvio 2 Prof. Crosetto Silvio Quando si avvicina ad un pezzo di magnetite
Laurea Magistrale di INGEGNERIA ELETTRONICA (LM-29) a.a , I semestre! Programma del corso di FISICA SUPERIORE! Docente: MAURO PAPINUTTO!
 Laurea Magistrale di INGEGNERIA ELETTRONICA (LM-29) a.a. 2013-14, I semestre Programma del corso di FISICA SUPERIORE Docente: MAURO PAPINUTTO Dipartimento di Fisica Phone: +39 06 4991 4376 Universita`
Laurea Magistrale di INGEGNERIA ELETTRONICA (LM-29) a.a. 2013-14, I semestre Programma del corso di FISICA SUPERIORE Docente: MAURO PAPINUTTO Dipartimento di Fisica Phone: +39 06 4991 4376 Universita`
IL PROGRAMMA DELLA SISSA
 SISSA PER LA SCUOLA IL PROGRAMMA DELLA SISSA venerdì 25 09:00 Laboratorio L alfabeto degli odori Che cosa è un odore? Siamo in grado di distinguere una pera da una banana usando solamente il nostro naso?
SISSA PER LA SCUOLA IL PROGRAMMA DELLA SISSA venerdì 25 09:00 Laboratorio L alfabeto degli odori Che cosa è un odore? Siamo in grado di distinguere una pera da una banana usando solamente il nostro naso?
Si intende la risposta di un materiale all esposizione alle radiazioni elettromagnetiche ed in particolare alla luce visibile.
 PROPRIETA OTTICHE DEI MATERIALI Si intende la risposta di un materiale all esposizione alle radiazioni elettromagnetiche ed in particolare alla luce visibile. Tratteremo inizialmente i concetti ed i principi
PROPRIETA OTTICHE DEI MATERIALI Si intende la risposta di un materiale all esposizione alle radiazioni elettromagnetiche ed in particolare alla luce visibile. Tratteremo inizialmente i concetti ed i principi
1 IL LINGUAGGIO MATEMATICO
 1 IL LINGUAGGIO MATEMATICO Il linguaggio matematico moderno è basato su due concetti fondamentali: la teoria degli insiemi e la logica delle proposizioni. La teoria degli insiemi ci assicura che gli oggetti
1 IL LINGUAGGIO MATEMATICO Il linguaggio matematico moderno è basato su due concetti fondamentali: la teoria degli insiemi e la logica delle proposizioni. La teoria degli insiemi ci assicura che gli oggetti
