La tecnica dell insetto sterile per il controllo integrato di insetti nocivi: evoluzione e prospettive
|
|
|
- Gilda Sartori
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 FOCUS_ La tecnica dell insetto sterile per il controllo integrato di insetti nocivi: evoluzione e prospettive Le nuove biotecnologie promettono di riproporre e di rilanciare la tecnica dell insetto sterile attraverso innovazioni in grado di rendere il processo più efficace e sostenibile DOI /EAI di Maurizio Calvitti e Riccardo Moretti, ENEA A causa della loro versatilità bio-ecologica gli insetti esercitano un notevole impatto economico, sanitario e sociale, condizionando le produzioni agroalimentari e mettendo a rischio la salute umana. Numerose strategie di verifica sono state sviluppate e sperimentate per il loro controllo e tra esse la tecnica dell insetto sterile è senz altro premiata da un altissimo livello di specificità ed ecocompatibilità. Rispetto alle attese teoriche, l applicazione di questo approccio di controllo ha però avuto risultati soddisfacenti solo in alcuni casi specifici. Le nuove biotecnologie promettono di rilanciare questa strategia attraverso innovazioni in grado di renderla più efficace e sostenibile. In particolare, il batterio endosimbionte Wolbachia può essere sfruttato per lo sviluppo di linee di insetti in grado di produrre naturalmente maschi sterili da rilasciare in campo per abbattere la fertilità delle popolazioni selvatiche di insetti dannosi o vettori di patogeni per uomo e animali. In un contesto di sempre maggiore consapevolezza del delicato equilibrio alla base dell ecosistema e della limitatezza di molte di quelle che sono le sue risorse, l uomo si trova necessariamente a confrontarsi con una serie di organismi competitori in grado, nel complesso, di mettere a repentaglio da una parte la produzione di cibo, dall altra la stessa salute umana. Gli insetti, in particolare, hanno enorme impatto sull attività umana, sia in quanto diretti consumatori delle risorse, sia perché vettori di microrganismi patogeni per piante, animali, uomo. Molte specie d insetti, un tempo relegate alle aree tropicali e subtropicali, hanno oggi iniziato a invadere le aree temperate in risposta sia ai cambiamenti climatici che ad un commercio fortemente globalizzato e non sottoposto ad adeguati controlli di frontiera. In considerazione di tutti gli effetti collaterali associati all uso di pesticidi e all acquisizione di resistenza evidenziata da molte specie d inset- 14 Energia, ambiente e innovazione 3/2016
2 ti a principi attivi efficaci solo fino a pochi anni fa, la lotta chimica sembra essere destinata nel futuro a perdere quel ruolo di componente essenziale e irrinunciabile delle strategie di lotta a fitofagi e vettori. Le crescenti restrizioni all uso di varie molecole di sintesi, dimostratesi altamente pericolose per l ambiente e per gli organismi non target (gli impollinatori in primo luogo), stanno facendo crescere l interesse per strategie innovative di difesa delle produzioni agroalimentari e della salute umana, basate su principi di sostenibilità economica ed ambientale. L alta specificità d azione accomuna due principali filoni di strategie di lotta agli insetti nocivi. Il primo è quello che vede come obiettivo primario la bio-fortificazione delle piante coltivate (miglioramento genetico e biotecnologie di nuova generazione per l acquisizione di resistenze) e di uomo e animali (vaccini). Altra strada è quella che mira a sviluppare metodologie in grado di contrastare direttamente gli insetti, sfruttando antagonisti naturali (predatori, parassitoidi, microorganismi entomopatogeni), molecole attrattive o repellenti, o applicando metodologie che ne inibiscano l elevata prolificità riproduttiva, una delle chiavi del successo invasivo di molte specie. Queste strategie, vaccini e varietà resistenti in particolare, hanno permesso di far fronte a diversi aspetti emergenziali di natura entomologica sia in ambito sanitario che agroalimentare, ma non sempre sono risultate attuabili. Per molti virus trasmessi all uomo da insetti, non è stato ad esempio ancora possibile sviluppare vaccini (vedi Dengue, Zika, Chikungunya), così come non esistono varietà colturali di piante resistenti all attacco di alcuni importanti virus trasmessi da insetti fitomizi. In questi casi non resta che un unica via da percorrere: potenziare la ricerca per sviluppare metodi e nuove tecnologie di controllo degli insetti vettori dei patogeni. In questo lavoro parleremo delle tecniche di lotta agli insetti dannosi definite autocide, della loro evoluzione e delle prospettive applicative future. La tecnica di lotta col maschio sterile (SIT) Si parla di metodo autocida di lotta quando il controllo numerico di una popolazione avviene attraverso l azione di esemplari conspecifici portatori di fattori di sterilità che si esprimono in fase post copula. Di base, la strategia è altamente specifica ed ecocompatibile, perché lo stru- 3/2016 Energia, ambiente e innovazione 15
3 mento di lotta è lo stesso insetto che si vuole combattere, e, idealmente, è volta a ridurre fortemente la capacità riproduttiva di specie d insetti dannose fino a livelli tali da causare un collasso nella popolazione. La forma di controllo autocida più nota ed utilizzata è la tecnica di lotta con l Insetto Sterile (SIT) [1]. Generalmente i fattori di sterilità sono l espressione di alterazioni cromosomiche (aberrazioni, traslocazioni) indotte sottoponendo gli insetti a radiazioni ionizzanti o, più raramente, ad agenti chimici che generalmente agiscono direttamente sulle gonadi. La SIT si basa su una filiera di operazioni che vanno dall allevamento intensivo della specie target alla sua sterilizzazione, alla separazione dei sessi e infine al lancio ripetuto degli insetti sterilizzati (possibilmente solo maschi) in campo. L obiettivo è quello di indurre un alta frequenza di accoppiamenti infecondi tra le femmine selvatiche e i maschi sterili al fine di ridurre progressivamente la capacità riproduttiva della popolazione naturale dannosa. È evidente come tale metodologia di lotta sia altamente selettiva e possa essere utilizzata da sola o in combinazione con altre tecniche di controllo nell ambito dell Integrated Pest Management (IPM), al fine di eradicare, sopprimere o controllare la popolazione del parassita in ambienti confinati o su ampi territori regionali. A livello mondiale, la tecnica dell insetto sterile è stata sviluppata e utilizzata con successo per il controllo di diverse specie di insetti, a partire dal caso esemplare di Cochliomyia hominivorax (mosca del bestiame). L uso è stato poi esteso a varie altre specie di interesse agronomico tra le quali, Anastrepha suspensa, Ceratitis capitata, Dacus cucurbitae, Bactrocera dorsalis, Laspeyresia pomonella. Negli anni 70, sotto la direzione del Prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, fu stabilita una collaborazione tra ENEA (allora CNEN) e la Joint Division FAO-IAEA per avviare una sperimentazione della SIT per il controllo della mosca mediterranea della frutta C. capitata nell isola di Procida. Il progetto portò alla realizzazione, presso il Centro Ricerche ENEA della Casaccia, del più grande e innovativo insettario d Europa per l allevamento della specie, dove si producevano fino a quattordici milioni di insetti sterili la settimana. I risultati di quell esperienza furono estremamente positivi e in seguito interessarono anche piccole aree della terraferma, dislocate in diverse regioni italiane (Calabria, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia). Tuttavia, dopo una preliminare fase di studi ecologici effettuati su ampi territori frutticoli di diverse regioni, l iniziativa conobbe una fase di declino venendo a mancare il necessario supporto per la realizzazione di impianti che in qualche modo industrializzassero il processo. Certamente, l estrema polverizzazione delle proprietà agricole e l errata convinzione che questo metodo di lotta potesse costituire una risposta adeguata solo dove fosse possibile ottenere l eradicazione completa degli insetti dannosi, determinarono il progressivo abbandono dell approccio, in una realtà poco incline a veder realizzati progetti area-wide di grande condivisione territoriale. A partire dagli anni 80, il mainstream della ricerca entomologica agraria europea si orientò principalmente verso la Lotta Biologica con la realizzazione di diverse biofabbriche per la produzione di insetti utili. La SIT venne marginalizzata ad approccio specifico solo per situazioni particolari. A essere critici, possiamo oggi dire che quel progetto ambizioso di SIT, una volta calato nel provincialismo italiano, per di più in un contesto legislativo ancora troppo permissivo per l uso degli insetticidi, non risultò forse avere tutte le caratteristiche richieste per essere definito realmente sostenibile e competitivo e tale da prevederne una crescente diffusione. Dobbiamo altresì constatare che anche molti progetti di lotta biologica non hanno portato ai risultati auspicati (si pensi all uso dei parassitoidi contro i ditteri tefritidi) in riferimento anche agli investimenti dedicati. Con questa premessa, riconsiderare il SIT e fare ricerca per renderlo più sostenibile è stato uno degli obiettivi della ricerca entomologica di ENEA, a cominciare dall ottimizzazione dei metodi utilizzati per produrre la sterilità. Criticità della SIT tradizionale La storia della SIT si accompagna allo sviluppo e alla promozione di dispositivi di irraggiamento, in particolare di raggi gamma, sempre più sofisticati e maneggevoli. Ancora oggi, come dimostrato dai molteplici progetti e dalle relative infrastrutture dedicate,, tale metodo di sterilizzazione rappresenta la soluzione più adottata nel mondo e la prima scelta per ottenere grandi numeri di maschi sterilizzati da introdurre in campo. Tuttavia alcuni aspetti critici della strategia non possono essere più sottovalutati se mettiamo al centro di una nuova tecnologia di lotta non solo la sua efficienza ma la sua coerenza con i principi della sostenibilità, gli unici che possono garantire successo e diffusione su larga scala. 16 Energia, ambiente e innovazione 3/2016
4 FOCUS_ In primo luogo, l applicazione del SIT convenzionale richiede il rispetto di un quadro normativo specifico per l allocazione e gestione delle sorgenti radioattive di 60 Co o 137 Cesio o delle infrastrutture necessarie all utilizzo di altre possibili strategie di irraggiamento (raggi x, elettroni, neutroni ecc.). Il trasporto degli insetti da irraggiare verso le suddette strutture e poi irraggiati verso le aree di rilascio richiede inoltre un livello di organizzazione elevato ed il supporto di una rete di trasporto non comune ad esempio a molti dei paesi del terzo mondo. Questi aspetti necessariamente limitano l autonomia periferica e la penetrazione capillare di tale forma di lotta, diversamente da quanto potrebbe avvenire utilizzando la lotta biologica o altre strategie di controllo che possano far a meno delle suddette strutture. Non meno importante è il fatto che i ripetuti cicli di allevamento in laboratorio e, soprattutto, la radiosterilizzazione degli insetti spesso inducono effetti che riducono in modo evidente la fitness dei maschi sterili, che divengono quindi meno efficienti rispetto ai selvatici in quanto a competitività sessuale. In tali casi, diviene quindi necessario massimizzare le quantità di individui rilasciati in campo determinando costi di produzione spesso non più sostenibili rispetto alle aspettative teoriche. Per di più, nel caso di specie di zanzare appartenenti al genere Aedes, vettrici di virus come quelli di Dengue e Zika, ottenere la completa sterilizzazione dei maschi è possibile solo al costo di ridurne significativamente la fitness riproduttiva. In alternativa, bisognerebbe accettare di sottoporre gli insetti a dosi di irraggiamento che trovino un compromesso accettabile tra effetti sulla fitness e mantenimento di piccole percentuali di fertilità. Questa finestra utile non è ovviamente disponibile per tutte le specie e la sub-sterilità potrebbe comunque consentire ad alcuni degli individui mutanti di riprodursi, con effetti difficili da prevedere nel lungo termine. Un terzo aspetto chiave nel determinare l efficienza dei programmi SIT è la disponibilità di sistemi avanzati ed efficienti di separazione dei sessi. La presenza di femmine insieme ai 3/2016 Energia, ambiente e innovazione 17
5 FOCUS_ Fig 1 Una strategia di lotta alla zanzara tigre basata sul rilascio di maschi resi sterili da Wolbachia maschi sterili da rilasciare può, infatti, ridurre l efficacia del programma di controllo e, nel caso di insetti ematofagi come le zanzare, può aumentare il numero di femmine in grado di pungere e/o trasmettere patogeni. Questi fattori limitanti sono spesso risultati critici nel determinare le possibilità di successo di un programma basato sul SIT. C è inoltre da considerare che la strategia è applicabile solamente alle specie d insetti che abbiano questi requisiti: possibilità di essere allevate in condizioni artificiali e per più cicli annuali in modo massale (e possibilmente automatizzato) e a basso costo; riproduzione sessuale (che non contempli cioè partenogenesi); stadio adulto riproduttore (il maschio in particolare) che non abbia alcun ruolo dannoso; limitata tendenza alla dispersione e distribuzione spaziale che tenda ad essere localizzata. Nuove biotecnologie per un SIT più sostenibile Alcune delle criticità della tecnica dell insetto sterile basata su irraggiamento sono state affrontate da varie altre strategie alternative e comunque volte alla produzione di maschi sterili. Obiettivi perseguiti singolarmente o nel complesso da queste strategie sono: il miglioramento dell efficienza dell allevamento, in termini di maschi sterili prodotti per uova di partenza; la messa a punto di metodi ideali e pratici per la separazione dei sessi; la ricerca di metodi di sterilizzazione a basso o nullo impatto sulla fitness dei maschi (sopravvivenza e competitività sessuale). A livello generale, le piattaforme omiche e la caratterizzazione del microbioma associato agli insetti stanno fornendo nuovi strumenti per una caratterizzazione a livello molecolare di molti processi biolo- 18 Energia, ambiente e innovazione 3/2016
6 gici fino ad ora di difficile investigazione. Questa rivoluzione strumentale e metodologica ha consentito di descrivere e comprendere nei minimi termini alcuni fenomeni che possono essere sfruttati per progettare strategie di controllo innovative e altamente specifiche. Modificazione genetica L individuazione e la caratterizzazione di diversi geni associati alla determinazione del sesso stanno consentendo di progettare nuovi metodi per la separazione dei maschi basati sull utilizzo di marcatori precoci della sessualità (ad esempio il colore dei pupari in alcuni ditteri teritidi o la fluorescenza in alcune specie di zanzara), geni che conferiscano sensibilità differenziale a shock termici o a insetticidi specifici. L individuazione di mutazioni ad effetto letale dominante è stata invece già utilizzata per la produzione di ceppi di zanzare in grado di trasmettere alla progenie geni letali e disattivabili solo tramite somministrazione dell appropriato antidoto, cioè uno specifico reagente chimico. Questa peculiarità permette l allevamento massivo di questi ceppi consentendo poi il rilascio in campo di individui maschi in grado di trasmettere questi fattori di mortalità alle femmine selvatiche fecondate (RIDL = Release of Insects carrying a Dominant Lethal). L applicazione e la diffusione di strategie basate sulle modificazioni genetiche fin qui descritte sono ovviamente subordinate a contesti etici e legislativi specifici che tuttora ne limitano l uso solo in alcuni paesi. Le nuove frontiere del genome editing promettono di consentire livelli di specificità estrema nella modificazione genetica, eliminando inoltre la necessità di ricorrere a geni ottenuti da altri organismi e, almeno in teoria, riducendo notevolmente il rischio di effetti collaterali (out of target) associati alla modificazione stessa. Sono ad esempio già state testate in laboratorio su Anopheles gambiae (la zanzara vettrice della malaria) alcune modificazioni ottenute tramite genome editing, in grado di indurre sterilità femminile o incapacità di trasmettere la malaria stessa. Lo sfruttamento dei simbionti naturali: Wolbachia ed il caso Aedes albopictus Varie specie di batteri sono note per le loro proprietà di influenzare in modo significativo la biologia riproduttiva e/o il funzionamento del sistema immunitario degli insetti di cui sono simbionti. Per il batterio Wolbachia sono già noti vari rilevanti esempi di applicazione pratica in campo per sfruttare i fenomeni di sterilità (incompatibilità citoplasmatica) o di inibizione della capacità vettoriale di virus patogeni, indotti dalla sua presenza [2]. Questo batterio, trasmesso verticalmente attraverso le uova, ha mostrato di poter anche essere trasferito artificialmente da specie a specie, consentendo spesso di preservare, nel nuovo ospite, gli effetti osservati nella specie originaria. L ENEA ha iniziato ad occuparsi di Wolbachia a metà anni 2000, coinvolta in un programma nazionale di lotta ad Aedes albopictus (zanzara tigre) col maschio sterile in collaborazione con il Centro Agricoltura Ambiente (CAA) di Crevalcore (Bologna). Tale progetto nacque per sviluppare un metodo di lotta innovativo che, mirando a inibire la riproduzione degli adulti, fosse integrabile con i protocolli di trattamento larvicida. Sappiamo che questa zanzara si insedia in modo discontinuo in aree urbane e periurbane dove, per la ovideposizione, sfrutta piccole raccolte di acqua non sempre facilmente raggiungibili dai trattamenti larvicidi. L aspetto più rilevante, in chiave SIT, è che gli adulti di questa specie si spostano, attivamente, solo per poche centinaia di metri. Con tali presupposti, gli approcci SIT che conosciamo, pensati per essere applicati uniformemente su vaste aree (area wide SIT), risultano poco appropriati per la zanzara tigre, in quanto il rilascio dei maschi sterili dovrebbe essere mirato e limitato ad aree riconosciute come potenziali siti riproduttivi, richiedendo un alto livello di coinvolgimento della cittadinanza per la gestione delle aree residenziali e private. La zanzara tigre, come circa il 40-60% di tutti gli insetti, è naturalmente infettata da Wolbachia. Trattando una linea di zanzara locale (R = Roma) con un antibiotico specifico è stata ottenuta una popolazione aposimbiotica, cioè priva del batterio (AR). Su centinaia di embrioni di questa linea, in modo analogo a quanto si fa per una fecondazione artificiale, è stata operata una microiniezione di ooplasma prelevato dalle uova della zanzara comune, Culex pipiens, ed infettato da un altro ceppo di Wolbachia, il ceppo wpip. Le poche uova sopravvissute a questo trattamento sono state fatte schiudere per allevarne le larve fino allo stadio adulto. Dopo la produzione di progenie (nuove uova), sono state selezionate le linee sviluppatesi da femmine risultate positive a saggi diagnostici (PCR) per la presenza del ceppo di Wolbachia wpip, portando alla produzione di una nuova linea di zanzara tigre (ARwP) [3]. Questa linea, pur senza nessuna modificazione genetica e pur ospitando un batterio comunemente diffuso in natura, presenta delle caratteristiche, dal punto di vista applicativo, eccezionali [4]. I maschi, perfettamente fertili rispetto alle femmine ARwP, inducono invece completa sterilità nelle uova prodotte da accoppiamenti con femmine selvatiche di zanzara tigre (Figura 1). In confronti 1:1 con i maschi selvatici, i maschi ARwP hanno evi- 3/2016 Energia, ambiente e innovazione 19
7 denziato la capacità di ridurre di più del 50% la fertilità attesa delle femmine selvatiche, sia confrontandosi con genotipi italiani che con genotipi tropicali [5][6]; si sviluppano inoltre più velocemente rispetto ai maschi selvatici e consentono una più efficiente separazione sessuale tramite mezzi meccanici (99,78% di purezza). I maschi ARwP appaiono quindi dei candidati ottimali per rinnovare e rilanciare la tecnica dell insetto sterile contro la zanzara tigre, ovviando a molte delle criticità associate alle tecniche di sterilizzazione basate su irraggiamento e rendendo più flessibile e penetrabile sul territorio il processo di rilascio di maschi sterili o di fattori di sterilità. L utilizzo di Wolbachia non subisce inoltre le restrizioni a cui sono assoggettati gli organismi modificati geneticamente. Sono comunque in corso esperimenti di verifica supportati da specifici modelli di dinamica di popolazione, atti a valutare una serie di criteri di sicurezza per consentire la messa a punto di nuove strategie applicative di ARwP ottimizzate e sostenibili nelle realtà urbane e periurbane sia di paesi come il nostro che di quelli in via di sviluppo. Conclusioni L esplorazione del ruolo funzionale dei batteri endosimbionti di insetti e delle potenzialità applicative che ne scaturiscono sta rappresentando una diramazione importante lungo il percorso di sviluppo delle biotecnologie entomologiche, che, ai fini di sviluppare strategie di controllo degli insetti nocivi, avevano finora puntato preferenzialmente sulle tecniche del DNA ricombinante. Questo campo d indagine ed applicazione sta acquisendo sempre maggiore rilevanza, tanto da rappresentare oggi una soluzione di eccellenza nel quadro di iniziative attive su campo. Un esempio emblematico è rappresentato dal progetto di lotta alla Dengue 1, malattia infettiva pandemica nelle zone tropicali e subtropicali causata da un virus trasmesso da insetti vettori, che sfrutta l effetto inibitorio di Wolbachia nei confronti del virus per promuoverne l eradicazione. Pur se attualmente gli esempi applicativi più importanti riguardano il mondo dei vettori, in prospettiva la stessa biotecnologia potrà essere utilizzata per combattere anche molte specie di insetti dannosi in agricoltura, grazie alla crescente conoscenza dell associazione simbiotica e ad una sapiente gestione di rapporti insetto-batterio naturali o artificialmente indotti. La simbiosi tra batteri e insetti può essere considerata a tutti gli effetti una risorsa naturale, ancora in gran parte da esplorare, che può essere opportunamente sfruttata per creare strategie di lotta sempre più efficaci e con costi di sviluppo ed applicazioni sempre più sostenibili. Per saperne di più: maurizio.calvitti@enea.it 20 Energia, ambiente e innovazione 3/2016
8 FOCUS_ 1 BIBLIOGRAFIA 1. Alphey L, Benedict M, Bellini R, Clark GG, Dame DA, Service MW, et al. (2010). Sterile-insect methods for control of mosquito-borne diseases: an analysis. Vector Borne Zoonotic Diseases,10: doi: /vbz Bourtzis K, Dobson SL, Xi Z, Rasgon JL, Calvitti M, Moreira LA, et al. (2014). Harnessing mosquito-wolbachia symbiosis for vector and disease control. Acta Tropica,132 Suppl: S doi: /j.actatropica Calvitti M, Moretti R, Lampazzi E, Bellini R, Dobson SL. (2010). Characterization of a new Aedes albopictus (Diptera: Culicidae)- Wolbachia pipientis (Rickettsiales: Rickettsiaceae) symbiotic association generated by artificial transfer of the wpip strain from Culex pipiens (Diptera: Culicidae). Journal of Medical Entomology, 47: doi:doi /Me Calvitti M, Moretti R, Skidmore AR, Dobson SL. (2012). Wolbachia strain wpip yields a pattern of cytoplasmic incompatibility enhancing a Wolbachia-based suppression strategy against the disease vector Aedes albopictus. Parasit Vectors. Parasites & Vectors, 5: 254. doi: / Moretti R, Calvitti M. (2013). Male mating performance and cytoplasmic incompatibility in a wpip Wolbachia trans-infected line of Aedes albopictus (Stegomyia albopicta). Medical and Veterinary Entomology, 27: doi: /j x 6. Atyame CM, Labbé P, Lebon C, Weill M, Moretti R, Marini F, et al. (2016). Comparison of irradiation and Wolbachia based approaches for sterile-male strategies targeting Aedes albopictus. PLoS One, 11: e doi: /journal.pone /2016 Energia, ambiente e innovazione 21
62024 Matelica Via Circonvallazione, 93/95 Tel Fax
 Scuola di Scienze Mediche Veterinarie 62024 Matelica Via Circonvallazione, 93/95 Tel. 0737.404001 Fax 0737.404002 vincenzo.cuteri@unicam.it www.cuteri.eu Matelica, 8 febbraio 2012 VALUTAZIONE DELL ATTIVITÀ
Scuola di Scienze Mediche Veterinarie 62024 Matelica Via Circonvallazione, 93/95 Tel. 0737.404001 Fax 0737.404002 vincenzo.cuteri@unicam.it www.cuteri.eu Matelica, 8 febbraio 2012 VALUTAZIONE DELL ATTIVITÀ
I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria
 I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni MinisterodellaSalute Dipartimento della sanità
I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni MinisterodellaSalute Dipartimento della sanità
DIPARTIMENTO DELL INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA UFFICIO IV DELL EX MINISTERO DELLA SALUTE ***
 DIPARTIMENTO DELL INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA UFFICIO IV DELL EX MINISTERO DELLA SALUTE *** LE BIOTECNOLOGIE CHE COSA SONO LE BIOTECNOLOGIE? Le biotecnologie
DIPARTIMENTO DELL INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA UFFICIO IV DELL EX MINISTERO DELLA SALUTE *** LE BIOTECNOLOGIE CHE COSA SONO LE BIOTECNOLOGIE? Le biotecnologie
Impostazione di un monitoraggio
 Impostazione di un monitoraggio I monitoraggi ambientali devono essere impostati partendo da due considerazioni: 1. Qual èla specie che vogliamo monitorare 2. Qual èlo scopo del nostro monitoraggio Impostazione
Impostazione di un monitoraggio I monitoraggi ambientali devono essere impostati partendo da due considerazioni: 1. Qual èla specie che vogliamo monitorare 2. Qual èlo scopo del nostro monitoraggio Impostazione
MAURIZIO CALVITTI* La lotta biologica
 Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL Memorie di Scienze Fisiche e Naturali 133 (2015), Vol. XXXIX, Parte II, Tomo I, pp. 195-201 MAURIZIO CALVITTI* La lotta biologica Summary This
Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL Memorie di Scienze Fisiche e Naturali 133 (2015), Vol. XXXIX, Parte II, Tomo I, pp. 195-201 MAURIZIO CALVITTI* La lotta biologica Summary This
La prescrizione degli agrofarmaci nell applicazione della direttiva sull uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
 La prescrizione degli agrofarmaci nell applicazione della direttiva sull uso sostenibile dei prodotti fitosanitari Roma, 12 maggio 2010 Enrico Antignati Consigliere C.O.N.A.F. (Coordinatore Dipartimento
La prescrizione degli agrofarmaci nell applicazione della direttiva sull uso sostenibile dei prodotti fitosanitari Roma, 12 maggio 2010 Enrico Antignati Consigliere C.O.N.A.F. (Coordinatore Dipartimento
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE DELL IA CON SEME FRESCO
 Valorizzare l allevamento e i prodotti della razza NERA DI VERZASCA negli ecosistemi montani CORSO DI FORMAZIONE PER ALLEVATORI E TECNICI DEL SETTORE CAPRINO 16 Gennaio 2012 Ristorante Lago dei Salici
Valorizzare l allevamento e i prodotti della razza NERA DI VERZASCA negli ecosistemi montani CORSO DI FORMAZIONE PER ALLEVATORI E TECNICI DEL SETTORE CAPRINO 16 Gennaio 2012 Ristorante Lago dei Salici
Stato di avanzamento della ricerca Studio sulle scelte sessuali femminili in Testudo hermanni hermanni
 Stato di avanzamento della ricerca Studio sulle scelte sessuali femminili in Testudo hermanni hermanni Giulia Cutuli e Sara Fratini Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Leo Pardi, Università di Firenze
Stato di avanzamento della ricerca Studio sulle scelte sessuali femminili in Testudo hermanni hermanni Giulia Cutuli e Sara Fratini Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Leo Pardi, Università di Firenze
IL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO DELL ASSAM A SUPPORTO DELLE SCELTE AZIENDALI
 IL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO DELL ASSAM A SUPPORTO DELLE SCELTE AZIENDALI SEMINARIO: RISCHIO MICOTOSSINE NELLA FILIERA CEREALICOLA MARCHIGIANA Osimo (AN) 12 aprile 2013 Dott. Agr.. Angela Sanchioni Centro
IL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO DELL ASSAM A SUPPORTO DELLE SCELTE AZIENDALI SEMINARIO: RISCHIO MICOTOSSINE NELLA FILIERA CEREALICOLA MARCHIGIANA Osimo (AN) 12 aprile 2013 Dott. Agr.. Angela Sanchioni Centro
QUADRO INTERNAZIONALE
 66 FOCUS QUADRO INTERNAZIONALE PUNTO E CONTROPUNTO Controllo integrato a Pollinators for FAO e Fondazione 32 Canino agricultural productivity 78 Edmund Mach Energia ambiente N 3/2016 wwweneait ISSN: 1124-0016
66 FOCUS QUADRO INTERNAZIONALE PUNTO E CONTROPUNTO Controllo integrato a Pollinators for FAO e Fondazione 32 Canino agricultural productivity 78 Edmund Mach Energia ambiente N 3/2016 wwweneait ISSN: 1124-0016
Il regolamento europeo prevede alcune regole principali per la coltivazione dei prodotti biologici:
 La normativa [ ] L A NORMAT I VA L N LA LEGGE CHE REGOLA IL SETTORE Il diffondersi dell agricoltura biologica e l incremento dei consumi di prodotti biologici ha fatto sì che anche le Istituzioni europee
La normativa [ ] L A NORMAT I VA L N LA LEGGE CHE REGOLA IL SETTORE Il diffondersi dell agricoltura biologica e l incremento dei consumi di prodotti biologici ha fatto sì che anche le Istituzioni europee
La coppia e l infertilità per cause genetiche
 La compromissione su base genetica della funzionalità riproduttiva, per la presenza di anomalie cromosomiche o geniche, si manifesta con quadri clinici che vanno dalla sterilità all'infertilità. I fattori
La compromissione su base genetica della funzionalità riproduttiva, per la presenza di anomalie cromosomiche o geniche, si manifesta con quadri clinici che vanno dalla sterilità all'infertilità. I fattori
INNOVĀRĒ. Centro di Competenza per un territorio migliore
 INNOVĀRĒ Centro di Competenza per un territorio migliore Formazione CRESCITA Impresa Mercato Il territorio è importante per un impresa come la terra è importante per una pianta. L humus che fa crescere
INNOVĀRĒ Centro di Competenza per un territorio migliore Formazione CRESCITA Impresa Mercato Il territorio è importante per un impresa come la terra è importante per una pianta. L humus che fa crescere
C 159/10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
 IT C 159/10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1.6.2001 RETTIFICHE Rettifica dell invito a presentare per azioni di RST nell ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
IT C 159/10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1.6.2001 RETTIFICHE Rettifica dell invito a presentare per azioni di RST nell ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
ferdinando boero Università di Lecce
 ferdinando boero Università di Lecce La diversità Il mondo è abitato da molti organismi evidentemente diversi tra loro L identificazione della diversità è presente sin dall inizio della cultura umana In
ferdinando boero Università di Lecce La diversità Il mondo è abitato da molti organismi evidentemente diversi tra loro L identificazione della diversità è presente sin dall inizio della cultura umana In
Il contesto PROGETTO AALBORG 10 PRESUD CARTA DELLA TERRA
 Venezia, 14.11.2014 L Accordo Comune di Venezia-MATTM per lo sviluppo di interventi di efficienza energetica e l utilizzo di fonti di energia rinnovabile: un opportunità di sviluppo per Venezia Il contesto
Venezia, 14.11.2014 L Accordo Comune di Venezia-MATTM per lo sviluppo di interventi di efficienza energetica e l utilizzo di fonti di energia rinnovabile: un opportunità di sviluppo per Venezia Il contesto
Sistema di previsione e avvertimento alle avversità
 Data, 03 agosto 2016 U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A Sistema di previsione e avvertimento alle avversità Agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso si molte sono state le prove
Data, 03 agosto 2016 U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A Sistema di previsione e avvertimento alle avversità Agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso si molte sono state le prove
REGIONE BASILICATA - ALSIA UFFICIO FITOSANITARIO NOVITA FITOIATRICHE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE BASILICATA: LE NOVITA
 REGIONE BASILICATA - ALSIA UFFICIO FITOSANITARIO NOVITA FITOIATRICHE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE BASILICATA: LE NOVITA Ermanno Pennacchio Vitantonio Fornarelli L agricoltura si
REGIONE BASILICATA - ALSIA UFFICIO FITOSANITARIO NOVITA FITOIATRICHE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE BASILICATA: LE NOVITA Ermanno Pennacchio Vitantonio Fornarelli L agricoltura si
Diffusione e infestazioni della Mosca della frutta in Italia
 PROCEDURA DI COLD TREATMENT per esportazione verso USA Diffusione e infestazioni della Mosca della frutta in Italia CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ISPETTORI FITOSANITARI Ravenna, 26-27 ottobre 2011 Diffusione
PROCEDURA DI COLD TREATMENT per esportazione verso USA Diffusione e infestazioni della Mosca della frutta in Italia CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ISPETTORI FITOSANITARI Ravenna, 26-27 ottobre 2011 Diffusione
Criticità e pratiche colturali sostenibili nella difesa in frutticoltura. Graziano Vittone, 19 settembre 2015
 Criticità e pratiche colturali sostenibili nella difesa in frutticoltura Graziano Vittone, 19 settembre 2015 APICOLTURA non come ostacolo alla FRUTTICOLTURA ma come UTILITA MELO PERO Ruolo fondamentale
Criticità e pratiche colturali sostenibili nella difesa in frutticoltura Graziano Vittone, 19 settembre 2015 APICOLTURA non come ostacolo alla FRUTTICOLTURA ma come UTILITA MELO PERO Ruolo fondamentale
Micorrize e microrganismi: strumenti utili per la salvaguardia degli ecosistemi
 Micorrize e microrganismi: strumenti utili per la salvaguardia degli ecosistemi 1 di 13 Il punto di vista: La tutela dell ambiente ed in particolare del suolo è una delle priorità dell Unione Europea;
Micorrize e microrganismi: strumenti utili per la salvaguardia degli ecosistemi 1 di 13 Il punto di vista: La tutela dell ambiente ed in particolare del suolo è una delle priorità dell Unione Europea;
P.A.N. Palazzo Marini Sala delle Conferenze
 P.A.N. PREVENZIONE ALIMENTAZIONE NUTRIZIONE ALIMENTAZIONE, AMBIENTE E SOSTENIBILITÁ Roma, 19 ottobre 2010 CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI Palazzo Marini Sala delle Conferenze DIETA MEDITERRANEA
P.A.N. PREVENZIONE ALIMENTAZIONE NUTRIZIONE ALIMENTAZIONE, AMBIENTE E SOSTENIBILITÁ Roma, 19 ottobre 2010 CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI Palazzo Marini Sala delle Conferenze DIETA MEDITERRANEA
L Agricoltura biologica ha bisogno della Biodiversità?
 L Agricoltura biologica ha bisogno della Biodiversità? Concetta Vazzana VivereBIO Pratovecchio - Stia 5 dicembre 2015 DISPAA (Dipartimento di Scienze della Produzione Agroalimentare e dell Ambiente) Scuola
L Agricoltura biologica ha bisogno della Biodiversità? Concetta Vazzana VivereBIO Pratovecchio - Stia 5 dicembre 2015 DISPAA (Dipartimento di Scienze della Produzione Agroalimentare e dell Ambiente) Scuola
Biodiversità e salute. Flavia Caretta
 Biodiversità e salute Flavia Caretta Biodiversità e salute salute degli ecosistemi salute umana Effetti della perdita di biodiversità sulla salute umana Ricerca epidemiologica Rivolta a fattori singoli
Biodiversità e salute Flavia Caretta Biodiversità e salute salute degli ecosistemi salute umana Effetti della perdita di biodiversità sulla salute umana Ricerca epidemiologica Rivolta a fattori singoli
Salvaguardia degli ecotipi Toscani di Apis mellifera ligustica
 Salvaguardia degli ecotipi Toscani di Apis mellifera ligustica L allevamento apistico nell ultimo secolo ha visto l introduzione in Italia di razze alloctone (Apism. carnica, Apism. mellifera) e di ibridi
Salvaguardia degli ecotipi Toscani di Apis mellifera ligustica L allevamento apistico nell ultimo secolo ha visto l introduzione in Italia di razze alloctone (Apism. carnica, Apism. mellifera) e di ibridi
La nuova biologia.blu
 David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum La nuova biologia.blu Genetica, DNA ed evoluzione PLUS 2 Capitolo B5 L evoluzione e l origine delle specie viventi 3 La teoria di Darwin
David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum La nuova biologia.blu Genetica, DNA ed evoluzione PLUS 2 Capitolo B5 L evoluzione e l origine delle specie viventi 3 La teoria di Darwin
Problemi emergenti di vaccinologia veterinaria
 Problemi emergenti di vaccinologia veterinaria Francesco Meliota Fatro S.p.A. Roma, 18 dicembre 2007 Il mercato mondiale dei vaccini veterinari circa il 25% del mercato dei farmaci veterinari, ma: prodotti
Problemi emergenti di vaccinologia veterinaria Francesco Meliota Fatro S.p.A. Roma, 18 dicembre 2007 Il mercato mondiale dei vaccini veterinari circa il 25% del mercato dei farmaci veterinari, ma: prodotti
Controllo delle infestazioni muscidiche e tecniche di mitigazione dell impatto visivo e olfattivo
 Controllo delle infestazioni muscidiche e tecniche di mitigazione dell impatto visivo e olfattivo INFESTANTI DELL AMBIENTE ANTROPICO INSETTI (mosche, zanzare, scarafaggi, farfalle, formiche) ARACNIDI (ragni
Controllo delle infestazioni muscidiche e tecniche di mitigazione dell impatto visivo e olfattivo INFESTANTI DELL AMBIENTE ANTROPICO INSETTI (mosche, zanzare, scarafaggi, farfalle, formiche) ARACNIDI (ragni
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE E FORESTALE
 Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale (IBAF) Unità Operativa di Supporto di Legnaro Borsa relativa al bando n IBAF.BS.01/2013.PD Borsista: Penelope Zanolli RELAZIONE DI FINE ANNO DI BORSA DI
Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale (IBAF) Unità Operativa di Supporto di Legnaro Borsa relativa al bando n IBAF.BS.01/2013.PD Borsista: Penelope Zanolli RELAZIONE DI FINE ANNO DI BORSA DI
Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive
 Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive INFEZIONE MALATTIA INFETTIVA ASPETTI GENERALI Interazione di un agente biologico (microrganismo) e un ospite recettivo (uomo, animale). Implica
Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive INFEZIONE MALATTIA INFETTIVA ASPETTI GENERALI Interazione di un agente biologico (microrganismo) e un ospite recettivo (uomo, animale). Implica
Il controllo degli insetti dannosi tramite il metodo della confusione sessuale
 Il controllo degli insetti dannosi tramite il metodo della confusione sessuale Dr. Antonio Mastropirro Agriproject - Rutigliano Il metodo si basa sull interruzione della comunicazione chimica tra insetti
Il controllo degli insetti dannosi tramite il metodo della confusione sessuale Dr. Antonio Mastropirro Agriproject - Rutigliano Il metodo si basa sull interruzione della comunicazione chimica tra insetti
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE
 FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE PRESENTAZIONE Lo sviluppo scientifico in campo biomedico ha subito un accelerazione senza precedenti dalla scoperta
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE PRESENTAZIONE Lo sviluppo scientifico in campo biomedico ha subito un accelerazione senza precedenti dalla scoperta
tre grandi problemi Perdita del 30% delle derrate alimentari per limitare le intossicazioni e infezioni di fumiganti (dannosi per l ambiente e l uomo)
 Applicazioni delle radiazioni ionizzanti i i in campo alimentare Il mercato alimentare oggi deve risolvere tre grandi problemi Perdita del 30% delle derrate alimentari dal produttore al consumatore (problema
Applicazioni delle radiazioni ionizzanti i i in campo alimentare Il mercato alimentare oggi deve risolvere tre grandi problemi Perdita del 30% delle derrate alimentari dal produttore al consumatore (problema
Tosi Lorenzo. Centro Studi
 Mezzi a disposizione per il controllo dei fitofagi e delle malattie delle piante in ambiente urbano Tosi Lorenzo Centro Studi REGOLAMENTO CE 1107/2009 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Mezzi a disposizione per il controllo dei fitofagi e delle malattie delle piante in ambiente urbano Tosi Lorenzo Centro Studi REGOLAMENTO CE 1107/2009 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
ZANZARE E RISAIE POBIETTO Morano Po
 ZANZARE E RISAIE POBIETTO Morano Po Dott.Enrico Priarone Dott. Luca Conti Premessa L ambiente della risaia e la lotta biologica alle zanzare Le risaie italiane, concentrate per lo più nelle province di
ZANZARE E RISAIE POBIETTO Morano Po Dott.Enrico Priarone Dott. Luca Conti Premessa L ambiente della risaia e la lotta biologica alle zanzare Le risaie italiane, concentrate per lo più nelle province di
Tavolo Tecnico PCP_153 Efficientamento energetico dei depuratori e riduzione della massa di fanghi prodotta. Lattarico, 14 Novembre 2014
 Tavolo Tecnico PCP_153 Efficientamento energetico dei depuratori e riduzione della massa di fanghi prodotta Lattarico, 14 Novembre 2014 AVVISO PUBBLICO PER LA RILEVAZIONE DI FABBISOGNI DI INNOVAZIONE ALL'INTERNO
Tavolo Tecnico PCP_153 Efficientamento energetico dei depuratori e riduzione della massa di fanghi prodotta Lattarico, 14 Novembre 2014 AVVISO PUBBLICO PER LA RILEVAZIONE DI FABBISOGNI DI INNOVAZIONE ALL'INTERNO
LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E/O DISABILITÀ ALL ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SINTESI DELLA POLITICA
 LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E/O DISABILITÀ ALL ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SINTESI DELLA POLITICA Contesto della politica Dati internazionali mostrano che le
LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E/O DISABILITÀ ALL ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SINTESI DELLA POLITICA Contesto della politica Dati internazionali mostrano che le
LA GESTIONE DELL INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
 LA GESTIONE DELL INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA Parte II: Ricerca & Sviluppo Angelo Bonomi LA RICERCA & SVILUPPO La ricerca & sviluppo costituisce il tipo principale di attività
LA GESTIONE DELL INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA Parte II: Ricerca & Sviluppo Angelo Bonomi LA RICERCA & SVILUPPO La ricerca & sviluppo costituisce il tipo principale di attività
ULSS 2 INCONTRA I mercoledì della Salute
 ULSS 2 INCONTRA I mercoledì della Salute Antibiotici: servono sempre? Relatore: Dr. Vincenzo Catena 05 febbraio 2014 sala Piccolotto Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione U.L.S.S.2 Feltre Direttore
ULSS 2 INCONTRA I mercoledì della Salute Antibiotici: servono sempre? Relatore: Dr. Vincenzo Catena 05 febbraio 2014 sala Piccolotto Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione U.L.S.S.2 Feltre Direttore
Le malattie delle piante. Classificazione e riconoscimento
 Le malattie delle piante Classificazione e riconoscimento MALATTIA: è una deviazione, uno sconvolgimento, delle normali funzioni vitali (di ricambio o di sviluppo) dell organismo; può essere causata da
Le malattie delle piante Classificazione e riconoscimento MALATTIA: è una deviazione, uno sconvolgimento, delle normali funzioni vitali (di ricambio o di sviluppo) dell organismo; può essere causata da
La metagenomica al servizio dell agricoltura
 La metagenomica al servizio dell agricoltura Marco Bazzicalupo Department of Biology University of Florence, Firenze, Italy http://www.unifi.it/dblage/mdswitch.html L albero della vita è microbico RNA
La metagenomica al servizio dell agricoltura Marco Bazzicalupo Department of Biology University of Florence, Firenze, Italy http://www.unifi.it/dblage/mdswitch.html L albero della vita è microbico RNA
Strategie di prodotto (cap. 16)
 Strategie di prodotto (cap. 16) Tipologie di prodotto Prodotti Cardine (leader) Realizzano gran parte del fatturato e dei profitti e richiedono particolare attenzione Prodotti civetta Convenienti per I
Strategie di prodotto (cap. 16) Tipologie di prodotto Prodotti Cardine (leader) Realizzano gran parte del fatturato e dei profitti e richiedono particolare attenzione Prodotti civetta Convenienti per I
Microbiologia clinica
 Microbiologia clinica Docente : Prof. Ubaldo Scardellato Testo: MICROBIOLOGIA CLINICA Eudes Lanciotti Cea ed. 2001 Temi cardine del programma 1. Lo sviluppo della microbiologia come scienza. 2. La natura
Microbiologia clinica Docente : Prof. Ubaldo Scardellato Testo: MICROBIOLOGIA CLINICA Eudes Lanciotti Cea ed. 2001 Temi cardine del programma 1. Lo sviluppo della microbiologia come scienza. 2. La natura
1. Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 8, comma 2, del DLgs n. 150/2012)
 Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all acquisto e all uso e all attività di consulenza sull impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti Premessa La direttiva
Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all acquisto e all uso e all attività di consulenza sull impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti Premessa La direttiva
Consiglio dell Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Ministero della Giustizia
 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi Contributo del Consiglio
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi Contributo del Consiglio
Genetica quantitativa Evoluzione dei caratteri fenotipici
 Genetica quantitativa Evoluzione dei caratteri fenotipici I caratteri che sono determinati da molti geni mostrano una variazione continua Esempi nell uomo sono l altezza, l intelligenza, l abilità nello
Genetica quantitativa Evoluzione dei caratteri fenotipici I caratteri che sono determinati da molti geni mostrano una variazione continua Esempi nell uomo sono l altezza, l intelligenza, l abilità nello
SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA
 SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA Doc. XVIII n. 90 RISOLUZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Estensore ALLEGRINI) approvata nella seduta del 18 aprile
SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA Doc. XVIII n. 90 RISOLUZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Estensore ALLEGRINI) approvata nella seduta del 18 aprile
L uomo utilizza e abita territori sempre più grandi. Le città e i paesi sono sempre più estesi.
 L uomo utilizza e abita territori sempre più grandi. Le città e i paesi sono sempre più estesi. Tutto ciò porta un crescente numero di insetti e di altri animali a vivere sempre più vicino alle nostre
L uomo utilizza e abita territori sempre più grandi. Le città e i paesi sono sempre più estesi. Tutto ciò porta un crescente numero di insetti e di altri animali a vivere sempre più vicino alle nostre
CHI SONO LE ZANZARE?? In Italia esistono oltre 60 specie di zanzare, di cui oltre 13 sono presenti nel nostro territorio.
 CHI SONO LE ZANZARE?? In Italia esistono oltre 60 specie di zanzare, di cui oltre 13 sono presenti nel nostro territorio. Le due specie prevalenti sono la zanzara comune (Culex pipiens molestus) e la zanzara
CHI SONO LE ZANZARE?? In Italia esistono oltre 60 specie di zanzare, di cui oltre 13 sono presenti nel nostro territorio. Le due specie prevalenti sono la zanzara comune (Culex pipiens molestus) e la zanzara
Il CNR affronta tale materia in coerenza con i principi della strategia Europa 2020. In particolare, ritiene che la ricerca e l innovazione nel campo
 Il CNR affronta tale materia in coerenza con i principi della strategia Europa 2020. In particolare, ritiene che la ricerca e l innovazione nel campo della bioeconomia ha ricadute importanti sia sul lato
Il CNR affronta tale materia in coerenza con i principi della strategia Europa 2020. In particolare, ritiene che la ricerca e l innovazione nel campo della bioeconomia ha ricadute importanti sia sul lato
Alessandra Franceschini Tecnico specialista della Sezione Zoologia degli invertebrati e idrobiologia
 Insetti coinquilini e concittadini quelli legati all acqua Alessandra Franceschini Tecnico specialista della Sezione Zoologia degli invertebrati e idrobiologia Tè degli Insegnanti - 16 marzo 2012 moscerini
Insetti coinquilini e concittadini quelli legati all acqua Alessandra Franceschini Tecnico specialista della Sezione Zoologia degli invertebrati e idrobiologia Tè degli Insegnanti - 16 marzo 2012 moscerini
Scheda di Valutazione
 Scheda di Valutazione Codice RBFR12NV2I Coordinatore GRIMALDI Salvatore Ateneo/Ente Università degli Studi della TUSCIA Titolo Particelle fluorescenti, aereomodelli radiocomandati ed analisi delle immagini
Scheda di Valutazione Codice RBFR12NV2I Coordinatore GRIMALDI Salvatore Ateneo/Ente Università degli Studi della TUSCIA Titolo Particelle fluorescenti, aereomodelli radiocomandati ed analisi delle immagini
Microsistemi per manipolazione di cellule in vitro
 Intervento dal titolo Microsistemi per manipolazione di cellule in vitro A cura di Giorgio Cellere Biosilab di Rovereto 75 MICROSISTEMI PER MANIPOLAZIONE DI CELLULE IN VITRO Biosilab nasce dall idea di
Intervento dal titolo Microsistemi per manipolazione di cellule in vitro A cura di Giorgio Cellere Biosilab di Rovereto 75 MICROSISTEMI PER MANIPOLAZIONE DI CELLULE IN VITRO Biosilab nasce dall idea di
Adeguatezza nutrizionale e sostenibilità Marisa Porrini Dip. Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l Ambiente Università di Milano
 FACOLTA DI SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI Adeguatezza nutrizionale e sostenibilità Marisa Porrini Dip. Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l Ambiente Università di Milano Sicurezza degli alimenti (food
FACOLTA DI SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI Adeguatezza nutrizionale e sostenibilità Marisa Porrini Dip. Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l Ambiente Università di Milano Sicurezza degli alimenti (food
LA TRASFORMAZIONE GENETICA NELLE PIANTE: PRINCIPI E STATO DEI LAVORI. Michele Morgante
 LA TRASFORMAZIONE GENETICA NELLE PIANTE: PRINCIPI E STATO DEI LAVORI Michele Morgante Per un agricoltura del futuro Produttività Popolazione crescente con bisogni crescenti Scarsità di risorse idriche
LA TRASFORMAZIONE GENETICA NELLE PIANTE: PRINCIPI E STATO DEI LAVORI Michele Morgante Per un agricoltura del futuro Produttività Popolazione crescente con bisogni crescenti Scarsità di risorse idriche
La ricerca in campo agricolo: la rete interregionale
 La ricerca in campo agricolo: la rete interregionale Massimo Ricciolini Donatella Cavirani Laura Bartalucci Regione Toscana La Rete interregionale per la ricerca agraria, forestale, acquacoltura e pesca
La ricerca in campo agricolo: la rete interregionale Massimo Ricciolini Donatella Cavirani Laura Bartalucci Regione Toscana La Rete interregionale per la ricerca agraria, forestale, acquacoltura e pesca
L innovazione nel PSR dell Emilia-Romagna I Gruppi Operativi e il sistema della conoscenza
 L innovazione nel PSR dell Emilia-Romagna I Gruppi Operativi e il sistema della conoscenza Giancarlo Cargioli Responsabile Servizio Ricerca, Innovazione e Promozione del Sistema Agro-alimentare Struttura
L innovazione nel PSR dell Emilia-Romagna I Gruppi Operativi e il sistema della conoscenza Giancarlo Cargioli Responsabile Servizio Ricerca, Innovazione e Promozione del Sistema Agro-alimentare Struttura
Srl. Tipologia di Impresa: Spin-off Accademico (Università di Pavia e Siena) Settori di Attività : Chimico e Farmaceutico
 Drug discovery & research Srl Tipologia di Impresa: Spin-off Accademico (Università di Pavia e Siena) Settori di Attività : Chimico e Farmaceutico Core business : Sviluppo di composti a rilascio controllato
Drug discovery & research Srl Tipologia di Impresa: Spin-off Accademico (Università di Pavia e Siena) Settori di Attività : Chimico e Farmaceutico Core business : Sviluppo di composti a rilascio controllato
L innovazione. #afiancodelcoraggio
 L innovazione #afiancodelcoraggio Innovare la tutela della salute significa per Roche migliorare le terapie disponibili, introdurre nuovi farmaci capaci di modificare il corso di importanti patologie,
L innovazione #afiancodelcoraggio Innovare la tutela della salute significa per Roche migliorare le terapie disponibili, introdurre nuovi farmaci capaci di modificare il corso di importanti patologie,
Rassegna stampa a cura di
 Rassegna stampa a cura di Programma Comunicati stampa Recall cartaceo Recall web Mercoledì 13 febbraio, ore 10.00, sede Parco Scientifico e Tecnologico - Catania LA RICERCA NEL SETTORE AGRICOLO, DELLE
Rassegna stampa a cura di Programma Comunicati stampa Recall cartaceo Recall web Mercoledì 13 febbraio, ore 10.00, sede Parco Scientifico e Tecnologico - Catania LA RICERCA NEL SETTORE AGRICOLO, DELLE
I macro temi segnalati nella mappa sono trattati nella presentazione e fruibili attraverso schede di approfondimento.
 I macro temi segnalati nella mappa sono trattati nella presentazione e fruibili attraverso schede di approfondimento. 2 L Unione Europea nel 2008 ha fissato, con il pacchetto 20-20-20, degli obiettivi
I macro temi segnalati nella mappa sono trattati nella presentazione e fruibili attraverso schede di approfondimento. 2 L Unione Europea nel 2008 ha fissato, con il pacchetto 20-20-20, degli obiettivi
Laboratorio Agricoltura e Industria agro-alimentare. Francesco Pennacchi. Perugia, 8 aprile 2011
 Laboratorio Agricoltura e Industria agro-alimentare Francesco Pennacchi Perugia, 8 aprile 2011 La multifunzionalità è la nuova strategia dell agro-alimentare Gli obiettivi: - garantire alimenti di qualità,
Laboratorio Agricoltura e Industria agro-alimentare Francesco Pennacchi Perugia, 8 aprile 2011 La multifunzionalità è la nuova strategia dell agro-alimentare Gli obiettivi: - garantire alimenti di qualità,
Danni all'apicoltura da pesticidi. e benefici di un buon rapporto tra api e agricoltura
 Danni all'apicoltura da pesticidi e benefici di un buon rapporto tra api e agricoltura Marco Valentini www.bioapi.it Nei campi agricoli si combatte costantemente una guerra Nei campi che accolgono le colture
Danni all'apicoltura da pesticidi e benefici di un buon rapporto tra api e agricoltura Marco Valentini www.bioapi.it Nei campi agricoli si combatte costantemente una guerra Nei campi che accolgono le colture
Gli altri alimenti: prospettive per l azienda agricola
 Sicura & QsA - Qualità, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale in convention, Modena Fiere, 24 25 settembre 2013 Gli altri alimenti: prospettive per l azienda agricola Marco Montanari Aldo Cervi Ordine
Sicura & QsA - Qualità, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale in convention, Modena Fiere, 24 25 settembre 2013 Gli altri alimenti: prospettive per l azienda agricola Marco Montanari Aldo Cervi Ordine
ACC Genomics per la Salute della Donna
 ACC Genomics per la Salute della Donna Profilo Alleanza Contro il Cancro (ACC), la più grande rete di ricerca oncologica italiana fondata nel 2002 dal Ministero della Salute tra sei centri di alto livello
ACC Genomics per la Salute della Donna Profilo Alleanza Contro il Cancro (ACC), la più grande rete di ricerca oncologica italiana fondata nel 2002 dal Ministero della Salute tra sei centri di alto livello
Sintesi di alcune domande: l allungamento dell età lavorativa
 Il questionario Sintesi di alcune domande: In che modo l allungamento dell età lavorativa influenzerà progetti e processi di formazione del personale nel prossimo futuro? Con la legge di stabilità sono
Il questionario Sintesi di alcune domande: In che modo l allungamento dell età lavorativa influenzerà progetti e processi di formazione del personale nel prossimo futuro? Con la legge di stabilità sono
HOLDING POWER BIOLIQUID
 HOLDING POWER BIOLIQUID IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - MOTORI ENDOTERMICI ALIMENTATI DA BIOMASSE AGRICOLE - SICILIA LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Nel 2020 l aumento dei consumi di energia
HOLDING POWER BIOLIQUID IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - MOTORI ENDOTERMICI ALIMENTATI DA BIOMASSE AGRICOLE - SICILIA LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Nel 2020 l aumento dei consumi di energia
La mia decisione di candidarmi a Sindaco di Petronà nasce dall esigenza. di apportare un contributo di cambiamento alla storia politica della nostra
 La mia decisione di candidarmi a Sindaco di Petronà nasce dall esigenza di apportare un contributo di cambiamento alla storia politica della nostra cittadina. La mia candidatura rappresenta un atto di
La mia decisione di candidarmi a Sindaco di Petronà nasce dall esigenza di apportare un contributo di cambiamento alla storia politica della nostra cittadina. La mia candidatura rappresenta un atto di
LE RISORSE E LE COMPETENZE COME BASE DELLA STRATEGIA
 LE RISORSE E LE COMPETENZE COME BASE DELLA STRATEGIA CAPITOLO QUINTO Grant R. L analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna, 1999 1 DAL SETTORE ALL IMPRESA Fino agli anni Novanta:
LE RISORSE E LE COMPETENZE COME BASE DELLA STRATEGIA CAPITOLO QUINTO Grant R. L analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna, 1999 1 DAL SETTORE ALL IMPRESA Fino agli anni Novanta:
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
 ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI Con il termine Organismo Geneticamente Modificato si intendono soltanto gli organismi in cui parte del genoma sia stato modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI Con il termine Organismo Geneticamente Modificato si intendono soltanto gli organismi in cui parte del genoma sia stato modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria
David Sadava, H. Craig Heller, Gordon H. Orians, William K. Purves, David M. Hillis. Biologia.blu B - Le basi molecolari della vita e dell evoluzione
 David Sadava, H. Craig Heller, Gordon H. Orians, William K. Purves, David M. Hillis Biologia.blu B - Le basi molecolari della vita e dell evoluzione 1 L evoluzione e i suoi meccanismi 2 Il viaggio di Charles
David Sadava, H. Craig Heller, Gordon H. Orians, William K. Purves, David M. Hillis Biologia.blu B - Le basi molecolari della vita e dell evoluzione 1 L evoluzione e i suoi meccanismi 2 Il viaggio di Charles
KIT DIDATTICO B - PERCORSO SPECIFICO
 KIT DIDATTICO B - PERCORSO SPECIFICO Numero e contesto degli interventi formativi: 10 incontri da ciascuno MODULO 1 CDCA Criticità ambientali presenti sul territorio di Frosinone, impatti sull'agricoltura
KIT DIDATTICO B - PERCORSO SPECIFICO Numero e contesto degli interventi formativi: 10 incontri da ciascuno MODULO 1 CDCA Criticità ambientali presenti sul territorio di Frosinone, impatti sull'agricoltura
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA CDL IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante all esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico) Presidente: Prof.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA CDL IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante all esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico) Presidente: Prof.
GENETICA QUANTITATIVA
 GENETICA QUANTITATIVA Caratteri quantitativi e qualitativi I caratteri discontinui o qualitativi esibiscono un numero ridotto di fenotipi e mostrano una relazione genotipo-fenotipo semplice I caratteri
GENETICA QUANTITATIVA Caratteri quantitativi e qualitativi I caratteri discontinui o qualitativi esibiscono un numero ridotto di fenotipi e mostrano una relazione genotipo-fenotipo semplice I caratteri
Sistema di Qualità Nazionale e marchi collettivi: per quali prodotti e a quali condizioni?
 Sistema di Qualità Nazionale e marchi collettivi: per quali prodotti e a quali condizioni? Prof. Gabriele Canali Dipartimento di Economia Agro-alimentare e SMEA, Alta scuola in economia agroalimentare,
Sistema di Qualità Nazionale e marchi collettivi: per quali prodotti e a quali condizioni? Prof. Gabriele Canali Dipartimento di Economia Agro-alimentare e SMEA, Alta scuola in economia agroalimentare,
L insediamento delle PMI nei parchi Ecoindustriali: il progetto Ecomark
 L insediamento delle PMI nei parchi Ecoindustriali: il progetto Ecomark Marino Cavallo, Provincia di Bologna Ecomondo Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile
L insediamento delle PMI nei parchi Ecoindustriali: il progetto Ecomark Marino Cavallo, Provincia di Bologna Ecomondo Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile
Cereali biologici di qualità
 Cereali biologici di qualità Scelta varietale ed interventi agronomici per il miglioramento quanti-qualitativo e la valorizzazione della produzione cerealicola biologica marchigiana e dei prodotti derivati.
Cereali biologici di qualità Scelta varietale ed interventi agronomici per il miglioramento quanti-qualitativo e la valorizzazione della produzione cerealicola biologica marchigiana e dei prodotti derivati.
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE
 TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE MATERIA: SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA) CLASSE SECONDA DOCENTE: PIETRO VISCONE INDIRIZZO* AFM * indicare Amministrazione, Finanza e Marketing per il biennio. Per il triennio indicare
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE MATERIA: SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA) CLASSE SECONDA DOCENTE: PIETRO VISCONE INDIRIZZO* AFM * indicare Amministrazione, Finanza e Marketing per il biennio. Per il triennio indicare
Verso nuove forme di energia
 Verso nuove forme di energia Un nuovo scenario energetico Il modo di produrre elettricità sta cambiando. L evoluzione del mercato, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il progresso tecnologico della rete
Verso nuove forme di energia Un nuovo scenario energetico Il modo di produrre elettricità sta cambiando. L evoluzione del mercato, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il progresso tecnologico della rete
Cinipide del Castagno in Campania
 Cinipide del Castagno in Campania Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu 28 Maggio 2008 Montoro sup.- AV Castagno : Superficie -Superficie Nazionale a castagneto da Frutto coltivato 150 000 Ha -Superficie in
Cinipide del Castagno in Campania Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu 28 Maggio 2008 Montoro sup.- AV Castagno : Superficie -Superficie Nazionale a castagneto da Frutto coltivato 150 000 Ha -Superficie in
Sintesi e valutazione dell attività antimicrobica di nuovi peptidomimetici cationici contenenti analoghi dell arginina
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" CHIETI PESCARA FACOLTÁ DI FARMACIA Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Dipartimento di Scienze del Farmaco Tesi Sperimentale di Laurea Sintesi e
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" CHIETI PESCARA FACOLTÁ DI FARMACIA Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Dipartimento di Scienze del Farmaco Tesi Sperimentale di Laurea Sintesi e
SICCITA, CREA: DEGRADO E DESERTIFICAZIONE
 SICCITA, CREA: DEGRADO E DESERTIFICAZIONE Pubblicato il 26/08/2015 at 16:4 Il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l analisi dell economia agraria) ha portato il suo contributo al convegno Siccità,
SICCITA, CREA: DEGRADO E DESERTIFICAZIONE Pubblicato il 26/08/2015 at 16:4 Il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l analisi dell economia agraria) ha portato il suo contributo al convegno Siccità,
ESPERIENZE DI CONTROLLO BIOLOGICO DELLE LARVE DI Aedes albopictus
 ESPERIENZE DI CONTROLLO BIOLOGICO DELLE LARVE DI Aedes albopictus MARILENA LEIS Dipartimento di Biologia ed evoluzione Università di Ferrara Via L. Borsari 46 lsm@unife.it 0532-455313 Comune di Ferrara
ESPERIENZE DI CONTROLLO BIOLOGICO DELLE LARVE DI Aedes albopictus MARILENA LEIS Dipartimento di Biologia ed evoluzione Università di Ferrara Via L. Borsari 46 lsm@unife.it 0532-455313 Comune di Ferrara
La genetica dei caratteri quantitativi
 Studia l ereditarietà nelle popolazioni dei caratteri quantitativi Molti caratteri sono quantitativi, cioè hanno molte classi fenotipiche Il modo in cui si esprimono e vengono trasmessi i caratteri quantitativi
Studia l ereditarietà nelle popolazioni dei caratteri quantitativi Molti caratteri sono quantitativi, cioè hanno molte classi fenotipiche Il modo in cui si esprimono e vengono trasmessi i caratteri quantitativi
Scheda di Valutazione
 Scheda di Valutazione Codice RBFR12D5RY Coordinatore SANTI Luca Ateneo/Ente Università degli Studi della TUSCIA Titolo Nanoparticelle virali bioingegnerizzate prodotte in pianta per la veicolazione sito
Scheda di Valutazione Codice RBFR12D5RY Coordinatore SANTI Luca Ateneo/Ente Università degli Studi della TUSCIA Titolo Nanoparticelle virali bioingegnerizzate prodotte in pianta per la veicolazione sito
Il ruolo delle Utilities nella Ricerca e nell Innovazione Tecnologica Acqua ed Energia per le città di domani: verso un approccio intelligente
 Il ruolo delle Utilities nella Ricerca e nell Innovazione Tecnologica Acqua ed Energia per le città di domani: verso un approccio intelligente Anna Ferrero Presidente Commissione Formazione Ricerca e Innovazione
Il ruolo delle Utilities nella Ricerca e nell Innovazione Tecnologica Acqua ed Energia per le città di domani: verso un approccio intelligente Anna Ferrero Presidente Commissione Formazione Ricerca e Innovazione
LA DISINFEZIONE CON IL CALORE IN ORTICOLTURA A CICLO VELOCE Una tecnica che premia Produttori e Consumatori
 LA DISINFEZIONE CON IL CALORE IN ORTICOLTURA A CICLO VELOCE Una tecnica che premia Produttori e Consumatori Calore istantaneo: una tecnologia per il miglioramento quantitativo e qualitativo dei prodotti
LA DISINFEZIONE CON IL CALORE IN ORTICOLTURA A CICLO VELOCE Una tecnica che premia Produttori e Consumatori Calore istantaneo: una tecnologia per il miglioramento quantitativo e qualitativo dei prodotti
Domande frequenti. cosa rispondere???
 cosa rispondere??? Domanda 1. Quali sono le principali differenze del Campese rispetto al pollo industriale? R: Il Campese è selezionato tra genetiche particolari che garantiscono le necessarie caratteristiche
cosa rispondere??? Domanda 1. Quali sono le principali differenze del Campese rispetto al pollo industriale? R: Il Campese è selezionato tra genetiche particolari che garantiscono le necessarie caratteristiche
La mappatura dei geni umani. SCOPO conoscere la localizzazione dei geni per identificarne la struttura e la funzione
 La mappatura dei geni umani SCOPO conoscere la localizzazione dei geni per identificarne la struttura e la funzione Un grande impulso alla costruzione di mappe genetiche è stato dato da le tecniche della
La mappatura dei geni umani SCOPO conoscere la localizzazione dei geni per identificarne la struttura e la funzione Un grande impulso alla costruzione di mappe genetiche è stato dato da le tecniche della
GTTS5: Processi produttivi innovativi. Introduzione R-0353-D0415-CI-I 1
 GTTS5: Processi produttivi innovativi Introduzione R-0353-D0415-CI-I 1 Facts and figures 3D Printing Impact (CSC Source) 2 Le sfide specifiche Obiettivo della linea di intervento LI5: Processi produttivi
GTTS5: Processi produttivi innovativi Introduzione R-0353-D0415-CI-I 1 Facts and figures 3D Printing Impact (CSC Source) 2 Le sfide specifiche Obiettivo della linea di intervento LI5: Processi produttivi
Risultati della Ricerca
 Risultati della Ricerca Titolo Studio della risposta epigenetica a stress ambientali in Arabidopsis e mais Descrizione estesa del risultato Il progetto Acquired Environmental Epigenetics Advances: from
Risultati della Ricerca Titolo Studio della risposta epigenetica a stress ambientali in Arabidopsis e mais Descrizione estesa del risultato Il progetto Acquired Environmental Epigenetics Advances: from
Piano d Azione Nazionale: come cambia la difesa del
 Piano d Azione Nazionale: come cambia la difesa del verde pubblico Nicoletta Vai Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna Massimo Bariselli e Nicoletta Vai Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna
Piano d Azione Nazionale: come cambia la difesa del verde pubblico Nicoletta Vai Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna Massimo Bariselli e Nicoletta Vai Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna
Incontro con gli stakeholder. Roma 11 febbraio 2016
 Incontro con gli stakeholder Roma 11 febbraio 2016 Documentazione a supporto Tasso di risposta 55% Format ricevuti (#) = 8 Dalla ricerca biotecnologica nuove risorse per l industria e per uno sviluppo
Incontro con gli stakeholder Roma 11 febbraio 2016 Documentazione a supporto Tasso di risposta 55% Format ricevuti (#) = 8 Dalla ricerca biotecnologica nuove risorse per l industria e per uno sviluppo
Grant, L'analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, 2011 Capitolo IV. L analisi dei concorrenti L ANALISI DEI CONCORRENTI
 L ANALISI DEI CONCORRENTI 1 Saper eseguire una corretta analisi dei concorrenti comporta saper: 1. valutare l impatto e i profitti potenziali di prodotti e fornitori complementari; 2. valutare le implicazioni
L ANALISI DEI CONCORRENTI 1 Saper eseguire una corretta analisi dei concorrenti comporta saper: 1. valutare l impatto e i profitti potenziali di prodotti e fornitori complementari; 2. valutare le implicazioni
Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS)
 Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS) adacher@dia.uniroma3.it Programma La simulazione ad eventi discreti, è una metodologia fondamentale per la valutazione delle prestazioni di sistemi complessi (di
Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS) adacher@dia.uniroma3.it Programma La simulazione ad eventi discreti, è una metodologia fondamentale per la valutazione delle prestazioni di sistemi complessi (di
RICERCA E SVILUPPO DI NUOVI FARMACI
 RICERCA E SVILUPPO DI NUOVI FARMACI In passato le scoperte dei farmaci erano occasionali. Si trattava di sostanze di derivazione vegetale o animale STRATEGIE DI RICERCA: Quali sono i fattori che influenzano
RICERCA E SVILUPPO DI NUOVI FARMACI In passato le scoperte dei farmaci erano occasionali. Si trattava di sostanze di derivazione vegetale o animale STRATEGIE DI RICERCA: Quali sono i fattori che influenzano
IL CONCETTO DI ZOONOSI CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI. Zoonosi dirette. Ciclozoonosi. Metazoonosi. Saprozoonosi
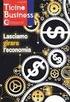 IL CONCETTO DI ZOONOSI Malattie ed infezioni che si trasmettono naturalmente dagli animali vertebrati all uomo e viceversa (O.M.S.) CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI Zoonosi dirette Trasmissione dall animale
IL CONCETTO DI ZOONOSI Malattie ed infezioni che si trasmettono naturalmente dagli animali vertebrati all uomo e viceversa (O.M.S.) CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI Zoonosi dirette Trasmissione dall animale
IL VANTAGGIO DI DIFFERENZIAZIONE
 IL VANTAGGIO DI DIFFERENZIAZIONE 1 Il vantaggio di differenziazione si ottiene quando un azienda riesce a ottenere, grazie alla differenziazione, un premio sul prezzo, che eccede il costo sostenuto per
IL VANTAGGIO DI DIFFERENZIAZIONE 1 Il vantaggio di differenziazione si ottiene quando un azienda riesce a ottenere, grazie alla differenziazione, un premio sul prezzo, che eccede il costo sostenuto per
TRASFORMAZIONE GENETICA DI SPINACIO (SPINACIA OLERACEA L.) MEDIATA DA AGROBACTERIUM TUMEFACIENS
 LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE VEGETALI (Prof. Alma Balestrazzi) TRASFORMAZIONE GENETICA DI SPINACIO (SPINACIA OLERACEA L.) MEDIATA DA AGROBACTERIUM TUMEFACIENS CHE COSA SONO LE PIANTE TRANSGENICHE? Le piante
LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE VEGETALI (Prof. Alma Balestrazzi) TRASFORMAZIONE GENETICA DI SPINACIO (SPINACIA OLERACEA L.) MEDIATA DA AGROBACTERIUM TUMEFACIENS CHE COSA SONO LE PIANTE TRANSGENICHE? Le piante
Soluzioni, servizi e prodotti a basso impatto ambientale
 Soluzioni, servizi e prodotti a basso impatto ambientale Un laboratorio di Idee dove l innovazione diventa lo strumento per raggiungere il traguardo La progettazione rappresenta un supporto efficace per
Soluzioni, servizi e prodotti a basso impatto ambientale Un laboratorio di Idee dove l innovazione diventa lo strumento per raggiungere il traguardo La progettazione rappresenta un supporto efficace per
