LIBRO I: REGNO DI AMORE
|
|
|
- Casimiro Vacca
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 U LIBRO I: REGNO DI AMORE na forte cesura tematica e stilistica divide il Regno d Amore dalle altre tre cantiche, più rivolte in direzione esemplare e spiritualistica. Fonte d ispirazione molto forte per il primo libro è il Boccaccio del Ninfale fiesolano 1 e dell Amorosa Visione. L eco del certaldese è percepibile nella descrizione dell ameno paesaggio e nelle rappresentazioni delle ninfe, dei loro cortei, dei loro giochi e dei loro discorsi, così come nelle cadute che il protagonista subisce a causa di Amore, oltre che nelle celebrazioni della potenza del dio-bambino tramite l elenco delle sue illustri vittime. Boccacciano risuona il verso fluido e armonioso, toccando a volte note di sensuale mollezza, altre di crudo realismo. Importante modello di riferimento per il primo libro è anche l Eneide di Virgilio 2 ; inoltre si avverte una qualche influenza dell Ovidio delle Metamorfosi 3, del Petrarca del Trionfo d Amore, del Nadal della Leandreride 4. Gilardi 5, per il riferimento che il Frezzi fa allo scudo di Achille di Iliade XVIII 6, sostenne che l autore conobbe Omero. L indizio è molto debole; è che probabile il poeta abbia tratto tale notizia da uno dei numerosi florilegi che trattavano della guerra di Troia, tanto diffusi in epoca medievale. 1 Non è forse un caso che in due codici si trovi, accanto al poemetto boccaccesco, uno squarcio del primo capitolo del Regno d Amore. I manoscritti in questione sono il Riccardiano 1149 e il Canoniciano 46 della Bodlejana di Oxford. Cfr. E. FILIPPINI, I codici del Quadriregio, Perugia 1905, pp , 44-45; G. ROTONDI, Alcuni studi su Federico Frezzi, «Memorie del r. istituto lombardo di scienze e lettere», XXIII, (1917), p Tra gli episodi virgiliani più evidenti su cui non mi soffermerò in questo capitolo: racconto della signoria di Eolo sui venti (Quadr., I, 15, ; En. I, 56-63); promessa di Didone posta sulle fallaci labbra della ninfa Ionia (Quadr., I, 16, 76, En. IV, 24); il poeta paragona se stesso a Enea in cerca di Creusa (Quadr., I, 17, 28-30, En. II, 745 ss.) Sui rapporti con il poeta mantovano, cfr. ZABUGHIN, Virgilio nel Rinascimento italiano. Da Dante a Torquato Tasso, Bologna, 1923, pp , In primis il massiccio utilizzo del motivo delle frecce d oro e di piombo, di cui è armato Cupido, tratte da Met. I, (cfr. E. FILIPPINI, Freccie e frecciate d Amore nel poema frezziano, in ID., Studi frezziani, Foligno 1922, pp ). Tra gli altri: molteplici riferimenti ad Atteone (Quadr., I, 4, 136; III, 5, 142 ; Met. III); descrizione del carro di Giunone e Minerva (Quadr., I, 5, 28, Met. II, 107); partenza di Astrea dalla terra contaminata di delitti (Quadr., I, 12, 100, Met. I, 149); descrizione del timore di Plutone che la terra, aprendosi, mostri agli sguardi indiscreti dei mortali i tenebrosi regni d abisso (Quadr., I, 15, 109 ; Met. V). 4 Medesima apertura con la descrizione della primavera, la comparsa di Cupido e la lunga enumerazione dei trionfi di Amore sugli dèi dell Olimpo (Quadr., I, 1; Leand. I, 1); stesso frequente utilizzo delle saette d oro e di piombo utilizzate dal dio-arciere. 5 B. GILARDI, Studi e ricerche intorno al Quadriregio, Torino 1911, p Quadr., I, 11, 23-27: «lo scudo cristallin gli vidi in mano / lucente quanto al sol nullo alabastro. / Ed era sì scolpito e sì sovrano, / che tanto adorno nol fece Achille, / per preghi della madre, dio Vulcano». 24
2 Seppur minore rispetto al resto del Quadriregio, anche nel primo libro la Commedia di Dante risulta essere fonte molto importante. Notevoli sono le riprese di situazioni e sintagmi danteschi, e sarebbe troppo lungo elencarle tutte: fra i tanti esempi ricordo l apparizione della ninfa Filena, di là da un fiumicello, intenta a cogliere fiori, che rievoca la Matelda del Purgatorio 7 ; la definizione del satiro che tradirà il poeta come «falso e bugiardo» 8 ; la minima modificazione tra le rime dantesche segnorso : morso : soccorso 9 e quelle frezziane signorso : corso : soccorso 10. Se la trama generale del poema sembra ricalcare quella della Commedia, in questa prima cantica, però, Frezzi si rivela originale nel suo indugiare compiaciuto nella descrizione del proprio periodo di traviamento giovanile, differendo in ciò dall Alighieri, che non accenna alla sua vita di peccatore, se non nel rimprovero di Beatrice nel XXXI del Purgatorio. Nella descrizione di se stesso «giovinetto» e nel continuo inseguimento che fece di vani amori, è come se il Frezzi abbia voluto percorrere ed esplicitare la «selva oscura» dantesca, raffigurandola però, non con cupi, ma con graziosi e splendidi colori, come quelli delle contemporanee pitture tardo-gotiche 11. Le vicende raccontate, dopo la precisa, ma topica introduzione dei primi versi che descrivono l avvento della primavera, si svolgono in un passato indefinito, lontano dalla precisione cronologica e simbolica di Dante. La rievocazione della propria giovinezza è ambientata in una geografia fatta di pianure, valli, fiumi, boschetti, giardini e colli; questi luoghi sono descritti in maniera stilizzata e convenzionale, ma non senza una dolce vena poetica. In questo contesto nascono gli amori del giovane Frezzi, sempre destinati al fallimento poiché, seppur le ninfe si mostrano spesse volte accondiscenti, inflessibile è la severità dei vari dèi, che tengono in maniera particolare alla castità delle loro protette. Lo schema narrativo è abbastanza ripetitivo: innamoramento dell autore; ninfa che esprime il proprio disprezzo per Amore; Cupido, con le sue frecce, punisce la ninfa facendola innamorare; breve incontro dell autore con la ninfa, sempre interrotto da qualche accadimento; la divinità cui appartiene la driade viene informata 7 Quadr., I, II, ; Purg., XXVIII, Quadr., I, 3, Inf. XXIX, 77, 79, Quadr., I, 11; 95, 97, Cfr. A. LANZA, L apogeo della letteratura tardogotica. Il poema tardogotico, in ID., La letteratura tardogotica. Arte e poesia a Firenze e Siena nell autunno del Medioevo, Anzio 1994, pp
3 dell innamoramento; obbligata separazione dei due amanti; imprecazioni contro Cupido e promessa di non seguirlo più; riapparizione del dio, riappacificazione e nuovo innamoramento del Frezzi. Non mancano però momenti elegiaci di efficace poesia, come nel canto VIII, dove è descritta la scena in cui Lippea, colpita dalla freccia di Cupido, piena di timore e vergogna 12, rivela il proprio amore per Federico, cui segue la loro eterna promessa d amore e la notte passata insieme in una fiorita valle rischiarata dal plenilunio 13. L episodio, pur nella sua freschezza, è pieno di dissimulati echi virgiliani: innanzitutto, l idillio tra i due può ricordare quello tra Enea e Didone, di Eneide IV. Nel Quadriregio, dopo il connubio, l Invidia, cui «nulla è mai nascosto, / c ha mille orecchie la malvagia e rea, / e l occhio suo in mille lochi è posto» 14, diffonde tra le dee e le ninfe la notizia dell amore tra i due, causando la punizione di Lippea da parte di Giunone. Non differentemente la Fama virgiliana, divinità malvagia e sinistra, provvede a diffondere fra i popoli dell Africa la notizia che Didone si è concessa al troiano Enea, facendo così infuriare il violento Iarba, il re che contava un giorno di sposare la regina di Cartagine. Costretta da Giunone ad abbandonare il regno di Diana, Lippea «come va l cervio, a cui già velenosa / è giunta saetta, e move il corso / or qua or là, e insin che muor non posa: / così ed ella per aver soccorso / giva» 15 ; non dissimilmente da Didone, che infiammata dall amore per il principe troiano, infelice, si aggira per la sua città, come una cerva colpita da una freccia e prossima alla morte 16. L episodio si segnala per la marcata attenzione al dato cromatico: Lippea, colpita da Cupido, diviene «vermiglia» e, lagrimando, abbassa gli occhi simili a «zaffiri»; di lei risaltano la «bianca mano» e il 12 Il pudico abbassare gli occhi di Lippea (Quadr., I, 8, 73-75) ricorda l analogo comportamento di Matelda in Purg. XXVIII, Da notare come il poeta spesso utilizzi, volti in ambito profano, sintagmi e versi di cui Dante si era servito in contesti decisamente diversi. Nell episodio in questione, il poeta viene chiamato dall amata «amoroso drudo» (Quadr., I, 8, 115), lo stesso epiteto che Bonaventura aveva rivolto a san Domenico (Par. XII, 55). Così, quando Lippea, giunta l alba, si congeda dall amato, gli dice: «prego che a vedermi torni tosto, / ché solo in veder te l mio core ha pace» (Quadr,, I, ), il cui ultimo verso è un calco di Par., XXX, 102: «che solo in lui vedere ha la sua pace». 14 Quadr., I, 8, Quadr., I, 9, En. IV, 66-73: «Est mollis flamma medullas / interea et tacitum vivit sub pectore volnus. / Uritur infelix Dido totaque vagatur / urbe furens, qualis coniecta cerva sagitta, / quam procul incautam remora inter cresia fixit / pastora gens telis liquitque volatile ferrum / nescius; illa fuga silvas saltusque peragrat / dictaeos, haeret lateri letalis harundo». 26
4 «capo bianco»; di variopinti fiori è il prato, rischiarato dalla luna, cui pervengono la ninfa e Federico per trascorrere la notte 17. E probabile che il primo libro, sotto la veste dell allegoria, riveli un reale traviamento giovanile del folignate 18, dietro le lusinghe del piacere sensuale; si è ipotizzato in ciascuna ninfa una donna amata dall autore e, nel racconto poetico di Ilbina portata via da Minerva, un allusione a un amore per una giovane monaca pisana 19. Proprio in quest ultimo episodio 20, il canovaccio di un Frezzi in continua caccia di ninfe sembra terminare con Minerva che lo convince a seguirlo nel suo regno celeste; ma la tentazione di una nuova ninfa promessagli da Venere, lo distoglie dalla retta strada. Anche questo avvenimento è interessante in prospettiva autobiografica: la comparsa di Minerva, dea della sapienza e, in un certo senso, della teologia, potrebbe rivelare come Frezzi, già da giovane, seppur per breve periodo, abbia sentito il bisogno di abbandonare gli svaghi mondani per dedicarsi agli studi e alla religione. Ritornato sotto l egida delle due divinità dell amore, proprio nel regno di Venere Federico raggiunge il culmine della disillusione nei loro confronti: prima è disgustato dalla vista di una gioconda compagnia di ninfe, uomini e ermafroditi tutti nudi, tanto da chiedere alla dea di condurlo da ninfe di più onesto contegno 21 ; poi si fidanza con la quindicenne Ionia, ninfa all apparenza timida e inesperta, che non fa che asciugarsi gli occhi umidi di pianto coi biondissimi e lunghi capelli fluenti; la fanciulla simula di essere terrorizzata da «centauri e fauni incestuosi, / turpi in ogni atto scostumato e rio» 22 e, dopo avergli promesso di raggiungerlo nottetempo in un boschetto contiguo, si congeda. Dopo aver trascorso l intera notte in sua attesa, il poeta, esausto, si addormenta. In sogno gli appare Ilbina, che lo informa del fatto che Ionia lo ha preso in giro col pieno consenso dei due dèi e si sta sollazzando con un fauno «vile, rozzo e negro» 23. Al risveglio Frezzi si mette immediatamente sulle orme della ninfa, «come il bracco va cercando a caccia» e constata, suo malgrado, che Ilbina gli ha detto il vero: 17 Quadr., I, 8, Il poeta viene continuamente chiamato con l appellativo di «giovinetto». 19 Che fosse pisana si deduce da Quadr., I, X, 163, in cui legge «Io nacqui già in Alfea». Dove Alfea è nome antico di Pisa, come è esplicito in Quadr., II, 17, Quadr., I, Quadr., I, 16, Quadr., I, 16, Quadr., I, 17,
5 sorprende, infatti, Ionia «stare tra le braccia / del fauno duro ed abbracciargli il seno» 24. Furente, si scaglia contro i due, che se la danno a gambe, mentre ricopre di insulti la ninfa traditrice: «perché fuggi così, o mala putta? / Son queste tue parole e atti onesti? / Tu m hai fatto aspettar la notte tutta / ed hai lasciato me sol per restarte / con un mostro cornuto e fèra brutta!» 25. Estremamente seccato, accetta perciò di buon grado la comparsa della donna che, dicendosi mandata da Minerva e Ilbina 26, lo invita a intraprendere il cammino alla ricerca della dea della Sapienza, che lo avrebbe salvato dai perfidi lacci di Cupido 27. Proprio Cupido, oltre al poeta, è il protagonista del primo libro, non per altro a lui intitolato 28. Nei primi versi l autore lo invoca e subito egli compare con aspetto giocondo. Il dio è descritto secondo l iconografia in voga in quel periodo, con i capelli biondi su cui spicca una corona di verde mirto, la veste rosso fuoco e le ali adorne di splendide penne; ed è, naturalmente, munito di arco, faretra e frecce d oro e di piombo per fare innamorare o per spegnere la passione. Cupido si offre a Frezzi come guida, ma si rivela inaffidabile: in più occasioni promette al poeta l amore di una ninfa, ma ogni volta tale amore risulta infelice, a volte proprio per colpa sua, come nell episodio sopra citato in cui fa innamorare la ninfa Ionia di un fauno 29. Nonostante i numerosi elogi che fa della propria potenza, come quando si mette a enumerare gli eroi e gli dèi che è riuscito a soggiogare 30, Amore viene continuamente ingiuriato: dalle ninfe, e ogni volta dovrà ferirle con le sue frecce per farle cambiare idea; da Frezzi, a conclusione di ognuno dei suoi sciagurati amori; dalle divinità, continuamente infastidite dall influenza 24 Quadr., I, 17, Quadr., I, 17, Quadr., I, 18, 44-45: «Minerva a te mi manda ed anco Ilbina, / ch io ti tragga del cammino stolto». Reminiscenza di Inferno, II, in cui Virgilio informa di essere giunto in soccorso a Dante per esortazione di Lucia e Beatrice. 27 La conversione da Cupido a Minerva è totale e manichea. Se in questo primo libro il poeta si è, con compiacimento, descritto in un fantastico mondo di ninfee e divinità, con tale moralistica esortazione a Dio inizierà il secondo: «O alto re, monarca, o sommo Dio, / non vedi tu che l mondo va sì male / e quanto egli è perverso e fatto rio? / Non vedi il vizio che la virtù assale? / E da che questo da te si comporta, / o tu nol vedi o dell uom non ti cale». (Quadr., II, 1, 10-15). 28 Il primo libro è chiamato Regno d Amore, ma in verità i regni che il poeta pellegrini attraversa sono tre: quello di Diana, di Eolo e di Minerva. Il primo, in particolare, occupa ben quattordici dei diciotto capitolo che compongono il libro. 29 Quadr., I, Il secondo capitolo si apre con Amore che dichiara: «Né ciel, né mar, né are mai, né terra / potero al foco mio far resistenza, / né all arco dur, ché mai ferendo egli erra». Segue poi il catalogo delle illustri vittime delle sue frecce, quali Giove, Nettuno, Plutone, Febo ed Ercole. Tale descrizione della potenza d Amore è frequente nei testi del tempo, tra cui i massimi esempi si ritrovano nell Amorosa Visone di Boccaccio e nel Trionfo dell Amore di Petrarca. Il motivo è presente anche nella Leandreride, I, 2 e nella Fimerodia III, 6,8. 28
6 che il dio alato vuole esercitare sulle loro driade; addirittura il suo patrigno Vulcano, arrabbiato, scenderà sulla terra, dando inizio a un combattimento memorabile per l umorismo e il grottesco che contiene 31. Se in seguito, nel canto XIV del Regno dei Vizi, il poeta smaschererà definitivamente la falsa bellezza di Amore e i suoi fallaci insegnamenti, in questo primo libro Frezzi lo pone addirittura come saggio maestro: nel canto X, infatti, Cupido fa una divagazione in cui spiega l origine dei fenomeni atmosferici; seppur di matrice aristotelica, essa in parte ricorda la descrizione fatta da Buonconte da Montefeltro nel quinto del Purgatorio. Come è noto, anche in Dante non mancano le digressioni erudite, ma in Frezzi esse appaiono fini a se stesse, non collegate con la trama: in ciò si può cogliere una costante della letteratura del Trecento, che apprezzava e imitava il poema dantesco in primis come summa enciclopedica dei saperi del tempo. Nel Regno d Amore, oltre a quella di Cupido, appaiono altre due lunghe digressioni scientifiche: nella prima 32 è la ninfa Taura a parlare delle stelle e delle comete 33, nella seconda 34 è la ninfa Panfia a spiegare il funzionamento dei venti. Nel primo libro tuttavia mancano quelle disquisizioni teologiche e morali che caratterizzeranno fortemente le restanti cantiche. 31 Quadr., I, 14. Arrabbiato poiché Cupido ha colpito e tramortito la sua Taura, Vulcano compare con mille ciclopi e, dopo averlo insultato, si mette a combattere contro di lui. Vulcano scaglia una saetta contro al dio-fanciullo, riuscendo a fondere le sue frecce nella faretra, e rendendole inutilizzabili; Cupido, dal canto suo, incendia con il «fuoco sacro» la barba del dio e i capelli dei suoi ciclopi. Solo l intervento di Giove riuscirà, pur con difficoltà, ad interrompere la zuffa tra i due. 32 Quadr., I, XIII, L introduzione scientifico-aristotelica riecheggia in parte la digressione di Matelda sul perché vi siano acqua e vento nel Paradiso Terrestre (Purg. XXVIII, ). Sono invece evidentissime le analogie tra i versi del poema frezziano («Se l vapor terreo passa l aer gielo, / sottile e secco è ad ardere disposto / più che la stoppa a lume di candelo. / Quand egli vien lassù, dove sta posto / il regno di Vulcan, l accende il foco / nel primo capo, e la fiamma tantosto / per lui trascorre e non a poco a poco, / ma ratto e presto; e la fiamma corrente / pare una stella che tramuti loco») e Par. 15, 13-18, quando, con un analoga similitudine astronomica, Dante descrive l illuminosa apparizione di Cacciaguida («Quale per li seren tranquilli e puri / discorre ad ora ad or subito foco, / movendo li occhi che stavan sicuri, / e pare stella che tramuti loco, / se non che da la parte ond el s accende / nulla sen perde, ed esso dura poco»). Si noti la presenza di un verso identico e la sequenza di rime uguali foco : loco : poco. 33 Come in certi versi dell Inferno, non mancano parti dove il linguaggio si fa bassomimetico. Qui, però, è proprio brutta la similitudine che usa Taura, nei versi , quando, spiegando come fanno le come ad essere infuocate, dice: «Pensa del cibo dentro al corpo umano, / quando è indigesto e quando egli evapora: / il qual, quando è cacciato fuor dell ano, / s infiammeria come trita vernice, / se si scontrasse in acceso vulcano». 34 Quadr., I, 15,
7 Nell ultimo canto emerge il motivo encomiastico: dallo scenario favoloso in cui si era svolta finora la vicenda, si è catapultati alla corte di Ugolino 35 a Foligno, non prima di essersi soffermato sul topos della fondazione della cittadina umbra per opera di un certo Tros, avo dei Trinci, esule troiano come vuole la tradizione. Tra i vari episodi narrati nel Regno d Amore, il più rilevante, per le ricche reminiscenze letterarie, è la trasformazione della ninfa Filena in quercia 36. Palesi sono i modelli cui Frezzi si rivolge: la tragedia di Polidoro trasformato in mirto, in Eneide III; la selva dei suicidi di Inferno XIII, dove è punito, trasformato in «pruno», Pier delle Vigne. I due celebri antecedenti sono brani ricchi di grande pathos: in Virgilio l episodio di Polidoro è particolarmente drammatico, sia per per la cruda immagine del sangue nero che sgorga dalla pianta, sia per il triste racconto di una barbara uccisione subita solo a fini di furto; in Dante la tensione drammatica dell incontro con Pier delle Vigne è ancora maggiore, grazie all ambientazione fosca e alla particolare tortuosità del linguaggio. Come il cancelliere di Federico II, anche la Filena frezziana è trasformata in pianta per punizione divina; però totalmente diverso è il tono della metamorfosi qui descritta, non più patetico, ma dotato di una elegiaca leggerezza. L episodio tratteggiato dal folignate manca di drammaticità, nonostante il fatto che la persona trasformata in pianta, a differenza degli esimi modelli, non sia per il poeta un estranea, tutt altro, si tratta addirittura della ragazza che ama. Ciò è dovuto a molteplici elementi: la scena si svolge in un ambientazione arcadica; la pianta in cui la ninfa viene tramutata non è un rovo, ma una più tranquilla quercia; Frezzi, quando raggiunge la pianta, è già consapevole della sorte dell amata, essendo stato precedentemente avvertito dalla ninfa Rifa; Filena non proferisce parola, a parte un flebile lamento («Oimè! Fa piano!»), quando un suo ramo viene spezzato dal poeta; infine perché la scena si conclude con la comparsa del giocondo Cupido che conduce presto il poeta con sé a caccia di nuove ninfe. 35 Il nome del signore di Foligno è evocato tramite un gioco linguistico: «e dietro al tuo signor movi il cammino / (per U e go, e per quel nominollo), / ch a Pier fu nel papato più vicino» (Quadr. I, 18, 70-72). L ultimo verso allude a san Lino, il secondo papa della storia, che nell anno 67 successe a Pietro sul soglio pontificio. Forse qui Frezzi è memore del gioco linguistico dantesco di Par. VII, 13-15: «Ma quella reverenza che s indonna / di tutto me, pur per Be e per ice, / mi richinava come l om ch assonna». 36 Quadr., I, 4,
8 Ulteriore fonte di ispirazione nell invenzione dell episodio, oltre alle Metamorfosi di Ovidio, fu il Filocolo di Boccaccio, in cui si narravano le trasformazioni di Idalogos in pino 37 e di Fileno in fonte 38. Interessante è anche l incontro di Frezzi con Diana e le sue ninfe, che ricorda quello che vede protagonista Africo nel Ninfale Fiesolano 39. La canzone che le ninfe cantano alla loro regina («O dea sovrana, / benedetta sii tu in ciascun ora, / e benedetti li fonti e li boschi, / dentro alli quai tua deità dimora» 40 ) riecheggia, volta ambito profano, il saluto dei ventiquattro vegliardi della mistica processione della Vergine di Purgatorio, XXIX, («Benedica tue / ne le figlie d Adamo, e benedette / sieno in eterno le bellezze tue!») 41. Frezzi, occultato dietro un albero e intento a spiare la splendida compagnia, ricorda l Atteone delle Metamorfosi ovidiane 42. La lunga olimpiade tra le ninfe 43, cui Frezzi assiste di nascosto, sembra essere una variazione sul tema dei giochi funebri celebrati in Sicilia da Enea in onore del defunto Anchise 44. La consonanza è evidente soprattutto nella gara di tiro con l arco 45 : in entrambi i casi partecipano quattro concorrenti e la vittoria, ottenuta con l ultima frecciata, è frutto dell intervento di una divinità 46. La seguente lite tra due ninfe per la «palma», ricorda un episodio simile del VI libro della Tebaide 47. Onde placare la contesa tra le driade, Diana e Giunone organizzano una battuta di caccia al cervo bianco, animale già protagonista del celebre 37 Cap. VIII. 38 Del rapporto con l opera boccaccesca è conferma lo stesso nome: Fileno, che ricorda la Filena frezziana. 39 Quadr., I, 4; Ninf. Fies Quiadr., I, 4, Frequente è l utilizzo di Frezzi di moduli religiosi di origine dantesca, volti in un uso profano. Le parole che le ninfe Pallia e Lippea rivolgono a Giunone («O regina del cielo, o alta Iuno, / moglie e sorella del superno Iove», Quadr., I, V, 1-2) ricordano l incipit della celebre preghiera di san Bernardo alla Vergine («Vergine madre, figlia del tuo figlio, / umile e alta più che creatura», Par. XXXIII, 1-2). Poco dopo, Quadr., I, 7, 16-18: Lippea, desiderosa di ottendere la ghirlanda meritata per la vittoria alla gara di tiro con l arco, così si rivolge alla stessa Giunone: «Se il pregio mio, regina, non ti piega / mover ti debbe la mia compagnia: / vedi che ognuna per me te ne prega». Ricorda la già gia citata preghiera di san Bernardo: «vedi Beatrice con quanti beati / per li miei preghi ti chiudon le mani» (Par. XXXIII, 38-39). 42 Met. III. Già in precedenza Cupido così aveva avvertito il poeta: «Se Diana ti vede, / come Acteon, quando da lei fu visto, / trasmutar ti farà da capo a piede» (Quadr., I, 2, ). Quando però Federico sarà sorpreso da Diana, nel capitolo VIII, Frezzi, a differenza del suo sfortunato predecessore, ottiene di non essere punito, chiedendo di poter stare nel suo regno come già fece Ippolito. 43 Quadr., I, En. V, 485 ss. 45 Quadr., I, 5, ; En. V, Nell Eneide Giove, nel Quadriregio Cupido. 47 Teb. VI,
9 sonetto CXC del Canzoniere 48, che richiama alla memoria una medesima scena presente in Ninfale Fiesolano, 214 ss. Roma S. CIGADA, La leggenda medievale del Cervo Bianco e le origini della Matière de Bretagne, 32
Trama Turno 1 dichiara a Latino di essere pronto ad attaccare Enea
 Eneide Libro XII Elementi principali: Duello Turno-Enea Sofferenza per la guerra Similitudini con l Iliade e l Odissea Presenza di elementi poetici e politici Trama Turno 1 dichiara a Latino di essere
Eneide Libro XII Elementi principali: Duello Turno-Enea Sofferenza per la guerra Similitudini con l Iliade e l Odissea Presenza di elementi poetici e politici Trama Turno 1 dichiara a Latino di essere
Francesco Petrarca
 Francesco Petrarca 1304-1374 Nacque ad Arezzo da una famiglia fiorentina; successivamente per motivi politici essa fu costretta all esilio presso Carpentras, ad Avignone (Francia), al tempo in cui risiedeva
Francesco Petrarca 1304-1374 Nacque ad Arezzo da una famiglia fiorentina; successivamente per motivi politici essa fu costretta all esilio presso Carpentras, ad Avignone (Francia), al tempo in cui risiedeva
PROGRAMMA DI ITALIANO
 I.I.S. ENZO FERRARI ROMA Sede Via Contardo Ferrini, 83 PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE III SEZIONE B - A F M Anno Scolastico 2015/2016 Per il recupero delle insufficienze gli alunni verranno sottoposti a
I.I.S. ENZO FERRARI ROMA Sede Via Contardo Ferrini, 83 PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE III SEZIONE B - A F M Anno Scolastico 2015/2016 Per il recupero delle insufficienze gli alunni verranno sottoposti a
I.T.I. Giordani Caserta
 I.T.I. Giordani Caserta Prof.ssa De Iorio Rosaria Programma di Italiano A.S. 2014/2015 Classe 3^A T.L. IL MEDIOEVO Il contesto storico e politico La rinascita delle città e la fioritura comunale in Italia
I.T.I. Giordani Caserta Prof.ssa De Iorio Rosaria Programma di Italiano A.S. 2014/2015 Classe 3^A T.L. IL MEDIOEVO Il contesto storico e politico La rinascita delle città e la fioritura comunale in Italia
ISTITUTO CRISTO RE PROGRAMMA SVOLTO LICEO LINGUISTICO. PROGRAMMA SVOLTO a.s Disciplina: ITALIANO. Docente: Laura MASTRANTUONO
 ISTITUTO CRISTO RE LICEO LINGUISTICO PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2016-2017 Disciplina: ITALIANO Docente: Laura MASTRANTUONO Classe: III LINGUISTICO Libro di testo: Baldi-Giusso Storia e testi della letteratura
ISTITUTO CRISTO RE LICEO LINGUISTICO PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2016-2017 Disciplina: ITALIANO Docente: Laura MASTRANTUONO Classe: III LINGUISTICO Libro di testo: Baldi-Giusso Storia e testi della letteratura
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL
 PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s.20123 / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL MEDIOEVO IL CONTESTO STORICO E POLITICO IL MEDIOEVO: La definizione
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s.20123 / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL MEDIOEVO IL CONTESTO STORICO E POLITICO IL MEDIOEVO: La definizione
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA. PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 2015
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 201 Materia d insegnamento: ITALIANO Classe 3^ sezione G Prof.ssa Linda Billi LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 201 Materia d insegnamento: ITALIANO Classe 3^ sezione G Prof.ssa Linda Billi LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
Programma di italiano
 ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. S.BANDINI SIENA Programma di italiano Antologia: TITOLO = SCRITTORI e SCRITTURE Poesia e Teatro AUTORE = A. De Simone C. Gusmini EDIZIONE = Le Monnier La poesia: Gli strumenti
ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. S.BANDINI SIENA Programma di italiano Antologia: TITOLO = SCRITTORI e SCRITTURE Poesia e Teatro AUTORE = A. De Simone C. Gusmini EDIZIONE = Le Monnier La poesia: Gli strumenti
1313 Certaldo, Firenze 1327 Napoli Bardi compagnia mercantile Fiorentina, finanze corte Angioina 34 volontà studi letterari presso la corte Angioina
 1313 Certaldo, Firenze 1327 Napoli Bardi compagnia mercantile Fiorentina, finanze corte Angioina 34 volontà studi letterari presso la corte Angioina Fiammetta Prime opere letterarie 40 Firenze causa fallimento
1313 Certaldo, Firenze 1327 Napoli Bardi compagnia mercantile Fiorentina, finanze corte Angioina 34 volontà studi letterari presso la corte Angioina Fiammetta Prime opere letterarie 40 Firenze causa fallimento
Eneide. Libro II. A cura di D. Belfiori, 4 LSc
 Eneide Libro II A cura di D. Belfiori, 4 LSc La distruzione di Troia Nel libro II dell Eneide viene narrata la presa di Troia da parte degli Achei grazie al genio di Ulisse e all'inganno del cavallo di
Eneide Libro II A cura di D. Belfiori, 4 LSc La distruzione di Troia Nel libro II dell Eneide viene narrata la presa di Troia da parte degli Achei grazie al genio di Ulisse e all'inganno del cavallo di
L ILIADE DI OMERO. Un introduzione PERCHE STUDIARLA?
 L ILIADE DI OMERO Un introduzione PERCHE STUDIARLA? L ILIADE È UNO DEI PIÙ GRANDI POEMI MAI SCRITTI, CHE È ALLA BASE DELLA NOSTRA CULTURA E DELLA NOSTRA CONCEZIONE DEL MONDO. LEGGENDO QUESTO POEMA SI RIESCE
L ILIADE DI OMERO Un introduzione PERCHE STUDIARLA? L ILIADE È UNO DEI PIÙ GRANDI POEMI MAI SCRITTI, CHE È ALLA BASE DELLA NOSTRA CULTURA E DELLA NOSTRA CONCEZIONE DEL MONDO. LEGGENDO QUESTO POEMA SI RIESCE
ZEFIRO TORNA E L BEL TEMPO RIMENA IL CANZONIERE F. PETRARCA
 ZEFIRO TORNA E L BEL TEMPO RIMENA IL CANZONIERE F. PETRARCA Croda Camilla, Simonini Sofia, Dridi Hamza, Aldini Luca ZEFIRO TORNA, E L BEL TEMPO RIMENA Zefiro torna, e 'l bel tempo rimena, e i fiori e l'erbe,
ZEFIRO TORNA E L BEL TEMPO RIMENA IL CANZONIERE F. PETRARCA Croda Camilla, Simonini Sofia, Dridi Hamza, Aldini Luca ZEFIRO TORNA, E L BEL TEMPO RIMENA Zefiro torna, e 'l bel tempo rimena, e i fiori e l'erbe,
 DIVINA COMMEDIA Opera elaborata da Dante tra il 1304 (o 1306) e il 1320-1321, la Divina Commedia appartiene al genere letterario dei poemi allegorico-didascalici che si propongono una funzione educativa
DIVINA COMMEDIA Opera elaborata da Dante tra il 1304 (o 1306) e il 1320-1321, la Divina Commedia appartiene al genere letterario dei poemi allegorico-didascalici che si propongono una funzione educativa
PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 3 SEZIONE I. a.s. 2015/2016 DOCENTE: BALDASSARRE DANIELA DISCIPLINE: ITALIANO - STORIA
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE Di Poppa-Rozzi Via F. Barnabei, 2 Teramo Cod. Fisc. 8003110675 tel.pres. 0861/248215 Segr.0861/247248 Fax : 0861/243136
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE Di Poppa-Rozzi Via F. Barnabei, 2 Teramo Cod. Fisc. 8003110675 tel.pres. 0861/248215 Segr.0861/247248 Fax : 0861/243136
Francesco Petrarca ( )
 Francesco Petrarca (1304 1374) Il Canzoniere Opera scritta dal Petrarca in lingua volgare. Il titolo iniziale dato dall autore era Francisci Petrarche laureati poete Rerum vulgarium fragmenta (Frammenti
Francesco Petrarca (1304 1374) Il Canzoniere Opera scritta dal Petrarca in lingua volgare. Il titolo iniziale dato dall autore era Francisci Petrarche laureati poete Rerum vulgarium fragmenta (Frammenti
DAL GRECO épos = NARRAZIONE, CANTO
 In origine TRAMANDATI ORALMENTE dagli AEDI (cantori e compositori), messi PER SCRITTO dai RAPSODI DAL GRECO épos = NARRAZIONE, CANTO Genere letterario a cui di cui fanno parte le narrazioni in versi, dette
In origine TRAMANDATI ORALMENTE dagli AEDI (cantori e compositori), messi PER SCRITTO dai RAPSODI DAL GRECO épos = NARRAZIONE, CANTO Genere letterario a cui di cui fanno parte le narrazioni in versi, dette
LICEO SCIENTIFICO STATALE
 LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI PdQ - 7.06 Ediz.: 1 Rev.: 0 Data 02/09/05 Alleg.: D01 PROG. M2 PROCEDURA della QUALITA' Programma Didattico Annuale Anno Scolastico 2011/2012 MATERIA : Lingua
LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI PdQ - 7.06 Ediz.: 1 Rev.: 0 Data 02/09/05 Alleg.: D01 PROG. M2 PROCEDURA della QUALITA' Programma Didattico Annuale Anno Scolastico 2011/2012 MATERIA : Lingua
[194] INDICE 68. Preghiera alla Celeste Regina per ogni giorno del mese di Maggio.
![[194] INDICE 68. Preghiera alla Celeste Regina per ogni giorno del mese di Maggio. [194] INDICE 68. Preghiera alla Celeste Regina per ogni giorno del mese di Maggio.](/thumbs/63/49051943.jpg) APPENDICE - Indice del manoscritto 155 [194] INDICE 68 Preghiera alla Celeste Regina per ogni giorno del mese di Maggio. 1º GIORNO della Divina Volontà. Il primo passo della Divina Volontà nell Immacolato
APPENDICE - Indice del manoscritto 155 [194] INDICE 68 Preghiera alla Celeste Regina per ogni giorno del mese di Maggio. 1º GIORNO della Divina Volontà. Il primo passo della Divina Volontà nell Immacolato
Natale è poesia Classe 4 B Anno scolastico 2015/2016
 Natale è poesia Classe 4 B Anno scolastico 2015/2016 Poesia è il mondo, l umanità la propria vita, fioriti nelle parole; è la meraviglia di un delirante fermento. Poesia è Arte ancora prima che,
Natale è poesia Classe 4 B Anno scolastico 2015/2016 Poesia è il mondo, l umanità la propria vita, fioriti nelle parole; è la meraviglia di un delirante fermento. Poesia è Arte ancora prima che,
Le figure di significato. La poesia
 Le figure di significato La poesia Il linguaggio figurato Il poeta usa le parole non solo nel loro significato letterale, ma anche secondo un significato più esteso. Le parole hanno infatti due significati:
Le figure di significato La poesia Il linguaggio figurato Il poeta usa le parole non solo nel loro significato letterale, ma anche secondo un significato più esteso. Le parole hanno infatti due significati:
CAPITOLO I. 1. Che cosa rappresentavano i due disegni fatti dal bambino? 2. Perché nessuno capiva il significato del disegno numero 1?
 ESERCIZI FACILITATI IL FRANKENSTEIN PICCOLO PRINCIPE CAPITOLO I 1. Che cosa rappresentavano i due disegni fatti dal bambino? 2. Perché nessuno capiva il significato del disegno numero 1? 3. Come reagivano
ESERCIZI FACILITATI IL FRANKENSTEIN PICCOLO PRINCIPE CAPITOLO I 1. Che cosa rappresentavano i due disegni fatti dal bambino? 2. Perché nessuno capiva il significato del disegno numero 1? 3. Come reagivano
DAL GRECO épos = NARRAZIONE, CANTO
 DAL GRECO épos = NARRAZIONE, CANTO In origine TRAMANDATI ORALMENTE dagli AEDI (cantori e compositori), messi PER SCRITTO dai RAPSODI Genere letterario a cui appartengono le narrazioni in versi, dette POEMI
DAL GRECO épos = NARRAZIONE, CANTO In origine TRAMANDATI ORALMENTE dagli AEDI (cantori e compositori), messi PER SCRITTO dai RAPSODI Genere letterario a cui appartengono le narrazioni in versi, dette POEMI
GIOVANNI Boccaccio. Contesto Storico Cenni Biografici Opere e Caratteristiche
 GIOVANNI Boccaccio Contesto Storico Cenni Biografici Opere e Caratteristiche Introduzione e contesto storico Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio operano in Italia in quasi un secolo;
GIOVANNI Boccaccio Contesto Storico Cenni Biografici Opere e Caratteristiche Introduzione e contesto storico Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio operano in Italia in quasi un secolo;
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia.
 Salmo 131 1 Canto delle salite. Di Davide. Signore, non si esalta il mio cuore né i miei occhi guardano in alto; non vado cercando cose grandi né meraviglie più alte di me. 2 Io invece resto quieto e sereno:
Salmo 131 1 Canto delle salite. Di Davide. Signore, non si esalta il mio cuore né i miei occhi guardano in alto; non vado cercando cose grandi né meraviglie più alte di me. 2 Io invece resto quieto e sereno:
Questa tua parola non avrà mai fine,ha varcato i cieli e porterà il suo frutto.
 AVE MARIA (BALDUZZI/CASUCCI) Donna del presente e madre del ritorno / Donna della terra e madre dell amore / Donna dell attesa e madre di speranza / Donna del sorriso e madre del silenzio / Ave Maria,
AVE MARIA (BALDUZZI/CASUCCI) Donna del presente e madre del ritorno / Donna della terra e madre dell amore / Donna dell attesa e madre di speranza / Donna del sorriso e madre del silenzio / Ave Maria,
Programma recupero debito e lavoro estivo assegnato
 SCUOLA: ANNO SCOLASTICO Istituto Alberghiero 2014/2015 DISCIPLINA: Italiano DOCENTE: Citterio Letizia CLASSE: ALB 3 C Programma recupero ANALISI DEL PERIODO LA POESIA RELIGIOSA IN ITALIA SAN FRANCESCO
SCUOLA: ANNO SCOLASTICO Istituto Alberghiero 2014/2015 DISCIPLINA: Italiano DOCENTE: Citterio Letizia CLASSE: ALB 3 C Programma recupero ANALISI DEL PERIODO LA POESIA RELIGIOSA IN ITALIA SAN FRANCESCO
Tanto gentile e tanto onesta pare Dante, La vita nova ( )
 Tanto gentile e tanto onesta pare Dante, La vita nova (1293-1295) Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand ella altrui saluta, ch ogne lingua deven tremando muta, e li occhi no l ardiscon di
Tanto gentile e tanto onesta pare Dante, La vita nova (1293-1295) Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand ella altrui saluta, ch ogne lingua deven tremando muta, e li occhi no l ardiscon di
CONCLUSIONI. 1 Quadr., III, 2, 89.
 F CONCLUSIONI ederico Frezzi viene generalmente considerato l epigono per eccellenza tra gli autori trecenteschi che hanno scritto poemi rifacendosi al modello della Divina Commedia: per la palese vicinanza
F CONCLUSIONI ederico Frezzi viene generalmente considerato l epigono per eccellenza tra gli autori trecenteschi che hanno scritto poemi rifacendosi al modello della Divina Commedia: per la palese vicinanza
NOVENA a Maria santissima Regina e Madre di tutte le grazie
 P.A.S. Appunti NOVENA a Maria santissima Regina e Madre di tutte le grazie Personale PAS NOVENA ALLA MADONNA DELLE GRAZIE 1. - Primo giorno. Clemenza, perdono, amore. A te, Madre santa, Regina delle grazie,
P.A.S. Appunti NOVENA a Maria santissima Regina e Madre di tutte le grazie Personale PAS NOVENA ALLA MADONNA DELLE GRAZIE 1. - Primo giorno. Clemenza, perdono, amore. A te, Madre santa, Regina delle grazie,
Vita nova: struttura e temi. PER APPROFONDIRE: STEFANO CARRAI, Dante elegiaco. Una chiave di lettura per la Vita nova, Firenze, Olschki, 2006
 Vita nova: struttura e temi PER APPROFONDIRE: STEFANO CARRAI, Dante elegiaco. Una chiave di lettura per la Vita nova, Firenze, Olschki, 2006 La vita nuova: struttura La Vita nuova è una raccolta di trentuno
Vita nova: struttura e temi PER APPROFONDIRE: STEFANO CARRAI, Dante elegiaco. Una chiave di lettura per la Vita nova, Firenze, Olschki, 2006 La vita nuova: struttura La Vita nuova è una raccolta di trentuno
Il monte Olimpo: la dimora degli dei
 Il monte Olimpo: la dimora degli dei La religione professata dai Greci era basata, come quella cretese da cui derivava, sulla personificazione delle forze della natura. Tali forze erano dominate dalle
Il monte Olimpo: la dimora degli dei La religione professata dai Greci era basata, come quella cretese da cui derivava, sulla personificazione delle forze della natura. Tali forze erano dominate dalle
Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ
 Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ Dio Padre è sempre con noi Non siamo mai soli Leggi il catechismo Cosa abbiamo imparato Nella fatica sei con noi, Signore Leggi il catechismo
Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ Dio Padre è sempre con noi Non siamo mai soli Leggi il catechismo Cosa abbiamo imparato Nella fatica sei con noi, Signore Leggi il catechismo
Dio ha creato l uomo perché ama le storie E.Wiesel
 Dio ha creato l uomo perché ama le storie E.Wiesel GLI UOMINI DI FRONTE ALLA NATURA Tutti gli uomini naturalmente desiderano conoscere Aristotele Grotta delle mani, Patagonia Uomini antichi di fronte alla
Dio ha creato l uomo perché ama le storie E.Wiesel GLI UOMINI DI FRONTE ALLA NATURA Tutti gli uomini naturalmente desiderano conoscere Aristotele Grotta delle mani, Patagonia Uomini antichi di fronte alla
II DOMENICA DOPO NATALE
 II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
ISTITUTO COMPRENSIVO A. FUSINATO SCHIO SCUOLA DELL INFANZIA A.ROSSI ATTIVITA DI PLESSO SIAMO TUTTI UGUALI SIAMO TUTTI DIVERSI!
 ISTITUTO COMPRENSIVO A. FUSINATO SCHIO SCUOLA DELL INFANZIA A.ROSSI ATTIVITA DI PLESSO SIAMO TUTTI UGUALI SIAMO TUTTI DIVERSI! ANNO SCOLASTICO 2013/2014 GUIZZINO In un angolo lontano del mare, viveva una
ISTITUTO COMPRENSIVO A. FUSINATO SCHIO SCUOLA DELL INFANZIA A.ROSSI ATTIVITA DI PLESSO SIAMO TUTTI UGUALI SIAMO TUTTI DIVERSI! ANNO SCOLASTICO 2013/2014 GUIZZINO In un angolo lontano del mare, viveva una
Donato Panza UNA POESIA PER TE
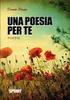 Una poesia per te Donato Panza UNA POESIA PER TE poesie Dedico questo libro alle persone a me più care, alla mia mamma, al mio papà, alla mia amata sorella Maria, e al mio secondo papà Donato. A tutti
Una poesia per te Donato Panza UNA POESIA PER TE poesie Dedico questo libro alle persone a me più care, alla mia mamma, al mio papà, alla mia amata sorella Maria, e al mio secondo papà Donato. A tutti
LA DIVINA COMMEDIA Prof.ssa Bosisio
 LA DIVINA COMMEDIA Prof.ssa Bosisio È UN OPERA FONDAMENTALE DELLA LETTERATURA ITALIANA: Si fondono (uniscono) in una sintesi straordinaria tutti gli aspetti del sapere medievale. Affronta temi e argomenti
LA DIVINA COMMEDIA Prof.ssa Bosisio È UN OPERA FONDAMENTALE DELLA LETTERATURA ITALIANA: Si fondono (uniscono) in una sintesi straordinaria tutti gli aspetti del sapere medievale. Affronta temi e argomenti
Pontificio Santuario della. Maggio Con Papa Francesco contempliamo Maria, Madre di Speranza. Schema 3 (dal 18 al 23 maggio)
 Pontificio Santuario della BEATA VERGINE del Santo Rosario di Pompei Buongiorno a Maria Maggio 2015 Con Papa Francesco contempliamo Maria, Madre di Speranza Schema 3 (dal 18 al 23 maggio) Mentre viene
Pontificio Santuario della BEATA VERGINE del Santo Rosario di Pompei Buongiorno a Maria Maggio 2015 Con Papa Francesco contempliamo Maria, Madre di Speranza Schema 3 (dal 18 al 23 maggio) Mentre viene
L opera artistica rinasce in forma digitale, le materie si fondono, scultura antica e contemporaneo rivivono una nuova forza espressiva.
 www.venereadone.com La collezione vuole dare una nuova interpretazione all arte classica, fondendo le nuove prospettive della Digital Art con la plasticità dell opera scultorea. L opera artistica rinasce
www.venereadone.com La collezione vuole dare una nuova interpretazione all arte classica, fondendo le nuove prospettive della Digital Art con la plasticità dell opera scultorea. L opera artistica rinasce
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
 ANNO SCOLASTICO: 2015-2016 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO Insegnante: Prof.ssa Micaela Degiovanni CLASSE: 3B Liceo Scientifico Ordinamentale Materia d insegnamento: Lingua e letteratura italiana LETTERATURA
ANNO SCOLASTICO: 2015-2016 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO Insegnante: Prof.ssa Micaela Degiovanni CLASSE: 3B Liceo Scientifico Ordinamentale Materia d insegnamento: Lingua e letteratura italiana LETTERATURA
PROGRAMMA DI ITALIANO DELLA CLASSE III A
 PROGRAMMA DI ITALIANO DELLA CLASSE III A 1) La poesia francese medievale: chanson de geste, lirica trobadorica, romanzo cortese. a) La morte di Orlando b) Can vei la lauzeta mover di Bertrand de Ventadorn
PROGRAMMA DI ITALIANO DELLA CLASSE III A 1) La poesia francese medievale: chanson de geste, lirica trobadorica, romanzo cortese. a) La morte di Orlando b) Can vei la lauzeta mover di Bertrand de Ventadorn
Le poesie del divino amore
 Le poesie del divino amore Fernando Isacco Benato LE POESIE DEL DIVINO AMORE Poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2016 Fernando Isacco Benato Tutti i diritti riservati L amore di due angeli Ho visto
Le poesie del divino amore Fernando Isacco Benato LE POESIE DEL DIVINO AMORE Poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2016 Fernando Isacco Benato Tutti i diritti riservati L amore di due angeli Ho visto
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE "ARTURO FERRARIN" CATANIA
 Anno Scolastico 2015-2016 PROGRAMMA ITALIANO CLASSE III E Prof. ssa Alberti Rosa Testo: La Letteratura, Dalle origini al Cinquecento Autori: G: Barberi Squarotti, G. Balbis, G. Genghini IL MEDIOEVO Capitolo
Anno Scolastico 2015-2016 PROGRAMMA ITALIANO CLASSE III E Prof. ssa Alberti Rosa Testo: La Letteratura, Dalle origini al Cinquecento Autori: G: Barberi Squarotti, G. Balbis, G. Genghini IL MEDIOEVO Capitolo
LITANIE MARIANE DOMENICANE. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi
 LITANIE MARIANE DOMENICANE Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Cristo, ascoltaci Cristo esaudiscici Padre celeste, Dio, abbi misericordia
LITANIE MARIANE DOMENICANE Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Cristo, ascoltaci Cristo esaudiscici Padre celeste, Dio, abbi misericordia
SCHEDA DEL PROGRAMMA PREVENTIVO
 SCHEDA DEL PROGRAMMA PREVENTIVO Disciplina ITALIANO (STORIA DELLA LETTERATURA) Classe.Terza N-R argomento contenuti tempi abilità metodologia didattica Il Medioevo Le parole chiave: Medioevo, Acquisire
SCHEDA DEL PROGRAMMA PREVENTIVO Disciplina ITALIANO (STORIA DELLA LETTERATURA) Classe.Terza N-R argomento contenuti tempi abilità metodologia didattica Il Medioevo Le parole chiave: Medioevo, Acquisire
IL LIBRO DELL APOCALISSE LA CROCE DI CRISTO COME TRIONFO
 IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
L ANNUNCIO DI PASQUA Luca 24, 1-10
 L ANNUNCIO DI PASQUA Luca 24, 1-10 Arcabas - Chiesa della Risurrezione - Comunità Nazareth - Torre de Roveri (Bg) Buio e luce Di buon mattino.... Sul fondo della valle la notte lotta contro il giorno.
L ANNUNCIO DI PASQUA Luca 24, 1-10 Arcabas - Chiesa della Risurrezione - Comunità Nazareth - Torre de Roveri (Bg) Buio e luce Di buon mattino.... Sul fondo della valle la notte lotta contro il giorno.
IIS CHINO CHINI - BORGO SAN LORENZO PROGRAMMA SVOLTO - ANNO SCOLASTICO
 IIS CHINO CHINI - BORGO SAN LORENZO PROGRAMMA SVOLTO - ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Docente _Poli Chiaretta Maria Materia LIANO Classe _3AA Indirizzo SOCIO-SANRIO 1. ARGOMENTI /MODULI SVOLTI PREVISTI DAL
IIS CHINO CHINI - BORGO SAN LORENZO PROGRAMMA SVOLTO - ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Docente _Poli Chiaretta Maria Materia LIANO Classe _3AA Indirizzo SOCIO-SANRIO 1. ARGOMENTI /MODULI SVOLTI PREVISTI DAL
Era la storia del suo sogno.
 Eravamo in un prato pieno di fiori colorati con farfalle che andavano a prendere il polline. Si sentiva un profumo buonissimo. Veniva dai petali rossi, gialli, rosa e bianchi. Era giorno; il cielo era
Eravamo in un prato pieno di fiori colorati con farfalle che andavano a prendere il polline. Si sentiva un profumo buonissimo. Veniva dai petali rossi, gialli, rosa e bianchi. Era giorno; il cielo era
Protocollo dei saperi imprescindibili. a.s LICEO MUSICALE
 CLASSE: 1 Grammatica: verbo, pronome, congiunzioni e connettivi logici, soggetto, predicato. Il testo narrativo letterario: tecniche narrative, sequenze, narratore, personaggi, figure retoriche. Brani:
CLASSE: 1 Grammatica: verbo, pronome, congiunzioni e connettivi logici, soggetto, predicato. Il testo narrativo letterario: tecniche narrative, sequenze, narratore, personaggi, figure retoriche. Brani:
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
Opere di Dante. Convivio E un opera nella quale Dante esalta la filosofia e la sapienza. E composto da prose e poesie.
 Contesto storico L epoca in cui vive Dante (XIII secolo) è caratterizzata da profonde contraddizioni e contrasti tra le tre grandi forze che dominano l Europa: il papato, l impero e i Comuni. La Chiesa
Contesto storico L epoca in cui vive Dante (XIII secolo) è caratterizzata da profonde contraddizioni e contrasti tra le tre grandi forze che dominano l Europa: il papato, l impero e i Comuni. La Chiesa
BENVENUTO IO HO UNA GIOIA NEL CUORE
 Marina di Carrara, 12 ottobre 2014 BENVENUTO Benvenuto benvenuto, benvenuto a te! (x2) Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che... l'amore ci unisce nel Signore. (x2) IO HO UNA GIOIA NEL CUORE Io ho una gioia
Marina di Carrara, 12 ottobre 2014 BENVENUTO Benvenuto benvenuto, benvenuto a te! (x2) Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che... l'amore ci unisce nel Signore. (x2) IO HO UNA GIOIA NEL CUORE Io ho una gioia
LICEO SCIENTIFICO STATALE C. CATTANEO - TORINO. Programma di Latino Classe V P a.s. 2015/2016
 LICEO SCIENTIFICO STATALE C. CATTANEO - TORINO Programma di Latino Classe V P a.s. 2015/2016 Prof.ssa Federica Cusseddu Testo in uso: GARBARINO-PASQUARIELLO, Veluti flos, Paravia La lingua e la letteratura
LICEO SCIENTIFICO STATALE C. CATTANEO - TORINO Programma di Latino Classe V P a.s. 2015/2016 Prof.ssa Federica Cusseddu Testo in uso: GARBARINO-PASQUARIELLO, Veluti flos, Paravia La lingua e la letteratura
Caratteristiche della poesia ermetica
 Corrente ermetica È da inquadrare nel periodo che va più o meno dal 1915 al 1930. Si parla di corrente perché non ne sono definite le tecniche e gli autori non partecipano coscientemente ad un progetto
Corrente ermetica È da inquadrare nel periodo che va più o meno dal 1915 al 1930. Si parla di corrente perché non ne sono definite le tecniche e gli autori non partecipano coscientemente ad un progetto
Le strade dell amore. L amore è nel cuore
 Le strade dell amore L amore è nel cuore Ogni riferimento a fatti realmente accaduti e/o a persone realmente esistenti è da ritenersi puramente casuale. Maria Loreta Gallo LE STRADE DELL AMORE L amore
Le strade dell amore L amore è nel cuore Ogni riferimento a fatti realmente accaduti e/o a persone realmente esistenti è da ritenersi puramente casuale. Maria Loreta Gallo LE STRADE DELL AMORE L amore
Sogno di una speranza
 Sogno di una speranza Susanna Nicoletti SOGNO DI UNA SPERANZA poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2014 Susanna Nicoletti Tutti i diritti riservati A volte vorrei cambiare tutto A volte vorrei non
Sogno di una speranza Susanna Nicoletti SOGNO DI UNA SPERANZA poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2014 Susanna Nicoletti Tutti i diritti riservati A volte vorrei cambiare tutto A volte vorrei non
 Sesto incontro Oggi vi parlerò del rito del Battesimo. Il battezzando viene accolto nella famiglia di Dio di cui entrerà a far parte. Il ministro chiede ai genitori il nome che gli vogliono dare. Con il
Sesto incontro Oggi vi parlerò del rito del Battesimo. Il battezzando viene accolto nella famiglia di Dio di cui entrerà a far parte. Il ministro chiede ai genitori il nome che gli vogliono dare. Con il
Una notte sotto le stelle
 Una notte sotto le stelle Impariamo a guardare il cielo Non occorre essere degli esperti per rimanere colpiti dalla bellezza delle stelle, e saper riconoscere stelle e pianeti dà una soddisfazione in più!
Una notte sotto le stelle Impariamo a guardare il cielo Non occorre essere degli esperti per rimanere colpiti dalla bellezza delle stelle, e saper riconoscere stelle e pianeti dà una soddisfazione in più!
Dante venne considerato il Padre della lingua italiana e la Divina Commedia il poema nazionale italiano
 DANTE ALIGHIERI Nasce nel 1265 (medioevo) a Firenze da una famiglia della piccola nobiltà, si dedica alla poesia ed è un rappresentante del DOLCE STIL NOVO un nuovo modo di esprimere i sentimenti attraverso
DANTE ALIGHIERI Nasce nel 1265 (medioevo) a Firenze da una famiglia della piccola nobiltà, si dedica alla poesia ed è un rappresentante del DOLCE STIL NOVO un nuovo modo di esprimere i sentimenti attraverso
I vignaioli. Riferimento biblico: Matteo 20, 1-16
 I vignaioli Riferimento biblico: Matteo 20, 1-16 Introduzione: Così infatti è il regno di Dio - comincia a spiegare Gesù, circondato da tanta gente che lo sta ascoltando attentamente Un signore era padrone
I vignaioli Riferimento biblico: Matteo 20, 1-16 Introduzione: Così infatti è il regno di Dio - comincia a spiegare Gesù, circondato da tanta gente che lo sta ascoltando attentamente Un signore era padrone
L età cortese XI-XIII secolo. Pearson Italia S.p.a.
 L età cortese XI-XIII secolo Cultura e mentalità in Francia verso la fine dell XI secolo rafforzamento della cavalleria esigenza di una nuova produzione letteraria in lingua volgare cavalleria: classe
L età cortese XI-XIII secolo Cultura e mentalità in Francia verso la fine dell XI secolo rafforzamento della cavalleria esigenza di una nuova produzione letteraria in lingua volgare cavalleria: classe
SIMBOLOGIA DELL APOCALISSE. 27/10/2010 Parrocchia "Maria Ss. Assunta" - Biccari
 SIMBOLOGIA DELL APOCALISSE 1 I simboli dell Apocalisse non sono nuovi nuovi ma sono presi dall A.T. soprattutto dal profeta Daniele. 1. Cfr. Dn 7: le 4 grandi bestie che salivano dal mare 2. Cfr. Ap 13,1.11:
SIMBOLOGIA DELL APOCALISSE 1 I simboli dell Apocalisse non sono nuovi nuovi ma sono presi dall A.T. soprattutto dal profeta Daniele. 1. Cfr. Dn 7: le 4 grandi bestie che salivano dal mare 2. Cfr. Ap 13,1.11:
Programma di Italiano A.S. 2012/2013
 Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" Palermo Programma di Italiano A.S. 2012/2013 Classe: III E Prof.ssa Calogera Rita Tiranno Libri di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La scrittura
Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" Palermo Programma di Italiano A.S. 2012/2013 Classe: III E Prof.ssa Calogera Rita Tiranno Libri di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La scrittura
Pregare il Rosario, è cogliere dal giardino del proprio cuore delle belle rose per offrirle a Maria. Questo opuscolo ha lo scopo di aiutare il
 Pregare il Rosario, è cogliere dal giardino del proprio cuore delle belle rose per offrirle a Maria. Questo opuscolo ha lo scopo di aiutare il bambino a pregare il Rosario in famiglia. 36 1 Credo in un
Pregare il Rosario, è cogliere dal giardino del proprio cuore delle belle rose per offrirle a Maria. Questo opuscolo ha lo scopo di aiutare il bambino a pregare il Rosario in famiglia. 36 1 Credo in un
Introduzione alla storia lezione 3. Prof. Marco Bartoli
 Introduzione alla storia lezione 3 Prof. Marco Bartoli Le metafore Dicevamo, la scorsa lezione, che le domande storiche sono quelle che trasformano gli interrogativi sul presente in interrogativi sul passato.
Introduzione alla storia lezione 3 Prof. Marco Bartoli Le metafore Dicevamo, la scorsa lezione, che le domande storiche sono quelle che trasformano gli interrogativi sul presente in interrogativi sul passato.
CONSIGLIO. consigliare ed ascoltare col cuore
 CONSIGLIO consigliare ed ascoltare col cuore IL DONO DEL CONSIGLIO Il dono del CONSIGLIO è la luce e la guida spirituale che ci orienta lungo il cammino della vita, che ci fa fare le scelte giuste per
CONSIGLIO consigliare ed ascoltare col cuore IL DONO DEL CONSIGLIO Il dono del CONSIGLIO è la luce e la guida spirituale che ci orienta lungo il cammino della vita, che ci fa fare le scelte giuste per
ODISSEA E ENEIDE: DUE VIAGGI A CONFRONTO
 ODISSEA E ENEIDE: DUE VIAGGI A CONFRONTO Due eroi della guerra di Troia, un greco e un troiano, affrontano due viaggi pieni di ostacoli e imprevisti: il greco Odisseo cerca di tornare a casa nella sua
ODISSEA E ENEIDE: DUE VIAGGI A CONFRONTO Due eroi della guerra di Troia, un greco e un troiano, affrontano due viaggi pieni di ostacoli e imprevisti: il greco Odisseo cerca di tornare a casa nella sua
ADORAZIONE EUCARISTICA MESE DI MAGGIO
 ADORAZIONE EUCARISTICA MESE DI MAGGIO 2012 - Madre, Madre della Redenzione Mamma!... Come Te, nessuna. Madre, Madre della Redenzione. Vergine, Vergine Immacolata, concepita senza peccato originale, preservata
ADORAZIONE EUCARISTICA MESE DI MAGGIO 2012 - Madre, Madre della Redenzione Mamma!... Come Te, nessuna. Madre, Madre della Redenzione. Vergine, Vergine Immacolata, concepita senza peccato originale, preservata
PRESENTAZIONE ESTATE RAGAZZI Associazione Culturale Artemide
 PRESENTAZIONE ESTATE RAGAZZI 2012 Associazione Culturale Artemide Artemid E EDUC AZIONE E DUCERE da fuori.portare dentro AGENZIE EDUCATIVE LA FAMIGLIA LA SCUOLA LA COMUNITA» PARROCCHIA» ATTIVITA SPORTIVE»
PRESENTAZIONE ESTATE RAGAZZI 2012 Associazione Culturale Artemide Artemid E EDUC AZIONE E DUCERE da fuori.portare dentro AGENZIE EDUCATIVE LA FAMIGLIA LA SCUOLA LA COMUNITA» PARROCCHIA» ATTIVITA SPORTIVE»
Lectio divina. Alla scuola di un Amore fuori misura. A cura di Vito Cassone Anno II/7 26 dicembre 2010 FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
 Lectio divina Alla scuola di un Amore fuori misura A cura di Vito Cassone Anno II/7 26 dicembre 2010 FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA Lectio Divina DOMENICA FRA L'OTTAVA DI NATALE SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA
Lectio divina Alla scuola di un Amore fuori misura A cura di Vito Cassone Anno II/7 26 dicembre 2010 FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA Lectio Divina DOMENICA FRA L'OTTAVA DI NATALE SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA
1 Concorso letterario Albero abbraccio e respiro del mondo. SEZIONE A - Scuola Primaria
 Giornata Nazionale dell Albero 21 novembre 2012 1 Concorso letterario Albero abbraccio e respiro del mondo SEZIONE A - Scuola Primaria Mentre gioco il sole tramonta odore di resina pianto di un albero
Giornata Nazionale dell Albero 21 novembre 2012 1 Concorso letterario Albero abbraccio e respiro del mondo SEZIONE A - Scuola Primaria Mentre gioco il sole tramonta odore di resina pianto di un albero
Dante Alighieri. La Commedia II C
 Dante Alighieri La Commedia STRUTTURA 14.223 endecasillabi in 100 canti 3 cantiche di 33 canti l una (+ 1 introduttivo) metro: terzina a rima incatenata ABA-BCB-CDC simmetria costruita sulla combinazione
Dante Alighieri La Commedia STRUTTURA 14.223 endecasillabi in 100 canti 3 cantiche di 33 canti l una (+ 1 introduttivo) metro: terzina a rima incatenata ABA-BCB-CDC simmetria costruita sulla combinazione
Dante Alighieri. La vita e le idee
 Dante Alighieri La vita e le idee La vita Poche sono le notizie certe Nasce a Firenze tra il 14 maggio e il 13 giugno 1265 La famiglia appartiene alla piccola nobiltà cittadina 1277: a soli 12 anni è promesso
Dante Alighieri La vita e le idee La vita Poche sono le notizie certe Nasce a Firenze tra il 14 maggio e il 13 giugno 1265 La famiglia appartiene alla piccola nobiltà cittadina 1277: a soli 12 anni è promesso
MISTERI DEL DOLORE 3. GESU E CORONATO DI SPINE
 MISTERI DEL DOLORE 1. GESU PREGA NELL ORTO DEGLI ULIVI La vigilia della sua passione, dopo aver cenato con gli apostoli, Gesù si reca in un orto vicino a Gerusalemme. E notte. Gli apostoli che lo accompagnano
MISTERI DEL DOLORE 1. GESU PREGA NELL ORTO DEGLI ULIVI La vigilia della sua passione, dopo aver cenato con gli apostoli, Gesù si reca in un orto vicino a Gerusalemme. E notte. Gli apostoli che lo accompagnano
Il medioevo si estende per nove secoli, e la sua cultura è diffusa in tutta l Europa occidentale per mezzo del Latino.
 La cultura medievale Il medioevo si estende per nove secoli, e la sua cultura è diffusa in tutta l Europa occidentale per mezzo del Latino. E una cultura Cristiana, che affronta i problemi alla luce della
La cultura medievale Il medioevo si estende per nove secoli, e la sua cultura è diffusa in tutta l Europa occidentale per mezzo del Latino. E una cultura Cristiana, che affronta i problemi alla luce della
Definizione del termine Barocco e origine. Contesto storico. Caratteristiche generali. Sperimentalismo. Generi Letterari Tematiche Linguistico
 IL BAROCCO Definizione del termine Barocco e origine Contesto storico Caratteristiche generali Sperimentalismo Generi Letterari Tematiche Linguistico Con termine Barocco indichiamo la produzione artistica
IL BAROCCO Definizione del termine Barocco e origine Contesto storico Caratteristiche generali Sperimentalismo Generi Letterari Tematiche Linguistico Con termine Barocco indichiamo la produzione artistica
Parrocchia san Giovanni Battista Casperia
 Parrocchia san Giovanni Battista Casperia Con le lampade accese incamminiamoci verso l Oriente, Incontro allo Sposo che viene! La corona, che accompagna la famiglia nelle quattro domeniche dell Avvento,
Parrocchia san Giovanni Battista Casperia Con le lampade accese incamminiamoci verso l Oriente, Incontro allo Sposo che viene! La corona, che accompagna la famiglia nelle quattro domeniche dell Avvento,
Paola Pámpana. Tra toga e politica. Un avvocato racconta. Edizioni ETS
 Paola Pámpana Tra toga e politica Un avvocato racconta Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2016 Edizioni ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com Distribuzione
Paola Pámpana Tra toga e politica Un avvocato racconta Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2016 Edizioni ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com Distribuzione
Il genere epico: un viaggio nel tempo sulle ali della fantasia
 Il genere epico: un viaggio nel tempo sulle ali della fantasia classe I prof.ssa Alessia Riccardi 1 Oggi racconteremo la storia di un uomo che, come un moderno supereroe, è dotato di un poteri eccezionali:
Il genere epico: un viaggio nel tempo sulle ali della fantasia classe I prof.ssa Alessia Riccardi 1 Oggi racconteremo la storia di un uomo che, come un moderno supereroe, è dotato di un poteri eccezionali:
Protocollo dei saperi imprescindibili a.s. 2015-2016. Ordine di scuola: tecnico grafico
 INDICE PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 1 P. 2 PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 2 P. 3 PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 3 P. 4 PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 4 P. 5 PROTOCOLLO
INDICE PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 1 P. 2 PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 2 P. 3 PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 3 P. 4 PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 4 P. 5 PROTOCOLLO
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito
 INCONTRO UNITARIO NELLA FEDE Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito Domenica 14 giugno 2015 DIOCESI DI MILANO SERVIZIO PER LA FAMIGLIA - ZONA MILANO Centro Rosetum Via Pisanello n. 1 h. 17.00 Introduzione
INCONTRO UNITARIO NELLA FEDE Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito Domenica 14 giugno 2015 DIOCESI DI MILANO SERVIZIO PER LA FAMIGLIA - ZONA MILANO Centro Rosetum Via Pisanello n. 1 h. 17.00 Introduzione
ORVIETOFEST MIRACOLO DI BELLEZZA GIUGNO 2016
 MIRACOLO DI BELLEZZA ORVIETOFEST 17-18-19 GIUGNO 2016 per sfogliare fai click con il tasto sinistro o destro del mouse oppure con > e < sulla tastiera Il tema di questa edizione prende spunto dall enciclica
MIRACOLO DI BELLEZZA ORVIETOFEST 17-18-19 GIUGNO 2016 per sfogliare fai click con il tasto sinistro o destro del mouse oppure con > e < sulla tastiera Il tema di questa edizione prende spunto dall enciclica
I Pro I Pr m o e m ss s i S s po i S sis I Promessi Sposi genere let- terario del romanzo storico è ambientato in un preciso periodo storico
 I Promessi Sposi I Promessi Sposi appartengono al genere letterario del romanzo storico: tutto quello che viene narrato infatti è ambientato in un preciso periodo storico che viene ricostruito con grande
I Promessi Sposi I Promessi Sposi appartengono al genere letterario del romanzo storico: tutto quello che viene narrato infatti è ambientato in un preciso periodo storico che viene ricostruito con grande
SAN GIOVANNI XXIII, papa
 11 ottobre SAN GIOVANNI XXIII, papa Dal Comune dei pastori: per un papa. COLLETTA Dio onnipotente ed eterno, che in san Giovanni, papa, hai fatto risplendere in tutto il mondo l immagine viva di Cristo,
11 ottobre SAN GIOVANNI XXIII, papa Dal Comune dei pastori: per un papa. COLLETTA Dio onnipotente ed eterno, che in san Giovanni, papa, hai fatto risplendere in tutto il mondo l immagine viva di Cristo,
OGGI VI RACCONTIAMO COME E FATTO IL SISTEMA SOLARE
 OGGI VI RACCONTIAMO COME E FATTO IL SISTEMA SOLARE Anche il cielo fa parte dell ambiente in cui viviamo e basta un attimo per vedere come cambia di continuo, ma puoi cominciare a guardare il cielo, lo
OGGI VI RACCONTIAMO COME E FATTO IL SISTEMA SOLARE Anche il cielo fa parte dell ambiente in cui viviamo e basta un attimo per vedere come cambia di continuo, ma puoi cominciare a guardare il cielo, lo
LA BIANCA COLOMBA CHE SCENDE DAL CIELO
 LA BIANCA COLOMBA CHE SCENDE DAL CIELO Legenda dell immagine di copertina: La Bianca Colomba custodisce relazioni di pace. 2 LA BIANCA COLOMBA CHE SCENDE DAL CIELO Racconto di Silva Maria Stefanutti Illustrazioni
LA BIANCA COLOMBA CHE SCENDE DAL CIELO Legenda dell immagine di copertina: La Bianca Colomba custodisce relazioni di pace. 2 LA BIANCA COLOMBA CHE SCENDE DAL CIELO Racconto di Silva Maria Stefanutti Illustrazioni
ULISSE (Al timoniere, invisible). Tieniti al largo perché ci avviciniamo all isola di Calipso.
 Quinto Quadro : Il viaggio nell oceano (Sulla nave) SCENA PRIMA (Ulisse e Nausica) ULISSE (Al timoniere, invisible). Tieniti al largo perché ci avviciniamo all isola di Calipso. Dov è Calipso? Vedi? (Indicando
Quinto Quadro : Il viaggio nell oceano (Sulla nave) SCENA PRIMA (Ulisse e Nausica) ULISSE (Al timoniere, invisible). Tieniti al largo perché ci avviciniamo all isola di Calipso. Dov è Calipso? Vedi? (Indicando
CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V
 ISTITUTO COMPRENSIVO 4 - CORPORENO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V Anno scolastico 2015 2016 CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^ Anno
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 - CORPORENO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V Anno scolastico 2015 2016 CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^ Anno
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA Fossalto. Preghiera di benedizione della casa
 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA Fossalto Preghiera di benedizione della casa Benedizione pasquale della casa La benedizione Pasquale è una tradizione molto antica e ha come scopo di far entrare nella famiglia
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA Fossalto Preghiera di benedizione della casa Benedizione pasquale della casa La benedizione Pasquale è una tradizione molto antica e ha come scopo di far entrare nella famiglia
Giuliani. Santa. via Crucis con. eronica 2,00. «La croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha risposto al male del mondo, una parola che è amore,
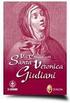 «La croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha risposto al male del mondo, una parola che è amore, misericordia, perdono. La parola della croce è anche la risposta dei cristiani al male che continua ad agire
«La croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha risposto al male del mondo, una parola che è amore, misericordia, perdono. La parola della croce è anche la risposta dei cristiani al male che continua ad agire
Esami di Idoneità/Integrativi. Liceo delle Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico
 Esami di Idoneità/Integrativi Liceo delle Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico Materia: Italiano Alla Classe seconda Contenuti essenziali La riflessione sulla lingua: la fonologia le regole
Esami di Idoneità/Integrativi Liceo delle Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico Materia: Italiano Alla Classe seconda Contenuti essenziali La riflessione sulla lingua: la fonologia le regole
27 marzo 2016 Domenica di Pasqua
 27 marzo 2016 Domenica di Pasqua Nei cieli un grido risuonò, alleluia! Cristo Signore trionfò: alleluia! Morte di Croce egli patì: alleluia! Ora al suo cielo risalì: alleluia! Cristo ora è vivo in mezzo
27 marzo 2016 Domenica di Pasqua Nei cieli un grido risuonò, alleluia! Cristo Signore trionfò: alleluia! Morte di Croce egli patì: alleluia! Ora al suo cielo risalì: alleluia! Cristo ora è vivo in mezzo
Dante e noi. PROVA DI COMPRENSIONE SCRITTA (per avanzati) Roberta Grassi Didattica della Lingua italiana (a stranieri) Mat. 3. Nome Cognome Matr.
 Nome Cognome Matr.: Data PROVA DI COMPRENSIONE SCRITTA (per avanzati) Testo tratto da G. Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana Dante e noi Gli storici della lingua notano che proprio a partire
Nome Cognome Matr.: Data PROVA DI COMPRENSIONE SCRITTA (per avanzati) Testo tratto da G. Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana Dante e noi Gli storici della lingua notano che proprio a partire
La spiritualità dell animatore. Giacomo Prati
 + La spiritualità dell animatore Giacomo Prati + La spiritualità dell animatore Ponte tra Dio ed i ragazzi + Cos è la spiritualità? La spiritualità è fare esperienza di Dio, un modo per essere cristiani
+ La spiritualità dell animatore Giacomo Prati + La spiritualità dell animatore Ponte tra Dio ed i ragazzi + Cos è la spiritualità? La spiritualità è fare esperienza di Dio, un modo per essere cristiani
ADORAZIONE EUCARISTICA OPERATORI PASTORALI
 PARROCCHIA SACRO CUORE ADORAZIONE EUCARISTICA OPERATORI PASTORALI Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 23 Ottobre 2014 Canto d esposizione G. La domenica del comandamento
PARROCCHIA SACRO CUORE ADORAZIONE EUCARISTICA OPERATORI PASTORALI Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 23 Ottobre 2014 Canto d esposizione G. La domenica del comandamento
I.I.S FEDERICO II DI SVEVIA PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA CLASSE III AA ANNO SCOLASTICO
 I.I.S FEDERICO II DI SVEVIA PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA CLASSE III AA ANNO SCOLASTICO 2014-2015 LETTERATURA: Le origini della letteratura romanza : La lingua latina e le lingue neolatine o
I.I.S FEDERICO II DI SVEVIA PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA CLASSE III AA ANNO SCOLASTICO 2014-2015 LETTERATURA: Le origini della letteratura romanza : La lingua latina e le lingue neolatine o
SOLENNITÀ DELL IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
 SOLENNITÀ DELL IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA ATTO DI VENERAZIONE ALL IMMACOLATA IN PIAZZA DI SPAGNA ROMA PIAZZA DI SPAGNA, 8 DICEMBRE 2016 In attesa dell arrivo del Santo Padre si prega
SOLENNITÀ DELL IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA ATTO DI VENERAZIONE ALL IMMACOLATA IN PIAZZA DI SPAGNA ROMA PIAZZA DI SPAGNA, 8 DICEMBRE 2016 In attesa dell arrivo del Santo Padre si prega
PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE IV SEZ:A
 PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE IV SEZ:A Liceo Scientifico M:MALPIGHI Docente: prof.ssa Gloria Galloni Anno scolastico: 2015-2016 Letteratura Italiana IL RINASCIMENTO: Il genere epico-cavalleresco. Ariosto
PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE IV SEZ:A Liceo Scientifico M:MALPIGHI Docente: prof.ssa Gloria Galloni Anno scolastico: 2015-2016 Letteratura Italiana IL RINASCIMENTO: Il genere epico-cavalleresco. Ariosto
Caruso ... Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento
 Caruso Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisce la voce e ricomincia il
Caruso Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisce la voce e ricomincia il
