Cooperazione di Agenti Informatici Corso di Laurea Specialistica in Informatica A.A. 2008/09 Prof. Alberto Postiglione
|
|
|
- Gianleone Monaco
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Cooperazione di Agenti Informatici Corso di Laurea Specialistica in Informatica A.A. 2008/09 Prof. Alberto Postiglione UD 2.1.2: Sistemi Complessi (2) interazioni nonlineari e feedback Bibliografia dell Unità Didattica 04/05/2009 Dia 2 Gandolfi, A. Formicai, imperi, cervelli, introduzione alla scienza della complessità, Bollati Boringhieri, 1999 Capitolo 1 (pag. 2229) interazioni nonlineari Capitolo 2 (tutto) feedback 1
2 Cooperazione di Agenti Informatici Corso di Laurea Specialistica in Informatica A.A. 2008/09 Prof. Alberto Postiglione INTERAZIONI NONLINEARI 04/05/2009 Dia 4 Sistemi Complessi: Interazioni nonlineari In un Sistema non lineare in corrispondenza di una variazione regolare dell input l output può variare in modo non regolare In sostanza, la variazione dell output non è proporzionale alla variazione dell input. Matematicamente, sugli assi cartesiani le funzioni lineari sono delle rette, mentre le funzioni non lineari sono delle curve. In natura sono pochi i fenomeni effettivamente lineari. Quasi tutti i fenomeni sono, invece, non lineari. 2
3 04/05/2009 Dia 5 Sistemi Complessi: Interazioni nonlineari Esempi di funzioni lineari: Quando al bar pago 3 caffè spendo il triplo di quanto spenderei se ne pagassi uno solo 04/05/2009 Dia 6 Sistemi Complessi: Interazioni nonlineari Esempi di funzioni non lineari: Scala Richter (ogni 0,1 gradi la potenza moltiplica per 1,41 il valore precedente) 3
4 Processi Sequenziali e a Rete 04/05/2009 Dia 7 Un modo differente di vedere la non linearità dei sistemi complessi è relativo all organizzazione dei processi In un sistema lineare i processi sono sequenziali (seguono una rigida successione dal primo all ultimo, una catena lineare) L output di un processo influenza l unico processo che segue In un sistema non lineare i processi sono organizzati a rete (nel senso che il processo che segue quello appena terminato può essere scelto tra un insieme di possibili altri processi). Ogni processo può avere più input e più output L output di un processo influenza tutti i processi collegati Processi Sequenziali e a Rete 04/05/2009 Dia 8 A B C D E Processi Lineari (o sequenziali) D A B C E F Processi NonLineari (o a Rete) 4
5 Processi Sequenziali e a Rete 04/05/2009 Dia 9 Una proprietà importante dei processi a Rete è che l output di alcuni processi (ad esempio i processi F ed E della figura precedente) può rientrare in input ad un processo (il processo A) che precede quello da cui esce Questo fenomeno è detto di Feedback Le Reti dei processi di un sistema complesso sono, normalmente, molto fitte. 04/05/2009 Dia 10 IMPREVEDIBILITA dei Sistemi Comlessi L'Illuminismo è il trionfo della linearità, della certezza che la storia, la scienza, i fatti sociali si potessero governare trovando una precisa relazione tra causa ed effetto. un sistema può dirsi deterministico quando il suo stato futuro è univocamente determinato dallo stato iniziale. Una visione totalizzante del mondo concedeva discrete possibilità di prevedere il futuro. 5
6 04/05/2009 Dia 11 IMPREVEDIBILITA dei Sistemi Comlessi Il comportamento di un Sistema Complesso non è prevedibile, anche conoscendo in modo preciso gli input che il sistema riceve (Gandolfi, pag. 27) I sistemi complessi si trovano in uno stato al limite tra la prevedibilità e la non prevedibilità, dove tutto è possibile ma non tutto si realizza E possibile prevedere in linea generale quali saranno i suoi possibili stati ma è impossibile prevedere con certezza quale sarà lo stato futuro di un sistema complesso 04/05/2009 Dia 12 IMPREVEDIBILITA dei Sistemi Comlessi L imprevedibilità dei Sistemi Complessi deriva anche dal fatto che i risultati di alcuni processi possono presentarsi sia immediatamente che molto tempo dopo il termine del processo stesso. Nei sistemi complessi sono all opera, parallelamente, meccanismi di breve, medio e lungo termine. Un input x può determinare una reazione immediata (spesso prevedibile) su una parte del sistema, ma anche un effetto a medio e lungo termine, su un altra parte del sistema. E in questo caso l effetto è difficilmente prevedibile, anzi è addirittura difficile attribuire tale effetto proprio all input x, di cui magari si sono perse le tracce. 6
7 04/05/2009 Dia 13 IMPREVEDIBILITA dei Sistemi Comlessi Tutte le nostre azioni hanno effetto sulle persone che ci circondano. Questi effetti si possono manifestare subito, ma anche a lungo termine Ad esempio una decisione importante potrebbe essere influenzata dal ricordo di un nostro comportamento tenuto anni prima. 04/05/2009 Dia 14 IMPREVEDIBILITA dei Sistemi Comlessi Un Sistema Complesso a volte reagisce subito, anche violentemente. Altre volte esso mostra una grande robustezza e assorbe una grande quantità di stimoli, senza reagire. Poi, improvvisamente, la situazione scoppia, e così il sistema modifica i propri comportamenti e la propria organizzazione. Viene raggiunto cioè, il punto critico (viene aggiunta la goccia che fa traboccare il vaso ). Questi scoppi si possono chiamare rivoluzioni, catastrofi naturali, estinzioni, crolli politici, fallimenti economici 7
8 04/05/2009 Dia 15 IMPREVEDIBILITA dei Sistemi Comlessi L Ecosistema terrestre si sta mostrando molto robusto, resistendo alle infinite violenze da noi portate ad esso. Fino a quando? Quando si raggiungerà il punto critico? Gli effetti a breve termine già si sono manifestati: Aumento della temperatura Aumento dei fenomeni estremi Aumento del buco dell ozono Estinzione di specie animali e vegetali Degrado sociale nei paesi del terzo mondo Cooperazione di Agenti Informatici Corso di Laurea Specialistica in Informatica A.A. 2008/09 Prof. Alberto Postiglione FEEDBACK 8
9 Feedback 04/05/2009 Dia 17 Una caratteristica delle reazioni nonlineari tra gli elementi di un Sistema Complesso è che, lungo una sequnza di processi, un processo può influenzare altri processi che lo precedono nella sequenza. Per feedback si intende il processo in cui: Una componente del sistema agisce su una seconda componente La seconda componente agisce a sua volta (retroagisce) sulla prima A AZIONE B RETROAZIONE Feedback 04/05/2009 Dia 18 Un Feedback può coinvolgere più processi. Ad esempio: A B C D Feedback di D su A Attraverso il feedback si formano dei cicli. Esistono due tipi di feedback: Negativo (Retroazione Inibitoria Angelo) Positivo (Retroazione eccitatoria Diavolo) Positivo e negativo NON vanno intesi come giudizi di valore ( buono/cattivo ) 9
10 Feedback Negativo 04/05/2009 Dia 19 A B C D L output del processo D inibisce il funzionamento del processo A Come effetto collaterale, D inibisce anche se stesso (poiché, a D si arriva tramite la sequenza di processi che parte da A). Feedback Negativo di D su A L effetto della inibizione è proporzionale alla grandezza dell output di D. Feedback Negativo 04/05/2009 Dia 20 Il feedback Negativo permette a un sistema di raggiungere un equilibrio e di stabilizzarsi. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, nel termostato si innesta un feedback negativo che spegne la caldaia evitando un ulteriore aumento della temperatura, che quindi, almeno per un periodo, resta stabile. Tutti i fenomeni (sia naturali che artificiali) che prevedono una regolazione sono basati sul feedback negativo. 10
11 Feedback Negativo 04/05/2009 Dia 21 Altro esempio: Omeostasi Capacità di un organismo di mantenere costanti le condizioni chimicofisiche interne anche al variare delle condizioni ambientali esterne. Omeostasi glicemica (livello dello zucchero nel sangue) l'iperglicemia (eccesso di zuccheri) cronica (quale si osserva in soggetti affetti da diabete di tipo 2) può condurre a moltissime degenerazioni, quali danni agli occhi, insufficienza renale, arteriopatia ischemica agli arti inferiori e ipertensione arteriosa. L'ipoglicemia (difetto di zuccheri) grave può causare danni cerebrali irreversibili. Feedback Negativo 04/05/2009 Dia 22 Il livello di zuccheri nel sangue è mantenuto costante dall innesco di meccanismi di feedback negativo, grazie alla produzione, da parte del pancreas dell ormone insulina, che permette agli zuccheri presenti nel sangue di alimentare le cellule, ottenendo come effetto quello di diminuire la quantità di zucchero nel sangue alla produzione di zuccheri da parte del fegato in caso di abbassamento oltre una certa soglia del livello degli zuccheri nel sangue. 11
12 Feedback Negativo 04/05/2009 Dia 23 In natura il feedback negativo permette alle specie di coesistere In un ecosistema, l equilibrio dinamico tra prede e predatori, per esempio, è mantenuto grazie a cicli di feedback negativo Infatti, quando le prede diminuiscono oltre un certo valore I predatori sono troppi, le prede sono poche e quindi i predatori cominciano a morire di fame, permettendo alle prede di crescere nuovamente in numero e ristabilendo così l equilibrio. Feedback Positivo 04/05/2009 Dia 24 A B C D Feedback Positivo di D su A Il Feedback positivo è detto anche ciclo di autocatalisi, in quanto ogni evento del ciclo catalizza direttamente o indirettamente se stesso. L output finale va a stimolare un processo iniziale. Come effetto collaterale, D aumenta la produzione del suo stesso output (poiché, a D si arriva tramite la sequenza di processi che parte da A che, come effetto del feedback, ha un input rafforzato ). 12
13 Feedback Positivo 04/05/2009 Dia 25 Si innesca un circolo vizioso che porta il Sistema ad autorafforzarsi senza intervento esterno, in un processo che può essere pericoloso. Il feedback positivo è un processo estremamente potente: può far esplodere un sistema, con conseguenze importantissime Una volta innescato, è difficile arrestarlo Allontana i sistemi dall equilibrio Attenzione: un feedback positivo può rafforzarsi Verso l alto Verso il basso, e in questo modo il sistema tende a bloccarsi Feedback Positivo 04/05/2009 Dia 26 Il feedback positivo ha tanti nomi, sia nel linguaggio comune, sia nella terminologia scientifica: Demone dei sistemi Circolo vizioso/circolo virtuoso Causalità circolare Effetto valanga 13
14 Feedback Positivo 04/05/2009 Dia 27 Esempi: Mercato dei dischi in vinile, sostituito dai CD CD cominciano a essere venduti diminuisce quella dei 45 e 33 l industria discografica produce meno 45 e 33 e più C e così via Diffusione della lingua inglese America avanguardia in commercio, ricerca, scienza e si comincia a usare l inglese aumentano i corsi di inglese e le persone che parlano inglese aumenta la presenza dell inglese come lingua di interazione Feedback Positivo 04/05/2009 Dia 28 Esito del feedback positivo: il proprietario del locale fa un sacco di soldi Locale di Tendenza A Ci vanni tutti B Esito del feedback positivo: il locale fallisce Locale da sfigati A Non ci va nessuno B 14
15 04/05/2009 Dia 29 Feedback Positivo Cure Sintomatiche rimuovono il sintomo, non la causa, non risolvono il problema e dopo un po il sintomo si ripresenta spesso in forma più acuta Cambiare la cura sintomatica non risolve il problema, lo sposta semplicemente 04/05/2009 Dia 30 Feedback Positivo L esempio più drammatico di spostamento del problema è quello degli oppiacei: la morfina è stata usata per curare la dipendenza dall oppio, l eroina è stata usata per curare la dipendenza dalla morfina, il metadone per la dipendenza dall eroina Assuefazione a droghe, alcool, tabacco, gioco, ecc La crescita dell assunzione segue, prima di stabilizzarsi, una legge esponenziale,che troveremo spesso nei sistemi complessi Assuefazione ad anticrittogamici, diserbanti, insetticidi, Usura Chiedere un Prestito A Aumenta il Debito B 15
16 Feedback Positivo 04/05/2009 Dia 31 (Escalation Simmetrica) Nei rapporti tra gruppi o nazioni, il feedback positivo è il processo che spiega la cosiddetta escalation simmetrica; esempi di escalation sono: La faida tra famiglie o popoli (ad esempio tra israeliani e palestinesi) L equilibrio del terrore durante la Guerra Fredda tra USA e URSS Aumento della potenza nucleare bellica Proliferazione nucleare in Corea del Nord A Proliferazione nucleare in altri paesi B Feedback Positivo 04/05/2009 Dia 32 Giudicare uno studente come promettente o negato modifica l investimento da parte dei docenti nei suoi confronti I risultati del maggiore/minore investimento tendono a rendere lo studente conforme al giudizio inizialmente formulato su di lui GIUDIZIO A STIMOLI B RISULTATI il meccanismo di feedback positivo basato su un giudizio iniziale prende svariati nomi effetto Pigmalione, labelling theory, profezione che si autoavverano, C 16
17 Feedback Positivo Più si è ricchi, più si guadagna 04/05/2009 Dia 33 L assistenzialismo tende a incrementare la richiesta di assistenza L aumento del costo della vita tende a far crescere il costo del lavoro, e così via 04/05/2009 Dia 34 Composizione di Feedback Positivo e Negativo Spesso si trovano sistemi che innescano reazioni di feedback positivo fino ad un certo punto e poi si stabilizzano con un feedback negativo Per ripetere eventualmente tutto il processo Esempio: Discoteca (Feedback Positivo: nessuno in pista feedback positivo ancora: aumentano le persone che ballano feedback Negativo: quando la pista si riempie il numero di persone resta più o meno stabile) Batteri in una coltura (crescono fino a saturare l ambiente cominciano a morire per mancanza di alimentazione, così stabilizzandosi) 17
18 04/05/2009 Dia 35 Composizione di Feedback Positivo e Negativo Ecosistema di Prede e Predatori (2 sistemi, in questo caso) Le prede sono mangiate dai predatori fino a che i predatori non sono troppi e le prede poche I predatori cominciano a diminuire perché muoino di fame e quindi le prede hanno la possibilità di crescere Quando le prede sono ridiventate molte aumentano anche i predatori perché non muoiono più di fame E così via, in un processo periodico. 04/05/2009 Dia 36 Composizione di Feedback Positivo e Negativo Le componenti di un sistema complesso interagiscono tra loro formando una RETE di interazioni non lineari All interno della rete, si intrecciano processi di feedback negativo e processi di feedback positivo Nei sistemi complessi reali (con tante componenti ciascuna molto complessa) la potenza esplosiva del feedback positivo si intreccia alla ricerca di equilibrio del feedback negativo, producendo fenomeni complessi davvero straordinari 18
19 19 04/05/2009 Dia 37 Prof Alberto Postiglione UD 2.1 Cooperazione di Agenti Informatici (08/09) Composizione di Feedback Positivo e Negativo C B G F J I K A E H 04/05/2009 Dia 38 Prof Alberto Postiglione UD 2.1 Cooperazione di Agenti Informatici (08/09) Composizione di Feedback Positivo e Negativo C B G F J I K A E H
20 20 04/05/2009 Dia 39 Prof Alberto Postiglione UD 2.1 Cooperazione di Agenti Informatici (08/09) Composizione di Feedback Positivo e Negativo C B G F J I K A E H 04/05/2009 Dia 40 Prof Alberto Postiglione UD 2.1 Cooperazione di Agenti Informatici (08/09) Composizione di Feedback Positivo e Negativo C B G F J I K A E H
21 21 04/05/2009 Dia 41 Prof Alberto Postiglione UD 2.1 Cooperazione di Agenti Informatici (08/09) Composizione di Feedback Positivo e Negativo C B G F J I K A E H 04/05/2009 Dia 42 Prof Alberto Postiglione UD 2.1 Cooperazione di Agenti Informatici (08/09) Composizione di Feedback Positivo e Negativo C B G F J I K A E H
22 Esempio: Giornale 04/05/2009 Dia 43 Consideriamo il sistema complesso costituito da un azienda che vende un giornale Per semplicità, consideriamo solo cinque componenti (tra le centinaia realmente presenti in tale sistema) Si noti un feedback Negativo tra profitto giornalisti costi QUALITA GIORNALISTI COSTI PREZZO PROFITTO Esempio: Giornale 04/05/2009 Dia 44 Il nostro sistema, come ogni sistema complesso, interagisce con l ambiente Nel nostro caso l ambiente è formato da Inserzionisti Acquirenti Concorrenti 22
23 Esempio: Giornale 04/05/2009 Dia 45 aggiungiamo adesso al sistema le interazioni con l ambiente QUALITA GIORNALISTI COSTI PREZZO PROFITTO Esempio: Giornale 04/05/2009 Dia 46 aggiungiamo adesso al sistema le interazioni con l ambiente QUALITA GIORNALISTI COSTI PREZZO PROFITTO VENDITE PUBBLICITA CONCORRENZA 23
24 Esempio: Giornale 04/05/2009 Dia 47 Considerato nelle sue interazioni con l ambiente, il sistema presenta due cicli di feedback negativo: profitto giornalisti costi vendite pubblicità profitto giornalisti costi prezzo ; e un feedback positivo: giornalisti qualità vendite pubblicità profitto Esempio: Giornale 04/05/2009 Dia 48 () profitto giornalisti costi QUALITA GIORNALISTI PROFITTO COSTI PREZZO VENDITE CONCORRENZA PUBBLICITA 24
25 Esempio: Giornale () profitto giornalisti costi 04/05/2009 Dia 49 QUALITA GIORNALISTI COSTI PREZZO PROFITTO VENDITE PUBBLICITA CONCORRENZA Esempio: Giornale 04/05/2009 Dia 50 () vendite pubblicità profitto giornalisti costi prezzo QUALITA GIORNALISTI COSTI PREZZO PROFITTO VENDITE PUBBLICITA CONCORRENZA 25
26 Esempio: Giornale 04/05/2009 Dia 51 () vendite pubblicità profitto giornalisti costi prezzo QUALITA GIORNALISTI COSTI PREZZO PROFITTO VENDITE PUBBLICITA CONCORRENZA Esempio: Giornale 04/05/2009 Dia 52 () giornalisti qualità vendite pubblicità profitto QUALITA GIORNALISTI COSTI PREZZO PROFITTO VENDITE PUBBLICITA CONCORRENZA 26
27 Esempio: Giornale 04/05/2009 Dia 53 () giornalisti qualità vendite pubblicità profitto QUALITA GIORNALISTI COSTI PREZZO PROFITTO VENDITE PUBBLICITA CONCORRENZA 27
Multiagent systems. Christian Schunck, Ph.D. UD 2.1.2: Sistemi Complessi (2) interazioni non-lineari e feedback
 Multiagent systems Sistemi i di Agenti Christian Schunck, Ph.D. UD 2.1.2: Sistemi Complessi (2) interazioni nonlineari e feedback Christian Schunck,Ph.D. Multiagent Systems Sistemi di Agenti UD 1.1 30/03/2010
Multiagent systems Sistemi i di Agenti Christian Schunck, Ph.D. UD 2.1.2: Sistemi Complessi (2) interazioni nonlineari e feedback Christian Schunck,Ph.D. Multiagent Systems Sistemi di Agenti UD 1.1 30/03/2010
Salite che si riparte!
 Salite che si riparte! 2. Caratteristiche dei sistemi complessi Come funzionano i sistemi complessi Caratteristiche processuali Il principale processo che avviene tra le componenti di un sistema complesso
Salite che si riparte! 2. Caratteristiche dei sistemi complessi Come funzionano i sistemi complessi Caratteristiche processuali Il principale processo che avviene tra le componenti di un sistema complesso
Motivazione. Germano Rossi ISSR 2009/10
 Motivazione Germano Rossi ISSR 2009/10 Motivazione una condizione che determina la direzione e l intensità del comportamento Corrisponde ai desideri (mangiare, bere, piacere, desiderio di fare qualcosa,
Motivazione Germano Rossi ISSR 2009/10 Motivazione una condizione che determina la direzione e l intensità del comportamento Corrisponde ai desideri (mangiare, bere, piacere, desiderio di fare qualcosa,
Economia del Lavoro 2010
 Economia del Lavoro 2010 Capitolo 3 La domanda di lavoro - La decisione di occupazione nel breve periodo 1 La domanda di lavoro La decisione di occupazione di b.p. Breve periodo è un tempo sufficientemente
Economia del Lavoro 2010 Capitolo 3 La domanda di lavoro - La decisione di occupazione nel breve periodo 1 La domanda di lavoro La decisione di occupazione di b.p. Breve periodo è un tempo sufficientemente
Esercitazione_4 Oligopolio e Concorrenza monopolistica
 Esercitazione_4 Oligopolio e Concorrenza monopolistica Oligopolio Mercato con pochi produttori Consapevolezza che le azioni di ogni concorrente (ad esempio la scelta del prezzo) hanno effetto su tutti
Esercitazione_4 Oligopolio e Concorrenza monopolistica Oligopolio Mercato con pochi produttori Consapevolezza che le azioni di ogni concorrente (ad esempio la scelta del prezzo) hanno effetto su tutti
Le imprese nei mercati concorrenziali
 Le imprese nei mercati concorrenziali Le decisioni di prezzo e di produzione delle imprese sono influenzate dalla forma di mercato. Un caso estremo di mercato è quello della concorrenza perfetta. Tre condizioni:
Le imprese nei mercati concorrenziali Le decisioni di prezzo e di produzione delle imprese sono influenzate dalla forma di mercato. Un caso estremo di mercato è quello della concorrenza perfetta. Tre condizioni:
Materiale per gli alunni
 Testi semplificati di storia Materiale per gli alunni LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA RICHIESTA: A2- B1 SI RIVOLGE A: studenti della scuola secondaria di I grado al 3 anno Prerequisiti: Gli alunni sanno
Testi semplificati di storia Materiale per gli alunni LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA RICHIESTA: A2- B1 SI RIVOLGE A: studenti della scuola secondaria di I grado al 3 anno Prerequisiti: Gli alunni sanno
Capitolo 12 Il monopolio
 Capitolo 12 Il monopolio IL MONOPOLIO Il monopolio è una forma di mercato in cui un unico venditore offre un bene che non ha stretti sostituti, ad una moltitudine di consumatori La differenza fondamentale
Capitolo 12 Il monopolio IL MONOPOLIO Il monopolio è una forma di mercato in cui un unico venditore offre un bene che non ha stretti sostituti, ad una moltitudine di consumatori La differenza fondamentale
Mercato dei beni. La composizione del Pil Consumo (C): beni e servizi acquistati dai consumatori
 Mercato dei beni La composizione del Pil Consumo (C): beni e servizi acquistati dai consumatori Investimento (I): talvolta chiamato investimento fisso per distinguerlo dalle scorte di magazzino. E la somma
Mercato dei beni La composizione del Pil Consumo (C): beni e servizi acquistati dai consumatori Investimento (I): talvolta chiamato investimento fisso per distinguerlo dalle scorte di magazzino. E la somma
La funzione di domanda
 La funzione di domanda Si consideri un certo bene scambiato nel mercato e sia p 0 il prezzo di tale bene La funzione di domanda è una funzione a valori reali f : + + che associa ad ogni livello di prezzo
La funzione di domanda Si consideri un certo bene scambiato nel mercato e sia p 0 il prezzo di tale bene La funzione di domanda è una funzione a valori reali f : + + che associa ad ogni livello di prezzo
RICETTIVITÀ TURISTICA a.a. 2008/09
 RICETTIVITÀ TURISTICA a.a. 2008/09 PROF. FRANCESCO MARANGON Dipartimento di Scienze Economiche Di cosa si occupa l economia? l L economia è la scienza che studia il modo in cui la società alloca in maniera
RICETTIVITÀ TURISTICA a.a. 2008/09 PROF. FRANCESCO MARANGON Dipartimento di Scienze Economiche Di cosa si occupa l economia? l L economia è la scienza che studia il modo in cui la società alloca in maniera
Economia Industriale Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale. Introduzione
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Economia Industriale Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale Introduzione Prof. Gianmaria Martini Oggetto di analisi Economia Industriale: Comportamento delle imprese
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Economia Industriale Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale Introduzione Prof. Gianmaria Martini Oggetto di analisi Economia Industriale: Comportamento delle imprese
Domanda e offerta. consumatori di un bene/servizio per ciascun livello di prezzo del bene/servizio preso
 . . La funzione di domanda La funzione di domanda (o curva di domanda) rappresenta la quantità domandata dai consumatori di un bene/servizio per ciascun livello di prezzo del bene/servizio preso in considerazione.
. . La funzione di domanda La funzione di domanda (o curva di domanda) rappresenta la quantità domandata dai consumatori di un bene/servizio per ciascun livello di prezzo del bene/servizio preso in considerazione.
Economia della Concorrenza e dei Mercati Lezione 11
 Economia della Concorrenza e dei Mercati Lezione 11 Corso di laurea Consulente del Lavoro e Giurista d'impresa UNIBS, a.a. 2014-2015 Prof.ssa Chiara Dalle Nogare Il modello di Cournot: ipotesi. 1.Due imprese,
Economia della Concorrenza e dei Mercati Lezione 11 Corso di laurea Consulente del Lavoro e Giurista d'impresa UNIBS, a.a. 2014-2015 Prof.ssa Chiara Dalle Nogare Il modello di Cournot: ipotesi. 1.Due imprese,
Forme di mercato e Massimizzazione del profitto con funzioni di ricavo
 Forme di mercato e Massimizzazione del profitto con funzioni di ricavo L importanza del regime di mercato Il comportamento e le decisioni di un impresa sono influenzati, oltre che da fattori interni all
Forme di mercato e Massimizzazione del profitto con funzioni di ricavo L importanza del regime di mercato Il comportamento e le decisioni di un impresa sono influenzati, oltre che da fattori interni all
Offerta in concorrenza perfetta: Cap.6
 Offerta in concorrenza perfetta: il lato dei costi Cap.6 Curva di offerta Per capire meglio le origini della curva di offerta consideriamo ora una impresa che debba decidere quale livello di produzione
Offerta in concorrenza perfetta: il lato dei costi Cap.6 Curva di offerta Per capire meglio le origini della curva di offerta consideriamo ora una impresa che debba decidere quale livello di produzione
IL SISTEMA ENDOCRINO S I L V I A G O R I G I O R G I A F A Z I O S U S A N N A D I L E O G I U L I A C O N T E A N N A M I C C O L I
 IL SISTEMA ENDOCRINO S I L V I A G O R I G I O R G I A F A Z I O S U S A N N A D I L E O G I U L I A C O N T E A N N A M I C C O L I INTRODUZIONE La funzione del sistema endocrino è quella di coordinare
IL SISTEMA ENDOCRINO S I L V I A G O R I G I O R G I A F A Z I O S U S A N N A D I L E O G I U L I A C O N T E A N N A M I C C O L I INTRODUZIONE La funzione del sistema endocrino è quella di coordinare
L ECONOMIA E LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE (DOMANDA, OFFERTA, PREZZO DI EQUILIBRIO) Prof.ssa Angela Donatiello 1
 L ECONOMIA E LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE (DOMANDA, OFFERTA, PREZZO DI EQUILIBRIO) Prof.ssa Angela Donatiello 1 Uno degli aspetti fondamentali di ogni società, a prescindere dal livello di progresso, è
L ECONOMIA E LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE (DOMANDA, OFFERTA, PREZZO DI EQUILIBRIO) Prof.ssa Angela Donatiello 1 Uno degli aspetti fondamentali di ogni società, a prescindere dal livello di progresso, è
IL SISTEMA ENDOCRINO
 IL SISTEMA ENDOCRINO LA FUNZIONE DEL SISTEMA ENDOCRINO Per coordinare tutte le attività del nostro organismo e mantenere una condizione di equilibrio interno (detta omeostasi) ci serviamo di due sistemi
IL SISTEMA ENDOCRINO LA FUNZIONE DEL SISTEMA ENDOCRINO Per coordinare tutte le attività del nostro organismo e mantenere una condizione di equilibrio interno (detta omeostasi) ci serviamo di due sistemi
MONOPOLIO. Monopolio: mercato nel quale vi è un solo offerente (Monopsonio: mercato nel quale vi è un solo compratore)
 MONOPOLIO Monopolio: mercato nel quale vi è un solo offerente (Monopsonio: mercato nel quale vi è un solo compratore) Monopolio e fallimento del mercato: in realtà ogni volta che in un mercato operano
MONOPOLIO Monopolio: mercato nel quale vi è un solo offerente (Monopsonio: mercato nel quale vi è un solo compratore) Monopolio e fallimento del mercato: in realtà ogni volta che in un mercato operano
Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS)
 Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS) adacher@dia.uniroma3.it Programma La simulazione ad eventi discreti, è una metodologia fondamentale per la valutazione delle prestazioni di sistemi complessi (di
Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS) adacher@dia.uniroma3.it Programma La simulazione ad eventi discreti, è una metodologia fondamentale per la valutazione delle prestazioni di sistemi complessi (di
ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI
 FACOLTA DI INGEGNERIA ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI ESERCIZI SVOLTI IN AULA A.A. 2010-2011 DOCENTE: Francesca Iacobone ASSISTENTE ALLA DIDATTICA: Andrea Maresca RICHIAMI DI TEORIA I richiami di teoria
FACOLTA DI INGEGNERIA ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI ESERCIZI SVOLTI IN AULA A.A. 2010-2011 DOCENTE: Francesca Iacobone ASSISTENTE ALLA DIDATTICA: Andrea Maresca RICHIAMI DI TEORIA I richiami di teoria
Capitolo 10: Giochi dinamici. Ora l impresa 1 sceglie l output per massimizzare i propri profitti 1 8 = 122,5 Q 2 = 61,25
 Capitolo 10: Giochi dinamici Esercizio 1 a) L impresa 2 sceglie la sua quantità per massimizzare i profitti π 2 = Q 2 1000 4Q 1 4Q 2 20Q 2 π 2 Q 2 = 10004Q 1 8Q 2 20 = 0 Q 2 = 1 8 980 4Q 1 Ora l impresa
Capitolo 10: Giochi dinamici Esercizio 1 a) L impresa 2 sceglie la sua quantità per massimizzare i profitti π 2 = Q 2 1000 4Q 1 4Q 2 20Q 2 π 2 Q 2 = 10004Q 1 8Q 2 20 = 0 Q 2 = 1 8 980 4Q 1 Ora l impresa
DIABETE E IPOGLICEMIA
 DIABETE E IPOGLICEMIA Il glucosio è fondamentale per l organismo poiché è il nutriente essenziale per tutte le cellule. L organo principale che utilizza il glucosio è il cervello, e grazie all energia
DIABETE E IPOGLICEMIA Il glucosio è fondamentale per l organismo poiché è il nutriente essenziale per tutte le cellule. L organo principale che utilizza il glucosio è il cervello, e grazie all energia
Controllo a retroazione
 E il tipo di controllo più antico. Q, T i SHT: la temperatura in uscita può variare perché vogliamo cambiare il set point o per effetto di disturbi Controllo di tipo servomeccanismo Controllo regolativo
E il tipo di controllo più antico. Q, T i SHT: la temperatura in uscita può variare perché vogliamo cambiare il set point o per effetto di disturbi Controllo di tipo servomeccanismo Controllo regolativo
Modelli Matematici Ambientali 1. Mastroeni/Cioni (Dipartimento di Informatica/Scuola Normale Superiore) Lezione 13/03 A.A.
 Modelli Matematici Ambientali 1 Mastroeni/Cioni (Dipartimento di Informatica/Scuola Normale Superiore) Lezione 13/03 A.A. 2014/2015 Ottava lezione piano di lavoro Considerazioni teoriche su: usi dei modelli,
Modelli Matematici Ambientali 1 Mastroeni/Cioni (Dipartimento di Informatica/Scuola Normale Superiore) Lezione 13/03 A.A. 2014/2015 Ottava lezione piano di lavoro Considerazioni teoriche su: usi dei modelli,
Economia Politica e Istituzioni Economiche
 Economia Politica e Istituzioni Economiche Barbara Pancino Lezione 13 Un analisi di equilibrio generale: il modello AS-AD Il modello AS-AD Usando le condizioni di equilibrio di tutti i mercati considerati
Economia Politica e Istituzioni Economiche Barbara Pancino Lezione 13 Un analisi di equilibrio generale: il modello AS-AD Il modello AS-AD Usando le condizioni di equilibrio di tutti i mercati considerati
Corso di Economia Internazionale Prof. Gianfranco Viesti
 Facoltà di Scienze Politiche Università di Bari Corso di Economia Internazionale Prof. Gianfranco Viesti Modulo 5 Due approfondimenti: Vernon e la dinamica del commercio; Porter e il vantaggio competitivo
Facoltà di Scienze Politiche Università di Bari Corso di Economia Internazionale Prof. Gianfranco Viesti Modulo 5 Due approfondimenti: Vernon e la dinamica del commercio; Porter e il vantaggio competitivo
Corso di Introduzione ai METODI e alle TECNICHE del SERVIZIO SOCIALE Anno accademico 2016/2017 (prof. MARCO GIORDANO)
 - Modello Sistemico- Relazionale (intro) Corso di Introduzione ai METODI e alle TECNICHE del SERVIZIO SOCIALE Anno accademico 2016/2017 (prof. MARCO GIORDANO) Teoria Generale dei Sistemi Pragmatica della
- Modello Sistemico- Relazionale (intro) Corso di Introduzione ai METODI e alle TECNICHE del SERVIZIO SOCIALE Anno accademico 2016/2017 (prof. MARCO GIORDANO) Teoria Generale dei Sistemi Pragmatica della
Politica economica: Lezione 13
 Politica economica: Lezione 13 II canale: M - Z Crediti: 9 Corsi di laurea: Nuovo Ordinamento (DM. 270) Vecchio ordinamento (DM. 590) 1 Caratteristiche di un monopolio puro Un unico venditore: una sola
Politica economica: Lezione 13 II canale: M - Z Crediti: 9 Corsi di laurea: Nuovo Ordinamento (DM. 270) Vecchio ordinamento (DM. 590) 1 Caratteristiche di un monopolio puro Un unico venditore: una sola
Offerta e Domanda Aggregata Lezione n.4. Corso di Economia Applicata all Ingegneria Anno Accademico Prof. Avv. Cristiano Di Giosa
 Offerta e Domanda Aggregata Lezione n.4 Corso di Economia Applicata all Ingegneria Anno Accademico 2013-2014 Prof. Avv. Cristiano Di Giosa Il Mercato La Uno dei temi centrali della Microeconomia è lo studio
Offerta e Domanda Aggregata Lezione n.4 Corso di Economia Applicata all Ingegneria Anno Accademico 2013-2014 Prof. Avv. Cristiano Di Giosa Il Mercato La Uno dei temi centrali della Microeconomia è lo studio
Lezione 12 Argomenti
 Lezione 12 Argomenti Costi di produzione: differenza tra costo economico e costo contabile I costi nel breve periodo Relazione di breve periodo tra funzione di produzione, produttività del lavoro e costi
Lezione 12 Argomenti Costi di produzione: differenza tra costo economico e costo contabile I costi nel breve periodo Relazione di breve periodo tra funzione di produzione, produttività del lavoro e costi
L ELASTICITÀ DEL CONSUMATORE PROF. MATTIA LETTIERI
 L ELASTICITÀ DEL CONSUMATORE ROF. MATTIA LETTIERI Indice 1 LA CURVA DI DOMANDA INDIVIDUALE ---------------------------------------------------------------------------- 3 2 GLI SOSTAMENTI DELLA CURVA DI
L ELASTICITÀ DEL CONSUMATORE ROF. MATTIA LETTIERI Indice 1 LA CURVA DI DOMANDA INDIVIDUALE ---------------------------------------------------------------------------- 3 2 GLI SOSTAMENTI DELLA CURVA DI
Lezione 7: Il modello IS/LM e la politica economica
 Corso di Scienza Economica (Economia Politica) prof. G. Di Bartolomeo Lezione 7: Il modello IS/LM e la politica economica Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di Teramo Due usi dei modelli
Corso di Scienza Economica (Economia Politica) prof. G. Di Bartolomeo Lezione 7: Il modello IS/LM e la politica economica Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di Teramo Due usi dei modelli
Cooperazione di Agenti Informatici Corso di Laurea Specialistica in Informatica A.A. 2008/09 Prof. Alberto Postiglione
 Cooperazione di Agenti Informatici Corso di Laurea Specialistica in Informatica A.A. 2008/09 Prof. Alberto Postiglione UD 2.1.5: Sistemi Complessi (6) Sistemi Complicati e complessi Bibliografia dell Unità
Cooperazione di Agenti Informatici Corso di Laurea Specialistica in Informatica A.A. 2008/09 Prof. Alberto Postiglione UD 2.1.5: Sistemi Complessi (6) Sistemi Complicati e complessi Bibliografia dell Unità
Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11)
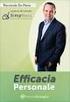 Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11) MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto economico
Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11) MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto economico
Elementi di Microeconomia: Introduzione
 Elementi di Microeconomia: Introduzione 1. Informazioni sul Corso 5 Crediti a. Lezioni Teoriche (4 crediti, 40h, 20 unità circa) b. Esercitazioni (1 credito, 10h, 5 unità) Dott. Luca Zarri Lezioni a. Lunedì
Elementi di Microeconomia: Introduzione 1. Informazioni sul Corso 5 Crediti a. Lezioni Teoriche (4 crediti, 40h, 20 unità circa) b. Esercitazioni (1 credito, 10h, 5 unità) Dott. Luca Zarri Lezioni a. Lunedì
Capitolo 9 La produzione. Robert H. Frank Microeconomia - 4 a Edizione Copyright The McGraw-Hill Companies, srl
 Capitolo 9 La produzione Dopo la teoria del (la scelta razionale del) consumatore OGGI INIZIAMO LA SECONDA (E CENTRALE) PARTE DEL CORSO: TEORIA DELLA PRODUZIONE E DELLA STRUTTURA DEI MERCATI LA PRODUZIONE
Capitolo 9 La produzione Dopo la teoria del (la scelta razionale del) consumatore OGGI INIZIAMO LA SECONDA (E CENTRALE) PARTE DEL CORSO: TEORIA DELLA PRODUZIONE E DELLA STRUTTURA DEI MERCATI LA PRODUZIONE
UD Influenza della politica monetaria e fiscale sulla domanda aggregata
 UD 10.2. Influenza della politica monetaria e fiscale sulla domanda aggregata Inquadramento generale In questa unità prendiamo in esame i meccanismi attraverso i quali la politica pubblica, sia monetaria
UD 10.2. Influenza della politica monetaria e fiscale sulla domanda aggregata Inquadramento generale In questa unità prendiamo in esame i meccanismi attraverso i quali la politica pubblica, sia monetaria
L ECONOMIA E LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE (RICAVO E PROFITTO) Prof.ssa Angela Donatiello 1
 L ECONOMIA E LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE (RICAVO E PROFITTO) Prof.ssa Angela Donatiello 1 LA FUNZIONE DEL RICAVO Chiamiamo RICAVO TOTALE il prodotto della quantità venduta per il prezzo unitario di vendita.
L ECONOMIA E LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE (RICAVO E PROFITTO) Prof.ssa Angela Donatiello 1 LA FUNZIONE DEL RICAVO Chiamiamo RICAVO TOTALE il prodotto della quantità venduta per il prezzo unitario di vendita.
Capitolo 9 La produzione
 Capitolo 9 La produzione LA PRODUZIONE Le risorse che le imprese usano per produrre beni e servizi sono dette fattori produttivi o input I beni e i servizi realizzati dalle imprese sono definiti semplicemente
Capitolo 9 La produzione LA PRODUZIONE Le risorse che le imprese usano per produrre beni e servizi sono dette fattori produttivi o input I beni e i servizi realizzati dalle imprese sono definiti semplicemente
MONOPOLIO. Monopolio: mercato nel quale vi è un solo offerente (Monopsonio: mercato nel quale vi è un solo compratore)
 MONOPOLIO Monopolio: mercato nel quale vi è un solo offerente (Monopsonio: mercato nel quale vi è un solo compratore) Monopolio e fallimento del mercato: in realtà ogni volta che in un mercato operano
MONOPOLIO Monopolio: mercato nel quale vi è un solo offerente (Monopsonio: mercato nel quale vi è un solo compratore) Monopolio e fallimento del mercato: in realtà ogni volta che in un mercato operano
concorrenza perfetta vs. monopolio
 Lezione di Giacomo Degli Antoni, 20-3- 13 concorrenza perfetta vs. monopolio (Cap. 3 e 4 Carlton - Perloff) Piano della lezione Caratteristiche principali della concorrenza perfetta Caratteristiche principali
Lezione di Giacomo Degli Antoni, 20-3- 13 concorrenza perfetta vs. monopolio (Cap. 3 e 4 Carlton - Perloff) Piano della lezione Caratteristiche principali della concorrenza perfetta Caratteristiche principali
Economia del Lavoro 2010
 Economia del Lavoro 2010 Capitolo 3 La domanda di lavoro - La curva di domanda di lavoro nel lungo periodo 1 La curva di domanda di lavoro nel l.p. Cosa accade alla domanda di lavoro di lungo periodo dell
Economia del Lavoro 2010 Capitolo 3 La domanda di lavoro - La curva di domanda di lavoro nel lungo periodo 1 La curva di domanda di lavoro nel l.p. Cosa accade alla domanda di lavoro di lungo periodo dell
Definizioni economia applicata all ingegneria
 Definizioni economia applicata all ingegneria October 28 2011 In questo documento assolutamente non ufficiale sono contenute le definizioni date durante le lezioni di economia applicata all ingegneria.
Definizioni economia applicata all ingegneria October 28 2011 In questo documento assolutamente non ufficiale sono contenute le definizioni date durante le lezioni di economia applicata all ingegneria.
Il modello AD-AS. Modello semplice
 Il modello AD-AS Modello semplice Introduciamo i prezzi Fino ad ora abbiamo ipotizzato che i prezzi fossero dati e costanti. Si trattava di una ipotesi semplificatrice che poteva valere nel breve periodo.
Il modello AD-AS Modello semplice Introduciamo i prezzi Fino ad ora abbiamo ipotizzato che i prezzi fossero dati e costanti. Si trattava di una ipotesi semplificatrice che poteva valere nel breve periodo.
Domanda e Offerta. G. Pignataro Microeconomia SPOSI
 Domanda e Offerta Domanda e Offerta Il meccanismo di mercato Variazioni dell equilibrio di mercato Elasticità della domanda e dell offerta Elasticità di breve e di lungo periodo 1 Domanda e offerta La
Domanda e Offerta Domanda e Offerta Il meccanismo di mercato Variazioni dell equilibrio di mercato Elasticità della domanda e dell offerta Elasticità di breve e di lungo periodo 1 Domanda e offerta La
La teoria dell offerta
 La teoria dell offerta Tecnologia e costi di produzione In questa lezione approfondiamo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta. In particolare: è possibile individuare
La teoria dell offerta Tecnologia e costi di produzione In questa lezione approfondiamo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta. In particolare: è possibile individuare
Capitolo XIV. Il mercato dei beni in economia aperta
 Capitolo XIV. Il mercato dei beni in economia aperta 1. La curva IS in economia aperta La domanda di beni nazionali è data da: Z C I G IM / X + domanda nazionale di beni (C+I+G) - importazioni (domanda
Capitolo XIV. Il mercato dei beni in economia aperta 1. La curva IS in economia aperta La domanda di beni nazionali è data da: Z C I G IM / X + domanda nazionale di beni (C+I+G) - importazioni (domanda
CAPITOLO 9 Introduzione alle fluttuazioni economiche
 ITOLO 9 Introduzione alle fluttuazioni economiche Domande di ripasso 1. Durante una recessione, consumo e investimento diminuiscono, mentre il tasso di disoccupazione aumenta. Di solito l investimento
ITOLO 9 Introduzione alle fluttuazioni economiche Domande di ripasso 1. Durante una recessione, consumo e investimento diminuiscono, mentre il tasso di disoccupazione aumenta. Di solito l investimento
Integrazioni al corso di Economia Politica (anno accademico ) Marianna Belloc
 Integrazioni al corso di Economia Politica (anno accademico 2013-2014) Marianna Belloc 1 L elasticità Come è già noto, la funzione di domanda di mercato indica la quantità che il mercato è disposto ad
Integrazioni al corso di Economia Politica (anno accademico 2013-2014) Marianna Belloc 1 L elasticità Come è già noto, la funzione di domanda di mercato indica la quantità che il mercato è disposto ad
BASI E STRATEGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO (CAP. 14, 15) Unit 10 Slide Lezioni del 01/02/03 dicembre 2015
 COMUNICAZIONE D IMPRESA Anno Accademico 2015/2016 BASI E STRATEGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO (CAP. 14, 15) Unit 10 Slide 10.2.1 Lezioni del 01/02/03 dicembre 2015 SODDISFARE LE OPPORTUNITÀ DI IL
COMUNICAZIONE D IMPRESA Anno Accademico 2015/2016 BASI E STRATEGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO (CAP. 14, 15) Unit 10 Slide 10.2.1 Lezioni del 01/02/03 dicembre 2015 SODDISFARE LE OPPORTUNITÀ DI IL
Economia politica: MACRO vs. MICRO
 Economia politica: MACRO vs. MICRO L economia politica, nell ambito delle scienze sociali, è la scienza che studia il comportamento umano in relazione all allocazione di risorse scarse MICROeconomia: studia
Economia politica: MACRO vs. MICRO L economia politica, nell ambito delle scienze sociali, è la scienza che studia il comportamento umano in relazione all allocazione di risorse scarse MICROeconomia: studia
Potere di mercato. Sommario. Monopolio. Monopolio
 Potere di mercato Monopolio Sommario Perché esistono i monopoli. Confronto Monopolio e Concorrenza perfetta Massimizzazione del profitto e determinazione del prezzo Costo del Monopolio in termini di benessere
Potere di mercato Monopolio Sommario Perché esistono i monopoli. Confronto Monopolio e Concorrenza perfetta Massimizzazione del profitto e determinazione del prezzo Costo del Monopolio in termini di benessere
Riassunto della Concorrenza Perfetta (LP=lungo periodo):
 Monopolio (Capitolo 10 del libro di testo di Micro) Riassunto della Concorrenza Perfetta (LP=lungo periodo): Elevato numero di acquirenti e di venditori entrambi price takers Prodotto omogeneo Informazione
Monopolio (Capitolo 10 del libro di testo di Micro) Riassunto della Concorrenza Perfetta (LP=lungo periodo): Elevato numero di acquirenti e di venditori entrambi price takers Prodotto omogeneo Informazione
CAPITOLO 9. La concorrenza perfetta
 CAPITOLO 9 La concorrenza perfetta 1 Mercati di concorrenza perfetta Un mercato di concorrenza perfetta è composto da imprese che producono beni identici e che vendono allo stesso prezzo. Il volume di
CAPITOLO 9 La concorrenza perfetta 1 Mercati di concorrenza perfetta Un mercato di concorrenza perfetta è composto da imprese che producono beni identici e che vendono allo stesso prezzo. Il volume di
Lezione 30: Modello AD-AS nel breve e lungo periodo
 Corso di Economia Politica prof. S. Papa Lezione 30: Modello AD-AS nel breve e lungo periodo Facoltà di Economia Sapienza Roma Curva AS di breve periodo Le imprese stabiliscono i prezzi dei propri prodotti
Corso di Economia Politica prof. S. Papa Lezione 30: Modello AD-AS nel breve e lungo periodo Facoltà di Economia Sapienza Roma Curva AS di breve periodo Le imprese stabiliscono i prezzi dei propri prodotti
Massimizzazione del profitto Appunti - Bozza
 Massimizzazione del profitto Appunti - Bozza Indice 1 Premessa 1 2 Massimizzazione del profitto 1 2.1 Introduzione............................ 1 2.2 Il costo............................... 2 2.3 Il ricavo..............................
Massimizzazione del profitto Appunti - Bozza Indice 1 Premessa 1 2 Massimizzazione del profitto 1 2.1 Introduzione............................ 1 2.2 Il costo............................... 2 2.3 Il ricavo..............................
Eroina. di Riccardo C. Gatti
 Eroina L'eroina non è una droga del passato: è molto presente nei mercati e, nel nord america, è la "nuova" droga emergente. Le persone si accostano a questa sostanza (ed all'uso improprio di farmaci oppiacei)
Eroina L'eroina non è una droga del passato: è molto presente nei mercati e, nel nord america, è la "nuova" droga emergente. Le persone si accostano a questa sostanza (ed all'uso improprio di farmaci oppiacei)
SECONDA PROVA PARZIALE DI MACROECONOMIA Del 1 Giugno 2015 (VERSIONE C) CLEC COGNOME NOME
 SECONDA PROVA PARZIALE DI MACROECONOMIA Del 1 Giugno 2015 (VERSIONE C) CLEC COGNOME NOME MATRICOLA 1) A B C D 2) A B C D 3) A B C D 4) A B C D 5) A B C D 6) A B C D 7) A B C D 8) A B C D 9) A B C D 10)
SECONDA PROVA PARZIALE DI MACROECONOMIA Del 1 Giugno 2015 (VERSIONE C) CLEC COGNOME NOME MATRICOLA 1) A B C D 2) A B C D 3) A B C D 4) A B C D 5) A B C D 6) A B C D 7) A B C D 8) A B C D 9) A B C D 10)
Mercati, domanda e offerta
 Mercati, domanda e offerta La Microeconomia La Microeconomia si interessa del comportamento economico delle unità individuali e della loro interazione all interno dei mercati: Consumatori/Famiglie Imprese/Banche
Mercati, domanda e offerta La Microeconomia La Microeconomia si interessa del comportamento economico delle unità individuali e della loro interazione all interno dei mercati: Consumatori/Famiglie Imprese/Banche
IL MODELLO REDDITO SPESA. Nel caso di un economia chiusa, la DA, cioè la domanda complessiva di beni nell economia, ha tre componenti: C, I e G.
 IL MODELLO REDDITO SPESA Nel caso di un economia chiusa, la DA, cioè la domanda complessiva di beni nell economia, ha tre componenti: C, I e G. Le ipotesi che adotteremo sono: - prezzi fissi (no distinzione
IL MODELLO REDDITO SPESA Nel caso di un economia chiusa, la DA, cioè la domanda complessiva di beni nell economia, ha tre componenti: C, I e G. Le ipotesi che adotteremo sono: - prezzi fissi (no distinzione
Corso di Ingegneria del Software. Modelli di produzione del software
 Corso di Ingegneria del Software a.a. 2009/2010 Mario Vacca mario.vacca1@istruzione.it 1. Concetti di base Sommario 2. 2.1 Modello a cascata 2.2 Modelli incrementali 2.3 2.4 Comparazione dei modelli 2.5
Corso di Ingegneria del Software a.a. 2009/2010 Mario Vacca mario.vacca1@istruzione.it 1. Concetti di base Sommario 2. 2.1 Modello a cascata 2.2 Modelli incrementali 2.3 2.4 Comparazione dei modelli 2.5
FUNZIONE DI COSTO E MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO
 45 FUNZIONE DI COSTO E MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO 4.1 Rendimenti di scala e funzione di costo Il costo di produzione c( w, ) dipende dal prodotto per la semplice ragione che più output richiede più input.
45 FUNZIONE DI COSTO E MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO 4.1 Rendimenti di scala e funzione di costo Il costo di produzione c( w, ) dipende dal prodotto per la semplice ragione che più output richiede più input.
P.A.S. Percorsi Abilitanti Speciali 2014 Facoltà di Giurisprudenza Ettore Peyron - Lezione N 1 C del CATEGORIE fondamentali della
 P.A.S. Percorsi Abilitanti Speciali 2014 Facoltà di Giurisprudenza Ettore Peyron - Lezione N 1 C del 24-4-2014 CATEGORIE fondamentali della MACROECONOMIA tratte dalla MICROECONOMIA Le LEGGI della DOMANDA
P.A.S. Percorsi Abilitanti Speciali 2014 Facoltà di Giurisprudenza Ettore Peyron - Lezione N 1 C del 24-4-2014 CATEGORIE fondamentali della MACROECONOMIA tratte dalla MICROECONOMIA Le LEGGI della DOMANDA
In questo esempio, come in tutti gli altri, chiamiamo l individuo 1 giocatore di riga, perché deve scegliere di collocarsi in una delle due righe
 Teoria dei Giochi La teoria dei giochi è la scienza matematica che studia e analizza le decisioni individuali di più soggetti che mirano al massimo guadagno personale dalla scelta che essi prendono. Le
Teoria dei Giochi La teoria dei giochi è la scienza matematica che studia e analizza le decisioni individuali di più soggetti che mirano al massimo guadagno personale dalla scelta che essi prendono. Le
Corso di Economia e Gestione delle Imprese e Marketing a.a Lezione 16 Prof. Elena Cedrola
 Corso di Economia e Gestione delle Imprese e Marketing a.a. 2015-2016 Lezione 16 Prof. Elena Cedrola elena.cedrola@unimc.it http://docenti.unimc.it/docenti/elenacedrola Programma Marketing Il marketing
Corso di Economia e Gestione delle Imprese e Marketing a.a. 2015-2016 Lezione 16 Prof. Elena Cedrola elena.cedrola@unimc.it http://docenti.unimc.it/docenti/elenacedrola Programma Marketing Il marketing
2.4 Risposte alle domande di ripasso
 Domanda e offerta 5 2.4 Risposte alle domande di ripasso 1. La penuria si verifica quando, a un dato prezzo, la domanda è superiore all offerta. Il concetto di scarsità implica invece che non tutti possano
Domanda e offerta 5 2.4 Risposte alle domande di ripasso 1. La penuria si verifica quando, a un dato prezzo, la domanda è superiore all offerta. Il concetto di scarsità implica invece che non tutti possano
Note sul sistema di Lotka-Volterra. Prima versione. Commenti e correzioni sono benvenuti.
 Ottobre 2016 Note sul sistema di Lotka-Volterra Prima versione. Commenti e correzioni sono benvenuti. 1 Introduzione Il sistema di Lotka Volterra (LV), o sistema preda predatore è probabilmente il primo
Ottobre 2016 Note sul sistema di Lotka-Volterra Prima versione. Commenti e correzioni sono benvenuti. 1 Introduzione Il sistema di Lotka Volterra (LV), o sistema preda predatore è probabilmente il primo
LA TEORIA DELL OFFERTA. Tecnologia e costi di produzione
 LA TEORIA DELL OFFERTA Tecnologia e costi di produzione IL COMPORTAMENTO DELL IMPRESA In questa lezione approfondiremo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta.
LA TEORIA DELL OFFERTA Tecnologia e costi di produzione IL COMPORTAMENTO DELL IMPRESA In questa lezione approfondiremo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta.
Implica quindi che le imprese oligopolistiche sono interdipendenti nelle loro scelte in un modo assolutamente inedito per la concorrenza perfetta
 L oligopolio In un mercato oligopolistico sono presenti solo poche imprese e le azioni del singolo venditore possono avere notevoli conseguenze sul profitto degli altri venditori Implica quindi che le
L oligopolio In un mercato oligopolistico sono presenti solo poche imprese e le azioni del singolo venditore possono avere notevoli conseguenze sul profitto degli altri venditori Implica quindi che le
La Teoria dei Giochi. (Game Theory)
 La Teoria dei Giochi. (Game Theory) Giochi simultanei, Giochi sequenziali, Giochi cooperativi. Mario Sportelli Dipartimento di Matematica Università degli Studi di Bari Via E. Orabona, 4 I-70125 Bari (Italy)
La Teoria dei Giochi. (Game Theory) Giochi simultanei, Giochi sequenziali, Giochi cooperativi. Mario Sportelli Dipartimento di Matematica Università degli Studi di Bari Via E. Orabona, 4 I-70125 Bari (Italy)
Produzione e tasso di cambio nel breve periodo
 Produzione e tasso di cambio nel breve periodo Determinanti della domanda aggregata nel breve periodo Un modello di breve periodo dell equilibrio del mercato dei beni Un modello di breve periodo dell equilibrio
Produzione e tasso di cambio nel breve periodo Determinanti della domanda aggregata nel breve periodo Un modello di breve periodo dell equilibrio del mercato dei beni Un modello di breve periodo dell equilibrio
Indice. Parte 1 Concetti fondamentali 1. 1 Organizzazione industriale: cosa, come e perché 3. 2 Fondamenti di microeconomia 19
 Prefazione all edizione originale Prefazione all edizione italiana Autori Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura XVII XIX XXI XXIII XXV Parte 1 Concetti fondamentali 1 1 Organizzazione industriale:
Prefazione all edizione originale Prefazione all edizione italiana Autori Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura XVII XIX XXI XXIII XXV Parte 1 Concetti fondamentali 1 1 Organizzazione industriale:
Lezioni di Microeconomia
 Lezioni di Microeconomia Lezione 2 L Economia di mercato, la domanda e l offerta Lezione 2: Economia di mercato, domanda e offerta Slide 1 Economia di Mercato e Scambio Ricordiamo: per ciascun bene o fattore
Lezioni di Microeconomia Lezione 2 L Economia di mercato, la domanda e l offerta Lezione 2: Economia di mercato, domanda e offerta Slide 1 Economia di Mercato e Scambio Ricordiamo: per ciascun bene o fattore
Fisiologia Fisiologia umana
 Atomi Molecole Cellule Tessuti Organi Apparati Sistemi CHIMICA BIOLOGIA MOLECOLARE BIOLOGIA CELLULARE FISIOLOGIA Obiettivo della Fisiologia è quello di spiegare il funzionamento degli organismi viventi
Atomi Molecole Cellule Tessuti Organi Apparati Sistemi CHIMICA BIOLOGIA MOLECOLARE BIOLOGIA CELLULARE FISIOLOGIA Obiettivo della Fisiologia è quello di spiegare il funzionamento degli organismi viventi
b) Un difetto di funzionamento: la fotorespirazione
 b) Un difetto di funzionamento: la fotorespirazione A questo punto, occorre dire qualcosa su quello che si può considerare un difetto di funzionamento della fotosintesi e sui meccanismi che determinate
b) Un difetto di funzionamento: la fotorespirazione A questo punto, occorre dire qualcosa su quello che si può considerare un difetto di funzionamento della fotosintesi e sui meccanismi che determinate
Capitolo 9 La produzione. Robert H. Frank Microeconomia - 5 a Edizione Copyright The McGraw-Hill Companies, srl
 Capitolo 9 La produzione LA PRODUZIONE Le imprese utilizzano i fattori produttivi (input) per produrre beni e servizi (output) La produzione trasforma un insieme di input in un insieme di output Tra gli
Capitolo 9 La produzione LA PRODUZIONE Le imprese utilizzano i fattori produttivi (input) per produrre beni e servizi (output) La produzione trasforma un insieme di input in un insieme di output Tra gli
1. Introduzione alle forme di mercato - Concorrenza perfetta
 1. Introduzione alle forme di mercato - Concorrenza perfetta Alessandra Michelangeli November 3, 2010 Alessandra Michelangeli () 1. Forme di mercato - Concorrenza perfetta November 3, 2010 1 / 16 Forme
1. Introduzione alle forme di mercato - Concorrenza perfetta Alessandra Michelangeli November 3, 2010 Alessandra Michelangeli () 1. Forme di mercato - Concorrenza perfetta November 3, 2010 1 / 16 Forme
Macroeconomia. Equilibrio di breve e medio periodo: Modello As - Ad. Esercitazione del 13.04.2016 (+ soluzioni) (a cura della dott.
 Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza Corso di Laurea in ECONOMIA Macroeconomia Equilibrio di breve e medio periodo: Modello As - Ad Esercitazione del 13.04.2016 (+ soluzioni) (a cura della dott.ssa
Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza Corso di Laurea in ECONOMIA Macroeconomia Equilibrio di breve e medio periodo: Modello As - Ad Esercitazione del 13.04.2016 (+ soluzioni) (a cura della dott.ssa
Indice Sommario. pag. Indice delle figure TEORIA DEL CONSUMATORE Domande a risposta aperta
 Indice Sommario pag. Indice delle figure... 5 1. TEORIA DEL CONSUMATORE... 9 Domande a risposta aperta... 11 Problemi... 38 Domande a risposta multipla... 55 2. PRODUZIONE E COSTI... 59 Domande a risposta
Indice Sommario pag. Indice delle figure... 5 1. TEORIA DEL CONSUMATORE... 9 Domande a risposta aperta... 11 Problemi... 38 Domande a risposta multipla... 55 2. PRODUZIONE E COSTI... 59 Domande a risposta
Note sul monopolio 1) Il monopolista fronteggia la domanda del mercato: diventa cruciale il concetto di ricavo marginale
 Note sul monopolio 1) Il monopolista fronteggia la domanda del mercato: diventa cruciale il concetto di ricavo marginale In monopolio esiste una sola impresa che perciò fronteggia tutta la domanda di mercato.
Note sul monopolio 1) Il monopolista fronteggia la domanda del mercato: diventa cruciale il concetto di ricavo marginale In monopolio esiste una sola impresa che perciò fronteggia tutta la domanda di mercato.
REGOLAZIONE DEL CICLO CELLULARE
 REGOLAZIONE DEL CICLO CELLULARE Il sistema di controllo che regola la progressione del ciclo cellulare deve: 1) Garantire che tutti i processi associati con le diverse fasi siano portati a termine al tempo
REGOLAZIONE DEL CICLO CELLULARE Il sistema di controllo che regola la progressione del ciclo cellulare deve: 1) Garantire che tutti i processi associati con le diverse fasi siano portati a termine al tempo
6014 Principi di Economia Domanda e Offerta aggregate (Cap. 33)
 614 Principi di Economia Domanda e Offerta aggregate (Cap. 33) Fluttuazioni Cicliche Modello di domanda e offerta aggregate Utilizzato per spiegare fluttuazioni cicliche Breve periodo, dove non vige dicotomia
614 Principi di Economia Domanda e Offerta aggregate (Cap. 33) Fluttuazioni Cicliche Modello di domanda e offerta aggregate Utilizzato per spiegare fluttuazioni cicliche Breve periodo, dove non vige dicotomia
Come sviluppare un progetto d impresa. Presentato da: dr.ssa Patrizia Andreani
 1 Come sviluppare un progetto d impresa Presentato da: dr.ssa Patrizia Andreani 2 L azienda come sistema L azienda è un sistema: aperto (input output); dinamico (si adatta alle mutevoli situazioni esterne);
1 Come sviluppare un progetto d impresa Presentato da: dr.ssa Patrizia Andreani 2 L azienda come sistema L azienda è un sistema: aperto (input output); dinamico (si adatta alle mutevoli situazioni esterne);
Struttura di mercato: insieme di elementi che incidono sul comportamento e il rendimento delle imprese di mercato, quali numero di imprese e tipo di
 Struttura di mercato: insieme di elementi che incidono sul comportamento e il rendimento delle imprese di mercato, quali numero di imprese e tipo di bene venduto Concorrenzialità del mercato: dipende dalla
Struttura di mercato: insieme di elementi che incidono sul comportamento e il rendimento delle imprese di mercato, quali numero di imprese e tipo di bene venduto Concorrenzialità del mercato: dipende dalla
L elasticità e le sue applicazioni in economia Introduzione
 L elasticità e le sue applicazioni in economia Introduzione Fino ad ora l analisi su domanda, offerta ed equilibrio di mercato è stata di tipo qualitativo. Se vogliamo avere una misura quantitativa degli
L elasticità e le sue applicazioni in economia Introduzione Fino ad ora l analisi su domanda, offerta ed equilibrio di mercato è stata di tipo qualitativo. Se vogliamo avere una misura quantitativa degli
Definizione di impresa PERCHE ESISTONO LE IMPRESE? CHE RUOLO HANNO NEL SISEMA ECONOMICO? COME SI COMPORTANO LE IMPRESE?
 Barbara Martini Definizione di impresa PERCHE ESISTONO LE IMPRESE? CHE RUOLO HANNO NEL SISEMA ECONOMICO? COME SI COMPORTANO LE IMPRESE? LE IMPRESE NEL CONTESTO ECONOMICO: LE FORME DI MERCATO CONCORRENZA
Barbara Martini Definizione di impresa PERCHE ESISTONO LE IMPRESE? CHE RUOLO HANNO NEL SISEMA ECONOMICO? COME SI COMPORTANO LE IMPRESE? LE IMPRESE NEL CONTESTO ECONOMICO: LE FORME DI MERCATO CONCORRENZA
CONCORRENZA PERFETTA
 CONCORRENZA PERFETTA PERFETTA INFORMAZIONE: tutti sanno quello che fanno gli altri Caratteristiche POLVERIZZAZIONE DEL MERCATO: molti piccoli acquirenti e produttori, incapaci di influire sul prezzo di
CONCORRENZA PERFETTA PERFETTA INFORMAZIONE: tutti sanno quello che fanno gli altri Caratteristiche POLVERIZZAZIONE DEL MERCATO: molti piccoli acquirenti e produttori, incapaci di influire sul prezzo di
4.4 Il regolatore di tensione a diodo zener.
 4.4 l regolatore di tensione a diodo zener. n molte applicazioni il valore del fattore di ripple ottenibile con un alimentatore a raddrizzatore e filtro capacitivo non è sufficientemente basso. Per renderlo
4.4 l regolatore di tensione a diodo zener. n molte applicazioni il valore del fattore di ripple ottenibile con un alimentatore a raddrizzatore e filtro capacitivo non è sufficientemente basso. Per renderlo
ECONOMIA URBANA. Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre. Contatti: costanti@uniroma3.it
 ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it LA MICROECONOMIA LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO DEI SINGOLI AGENTI IN UN SISTEMA ECONOMICO Economia
ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it LA MICROECONOMIA LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO DEI SINGOLI AGENTI IN UN SISTEMA ECONOMICO Economia
Sesta Indagine Eurostudent
 Sesta Indagine Eurostudent Popolazione: iscritti 2008-2009 a corsi di I e II ciclo (L, LM, LMCU) Campione: 4.499 studenti (università statali e non statali) Periodo di rilevazione: maggio-giugno 2010 Modalità
Sesta Indagine Eurostudent Popolazione: iscritti 2008-2009 a corsi di I e II ciclo (L, LM, LMCU) Campione: 4.499 studenti (università statali e non statali) Periodo di rilevazione: maggio-giugno 2010 Modalità
INDICE CAPITOLO 1 IL SISTEMA ECONOMICO, LE REGOLE E GLI OPERATORI
 INDICE CAPITOLO 1 IL SISTEMA ECONOMICO, LE REGOLE E GLI OPERATORI 1. Introduzione... pag. 1 2. Il sistema economico e i modelli in economia...» 5 3. Il flusso circolare dei beni e del reddito...» 7 4.
INDICE CAPITOLO 1 IL SISTEMA ECONOMICO, LE REGOLE E GLI OPERATORI 1. Introduzione... pag. 1 2. Il sistema economico e i modelli in economia...» 5 3. Il flusso circolare dei beni e del reddito...» 7 4.
Perche le banche soddisfano il fabbisogno delle imprese
 Perche le banche soddisfano il fabbisogno delle imprese 1 ATTENZIONE: La presente dispensa contiene materiale messo a disposizione per gli utenti del sito www.bilancioutile.com Essendo materiale didattico
Perche le banche soddisfano il fabbisogno delle imprese 1 ATTENZIONE: La presente dispensa contiene materiale messo a disposizione per gli utenti del sito www.bilancioutile.com Essendo materiale didattico
Capitolo otto. L economia politica degli investimenti. Ideologie politiche e IDE. Nazionalismo pragmatico. Anti-IDE. Liberista 8-3
 EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO Capitolo otto L economia politica degli investimenti Ideologie politiche e IDE 8-3 Anti-IDE Nazionalismo pragmatico Liberista La posizione anti-ide 8-4 Visione marxista: le
EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO Capitolo otto L economia politica degli investimenti Ideologie politiche e IDE 8-3 Anti-IDE Nazionalismo pragmatico Liberista La posizione anti-ide 8-4 Visione marxista: le
Politiche ambientali e politiche commerciali. [a.a. 2013/14]
![Politiche ambientali e politiche commerciali. [a.a. 2013/14] Politiche ambientali e politiche commerciali. [a.a. 2013/14]](/thumbs/54/33759300.jpg) olitiche ambientali e politiche commerciali. [a.a. 2013/14] 8 (1) - 1 aa. 11-12 Commercio internazionale e standard ambientali Rispetto agli standard dei paesi ricchi, gli standard ambientali dei paesi
olitiche ambientali e politiche commerciali. [a.a. 2013/14] 8 (1) - 1 aa. 11-12 Commercio internazionale e standard ambientali Rispetto agli standard dei paesi ricchi, gli standard ambientali dei paesi
Il comportamento delle imprese
 Il comportamento delle imprese Fino a ora il comportamento delle imprese è entrato nella nostra analisi in modo del tutto marginale, attraverso la curva di offerta e la legge dell offerta secondo cui al
Il comportamento delle imprese Fino a ora il comportamento delle imprese è entrato nella nostra analisi in modo del tutto marginale, attraverso la curva di offerta e la legge dell offerta secondo cui al
Individuare le risposte corrette per ciascun quesito (anche più di una)
 F. GIUNTA ECONOMIA AZIENDALE QUESITI DI AUTOVALUTAZIONE CAPITOLO IX Individuare le risposte corrette per ciascun quesito (anche più di una) 1. Si ha equilibrio economico quando: a. i ricavi sono uguali
F. GIUNTA ECONOMIA AZIENDALE QUESITI DI AUTOVALUTAZIONE CAPITOLO IX Individuare le risposte corrette per ciascun quesito (anche più di una) 1. Si ha equilibrio economico quando: a. i ricavi sono uguali
Capitolo cinque. La teoria del commercio internazionale. Una visione d insieme sulle teorie del commercio internazionale
 Capitolo cinque La teoria del commercio internazionale Una visione d insieme sulle teorie del commercio internazionale 5-3 Si ha libero scambio quando un governo non cerca di influenzare, con contingentamenti
Capitolo cinque La teoria del commercio internazionale Una visione d insieme sulle teorie del commercio internazionale 5-3 Si ha libero scambio quando un governo non cerca di influenzare, con contingentamenti
Grant, L'analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, 2011 Capitolo IV. L analisi dei concorrenti L ANALISI DEI CONCORRENTI
 L ANALISI DEI CONCORRENTI 1 Saper eseguire una corretta analisi dei concorrenti comporta saper: 1. valutare l impatto e i profitti potenziali di prodotti e fornitori complementari; 2. valutare le implicazioni
L ANALISI DEI CONCORRENTI 1 Saper eseguire una corretta analisi dei concorrenti comporta saper: 1. valutare l impatto e i profitti potenziali di prodotti e fornitori complementari; 2. valutare le implicazioni
