FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE
|
|
|
- Carla Carbone
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE 1
2 TIPOLOGIE DI INQUINAMENTO Reflui e rifiuti urbani, industriali o agricoli possono dare luogo a diversi tipi di inquinamento: 1. Inquinamento estetico - organolettico; 2. Deossigenazione, 3. Eutrofizzazione 4. Inquinamento microbiologico; 5. Inquinamento chimico; 6. Inquinamento termico. 2
3 INQUINAMENTO ESTETICO ORGANOLETTICO Cause Sostanze galleggianti; Intorbidamento; Colorazione delle acque; Maleodorazione. Effetti Alterazione del valore paesaggistico; Diminuzione della fruibilità del corpo idrico; Effetti secondari (limitata penetrazione della luce, carente diffusione di ossigeno). 3
4 DEOSSIGENAZIONE DELLE ACQUE OSSIGENO DISCIOLTO IN ACQUA p = π x = H Legge di Henry C s p = pressione parziale dell O 2 nell aria π = pressione totale dell aria (1 atmosfera) x = frazione molare dell O 2 nell aria H = coeff. di Henry C s = concentrazione di saturazione dell O 2 in acqua 4
5 C s = f (T, p) A T cost, C s diminuisce all aumentare della salinità. Concentrazione di O 2 in acqua Per T = 4 25 C, C s ~ 10 mg/l Concentrazioni minime per la sopravvivenza della fauna ittica: 5 mg/l per specie ittiche pregiate (ex. Salmonidi); 4 mg/l per la maggior parte delle specie ittiche; 2 mg/l per le specie ittiche meno pregiate (ex. Ciprinidi). 5
6 BILANCIO DELL OSSIGENO O 2 = R 1 + R 2 + Z - S Fattori principali che incidono sul bilancio: R 1 consumo di O 2 operato dalla flora batterica per la degradazione del BOD; R 2 riossigenazione delle acque attraverso scambio diretto con l atmosfera; Fattori di minore rilevanza per il bilancio: Z produzione netta di O 2 per fotosintesi algale [kg/h]; S consumo di O 2 da parte del bentos [kg/h]. 6
7 EQUAZIONE DI BILANCIO x x + dx Q C R 1 R 2 S Z Q C + (dc/dx) dx Variazione del carico di O 2 tra la sezione x e la sezione x + dx + Somma algebrica dei termini di generazione/ scomparsa = Accumulo nel tempo del peso di ossigeno nell elemento dv (=A*dx) 7
8 CONSUMO BIOCHIMICO DELL OSSIGENO (R 1 ) L ossigeno è utilizzato dai batteri aerobi per la degradazione dei composti organici naturali. Un ulteriore apporto di BOD (sostanze organiche) determina un aumento dell attività batterica; se ne deduce che: Cinetica del consumo di O 2 I ordine Cinetica della rimozione del BOD 8
9 DEOSSIGENAZIONE BIOCHIMICA dc db r = = = K B = K B e dt dt K t C = concentrazione di O 2 ; B = concentrazione sostanza organica (BOD 5 ) B 0 = BOD 5 iniziale (per t = 0) K 1 = costante di deossigenazione t = x/v, dove x = spazio percorso e v = velocità media 9
10 Consumo di BOD (B) ed ossigeno (C) disciolto in un corso d acqua a seguito del solo fenomeno di deossigenazione biochimica Consumo O 2 Consumo BOD 10
11 DIFFUSIONE MOLECOLARE Nel bilancio è stato trascurato lo scambio di O 2 per diffusione molecolare; il flusso di massa viene calcolato in base alla seguente formula: = ϕ C D x Legge di diffusione di Fick ϕ = flusso di massa per diffusione molecolare [kg/mq h] D = coeff. di diffusione (molecolare + aggregati) C = concentrazione dell O 2 D molecolare = f (T, natura della materia, natura del mezzo) D aggregati = f (livello di turbolenza locale x) 11
12 FATTORI DI CONTROLLO Nella valutazione dello scambio di O 2 per diffusione molecolare è necessario tenere conto di alcune caratteristiche del corso d acqua che influiscono sul flusso di massa: Pendenza Zone morte Profondità turbolenza quiete minore scambio 12
13 RIOSSIGENAZIONE (R 2 ) Il trasporto dell ossigeno dalla fase gassosa alla fase liquida (ossigeno disciolto) è governato dall equazione del trasporto di massa: Q = KS ( C C) S Q = O 2 trasferito nell unità di tempo [kg/h] K = coefficiente di trasporto [m/h] S = superficie interfacciale di scambio gas/liquido [m 2 ] C s = concentrazione di saturazione dell O 2 in acqua [kg/m 3 ] C = concentrazione dell O 2 disciolto in acqua [kg/m 3 ] 13
14 PRODUZIONE NETTA PER FOTOSINTESI ALGALE (Z) Il termine Z è dato dalla differenza tra la produzione lorda P, dovuta alla fotosintesi, ed il consumo R, dovuto alla respirazione (Z = P R). I parametri che influenzano la produzione netta di O 2 sono: Intensità e durata dell irraggiamento solare Temperatura dell acqua Altezza media dell acqua (solo i primi cm sono interessati da intesa fotosintesi) 14
15 Andamento tipico dell ossigeno disciolto per effetto dell attività algale (fotosintesi e respirazione). Fotosintesi Respirazione 15
16 CONSUMO BENTONICO DELL O 2 (S) Sul letto di alcuni fiumi lenti si formano dei depositi che, per l intensa attività batterica aerobica che si sviluppa lungo l interfaccia acqua/deposito, esercitano una domanda di O 2. Questo termine ha, nella gran parte dei casi, un incidenza relativa. 16
17 MODELLO DI STREETER & PHELPS (America ~ 1930) Modello semplificato che tiene conto di due soli fattori: R 1 deossigenazione per consumo biochimico dell O 2 ; R 2 riossigenazione attraverso lo scambio diretto con l atmosfera. E si basa sulle seguenti ipotesi: d( CV) Condizioni stazionarie; Costanza della portata Q lungo la direzione del flusso; = 0 Scambi di O 2 per diffusione trascurabili. dt 17
18 EQUAZIONE DI STREETER & PHELPS () D t = K 2 K 1 K 1 B 0 e K v 1 x e K v 2 x + Dove D rappresenta il deficit dato da (C s C) D e 0 K v 2 x 1 deossigenazione 2 riossigenazione 2 riossigenazione impedita 3 curva a sacco 18
19 Comparazione della curva a sacco col limite di 5 mg/l di O 2 disciolto, necessario per la sopravvivenza ittica: a. Condizione accettabile b. Condizione inaccettabile per il tratto A-B c. Condizione inaccettabile per il tratto C-D, nel tratto E-F si manifesta una condizione anaerobica 19
20 1. Influenza della temperatura sull andamento della curva a sacco 2. Influenza di uno scarico termico sull andamento della curva a sacco e della curva del BOD 20
21 Andamento della curva a sacco e del BOD nel caso di tre scarichi organici in successione scarichi
22 EUTROFIZZAZIONE Manifestazione di inquinamento cronico dei bacini lacustri e di bacini idrici con debole ricambio (baie, lagune, ). CAUSA: eccessivo apporto di sostanze nutritive; Carbonio, Azoto e Fosforo, questi ultimi costituiscono i fattori limitanti perché il Carbonio è sempre presente in sovrabbondanza nelle acque naturali. Fosforo: assimilato dalle alghe solo come ortofosfato (PO 4 3- ); Azoto: assimilato sia come nitrato (NO 3- ), sia come ammonio (NH 4+ ); alcune alghe (blu/verdi) sono in grado di utilizzare l azoto atmosferico. 22
23 Catena alimentare Fito/zooplancton necton CO 2 + NO 3- + PO 4 3- bentos Il fitoplancton costituisce alimento per lo zooplancton, del quale si ciba il necton (pesci). Gli organismi indicati, al termine del loro ciclo vitale, decadono sul fondo arricchendo il bentos in cui si sviluppa l attività batterica, vengono così liberati sali minerali e nutrienti tra cui N e P che costituiscono alimento per il fitoplancton. 23
24 ECCESSIVO APPORTO DI NUTRIENTI Il ciclo alimentare diventa squilibrato quando si inseriscono degli apporti di nutrienti dall esterno, se il fenomeno diventa troppo intenso si generano degli effetti indesiderati: 1. Intorbidimento e colorazione delle acque (eccessiva crescita algale) - clorofilla; 2. Diminuzione del contenuto di O 2 disciolto in acqua per l intensa attività bentonica; 3. Scomparsa progressiva delle specie ittiche più pregiate, con conseguente incremento delle specie più resistenti alle cattive condizioni; 4. Formazione di zone anossiche in cui si instaurano dei processi anaerobi dai quali ha origine la formazione di sottoprodotti tossici (S 2-, CH 4, ) o maleodoranti (H 2 S, PH 3 ). 24
25 CLASSIFICAZIONE DEI LAGHI A seconda dell arricchimento in nutrienti (e conseguente produttività algale), i laghi sono così classificati: Lago oligotrofico: bassi livelli di nutrienti, quindi di alghe; Lago mesotrofico: presenza equilibrata di nutrienti; Lago distrofico: ricco di un nutriente e povero di un altro; Lago eutrofico: ricco di nutrienti e produttività algale. Esistono due classificazioni estreme: ultraoligotrofico ed ipertrofico. 25
26 STRATIFICAZIONE DEI LAGHI Il lago può essere suddiviso in tre zone distinte: Epilimnio: zona superiore; Termoclinio: zona intermedia con gradiente di 1 C ogni m; Ipolimnio: zona profonda. Le acque profonde (ipolimnio) sono caratterizzate da una temperatura costante pari a ca. 4 C; l epilimnio è invece soggetto alle fluttuazioni termiche esterne, si generano così dei fenomeni di stratificazione in inverno ed in estate. Durante il periodo primaverile l epilimnio tende a riscaldarsi e le sue acque si miscelano con quelle dell ipolimnio, lo stesso avviene in autunno, quando le acque dell epilimnio si raffreddano. 26
27 Fenomeni di stratificazione invernale e estiva e di ricircolazione primaverile ed autunnale. 27
28 Durante i periodi di ricircolazione le sostanze nutritive, presenti sul fondo del lago, vengono messe in circolo determinando la crescita del fitoplancton (fioriture algali). 28
29 CONTROLLO DELL EUTROFIZZAZIONE Per controllare l eutrofizzazione è necessario operare sui carichi nutrienti, siano essi già presenti nel lago o che vengano immessi tramite scarico. FOSFORO AZOTO Per il criterio del fattore limitante è sufficiente operare su un singolo nutriente, in genere si interviene sul fosforo, sia perché il carico di P associato alle acque di rifiuto è una quota rilevante, sia perché il P rappresenta il fattore limitante per la crescita algale. 29
30 BILANCIO DEI CARICHI DI FOSFORO CARICHI LOCALIZZATI Si tratta dei carichi associati alle acque reflue: 1. Liquami domestici Il P tot è costituito da fosforo organico (P-organico), ortofosfati (PO 4 3- ) e polifosfati (P x O x ). Prima dei provvedimenti legislativi del 92, che hanno limitato la presenza di P nei detersivi ad un max dell 1%, il carico di P nei liquami grezzi era di ca kg/ab anno, oggi questo valore si aggira intorno a kg/ab anno. La rimozione del fosforo negli impianti di depurazione meccanico-biologici ha le rese seguenti: dopo sedimentazione primaria 10% ca. dopo trattamenti meccanici-biologici 20% ca. 30
31 2. Liquami zootecnici La stima del carico di fosforo associato alle diverse tipologie di allevamenti è la seguente: equini 11.8 [kg P/capo anno] bovini 9.1 [kg P/capo anno] suini 5.6 [kg P/capo anno] ovini/caprini 1.5 [kg P/capo anno] polli 0.06 [kg P/capo anno] Il carico effettivamente destinato al corpo idrico dipende dalla quantità di deiezioni riutilizzata in agricoltura e dall efficienza del sistema di depurazione. 3. Liquami industriali L apporto di P da parte delle industrie è limitato, salvo particolari scarichi (industrie agro alimentari, distillerie, ) per cui la concentrazione è simile a quella dei reflui domestici. 31
32 CARICHI DIFFUSI Carichi determinati da fonti diffuse come piogge e terreni: 1. Pioggia: contribuisce col dilavamento del pulviscolo atmosferico sia naturale sia di origine industriale; 2. Residui organici naturali: vegetali in decadimento e deiezioni della fauna selvatica, hanno un modesto contributo; 3. Drenaggio di suolo non coltivato: il P (P-organico e apatite) viene ceduto in minima parte dal terreno a causa del dilavamento meteorico (ca. 0.1 kg/ha anno); 4. Drenaggio di suolo coltivato: la quantità di P rilasciato dai terreni coltivati può raggiungere 0.4 kg/ha anno; 5. Drenaggio di aree urbanizzate: il P presente sul suolo urbano deriva da residui organici animali e vegetali e/o da alcuni additivi presenti nelle benzine (solo in USA). Il carico stimato è pari a ~1 2 kg P/ha anno. 32
33 INTERVENTI PER LA LIMITAZIONE DEI CARICHI 1. Limitazione nei detersivi: il limite di concentrazione di P nei detersivi è stato fissato per legge all 1%; per i TPF (tripolifosfati) sono stati testati dei prodotti alternativi tipo zeoliti artificiali, citrato di sodio e NTA (acido nitrilotriacetico); 2. Razionalizzazione delle risorse agricole: si cerca di limitare l uso dei fertilizzanti chimici sostituendoli con le deiezioni animali, programmando una corretta concimazione dei terreni e utilizzando concimi a lento rilascio; 3. Pratiche alternative in zootecnia: attraverso un attenta gestione della risorsa acqua si riesce a ridurne il consumo e di conseguenza la quantità delle acque di rifiuto. 33
34 MODELLO DI WOLLENVEIDER Attraverso la curva di Wollenveider si riescono a stimare i carichi critici di P (L c ) note le caratteristiche del lago (q s ) ed i carichi di P alimentati. Z q s = T q s = carico idraulico superficiale, w Carico critico L c [g di P/m 2 anno] Z = altezza media delle acque del lago; T w = tempo medio di ricambio delle acque CONDIZIONI EUTROFICHE CONDIZIONI OLIGOTROFICHE Carico idraulico q s [m/anno] 34
35 TECNICHE DI RISANAMENTO TECNICHE DI PREVENZIONE Per evitare l eutrofizzazione dei laghi è necessario operare sui carichi di P apportati nel bacino, gli interventi possono interessare il singolo scarico e/o tutti gli scarichi. Operando sui singoli scarichi è possibile affrontare più rapidamente il problema attraverso la graduale realizzazione degli impianti. 35
36 La costruzione di un collettore circumlacuale richiede degli investimenti iniziali massicci, ha tuttavia il vantaggio di sottrarre l intero carico inquinante associato agli scarichi; inoltre si hanno maggiori benefici sui costi di esercizio e sull affidabilità dei controlli La soluzione adottata più di frequente è quella mista, in cui esistono tratti di collettore circumlacuale e scarichi con singoli impianti di depurazione. 36
37 TECNICHE DI CURA Nel caso in cui il lago si trovi già nello stato eutrofico è necessario operare degli interventi curativi, i tempi necessari per il ripristino dello stato di equilibrio sono molto lunghi a causa di: Tempo naturale di ricambio delle acque (alcuni anni); Rilascio di fosforo da parte dei sedimenti (grandi quantità di depositi bentonici). Per accelerare i tempi di recupero, si può operare attraverso: 1. Sifonamento ipolimnico Vengono drenate le acque ipolimniche che sono quelle più ricche essendo a contatto diretto con il bentos. L acqua drenata viene recapitata direttamente nell emissario tramite un sifone che, una volta attivato, si autoalimenta. Questo intervento richiede degli elevati costi d investimento e può alterare il bilancio idraulico del loco. 37
38 2. Dragaggio dei sedimenti di fondo Intervento più energico che incide sulla causa prima del fenomeno. Si asportano i primi cm di sedimento che sono quelli soggetti a trasformazione biologica. I sedimenti asportati devono essere disidratati e smaltiti correttamente (come fertilizzanti o direttamente in discarica). Questo metodo comporta delle difficoltà gestionali e la possibile alterazione dell equilibrio di vita del fondo (bentos). 3. Ossigenazione delle acque Questa tecnica agisce sull effetto dell eutrofizzazione (carenza di O 2 ) e non sulle cause. Si tratta di una tecnica complementare alle precedenti che permette di accelerare i tempi di recupero. L ossigenazione viene effettuata sia con aria, sia con O 2 puro e può interessare tutta la colonna d acqua (profondità del bacino limitata) o solo l ipolimnio. 38
39 L aerazione è limitata alla zona ipolimnica, con questo metodo si evita la destratificazione che avviene quando l ossigenazione interessa tutta la colonna d acqua. Oltre alla tecnica rappresentata in figura, si può aspirare l acuqa dal fondo, saturarla con O 2 e reimmeterla nell ipolimnio. 39
Acque superficiali. Parte 4 (13)
 Corso di: DINAMICA DEGLI INQUINANTI Acque superficiali Parte 4 (13) Università di Roma Tor Vergata Anno Accademico 2009-2010 ing. Simona Berardi ARGOMENTI TRATTATI: Inquinamento dei fiumi Bilancio dell
Corso di: DINAMICA DEGLI INQUINANTI Acque superficiali Parte 4 (13) Università di Roma Tor Vergata Anno Accademico 2009-2010 ing. Simona Berardi ARGOMENTI TRATTATI: Inquinamento dei fiumi Bilancio dell
Capitolo 1 FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI
 Capitolo FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI INDICE Capitolo FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI... INDICE... 2 TIPOLOGIE DI INQUINAMENTO... 4 2 INQUINAMENTO ESTETICO-ORGANOLETTICO...
Capitolo FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI INDICE Capitolo FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI... INDICE... 2 TIPOLOGIE DI INQUINAMENTO... 4 2 INQUINAMENTO ESTETICO-ORGANOLETTICO...
corso d acqua Un corso d acqua origina da una sorgente e termina con una foce,
 Corsi d acqua Un corso d acqua origina da una sorgente e termina con una foce, che può essere il mare o un titolo corso d acqua copertina più grande. Dalla sorgente alla foce sono riconoscibili tratti
Corsi d acqua Un corso d acqua origina da una sorgente e termina con una foce, che può essere il mare o un titolo corso d acqua copertina più grande. Dalla sorgente alla foce sono riconoscibili tratti
VALUTAZIONE DEL CARICO TROFICO
 VALUTAZIONE DEL CARICO TROFICO Le metodologie per la valutazione del carico trofico sono disponibili per il momento solo per i laghi naturali e artificiali, a causa del consumo umano di tali acque. CRITERI
VALUTAZIONE DEL CARICO TROFICO Le metodologie per la valutazione del carico trofico sono disponibili per il momento solo per i laghi naturali e artificiali, a causa del consumo umano di tali acque. CRITERI
FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI
 FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI INDICE FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI... i INDICE... ii. TIPOLOGIE DI INQUINAMENTO.... INQUINAMENTO ESTETICO-ORGANOLETTICO... 3. DEOSSIGENAZIONE
FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI INDICE FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI... i INDICE... ii. TIPOLOGIE DI INQUINAMENTO.... INQUINAMENTO ESTETICO-ORGANOLETTICO... 3. DEOSSIGENAZIONE
Ruolo dell azoto. L azoto è: Costituente di numerosi composti biologici (proteine, amminoacidi, nucleotidi, coenzimi )
 Ruolo dell azoto L'azoto è l'elemento più abbondante nella nostra atmosfera ed è presente per natura in varie forme, nell'aria, nel suolo, nell'acqua e in tutti gli esseri viventi. L azoto è: Costituente
Ruolo dell azoto L'azoto è l'elemento più abbondante nella nostra atmosfera ed è presente per natura in varie forme, nell'aria, nel suolo, nell'acqua e in tutti gli esseri viventi. L azoto è: Costituente
I RISULTATI WQI 1) BOD
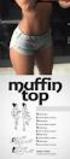 WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
Indicatori agro ecologici: bilancio dell azoto. Mattia Fumagalli
 Indicatori agro ecologici: bilancio dell azoto Mattia Fumagalli Bilancio dell azoto Valutare la gestione dell azoto di una realtà aziendale Capire come l attività agricola inserita in un determinato contesto
Indicatori agro ecologici: bilancio dell azoto Mattia Fumagalli Bilancio dell azoto Valutare la gestione dell azoto di una realtà aziendale Capire come l attività agricola inserita in un determinato contesto
La struttura e le dinamiche degli ecosistemi
 La struttura e le dinamiche degli ecosistemi L ecologia degli ecosistemi prende in considerazione il flusso di energia e il riciclaggio chimico Un ecosistema è costituito dall insieme di tutti gli organismi
La struttura e le dinamiche degli ecosistemi L ecologia degli ecosistemi prende in considerazione il flusso di energia e il riciclaggio chimico Un ecosistema è costituito dall insieme di tutti gli organismi
L'EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE
 L'EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE L eutrofizzazione è un processo degenerativo dell ecosistema acquatico dovuto all eccessivo arricchimento in nutrienti (in questo caso fattori limitanti - sali di fosforo
L'EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE L eutrofizzazione è un processo degenerativo dell ecosistema acquatico dovuto all eccessivo arricchimento in nutrienti (in questo caso fattori limitanti - sali di fosforo
DINAMICA DEGLI INQUINANTI A.A INQUINAMENTO DEI LAGHI PROF. RENATO BACIOCCHI
 DINAMICA DEGLI INQUINANTI A.A. 2012 2013 PROF. RENATO BACIOCCHI ARGOMENTI TRATTATI: Acque superficiali Classificazione delle acque superficiali Sorgenti e tipologie di inquinamento Inquinamento dei laghi
DINAMICA DEGLI INQUINANTI A.A. 2012 2013 PROF. RENATO BACIOCCHI ARGOMENTI TRATTATI: Acque superficiali Classificazione delle acque superficiali Sorgenti e tipologie di inquinamento Inquinamento dei laghi
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica
 Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
Sistemi Colturali. CS azoto nel sistema suolo-coltura
 CS azoto nel sistema suolo-coltura Aspetti che affronteremo Sistemi Colturali L ambiente suolo Forme di azoto nel terreno Trasformazioni dell azoto Asportazione di azoto da parte della coltura Trasporto
CS azoto nel sistema suolo-coltura Aspetti che affronteremo Sistemi Colturali L ambiente suolo Forme di azoto nel terreno Trasformazioni dell azoto Asportazione di azoto da parte della coltura Trasporto
Analisi chimiche. Confronto di alcuni parametri chimici dell acqua del Lambro alla sorgente e alla foce
 Analisi chimiche Confronto di alcuni parametri chimici dell acqua del Lambro alla sorgente e alla foce 1 Scuola media Anna Frank Graffignana (Lo) Ecolab a.s.2008/2009 Tipologia di analisi Abbiamo analizzato
Analisi chimiche Confronto di alcuni parametri chimici dell acqua del Lambro alla sorgente e alla foce 1 Scuola media Anna Frank Graffignana (Lo) Ecolab a.s.2008/2009 Tipologia di analisi Abbiamo analizzato
Commissione Internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere
 Istituto Scienze della Terra Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana Ricerche sull evoluzione del Lago di Lugano Aspetti limnologici Triennio 2013-2015 Campagna 2015 Rapporto informativo
Istituto Scienze della Terra Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana Ricerche sull evoluzione del Lago di Lugano Aspetti limnologici Triennio 2013-2015 Campagna 2015 Rapporto informativo
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA ED AMBIENTALE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA ED AMBIENTALE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA
Verifiche di funzionalita negli impianti di depurazione acque
 Verifiche di funzionalita negli impianti di depurazione acque Scopi delle verifiche Conformità dell impianto a limiti di legge o contratto (collaudo o inizio gestione) Verifiche di buon funzionamento rese
Verifiche di funzionalita negli impianti di depurazione acque Scopi delle verifiche Conformità dell impianto a limiti di legge o contratto (collaudo o inizio gestione) Verifiche di buon funzionamento rese
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. La fioritura dell alga tossica Planktothrix rubescens nell invaso di Occhito (CB)
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche Tesi di Laurea in Ecologia La fioritura dell alga tossica Planktothrix
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche Tesi di Laurea in Ecologia La fioritura dell alga tossica Planktothrix
Utilizzo di fonti esterne di carbonio in processi di denitrificazione biologica
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA TRIENNALE Utilizzo di fonti esterne di
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA TRIENNALE Utilizzo di fonti esterne di
Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/2010.
 Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/. Il recente Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali,
Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/. Il recente Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali,
INQUINAMENTO DA NITRATI
 INQUINAMENTO DA NITRATI 1 QUALITA DELLE ACQUE SOTTERRANEE Il sistema acquifero della Pianura Padana rappresenta la fonte principale sia per l approvvigionamento idropotabile (>90%), sia per l agricoltura
INQUINAMENTO DA NITRATI 1 QUALITA DELLE ACQUE SOTTERRANEE Il sistema acquifero della Pianura Padana rappresenta la fonte principale sia per l approvvigionamento idropotabile (>90%), sia per l agricoltura
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
 DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
I fiumi. La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia
 I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
Che cos è l eutrofizzazione? Cause, effetti e controllo
 Che cos è l eutrofizzazione? Cause, effetti e controllo Fioritura algale del 2010 lungo la costa di Qingdao, Cina orientale (http://www.nationalgeographic.it/) Dopo aver visto l immagine dei bimbi che
Che cos è l eutrofizzazione? Cause, effetti e controllo Fioritura algale del 2010 lungo la costa di Qingdao, Cina orientale (http://www.nationalgeographic.it/) Dopo aver visto l immagine dei bimbi che
Il risanamento ambientale del lago di Viverone: un obiettivo per la Provincia di Biella, possibilità di utilizzo delle fasce tampone
 Il risanamento ambientale del lago di Viverone: un obiettivo per la Provincia di Biella, possibilità di utilizzo delle fasce tampone Matteo Massara Biella, 28 settembre 2007 Il lago di Viverone è un importante
Il risanamento ambientale del lago di Viverone: un obiettivo per la Provincia di Biella, possibilità di utilizzo delle fasce tampone Matteo Massara Biella, 28 settembre 2007 Il lago di Viverone è un importante
Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali
 Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
MONITORAGGIO R.N.O. CAPO PELORO
 MONITORAGGIO R.N.O. CAPO PELORO Gennaio Dicembre 2016 Monitoraggio Laguna di Capo Peloro La Riserva Naturale Orientata Laguna di Capo Peloro, istituita con Decreto Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
MONITORAGGIO R.N.O. CAPO PELORO Gennaio Dicembre 2016 Monitoraggio Laguna di Capo Peloro La Riserva Naturale Orientata Laguna di Capo Peloro, istituita con Decreto Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Gestione dell Azoto in Agricoltura
 Gestione dell Azoto in Agricoltura Il ciclo dell azoto in azienda Il ciclo dell azoto in azienda Comparto colturale Input Fertilizzanti minerali Effluenti di allevamento (e.a.) sia prodotti in azienda
Gestione dell Azoto in Agricoltura Il ciclo dell azoto in azienda Il ciclo dell azoto in azienda Comparto colturale Input Fertilizzanti minerali Effluenti di allevamento (e.a.) sia prodotti in azienda
Avigliana - Giugno 2011
 Avigliana - Giugno 2011 RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLE ACQUE IPOLIMNICHE DEI LAGHI DI AVIGLIANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL ASPORTAZIONE DI FOSFORO DAL FONDO DAL LAGO GRANDE Fabrizio Merati*, Gilberto
Avigliana - Giugno 2011 RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLE ACQUE IPOLIMNICHE DEI LAGHI DI AVIGLIANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL ASPORTAZIONE DI FOSFORO DAL FONDO DAL LAGO GRANDE Fabrizio Merati*, Gilberto
Applicazione della Direttiva Nitrati in Liguria: aziende non zootecniche
 SEMINARIO CONDIZIONALITA Applicazione della Direttiva Nitrati in Liguria: aziende non zootecniche Dott. Agr. Stefano Pini Servizi alle Imprese Agricole 19 aprile 2010 DIRETTIVA NITRATI È la Direttiva 91/676/CEE
SEMINARIO CONDIZIONALITA Applicazione della Direttiva Nitrati in Liguria: aziende non zootecniche Dott. Agr. Stefano Pini Servizi alle Imprese Agricole 19 aprile 2010 DIRETTIVA NITRATI È la Direttiva 91/676/CEE
I FERTILIZZANTI ED I CORRETTIVI NEI SUBSTRATI:
 con il patrocinio di Primo corso di formazione I SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE: produzione, controllo di qualità e impiego CerSAA, Albenga 26-27 novembre 2009 I FERTILIZZANTI ED I CORRETTIVI NEI SUBSTRATI:
con il patrocinio di Primo corso di formazione I SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE: produzione, controllo di qualità e impiego CerSAA, Albenga 26-27 novembre 2009 I FERTILIZZANTI ED I CORRETTIVI NEI SUBSTRATI:
FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI
 FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI INDICE FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI... i INDICE... ii 4. EUTROFIZZAZIONE...1 4.1 CAUSE ED EFFETTI DELL EUTROFIZZAZIONE...1 4.2 LA CLASSIFICAZIONE
FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI INDICE FENOMENI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE NATURALI... i INDICE... ii 4. EUTROFIZZAZIONE...1 4.1 CAUSE ED EFFETTI DELL EUTROFIZZAZIONE...1 4.2 LA CLASSIFICAZIONE
mmsimpianti I depuratori Raccolta e trattamento
 mmsimpianti I depuratori Raccolta e trattamento Dalle città, al depuratore, al fiume. Prelievo dall ambiente Trattamento di potabilizzazione Distribuzione all utente Reimmissione nell ambiente Depurazione
mmsimpianti I depuratori Raccolta e trattamento Dalle città, al depuratore, al fiume. Prelievo dall ambiente Trattamento di potabilizzazione Distribuzione all utente Reimmissione nell ambiente Depurazione
Applicazioni del biochar in zootecnia
 Fiera di Sant Alessandro Bergamo, 5 Settembre 2014 Workshop on Biochar Applicazioni del biochar in zootecnia Dr. Costanza Zavalloni Programma 1. Il biochar in agricoltura ( ma non solo) 2. Caratteristiche
Fiera di Sant Alessandro Bergamo, 5 Settembre 2014 Workshop on Biochar Applicazioni del biochar in zootecnia Dr. Costanza Zavalloni Programma 1. Il biochar in agricoltura ( ma non solo) 2. Caratteristiche
DATABASE SOSTANZE Modulo TOXI
 DATABASE SOSTANZE Modulo TOXI All interno del modulo TOXI è stato previsto un Database sostanze che potesse raccogliere al suo interno tutti composti tossici d interesse per l utente e le loro proprietà
DATABASE SOSTANZE Modulo TOXI All interno del modulo TOXI è stato previsto un Database sostanze che potesse raccogliere al suo interno tutti composti tossici d interesse per l utente e le loro proprietà
Presentazione corso_acque
 Presentazione corso_acque La chimica delle acque Classificazione delle acque e principali fonti di contaminazione Normativa in materia di acque Analisi dei principali parametri, campionamento Tecniche
Presentazione corso_acque La chimica delle acque Classificazione delle acque e principali fonti di contaminazione Normativa in materia di acque Analisi dei principali parametri, campionamento Tecniche
PROGETTO ANCONAPACO Analisi delle condizioni del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico delle aree di collina, pianura e costiere
 Analisi delle condizioni del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico delle aree di collina, pianura e costiere ANALISI DELL EROSIONE E DEL TRASPORTO SOLIDO NEI BACINI IDROGRAFICI COSTIERI DELLE
Analisi delle condizioni del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico delle aree di collina, pianura e costiere ANALISI DELL EROSIONE E DEL TRASPORTO SOLIDO NEI BACINI IDROGRAFICI COSTIERI DELLE
CORSO DI ECOLOGIA. Docente: Marco Ciolli. CORSO di Tecniche della Prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro. Ciclo del carbonio
 CORSO DI ECOLOGIA CORSO di Tecniche della Prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro Ciclo del carbonio Docente: Marco Ciolli Lucidi di Marco Ciolli Corso Economia 2009 Trento 1 CICLO DEL CARBONIO
CORSO DI ECOLOGIA CORSO di Tecniche della Prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro Ciclo del carbonio Docente: Marco Ciolli Lucidi di Marco Ciolli Corso Economia 2009 Trento 1 CICLO DEL CARBONIO
PROGRAMMA CORSO ECOLOGIA APPLICATA Dott. Fabrizio Scialanca - Limnologo
 PROGRAMMA CORSO ECOLOGIA APPLICATA Dott. Fabrizio Scialanca - Limnologo 1. CENNI DI ECOLOGIA I principali cicli biogeochimici Le catene trofiche 2. FATTORI ED ELEMENTI CLIMATICI Caratteristiche chimico-fisiche
PROGRAMMA CORSO ECOLOGIA APPLICATA Dott. Fabrizio Scialanca - Limnologo 1. CENNI DI ECOLOGIA I principali cicli biogeochimici Le catene trofiche 2. FATTORI ED ELEMENTI CLIMATICI Caratteristiche chimico-fisiche
Macronutrienti e micronutrienti
 Macronutrienti e micronutrienti La scala spazio-tempo di un ciclo biogeochimico può essere molto grande Input dall atmosfera Modello di flusso di un elemento nell ecosistema Output Input dall alterazione
Macronutrienti e micronutrienti La scala spazio-tempo di un ciclo biogeochimico può essere molto grande Input dall atmosfera Modello di flusso di un elemento nell ecosistema Output Input dall alterazione
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile,Edile e Ambientale
 Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile,Edile e Ambientale Corso di Laurea in INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile,Edile e Ambientale Corso di Laurea in INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed
AgrelanWeb uno strumento per definire la concimazione ottimale
 AgrelanWeb uno strumento per definire la concimazione ottimale Paolo Giandon ARPAV - Servizio Osservatorio Suoli e Rifiuti AgrelanWeb: obiettivo La predisposizione di un piano di concimazione a partire
AgrelanWeb uno strumento per definire la concimazione ottimale Paolo Giandon ARPAV - Servizio Osservatorio Suoli e Rifiuti AgrelanWeb: obiettivo La predisposizione di un piano di concimazione a partire
Contenuti della sezione ACQUE
 Contenuti della sezione ACQUE La Qualità delle acque superficiali Azioni del Dipartimento di Como Punti di monitoraggio delle acque superficiali Descrittore: Stato ecologico dei corsi d acqua Descrittore:
Contenuti della sezione ACQUE La Qualità delle acque superficiali Azioni del Dipartimento di Como Punti di monitoraggio delle acque superficiali Descrittore: Stato ecologico dei corsi d acqua Descrittore:
mmsimpianti I depuratori Raccolta e trattamento
 mmsimpianti I depuratori Raccolta e trattamento Dalle città, al depuratore, al fiume. Prelievo dall ambiente Trattamento di potabilizzazione Distribuzione all utente Reimmissione nell ambiente Depurazione
mmsimpianti I depuratori Raccolta e trattamento Dalle città, al depuratore, al fiume. Prelievo dall ambiente Trattamento di potabilizzazione Distribuzione all utente Reimmissione nell ambiente Depurazione
COMUNE DI CINGOLI. GIUNTA REGIONALE Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia P.F. TUTELA DELLE ACQUE. Acque di Balneazione.
 GIUNTA REGIONALE Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia P.F. TUTELA DELLE ACQUE ZZ A COMUNEDICINGOLI Acque di Balneazione ID BW Denominazione BW CONTRADA CROCIFISSO SPIAGGIA KAMBUSA CONTRADA PANICALI
GIUNTA REGIONALE Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia P.F. TUTELA DELLE ACQUE ZZ A COMUNEDICINGOLI Acque di Balneazione ID BW Denominazione BW CONTRADA CROCIFISSO SPIAGGIA KAMBUSA CONTRADA PANICALI
IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE METADATI
 IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE METADATI Introduzione... 2 Area Tematica: Acqua superficiale Corsi d acqua... 3 Diatomee... 3 LIMeco... 4 Macrobenthos... 5 Macrofite... 6 tato Ecologico... 7 Area Tematica:
IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE METADATI Introduzione... 2 Area Tematica: Acqua superficiale Corsi d acqua... 3 Diatomee... 3 LIMeco... 4 Macrobenthos... 5 Macrofite... 6 tato Ecologico... 7 Area Tematica:
La quantità di ossidi di azoto è dovuta per: il 3% allo smaltimento rifiuti; il 19% al riscaldamento delle case; il 78% ai trasporti (grafico 1).
 APPROFONDIMENTO Le analisi chimiche dell aria delle città, anche di quelle piccole, segnalano che il livello di inquinamento dell antropobiosfera rimane elevato: quali le principali cause? L inquinamento
APPROFONDIMENTO Le analisi chimiche dell aria delle città, anche di quelle piccole, segnalano che il livello di inquinamento dell antropobiosfera rimane elevato: quali le principali cause? L inquinamento
Rsu = tutto quanto risulta di scarto o avanzo alle più svariate attività umane
 RIFIUTI SOLIDI URBANI Rsu = tutto quanto risulta di scarto o avanzo alle più svariate attività umane Rifiuti domestici; Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad altri usi assimilati
RIFIUTI SOLIDI URBANI Rsu = tutto quanto risulta di scarto o avanzo alle più svariate attività umane Rifiuti domestici; Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad altri usi assimilati
SCHEDA 6 - CARATTERISTICHE DELLE ACQUE COSTIERE
 Scheda 6 (trasmissione ogni 6 anni - primo invio entro il 30/06/2004 - salvo le parti c), d) ed e) relative al monitoraggio SCHEDA 6 - CARATTERISTICHE DELLE ACQUE COSTIERE A) IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO
Scheda 6 (trasmissione ogni 6 anni - primo invio entro il 30/06/2004 - salvo le parti c), d) ed e) relative al monitoraggio SCHEDA 6 - CARATTERISTICHE DELLE ACQUE COSTIERE A) IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO
LA PERDITA D EFFICIENZA NELLARETE IDRICA: L IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO E DEL SISTEMA
 LA PERDITA D EFFICIENZA NELLARETE IDRICA: L IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO E DEL SISTEMA LA STRUTTURA DI UNA RETE IDRICA TUBAZIONI POSSIBILI PROBLEMATICHE DI UNA RETE IDRICA Nel corso del suo funzionamento,
LA PERDITA D EFFICIENZA NELLARETE IDRICA: L IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO E DEL SISTEMA LA STRUTTURA DI UNA RETE IDRICA TUBAZIONI POSSIBILI PROBLEMATICHE DI UNA RETE IDRICA Nel corso del suo funzionamento,
Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto Figura Dislocazione delle stazioni meteorologiche
 Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto 1 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 3.1 - Gli indicatori meteorologici per lo studio della
Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto 1 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 3.1 - Gli indicatori meteorologici per lo studio della
Anna Laura Eusebi, Martina Santinelli, Paolo Battistoni. Università Politecnica delle Marche, Ancona. Facoltà di Ingegneria Dipartimento SIMAU
 La Precipitazione della Struvite per il Recupero dei Nutrienti da Surnatanti di Digestione Anaerobica di Acque Reflue Urbane o di Reflui Zootecnici: Anna Laura Eusebi, Martina Santinelli, Paolo Battistoni
La Precipitazione della Struvite per il Recupero dei Nutrienti da Surnatanti di Digestione Anaerobica di Acque Reflue Urbane o di Reflui Zootecnici: Anna Laura Eusebi, Martina Santinelli, Paolo Battistoni
Il valore ecologico della risorsa acqua
 Il valore ecologico della risorsa acqua Che cos è una risorsa? Qualsiasi cosa che noi preleviamo dall ambiente vivente e non, per soddisfare le nostre necessità. Le risorse sono divisibili in 1) risorse
Il valore ecologico della risorsa acqua Che cos è una risorsa? Qualsiasi cosa che noi preleviamo dall ambiente vivente e non, per soddisfare le nostre necessità. Le risorse sono divisibili in 1) risorse
Lo stato ecologico Lago di Varese
 Lo stato ecologico Lago di Varese Sala Coop Varese, 10 marzo 2015 Dr Valeria Roella Settore Monitoraggi Ambientali ARPA Lombardia Il Lago di Varese: inquadramento EMISSARIO: fiume Bardello Lago Maggiore
Lo stato ecologico Lago di Varese Sala Coop Varese, 10 marzo 2015 Dr Valeria Roella Settore Monitoraggi Ambientali ARPA Lombardia Il Lago di Varese: inquadramento EMISSARIO: fiume Bardello Lago Maggiore
MONITORAGGIO R.N.O. MARINELLO
 MONITORAGGIO R.N.O. MARINELLO Febbraio Dicembre 2016 La riserva naturale orientata Laghetti di Marinello, istituita nel 1998 e affidata in gestione alla Provincia Regionale di Messina (ora Città Metropolitana
MONITORAGGIO R.N.O. MARINELLO Febbraio Dicembre 2016 La riserva naturale orientata Laghetti di Marinello, istituita nel 1998 e affidata in gestione alla Provincia Regionale di Messina (ora Città Metropolitana
DEFINIZIONE DI ACQUE REFLUE
 DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE: NORMATIVA E FINALITÀ PROF. ANTONIO PANICO Indice 1 DEFINIZIONE DI ACQUE REFLUE ------------------------------------------------------------------------------------- 3 2
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE: NORMATIVA E FINALITÀ PROF. ANTONIO PANICO Indice 1 DEFINIZIONE DI ACQUE REFLUE ------------------------------------------------------------------------------------- 3 2
Piano di Tutela delle Acque
 Piano di Tutela delle Acque E lo strumento di Pianificazione territoriale attraverso il quale raggiungere gli obiettivi di qualità fissati dalla Direttive Europee. In quanto Piano di valenza territoriale
Piano di Tutela delle Acque E lo strumento di Pianificazione territoriale attraverso il quale raggiungere gli obiettivi di qualità fissati dalla Direttive Europee. In quanto Piano di valenza territoriale
L ACQUA ( l oro blu )
 1 LE RISORSE PIU PREZIOSE: ARIA E ACQUA Sono le più preziose perché senza di esse non ci può essere vita sulla terra. La qualità di aria ed acqua è sempre più scadente a causa dell inquinamento. L ACQUA
1 LE RISORSE PIU PREZIOSE: ARIA E ACQUA Sono le più preziose perché senza di esse non ci può essere vita sulla terra. La qualità di aria ed acqua è sempre più scadente a causa dell inquinamento. L ACQUA
Giornata dimostrativa La fertirrigazione con il digestato Azienda Sperimentale Tadini, Gariga di Podenzano (PC), 27 luglio 2010
 Giornata dimostrativa La fertirrigazione con il digestato Azienda Sperimentale Tadini, Gariga di Podenzano (PC), 27 luglio 2010 IL DIGESTATO Caratteristiche e norme per l'uso agronomico Lorella Rossi Centro
Giornata dimostrativa La fertirrigazione con il digestato Azienda Sperimentale Tadini, Gariga di Podenzano (PC), 27 luglio 2010 IL DIGESTATO Caratteristiche e norme per l'uso agronomico Lorella Rossi Centro
Foto aerea di un impianto di depurazione
 Un impianto di depurazione è articolato in varie fasi di lavorazione, la prima distinzione che si può fare è quella di separare la LINEA ACQUE dalla LINEA FANGHI Foto aerea di un impianto di depurazione
Un impianto di depurazione è articolato in varie fasi di lavorazione, la prima distinzione che si può fare è quella di separare la LINEA ACQUE dalla LINEA FANGHI Foto aerea di un impianto di depurazione
LA DIFFUSIONE. M At 1 A. dm dt
 LA DIFFUSIONE Il trasferimento di massa, all interno di un solido, di un liquido o di un gas o di un altra fase solida è detto diffusione ( trasporto di materiale mediante movimento di atomi). La diffusione
LA DIFFUSIONE Il trasferimento di massa, all interno di un solido, di un liquido o di un gas o di un altra fase solida è detto diffusione ( trasporto di materiale mediante movimento di atomi). La diffusione
IMPATTI INDOTTI SU UN CORSO D ACQUA
 servizio idraulica DERIVAZIONI IDROELETTRICHE: IMPATTI INDOTTI SU UN CORSO D ACQUA Ing. Federica Lippi Malnisio,, 16 giugno 2011 Le filiere dell energia Energia idroelettrica PREMESSA L acqua rappresenta
servizio idraulica DERIVAZIONI IDROELETTRICHE: IMPATTI INDOTTI SU UN CORSO D ACQUA Ing. Federica Lippi Malnisio,, 16 giugno 2011 Le filiere dell energia Energia idroelettrica PREMESSA L acqua rappresenta
Inquinamento, potabilizzazione e depurazione delle acque
 Inquinamento, potabilizzazione e depurazione delle acque Acqua di falda: approvvigionamento, comntaminazione e risanamento Il 99% delle acque dolci disponibili si trova nel sottosuolo (acque
Inquinamento, potabilizzazione e depurazione delle acque Acqua di falda: approvvigionamento, comntaminazione e risanamento Il 99% delle acque dolci disponibili si trova nel sottosuolo (acque
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 5
 Qualità dell'acqua Pagina 1 di 5 DISTRETTO CISANO Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 17/11/2016 120 mg/l - Ammoniaca (NH4) 17/11/2016 0,093 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 17/11/2016 0 µg/l 0-10 Calcio
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 5 DISTRETTO CISANO Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 17/11/2016 120 mg/l - Ammoniaca (NH4) 17/11/2016 0,093 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 17/11/2016 0 µg/l 0-10 Calcio
1 L eutrofizzazione. Autorità di bacino del fiume Po
 1 L eutrofizzazione 1 Torna al menù principale 1.1 Cause ed effetti dell eutrofizzazione Il termine eutrofizzazione definisce l aumento di produttività negli ambienti acquatici dovuto all arricchimento
1 L eutrofizzazione 1 Torna al menù principale 1.1 Cause ed effetti dell eutrofizzazione Il termine eutrofizzazione definisce l aumento di produttività negli ambienti acquatici dovuto all arricchimento
Trasferimento di ossigeno nei bioreattori. In particolare avremo:
 Trasferimento di ossigeno nei bioreattori In particolare avremo: 1. resistenza di trasferimento nella fase gassosa. Questo è generalmente trascurabile dato che la velocità del trasferimento del gas in
Trasferimento di ossigeno nei bioreattori In particolare avremo: 1. resistenza di trasferimento nella fase gassosa. Questo è generalmente trascurabile dato che la velocità del trasferimento del gas in
EFFETTI INDOTTI DALLA CONCIMAZIONE ORGANICA CON VENUS (CONCIME ORGANO-MINERALE NK 12-15) SULLO SVILUPPO DEL MAIS
 EFFETTI INDOTTI DALLA CONCIMAZIONE ORGANICA CON VENUS (CONCIME ORGANO-MINERALE NK 12-15) SULLO SVILUPPO DEL MAIS OBIETTIVO DELLA PROVA Valutazione dell effetto di diverse dosi del concime organo-minerale
EFFETTI INDOTTI DALLA CONCIMAZIONE ORGANICA CON VENUS (CONCIME ORGANO-MINERALE NK 12-15) SULLO SVILUPPO DEL MAIS OBIETTIVO DELLA PROVA Valutazione dell effetto di diverse dosi del concime organo-minerale
FERTILITA CHIMICA. Disponibilità ottimale dei nutrienti. Fattori atmosferici favorevoli. Fattori pedologici. Pratiche agricole
 ANALISI DEL SUOLO - Conoscere i valori di alcuni parametri chimico-fisici allo scopo di giudicarne l idoneità ai fini di una normale e redditizia crescita dei vegetali - Individuare il tipo e l intensità
ANALISI DEL SUOLO - Conoscere i valori di alcuni parametri chimico-fisici allo scopo di giudicarne l idoneità ai fini di una normale e redditizia crescita dei vegetali - Individuare il tipo e l intensità
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 9
 Qualità dell'acqua Pagina 1 di 9 DISTRETTO DESENZANO CENT Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 23/12/2016 148,5 mg/l - Ammoniaca (NH4) 23/12/2016 0,1275 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 23/12/2016 0,8125
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 9 DISTRETTO DESENZANO CENT Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 23/12/2016 148,5 mg/l - Ammoniaca (NH4) 23/12/2016 0,1275 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 23/12/2016 0,8125
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 9
 Qualità dell'acqua Pagina 1 di 9 DISTRETTO DESENZANO CENTRO Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 22/06/2017 141,6 mg/l - Ammoniaca (NH4) 22/06/2017 0,147 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 22/06/2017 0,27
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 9 DISTRETTO DESENZANO CENTRO Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 22/06/2017 141,6 mg/l - Ammoniaca (NH4) 22/06/2017 0,147 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 22/06/2017 0,27
Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali Università di Palermo
 Andamenti dei rendimento minimo in funzione del volume specifico vasca 1 η min 0.9 Vasca di transito in linea 1 η min 0.9 Vasca di transito fuori linea 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 Parco d'orleans
Andamenti dei rendimento minimo in funzione del volume specifico vasca 1 η min 0.9 Vasca di transito in linea 1 η min 0.9 Vasca di transito fuori linea 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 Parco d'orleans
Dr. Luigi Trovarelli
 Evoluzione stagionale delle masse d acqua lungo la fascia costiera tra Senigallia e Porto Recanati Nella zona tra Senigallia e Porto Recanati l area del largo nel periodo fine inverno primavera, è caratterizzata
Evoluzione stagionale delle masse d acqua lungo la fascia costiera tra Senigallia e Porto Recanati Nella zona tra Senigallia e Porto Recanati l area del largo nel periodo fine inverno primavera, è caratterizzata
Stima delle emissioni in atmosfera di ammoniaca derivanti dagli allevamenti zootecnici
 8 febbraio 2012 Stima delle emissioni in atmosfera di ammoniaca derivanti dagli allevamenti zootecnici Bagnolo, Cadelbosco di Sopra, Gualtieri, Novellara Sezione Provinciale di Reggio Emilia Servizio Sistemi
8 febbraio 2012 Stima delle emissioni in atmosfera di ammoniaca derivanti dagli allevamenti zootecnici Bagnolo, Cadelbosco di Sopra, Gualtieri, Novellara Sezione Provinciale di Reggio Emilia Servizio Sistemi
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 7
 Qualità dell'acqua Pagina 1 di 7 DISTRETTO CECINA Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 04/01/2017 152,5 mg/l - Ammoniaca (NH4) 04/01/2017 0,0935 mg/l 0-0,5 Calcio (Ca) 04/01/2017 56,35 mg/l - Cloro
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 7 DISTRETTO CECINA Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 04/01/2017 152,5 mg/l - Ammoniaca (NH4) 04/01/2017 0,0935 mg/l 0-0,5 Calcio (Ca) 04/01/2017 56,35 mg/l - Cloro
IL RUOLO DEI CONSORZI DI BONIFICA NELLA RIDUZIONE DELL INQUINAMENTO DIFFUSO.
 Segreteria Regionale all Ambiente e Territorio Direzione Progetto Venezia CONVEGNO DIRETTIVA NITRATI: Dalla ricerca alla gestione del territorio Inquinamento diffuso ed aree tampone 31 maggio 1 giugno
Segreteria Regionale all Ambiente e Territorio Direzione Progetto Venezia CONVEGNO DIRETTIVA NITRATI: Dalla ricerca alla gestione del territorio Inquinamento diffuso ed aree tampone 31 maggio 1 giugno
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 5
 Qualità dell'acqua Pagina 1 di 5 DISTRETTO CASTELLETTO Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 31/10/2016 384 mg/l - Ammoniaca (NH4) 31/10/2016 0,11 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 31/10/2016 0 µg/l 0-10
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 5 DISTRETTO CASTELLETTO Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 31/10/2016 384 mg/l - Ammoniaca (NH4) 31/10/2016 0,11 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 31/10/2016 0 µg/l 0-10
Wew32q4e2. Monitoraggio Diga del Pertusillo
 Wew32q4e2 Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MAGGIO 2011 L attività di monitoraggio dell A.R.P.A.B. della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
Wew32q4e2 Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MAGGIO 2011 L attività di monitoraggio dell A.R.P.A.B. della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
ESERCITAZIONE DI AGRONOMIA. Piano di concimazione
 ESERCITAZIONE DI AGRONOMIA Piano di concimazione 22 maggio 2012 Introduzione Piano di concimazione N, P 2 O 5 e K 2 O Quanto sarà presentato è stato sviluppato basandosi sulle linee guida previste dal
ESERCITAZIONE DI AGRONOMIA Piano di concimazione 22 maggio 2012 Introduzione Piano di concimazione N, P 2 O 5 e K 2 O Quanto sarà presentato è stato sviluppato basandosi sulle linee guida previste dal
LAGO DI GHIRLAHIRLA. Tempo teorico di ricambio (anni) 0,1. Torrente Margorabbia Lago maggiore Fiume Ticino Fiume Po
 LAGO DI GHIRLAHIRLA Latitudine ( N): 45 55 Longitudine ( E): 08 49 Altitudine (m s.l.m.) 442 Altitudine max bacino imbrifero (m s.l.m.) 1129 Superficie lago (km2) 0,28 Superficie bacino imbrifero naturale
LAGO DI GHIRLAHIRLA Latitudine ( N): 45 55 Longitudine ( E): 08 49 Altitudine (m s.l.m.) 442 Altitudine max bacino imbrifero (m s.l.m.) 1129 Superficie lago (km2) 0,28 Superficie bacino imbrifero naturale
Lo studente scriva la differenza tra concimi, ammendanti e correttivi.
 Lo studente scriva sull epoca, modalità, tipo e quantità di concime azotato/fosfatico/potassico che può essere somministrato ad una coltura in relazione : alla specie, al sistema colturale (precessione),
Lo studente scriva sull epoca, modalità, tipo e quantità di concime azotato/fosfatico/potassico che può essere somministrato ad una coltura in relazione : alla specie, al sistema colturale (precessione),
L anidride carbonica nel settore alimentare. Anna Marigo SAPIO Srl
 L anidride carbonica nel settore alimentare Anna Marigo SAPIO Srl ANIDRIDE CARBONICA le applicazioni nel settore food Forma liquida: Surgelazione Raffreddamento Controllo delle T. Forma gassosa: Confezionamento
L anidride carbonica nel settore alimentare Anna Marigo SAPIO Srl ANIDRIDE CARBONICA le applicazioni nel settore food Forma liquida: Surgelazione Raffreddamento Controllo delle T. Forma gassosa: Confezionamento
Relazione Tecnica Prog. Esecutivo-Opere di Miglioramento Centro di raccolta - Isola Ecologica Sava (Ta) Relazione Tecnica
 Oggetto: Relazione Tecnica sui sistemi naturali sostenibili per la riduzione dell inquinamento diffuso delle acque di dilavamento in aree urbanizzate e riutilizzo delle acque meteoriche, per i lavori di
Oggetto: Relazione Tecnica sui sistemi naturali sostenibili per la riduzione dell inquinamento diffuso delle acque di dilavamento in aree urbanizzate e riutilizzo delle acque meteoriche, per i lavori di
PIANO PER LA PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA
 REGIONE VENETO SEGRETERIA REGIONALE ALL AMBIENTE DIREZIONE TUTELA DELL AMBIENTE PIANO PER LA PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA
REGIONE VENETO SEGRETERIA REGIONALE ALL AMBIENTE DIREZIONE TUTELA DELL AMBIENTE PIANO PER LA PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA
Caratterizzazione ecologica e utilizzo dei laghi di cava nelle aree golenali
 Caratterizzazione ecologica e utilizzo dei laghi di cava nelle aree golenali Daniele Nizzoli, Rossano Bolpagni, Marco Bartoli, Pierluigi Viaroli Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi
Caratterizzazione ecologica e utilizzo dei laghi di cava nelle aree golenali Daniele Nizzoli, Rossano Bolpagni, Marco Bartoli, Pierluigi Viaroli Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi
L inquinamento ambientale: Acqua,suolo e aria. Cos è l inquinamento? Varie tipologie di inquinamento ambientale: idrico,del suolo e dell aria;
 L inquinamento ambientale: Acqua,suolo e aria. Cos è l inquinamento? D.Kudlik ; M.Borreca 6/04/2012 Varie tipologie di inquinamento ambientale: idrico,del suolo e dell aria; Possibili cause, effetti e
L inquinamento ambientale: Acqua,suolo e aria. Cos è l inquinamento? D.Kudlik ; M.Borreca 6/04/2012 Varie tipologie di inquinamento ambientale: idrico,del suolo e dell aria; Possibili cause, effetti e
Domande preparatorie esame di ecologia
 Domande preparatorie esame di ecologia 1. Qual è la composizione dell atmosfera? 2. Da dove si origina la CO 2 atmosferica? 3. Quali processi riducono e quali incrementano la CO 2 atmosferica? 4. Come
Domande preparatorie esame di ecologia 1. Qual è la composizione dell atmosfera? 2. Da dove si origina la CO 2 atmosferica? 3. Quali processi riducono e quali incrementano la CO 2 atmosferica? 4. Come
ELIMINAZIONE DEI NITRATI DALLE ACQUE POTABILI
 ELIMINAZIONE DEI NITRATI DALLE ACQUE POTABILI Fondamenti di chimica-fisica Scelta del processo: ANDEL NITRA ANF www.acqua-depurazione.it IL PROBLEMA DEI NITRATI Lo ione nitrato è un importante anione poliatomico.
ELIMINAZIONE DEI NITRATI DALLE ACQUE POTABILI Fondamenti di chimica-fisica Scelta del processo: ANDEL NITRA ANF www.acqua-depurazione.it IL PROBLEMA DEI NITRATI Lo ione nitrato è un importante anione poliatomico.
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI
 SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
Inquinamento ARIA. Inquinamento ARIA. Inquinamento ARIA. Inquinamento ARIA
 COMBUSTIONE: principi Processo di ossidazione di sostanze contenenti C ed H condotto per ottenere energia termica (calore) C,H + O 2 calore + gas comb. COMBUSTIBILE + COMBURENTE CALORE + RESIDUI [ARIA]
COMBUSTIONE: principi Processo di ossidazione di sostanze contenenti C ed H condotto per ottenere energia termica (calore) C,H + O 2 calore + gas comb. COMBUSTIBILE + COMBURENTE CALORE + RESIDUI [ARIA]
Questa presentazione verterà sugli NOx e in particolare: -cosa sono gli NOx -effetti sulla salute e alla vegetazione -dove si trovano -le concause
 Questa presentazione verterà sugli NOx e in particolare: -cosa sono gli NOx -effetti sulla salute e alla vegetazione -dove si trovano -le concause degli NOx I principali NOx presenti nell'atmosfera sono
Questa presentazione verterà sugli NOx e in particolare: -cosa sono gli NOx -effetti sulla salute e alla vegetazione -dove si trovano -le concause degli NOx I principali NOx presenti nell'atmosfera sono
ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2013 Qualità dei corpi idrici superficiali e ambiente marino costiero - Acque dolci idonee alla vita dei pesci
 ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2013 Qualità dei corpi idrici superficiali e ambiente marino costiero - Acque dolci idonee alla vita dei pesci Nome indicatore DPSIR Fonte dati Acque dolci idonee alla
ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2013 Qualità dei corpi idrici superficiali e ambiente marino costiero - Acque dolci idonee alla vita dei pesci Nome indicatore DPSIR Fonte dati Acque dolci idonee alla
CORSO ANALISI CHIMICA MOD Analisi terreni ITIS VIOLA A.S. 2016/2017 SUOLO LEZIONE 1: INTRODUZIONE E CAMPIONAMENTO
 SUOLO LEZIONE 1: INTRODUZIONE E CAMPIONAMENTO 1 DEFINIZIONI SUOLO: Strato superficiale della crosta terrestre formatosi in seguito all alterazione del substrato roccioso per successive azioni fisiche,
SUOLO LEZIONE 1: INTRODUZIONE E CAMPIONAMENTO 1 DEFINIZIONI SUOLO: Strato superficiale della crosta terrestre formatosi in seguito all alterazione del substrato roccioso per successive azioni fisiche,
BIODIVERSITA DEL SUOLO
 Pillole di suolo BIODIVERSITA DEL SUOLO Il suolo ospita una miriade di organismi viventi, e la loro diversità e quantità è di gran lunga maggiore di quella che si trova al suo esterno. Addirittura, ci
Pillole di suolo BIODIVERSITA DEL SUOLO Il suolo ospita una miriade di organismi viventi, e la loro diversità e quantità è di gran lunga maggiore di quella che si trova al suo esterno. Addirittura, ci
Diverse tipologie idrogeomorfologiche: fiordi, estuari, lagune, stagni
 Parma 6 febbraio 2008 Quadro sinottico delle problematiche delle aree di transizione dell'alto adriatico e obiettivi di qualità definiti dalla WFD 2000/60/CE Giorgio Mattassi Diverse tipologie idrogeomorfologiche:
Parma 6 febbraio 2008 Quadro sinottico delle problematiche delle aree di transizione dell'alto adriatico e obiettivi di qualità definiti dalla WFD 2000/60/CE Giorgio Mattassi Diverse tipologie idrogeomorfologiche:
Corso di «Acquedotti e Fognature» ACQUE BIANCHE
 Corso di «Acquedotti e Fognature» ACQUE BIANCHE 1 Mitigazione degli effetti degli scaricatori Una corretta gestione delle acque meteoriche operata sostanzialmente tramite il consapevole utilizzo degli
Corso di «Acquedotti e Fognature» ACQUE BIANCHE 1 Mitigazione degli effetti degli scaricatori Una corretta gestione delle acque meteoriche operata sostanzialmente tramite il consapevole utilizzo degli
Nitrati e irrigazione
 Lisciviazione (kg ha -1 N-NO3) Irrigazioni (m 3 ha -1 ) Nitrati e irrigazione L irrigazione può diventare una pratica colturale in grado di influenzare negativamente l ambiente mediante il movimento dell'acqua
Lisciviazione (kg ha -1 N-NO3) Irrigazioni (m 3 ha -1 ) Nitrati e irrigazione L irrigazione può diventare una pratica colturale in grado di influenzare negativamente l ambiente mediante il movimento dell'acqua
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
 DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE: IMPIANTI DI DEPURAZIONE PROF. ANTONIO PANICO Indice 1 IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE --------------------------------------------------------- 3 2 IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE: IMPIANTI DI DEPURAZIONE PROF. ANTONIO PANICO Indice 1 IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE --------------------------------------------------------- 3 2 IMPIANTI DI
Liceo B. Cavalieri Classe 2D sc. Anno Scolastico 2013/2014 Svolto da Agrati Giorgia
 Liceo B. Cavalieri Classe 2D sc. Anno Scolastico 2013/2014 Svolto da Agrati Giorgia Cos è un industria? L industria è tutto ciò che svolge attività di produzione di beni di interesse economico con criterio
Liceo B. Cavalieri Classe 2D sc. Anno Scolastico 2013/2014 Svolto da Agrati Giorgia Cos è un industria? L industria è tutto ciò che svolge attività di produzione di beni di interesse economico con criterio
ARIA PULITA E ARIA INQUINATA. naturale è composta da un miscuglio di gas e particelle con concentrazione variabile
 Parametri meteorologici e inquinanti atmosferici ARIA PULITA E ARIA INQUINATA L aria naturale è composta da un miscuglio di gas e particelle con concentrazione variabile Azoto, ossigeno, argon e vapore
Parametri meteorologici e inquinanti atmosferici ARIA PULITA E ARIA INQUINATA L aria naturale è composta da un miscuglio di gas e particelle con concentrazione variabile Azoto, ossigeno, argon e vapore
Lezione 19 del 15/05/2015 Modelli Matematici Ambientali
 Lezione 19 del 15/05/2015 Modelli Matematici Ambientali Lorenzo Cioni - SNS 1 Introduzione In questa lezione vedremo come sia possibile descrivere, sia pure con molte semplificazioni, i processi di contaminazione
Lezione 19 del 15/05/2015 Modelli Matematici Ambientali Lorenzo Cioni - SNS 1 Introduzione In questa lezione vedremo come sia possibile descrivere, sia pure con molte semplificazioni, i processi di contaminazione
