Il Simposio di Platone e Il Discorso di Verità di Socrate sull Amore
|
|
|
- Raimonda Turco
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Il Simposio di Platone e Il Discorso di Verità di Socrate sull Amore Il Simposio è il dialogo in cui Platone ha consegnato alla storia dell Occidente alcune espressioni diventate proverbiali, come la mia dolce metà che deriva dal discorso di Aristofane, oppure Amore platonico. Il Simposio tratta di un banchetto avvenuto per festeggiare Agatone, che vince nel 416 a C, con una sua tragedia, la stagione teatrale. La festa avviene in casa di Agatone (poeta e drammaturgo) e gli amici invitati che si ritrovano sono Fedro (retore), Aristofane (commediografo), Pausania (politico e sofista), Eurissimaco (medico, rappresentante della medicina di stampo ippocratico), Socrate e Aristodemo che non era stato invitato da Agatone, il padrone di casa, ma da Socrate, incontrato per strada. Alla fine irrompe Alcibiade (comandante militare) con i suoi amici. Il Simposio, da originario pasto sacrificale a momento centrale della socialità dell èlite aristocratica e guerriera, fino alla forma più comune di banchetto ospitale, è di solito offerto nelle case dei più abbienti o indetto dai componenti di un tiaso (gruppo iniziatico), che contribuiscono portando con sé cibi pronti. Si tratta sempre di pasti fra uomini, perché le donne libere sono escluse tanto dalle riunioni politiche quanto da quelle sociali. Le uniche donne a comparire nella seconda parte del banchetto sono schiave, musicanti, danzatrici ed etère, le cortigiane. Il banchetto greco si divideva in due momenti: una prima parte coincide con il tramonto ed è destinata al pasto e al consumo di cibo; la seconda, più lunga, è chiamata propriamente simposio, cioè il momento del bere insieme tra una conversazione e l altra o in mezzo a danze e giochi di vario tipo. Prima di entrare in casa dell ospite per un banchetto, il primo atto è quello di togliersi le calzature. I servi lavano i piedi a ciascun convitato che può entrare così nella sala dei banchetti e adagiarsi sul letto senza il rischio di sporcare il giaciglio. I convitati, talora coronati di foglie o fiori, mangiano coricati o con le gambe distese, a due a due su letti disposti intorno a piccoli 1
2 tavoli. La seconda abluzione prima del pasto è quella delle mani in bacili portati dai servi, tanto più che il cibo si prende con le dita e non sono in uso tovaglioli; ci si asciuga la bocca con pezzi di mollica di pane che vengono poi gettati in terra insieme agli avanzi. Il pasto inizia con una sorta di aperitivo, ovvero con una coppa di vino aromatizzato che si fa passare tra i convitati. Al termine del pasto si tolgono le mense e si ripuliscono i pavimenti. Si versano poi le libagioni e si intona l inno: comincia il simposio vero e proprio. Prima di bere si nomina un simposiarca o re del banchetto che fissa il numero di coppe che un invitato può bere; a turno si brinda alla salute di tutti. Musica e danze possono allietare i convitati che durante il simposio diventato poi un vero e proprio genere letterario- conversano o si abbandonano ai piaceri dell amore e si destreggiano in giochi di abilità come il còttabo. Questo il banchetto ateniese. Diverso il pasto comune spartano che, secondo la tradizione, è regolato da Licurgo. Nel Simposio descritto da Platone, il tema che viene scelto per la discussione è Eros, Amore, che rimane il filo conduttore di tutto il dialogo. Quello che emerge è un ventaglio a vasto raggio sull Amore in cui Platone ci consegna tutto quello che la grecità ha pensato e creato sul tema dell amore. Sono soprattutto degli encomi secondo i canoni della mitologia classica, della politica e quindi sulla legislazione dei rapporti sessuali, della medicina, della tragedia e della commedia, della filosofia, fino al discorso di verità di Diòtima di Mantinea una saggia sacerdotessa dei riti Eleusini che inizia Socrate ai misteri d Amore e gli presenta una dottrina mistica di elevazione della componente carnale a quella spirituale. Questa è un po tutta la tensione della filosofia di Platone che vuole innalzare la dimensione dell uomo da un piano materiale ad un livello spirituale, ad una dimensione mistica. Tutti i discorsi tenuti durante il simposio sembrano rispecchiare prospetticamente, visioni sull Eros, sull Amore, che Platone in qualche modo condivide intendendo tuttavia integrarle e anche completarle proprio con il discorso di Socrate che riferisce l insegnamento mistico-misterico di Diòtima. Personaggi del dialogo: Apollodoro Aristodemo Agatone Aristofane Fedro Amico Socrate, Eratò, Diòtima (dialogo immaginato) Pausania Eurissimaco Alcibiade Apollodoro si prepara a raccontare ad un amico i discorsi scambiati molto tempo prima tra Socrate, Agatone, Alcibiade e altri; discorsi di cui egli è venuto a conoscenza tramite Aristodemo e che ancora ricorda bene per averli già ripetuti a Glaucone. Racconto di Apollodoro: Socrate, mentre sta recandosi a cena da Agatone, vincitore il giorno prima nelle gare tragiche, si imbatte in Aristodemo e lo invita ad accompagnarlo. Aristodemo entra in casa di Agatone, ma Socrate non è con lui: si è fermato assorto in meditazione. Aristodemo impedisce che Socrate venga disturbato, e solo quando i convitati sono a metà cena, Socrate entra. Agatone lo invita a sedersi vicino a lui perché possa comunicargli, anche con la vicinanza, la sua sapienza. Socrate gli risponde ironicamente. 2
3 Finita la cena, tutti i convitati decidono di bere con moderazione e lentamente, passando il tempo a discutere. Eurissimaco, il medico, propone il tema della discussione, suggeritogli da Fedro: l elogio di Amore. Tutti si dichiarano d accordo. 1. Il primo a parlare è Fedro che pronuncia un encomio su Eros, Amore, secondo i canoni classici della retorica e della poetica, per cui infarcisce il suo discorso con citazioni di Esiodo, Parmenide, Omero e della religiosità orfica. Eros è particolarmente venerato dagli uomini e dagli dei, perché è il più antico, il primo generato di tutti gli dei. Fedro cita a sostegno della sua tesi la teogonia di Esiodo in cui Eros viene fuori dal Caos insieme a Gaia, la Terra. Una terra in origine informe, spoglia, oscura che proprio grazie ad Eros, viene vivificata, arricchita. Viene dotata di quel principio vitale che le dà vita e bellezza. Fedro declama i grandi effetti che questo dio produce e infonde nel cuore degli amanti. Alcune espressioni usate da Fedro sono diventate canoniche, come ad esempio morire per amore : l idea che per amore l amante è disposto a morire, che l amore più grande porta alla morte, alla morte per l amato. Lo fa con esempi concreti citando le storie di Alcesti-Admeto, Orfeo-Euridice, Achille Patroclo. Inoltre, per Fedro, l amore tra amante e amato è asimmetrico: il dio Eros è presente soprattutto nell amante, in chi ama, in chi è innamorato e non tanto nell amato, che è oggetto d amore. Eros possiede e fa innamorare, soffrire, morire, l amante. E quindi più divino, più posseduto dal dio, l amante, dell amato. E quali beni sono maggiori di quelli dati da Amore? Ed ancora, è il legame tra amante e amato che crea il sentimento di vergogna per le cose turpi e di zelo per quelle oneste. 2. Il secondo è il discorso di Pausania. Pausania è un sofista politico che descrive il rapporto omosessuale secondo la dinamica di scambio tra Eros e Paideia (cultura ed educazione) e lo fa citando anche la legislazione in materia nella Beozia, nell Elide, dove tutto è permesso. Per converso, nei regimi tirannici della Ionia, tutto è vietato, tutto è represso, perché, dice Pausania, i tiranni temono i legami, le amicizie solidali che portano al pensiero critico e quindi possono rovesciare la tirannide. E ovvio che in Pausania, democratico, sia presente in modo forte il mito di Armodio e Aristogitone: coppia di amanti che appunto rovesciano la tirannide dei pisistratidi e fanno nascere la democrazia. La legislazione rende lecito l amore tra l adulto ed il giovane se si prevede lo scambio condiviso: il giovane concede i suoi favori, mentre l adulto si preoccupa dell educazione e della formazione del giovane amato. L amore uomo-donna è volgare, cioè del popolo, e corrisponde ad Afrodite Pandemia, l Afrodite terrestre; l amore uomo-uomo ad Afrodite Urania, l Afrodite celeste, più nobile, superiore rispetto alla Pandemia. Amore dunque non è un dio unico, ma duplice, come duplice è Afrodite. Chi ama secondo l Amore volgare, terrestre, ama tanto i fanciulli che le donne, i corpi piuttosto che le anime. Chi ama secondo l Amore celeste ama invece solo i maschi, ma questo Amore celeste è diverso dalla pederastia, anche se differenti sono i costumi tra le varie città greche. Le diverse prescrizioni e valutazioni morali dipendono dal fatto che il rapporto amante-amato di per sé non è buono né cattivo, ma buono se volto al bene, cattivo se volto al male. E necessario perciò far coincidere l amore per i fanciulli e l amore per la sapienza e il compiacere all amato è lecito ed assolutamente bello solo quando è a scopo di virtù. Bisogna dunque stabilire quale è l Amore che vogliamo elogiare: è quello che induce a bene amare. 3
4 3. Il terzo a parlare è Eurissimaco, il medico. Costui fa un discorso ispirato alla medicina greca ed alla teoria di Empedocle della filìa, dell amore come forza unitiva dell universo che tiene uniti gli elementi e che riguarda tutta la natura, uomini, piante, animali. E il principio armonizzante dell universo che porta all alternarsi delle stagioni, quindi all alternanza e mescolanza dei contrari, caldo e freddo, secco e umido e una armonia che porta salute, piacere e ordine. Questo amore è compito e indagine della medicina ed il medico contrasta gli amori malati e favorisce quelli sani ristabilendo il superamento degli squilibri e degli scompensi; lo stesso fa la musica come ha insegnato il divino Pitagora. Ciò vale anche per l astronomia e per l arte della divinazione. 4. Interviene ora Aristofane che in forma comica presenta il più grande mito che Platone ha creato in questo dialogo: il mito dell androgino. Tempo addietro - espone il poeta seguendo il mito orfico - non esistevano come adesso soltanto due sessi (il maschile e il femminile), bensì tre, tra cui, oltre a quelli già citati, il sesso androgino, proprio di esseri che avevano in comune caratteristiche maschili e femminili. In quel tempo, tutti gli esseri umani avevano due teste, quattro braccia, quattro mani, quattro gambe e due organi sessuali ed erano tondi, ovoidali. Per via della loro potenza, gli esseri umani erano superbi e tentarono la scalata all'olimpo per spodestare gli dei. Zeus, che non poteva accettare un simile oltraggio, decise di intervenire e tagliò in due parti ogni aggressore a colpi di saetta. In questo modo gli esseri umani furono divisi e s'indebolirono. Apollo fu incaricato di riplasmare le due metà così separate. Tuttavia, poiché le due metà separate si ricercavano e, ritrovatesi, si abbracciavano, e poiché così abbracciate non potevano fare altro e morivano, Zeus li adattò per la procreazione. Ed è da quel momento - spiega il poeta - che essi sono alla ricerca della loro antica unità e della perduta forza che possono ritrovare soltanto unendosi sessualmente. Da questa divisione originaria in due parti, infatti, nasce negli umani il desiderio di ricreare la primitiva unità. Dunque, al desiderio e alla ricerca dell intero si dà nome amore. Siccome i sessi erano tre, due sono oggi le tipologie d'amore: il rapporto omosessuale (se i due partner prima della divisione, facevano parte di un essere umano completamente maschile o completamente femminile) e il rapporto eterosessuale (se i due facevano parte di un essere androgino). La caratteristica interessante del discorso di Aristofane risiede nel fatto che la relazione erotica fra due esseri umani non è messa in atto per giungere a un fine quale potrebbe essere la procreazione, ma ha valore per se stessa, prescindendo così dalle conseguenze, in quanto la varietà degli amori tra i sessi dipende dall attrazione conseguente alla natura originaria dell umanità. Questo mito ha avuto una fortuna enorme e qualcuno lo ha addirittura legato al mito di Adamo ed Eva. 5. Parla quindi Agatone che è il festeggiato. Ci presenta una dottrina dell Eros che è una sorta di autocelebrazione della bellezza. Per fare realmente un elogio all Amore, è necessario dire prima chi è Amore, poi quali sono i suoi benefici. Amore, è il più bello e il più buono tra gli dei. Egli è il più giovane di tutti gli dei, è eterno, di delicata natura, flessuoso e leggiadro, descrizione che sta all origine dell iconografia dell amore visto come un angioletto tenero, delicato, che scocca le frecce, che vola sui fiori, che abita in ciò che è morbido: il Cupido della mitologia romana. Ma Amore è anche il più buono. Né fa né riceve ingiustizia, è massimamente temperante, è il più valoroso e il più sapiente, insomma, ha tutte le virtù pitagoriche. Per amore si è poeti, come Eratò, la ninfa della poesia d amore, figlia di Zeus; per amore c è la generazione, ed è l Amore 4
5 che presiede a tutte le arti e a tutte le virtù dell anima. Non solo, ma Amore genera anche negli altri le sue virtù. Il discorso di Agatone è armonioso, elegante, ma viene contestato da Socrate il quale si aggancia al fatto che nega che Eros sia un dio bello, giovane e antico. Socrate, sull Amore, di fatto ripeterà il discorso di verità che udì direttamente da Diòtima. Non dico nulla di più, in quanto ascolteremo tra poco un dialogo immaginato tra Socrate, appunto, Eratò, la ninfa della poesia amorosa e Diotima, la saggia sacerdotessa di Mantinea. Sottolineo solo che, da tutto quanto è stato detto e si dirà, si comprenderà meglio come l amore platonico non è necessariamente disincarnato, non legato all aspetto materiale, come si tende invece solitamente a credere ( Discorso di verità tra Socrate, Eratò (la Musa della poesia d amore) e Diòtima, donna sapiente, sacerdotessa dei misteri Eleusini orfico-dionisiaci. Il testo è stato composto e sviluppato seguendo le osservazioni e i commenti di Simone Weil ne La Grecia e le intuizioni precristiane ). Socrate: Amici, grande è l imbarazzo per chi deve parlare dopo i tanti vostri bei discorsi su Amore! Malgrado ciò, acconsento a partecipare con voi a fare l encomio di Amore. Per me però, un encomio significa dire la verità e solo la verità, ed è ciò che io farò, senza perciò mettermi in gara con i discorsi di chi mi ha preceduto. La musa Eratò: Amato Socrate, so bene che tu non parli in nome proprio, ma ripeti, commenti e approvi gli insegnamenti che ti ha donato Diòtima, una donna di Mantinea molto saggia, venuta ad Atene per compiere un sacrificio agli dei. Con tale sacrificio ha allontanato di dieci anni la peste dalla Città. Il suo sesso e le parole di iniziazione e di mistero che usa di continuo, rivelano che si tratta di una sacerdotessa dei Misteri di Orfeo e Dioniso, di Demetra e Persefone. [Il Simposio è anche una risposta a coloro che credono che Socrate e Platone disprezzassero i Misteri! C è qui anche un indicazione abbastanza chiara che la dottrina contenuta in quest opera non è uscita da una riflessione filosofica, ma da una tradizione religiosa, mistico-misterica]. Socrate: Sì, Eratò. E proprio così. Diòtima innanzitutto mi ha fatto ben comprendere che, essendo l amore desiderio di bene, di bellezza, di saggezza, non è né bello, né saggio, benché non sia neppure brutto, cattivo e ignorante. Agatone ha appena sostenuto invece che l amore possiede la pienezza del bene, della beltà e della saggezza... Bisogna comprendere che sovente le proposizioni contraddittorie sono ugualmente vere. E poiché l amore non soffre niente se non con pieno consenso, egli si è volontariamente svuotato di bene, di beltà e di saggezza. La musa Eratò: Diòtima ti ha certo spiegato che l amore è un daìmon, parola che designa i mediatori, gli intermediari tra l uomo e Dio. [L uso della parola daìmon in greco è molto vario. Talora questa parola è sinonimo di theòs, dio; talora indica un essere che è al di sopra dell uomo, che appartiene a un mondo sovrannaturale, ma che è al di sotto della divinità; qualcosa come un angelo. Del resto, oì theòi, 5
6 gli dei, vuol dire talvolta qualcosa come gli angeli. Talora daìmon vuol dire anche demonio nel senso negativo che diamo noi a questa parola] Diòtima: L amore è un mediatore tra ciò che è mortale e ciò che è immortale E un grande demone. E tutto ciò che è di questa specie è mediatore fra Dio e l uomo. La musa Eratò: Con quale funzione, Diòtima? Diòtima: Quella di interpretare e trasmettere agli dei i messaggi umani e agli uomini i messaggi divini, da un lato le suppliche e i sacrifici, dall altro i comandi e le risposte ai sacrifici. Ciò che appartiene a questa specie di daìmon, essendo in mezzo fra gli uni e gli altri, colma questo mezzo e riallaccia in tal modo tutto a se stesso. Per esso si compie l arte degli oracoli, quella dei sacerdoti e quella dei sacrifici, dei misteri e degli incantamenti. Il Divino non si mescola direttamente all umano; è unicamente grazie all Amore che vi è scambio e dialogo tra gli dei e gli uomini. La musa Eratò: Affermi dunque, nel modo più categorico, che senza questa mediazione divina, non può esservi alcuna relazione fra Dio e l uomo? [ Nessuno va al Padre se non attraverso di me ]. Socrate: Lei dice in realtà che vi sono diversi mediatori di questa specie e che Eros, l Amore, è uno di essi, ma certo intende che vi sono diversi aspetti dello stesso, unico, essere. Nelle sue parole, l Amore appare come il sacerdote per eccellenza; ma l Amore è anche ermeneuon, colui che interpreta Questo lo avvicina al dio Hermes, l interprete, il messaggero degli dei La musa Eratò: e il dio che accompagna le anime nell altro mondo, il dio inventore della lira, il dio bambino-prodigio [Hermes che accompagna le anime nel viaggio nell aldilà è detto psicopompo] Socrate: sicuro Eratò; ma l Amore che è sacerdote e mediatore, che sta tra la divinità e l uomo, è lo stesso che, secondo il discorso che ci ha fatto prima Agatone, è almeno pari a Zeus, cui insegna l arte di governare l Amore che è il re degli dei. La musa Eratò: Raccontaci dunque, Diòtima: come nacque Amore? Diòtima: Egli nacque quando nacque la Celeste Afrodite; per festeggiarla gli dei fecero un banchetto, e fra essi vi era Pòros, Risorsa, il figlio della Saggezza. Dopo il pasto, Penìa, la Miseria, venne a mendicare, com è costume nelle feste. E rimase vicino alle porte. Lui, Risorsa, ebbro di nettare (poiché il vino ancora non esisteva), entrò nel giardino di Zeus e, appesantito, si addormentò. Miseria, per la mancanza di risorse in cui si trovava, volle fare in modo di avere un figlio da Risorsa. Si stese al suo fianco e così divenne gravida di Eros, di Amore. Ecco perché l Amore è nato compagno e servitore di Afrodite, essendo stato concepito nella festa per la sua nascita; inoltre egli è essenzialmente amante del bello, e Afrodite è bella. 6
7 Socrate: Quale è dunque, Diòtima, la vera natura di Amore? Diòtima: Come figlio di Risorsa e di Miseria, l Amore si trova in questa condizione: prima di tutto, egli è perpetuamente miserabile, ed è ben lungi dall essere delicato e bello come lo crede la moltitudine. E indurito e disseccato, ha i piedi nudi, è senza riparo; e sempre giace sulla nuda terra e dorme davanti alle porte e sulle strade, all aria aperta; e avendo la natura di sua madre, è sempre in compagnia della privazione. Ma, grazie a suo padre, è intraprendente nei riguardi delle cose belle e buone; coraggioso, sempre in cammino, sempre motivato, cacciatore temibile che tesse perpetuamente qualche invenzione, desideroso di saggezza, capace di risorse, egli filosofa per tutta quanta la vita, abile nelle lamentazioni incantatorie e nei rimedi, abile sofista. La sua natura non è né immortale, né mortale; talora in una stessa giornata è fiorente, vive quando sia pieno di risorse, poi muore, e di nuovo resuscita per la natura che ha ereditato da suo padre La saggezza concerne la bellezza suprema, e l Amore è amore del bello; egli ama dunque necessariamente la saggezza e, amando la saggezza, è mediatore tra il saggio e l ignorante. La causa di ciò è nella sua nascita, poiché suo padre è saggio e pieno di risorse, mentre sua madre è priva di saggezza e di risorse. La musa Eratò: Ogni parola di questo delizioso mito è da meditare! Socrate: Diòtima, tu hai nominato con Afrodite cinque personaggi: Saggezza, Risorsa, Zeus, Miseria e Amore. Pòros, giustamente, lo hai chiamato Risorsa, per contrapporlo a Miseria - Penìa, penuria - ma il suo nome significa anche via, passaggio, strada e mezzo, ed è all origine di due nostri verbi che significano letteralmente aprire il cammino, ma soprattutto procurare, fornire, dare. Penso perciò che in senso prossimo pòros voglia dire dono. Nel Prometeo incatenato di Eschilo c è un gioco di parole su questa stessa radice verbale [La radice ritorna tre volte in pochi versi: Io devo sopportare la sorte che mi è stata data (pòros); Avendo dato un privilegio (poròn) ai mortali ; La fonte del fuoco (pyròs) che apparve come una maestra e una grande risorsa (pòros) (o un gran tesoro o un gran dono)] E vi è pure un gioco di parole tra pyr (fuoco) e pòros (dono). C è dunque uno stretto rapporto tra l essere chiamato Pòros e Prometeo. [E questo essere è il Logos femminile, la Parola o il Verbo, la Parola che si fa carne, figlio della Sapienza Divina o Theo-Sophìa] La musa Eratò: E vero, Pòros è figlio della Saggezza, di Metis, il cui nome è quasi quello stesso di Prometeo Socrate: Promethèia, infatti, la Saggezza che prevede e provvede, la provvidenza divina. [Nella Trinità Eraclitea, così chiara nell Inno a Zeus di Cleante, Zeus, la folgore o il fuoco, è il Logos Padre della Saggezza. Esiodo racconta che la terra, Gaia che in Eschilo è identica a Temi e madre di Prometeo avvertì un giorno Zeus che la Saggezza, Metis, era destinata ad avere un figlio più potente di lui che lo avrebbe detronizzato. Per evitare questo pericolo, Zeus 7
8 ingoiò la Saggezza. Essa era Metis sua sposa, già incinta di Athena, che nascerà dalla testa di Zeus, completamente formata e dotata di tutti i suoi attributi] La musa Eratò: L Afrodite celeste è certo la bellezza divina. Eros, l Amore, è stato concepito dal padre Pòros ebbro di nettare Socrate: l archetipo del dio Diòniso La musa Eratò: il giorno della nascita di Afrodite Amore è dunque il suo compagno e l ama? Socrate: in realtà, i due sono aspetti della stessa Persona divina: Afrodite in quanto immagine di Dio, del Bene, e Amore in quanto mediatore, il re degli dei. [E Amore è Diòniso, il dio dei misteri traci e orfico-dionisiaci, che porterà all uomo il dono della vite la nuova vita da cui il vino, simbolo del sangue della passione del dio incarnatosi] La musa Eratò: Ma Amore, che hai presentato or ora, di nuovo, come re degli dei, è qui in terra descritto da Diòtima anche come un vagabondo miserevole Forse è lui che lo ha voluto? Ha voluto nascere figlio della Miseria? [Si tratta qui del sacrificio volontario, dell incarnazione del Logos, della Parola). Socrate: L Amore qui appare come l autore dell armonia più completa, nel senso che gli dava Pitagora, l unità fra i contrari il più possibile contrari: cioè la pienezza di Dio e la miseria o la privazione dell uomo. Così mi insegni o Diòtima: Diòtima: In breve, ogni desiderio è desiderio del bene e della felicità C è una dottrina che dice che coloro che cercano la metà di se stessi, quelli amano. La mia dottrina afferma invece che l amore non ha per oggetto né la metà né il tutto, a meno che per caso ciò sia buono. Perché gli uomini acconsentono a farsi tagliare i piedi e le mani, se questi sembrano loro un male. Io non credo che ognuno ami ciò che gli appartiene; a meno che un uomo non chiami bene ciò che gli è proprio e gli appartiene; e chiami male ciò che gli è estraneo. Non vi è altro oggetto d amore per gli uomini che il bene In breve, l amore è ciò per cui si desidera possedere perpetuamente il bene. La musa Eratò: Quanto dici, Diòtima, può sembrare una confutazione del mito esposto prima da Aristofane, il mito dell uomo tagliato in due, le cui metà si cercano disperatamente Socrate: Certo noi siamo esseri incompleti, che furono tagliati con violenza, frammenti perpetuamente in cerca del loro completamento... ma, contrariamente a quanto sembrerebbe indicare a prima vista proprio il mito di Aristofane, questo completamento non può essere il nostro simile. Questo completamento è il Bene: è Dio. Noi siamo frammenti staccati da Dio. La musa Eratò: Non vi è dunque per gli uomini altro oggetto d amore che il Bene? 8
9 Socrate: E così, ma noi non dobbiamo cercare in che modo mettere in noi l amore del Bene. Vi è già, è il fondo stesso del nostro essere. Se amiamo altra cosa è per errore, per effetto di un errata visione, di una falsa prospettiva: come quando per strada si corre con gioia verso uno sconosciuto perché di lontano lo si è preso per un amico. Ma tutto ciò che vi è in noi di mediocre, allo scopo di conservare se stesso tenta con ogni sorta di menzogne di impedirci di riconoscere che ciò che amiamo perpetuamente, dal primo all ultimo istante della vita, non è altro che il Bene, il vero Dio. Perché nel momento in cui lo riconosciamo, tutta la mediocrità che è in noi è condannata a morire. La musa Eratò: Diotìma ti ha certo mostrato anche un quadro delle tappe dell anima verso la salvazione, la salvazione attraverso la bellezza... Socrate: ha cominciato con la teoria dell amore carnale come desiderio di generare nella bellezza, in vista dell immortalità. La generazione carnale è ciò che vi è di indistruttibile nella vita animale, ma il desiderio di eternità che è in noi, si inganna e va dapprima verso questa immagine materiale dell eternità. La musa Eratò: Grazie a un misterioso legame, il desiderio di generazione non viene suscitato che dalla bellezza; bellezza carnale, poiché si tratta di generazione carnale, come hai detto [In fatto di amore carnale Platone considera legittimo soltanto quello diretto alla generazione dei figli; ciò confuta le accuse calunniose di immoralità]. Socrate: parallelamente però, in quelli che ne sono capaci, la bellezza spirituale suscita un desiderio di generazione spirituale; l amore fa nascere allora virtù, conoscenze, opere dello spirito: Diotima: Affinché nell educazione di Amore, l uomo veda la bellezza delle scienze, (la bellezza dell ordine del mondo colto attraverso la più rigorosa necessità, quella che fa da materia alla dimostrazione matematica) e guardi infine verso l abbondanza della bellezza volgendosi verso il vasto mare del bello e contemplandolo, partorirà dottrine vaste, belle e grandi, e molti pensieri in una filosofia generosa; fino a quando, essendo in tal modo fortificato e maturato, discerna una scienza unica, che è quella del bello. Poiché colui che è giunto a questo grado dell educazione amorosa, considerando le cose belle nell ordine e correttamente, pervenuto al compimento dell amore, d un tratto contemplerà una specie miracolosa di bello Innanzitutto, eternamente reale, che non nasce, non perisce, non si accresce, non si esaurisce. Poi non è una bellezza che sia bella da un lato, brutta dall altro; bella a un certo momento e non a un altro; bella sotto un aspetto, brutta sotto un altro; bella in un luogo, brutta in un altro; bella per gli uni, brutta per gli altri. E il bello non gli apparirà come un volto o delle mani o una parte qualunque del corpo; o una dottrina; o una scienza; e non gli apparirà in alcun modo come dimorante in altra cosa, in un essere vivente o nella terra o nel cielo o in checché sia. Sarà il bello stesso, in se stesso, con se stesso, di essenza unica, eternamente reale. Tutte le belle cose ne partecipano, ma in modo tale che quando esse nascono e periscono esso non ha né accrescimento né diminuzione né alcuna modificazione Quando qualcuno si è messo a contemplare il bello in tal modo, ha quasi raggiunto la perfezione sa finalmente che cos è il bello. 9
10 Pensi tu, Socrate, che sia una vita mediocre quella dell uomo che guarda in questo luogo, che lo contempla con l organo che conviene e si unisce a lui? Pensaci; è la, è lui solo, colui che vede il bello con l organo capace di vederlo, l occhio dell amore spirituale; e a lui accadrà di partorire non simulacri di virtù (poiché egli non ha colto un simulacro), ma virtù vere, perché ha colto il vero. E partorendo e nutrendo la virtù vera, gli è accordato di essere amico di Dio; e se mai un uomo è divenuto immortale, egli lo diverrà. In quest opera si troverebbe difficilmente per la natura umana, miglior collaboratore dell Amore. La musa Eratò: Le tappe del progresso dell anima che Diòtima ha descritto conducono dalla considerazione della bellezza fisica di un essere alla considerazione della bellezza fisica ovunque si trovi; quindi alla bellezza nelle anime, quindi alla bellezza nelle leggi e nelle istituzioni, quindi alla bellezza nelle scienze, per giungere al compimento dell amore, alla contemplazione della bellezza stessa. Socrate: Diòtima mi ha parlato di un matrimonio spirituale col bello, grazie al quale l anima partorisce veramente delle virtù. E il bello non risiede in null altro, non è un attributo, è un soggetto, è il Bene, è Dio! La musa Eratò: Nella nostra antica poesia, nel racconto del mito, mi par di ricordare, il bello assoluto è l Afrodite celeste, riflesso diretto del Bene la Luna che riflette la luce del Sole, come il Figlio riflette (e rivela in sé) la natura del Padre Socrate: Il bello assoluto è qualcosa, si può dire, di concreto, come gli oggetti sensibili, qualcosa che si vede, ma non con gli occhi del corpo, con la vista spirituale. Dopo una lunga preparazione nell Amore spirituale vi si accede con una specie di rivelazione, uno squarcio improvviso Diòtima: Colui che contempla con amore l ordine del mondo perverrà al momento in cui, all improvviso, contemplerà altra cosa, un bello di una specie unica, miracolosa. Socrate: Così mi parlava Diòtima e mi ha convinto. E così persuaso cerco di persuadere anche gli altri che per acquisire l immortalità del Bene, per la natura umana, l aiuto migliore è l Amore. Ecco perché io dico che ogni uomo ha il dovere di tenere caro, Amore, ed io stesso onoro la sua disciplina, e particolarmente la esplicito, mentre esorto anche gli altri, ed ora e sempre lodo la potenza e la forza di Amore, per quanto ne sono capace Ecco dunque, Amici: considerate questo discorso di verità, se volete, detto come encomio di Amore; se no, chiamatelo come vi piace Dopo questo discorso di verità di Socrate, irrompe Alcibiade ubriaco con una masnada di amici che incarna, si può dire, l aspetto dionisiaco propriamente simposiale. Lui è ubriaco e Dioniso è il dio del vino. Alcibiade cambia completamente registro: non fa un discorso su Amore come tutti gli altri ma su Socrate. Su Socrate come suo amante, su Socrate come uomo erotico. Tutti gli encomi e gli elogi non sono per Eros, ma si concentrano sulla figura di Socrate: 10
11 Socrate è come le statue dei sileni istruttori del giovane Diòniso, che all interno contengono le immagini del dio, e somiglia al satiro Marsia: la sua musica sono i discorsi. Quale straordinario effetto questi discorsi producono! Socrate è saggio e temperante e grandi sono la sua sopportazione e la sua resistenza nei confronti delle circostanze esterne. Socrate è capace di astrarsi da tutto ciò che lo circonda e ha grande coraggio. Nessuno è simile a lui. Anche i discorsi di Socrate somigliano alle statue dei sileni dionisiaci: disadorne di fuori, il loro contenuto è il solo che meriti di essere ascoltato. La parte finale, una sorta di dramma satiresco, è presentato come lo svelamento della vera natura dell amore che c è tra Socrate e Alcibiade. Anche qui troviamo un altra espressione famosa: In vino veritas (tradotta in latino), dice Alcibiade è il vino che mi fa parlare e mi fa dire la verità. Alcibiade racconta dei tentativi di seduzione che ha messo in atto per conquistare Socrate e per realizzare quel rapporto tra Eros e Paideia teorizzato da Pausania. Ma Socrate si sottrae a questo scambio che dice esplicitamente equivarrebbe ad uno scambio di armi d oro con armi di bronzo, il bronzo dell apparenza del bello; l oro della verità e del bello che è poi la Sapienza. Dopo le battute con Socrate, Alcibiade si appresta a fare, a sua volta, l elogio di Agatone. Arriva però un altra comitiva di bevitori e riprendono le libagioni. Tutti alla fine si addormentano ubriachi. Solo Socrate rimane sveglio fino all alba a discutere con il tragico e con il comico, cioè con Aristofane e Agatone, sul senso del tragedia e della commedia, cioè del teatro: Socrate: L amore è come il teatro, a volte è tragedia, a volte è commedia. In fondo, la tragedia e la commedia, il piacere ed il dolore, la gioia e la sofferenza che sono parte del teatro ma anche parte della vita, non devono essere visti come due cose separate, ma come unità. Quindi chi è poeta tragico è poeta comico e viceversa ed il vero conoscitore dell ambivalenza della vita è il filosofo, l unico che rimane sveglio Eratò e che all alba se ne va, come Socrate, al Liceo e vi trascorre l intero giorno, ad insegnare * 11
L impero di Afrodite
 L impero di Afrodite Afrodite ed Eros non sono interscambiabili E S P R I M O N O L U N I O N E I N N O M E D E L L A M O R E L E R E L A Z I O N I T R A L E P E R S O N E Come nasce Eros? LE P R I M E
L impero di Afrodite Afrodite ed Eros non sono interscambiabili E S P R I M O N O L U N I O N E I N N O M E D E L L A M O R E L E R E L A Z I O N I T R A L E P E R S O N E Come nasce Eros? LE P R I M E
L ANNUNCIO DI PASQUA Luca 24, 1-10
 L ANNUNCIO DI PASQUA Luca 24, 1-10 Arcabas - Chiesa della Risurrezione - Comunità Nazareth - Torre de Roveri (Bg) Buio e luce Di buon mattino.... Sul fondo della valle la notte lotta contro il giorno.
L ANNUNCIO DI PASQUA Luca 24, 1-10 Arcabas - Chiesa della Risurrezione - Comunità Nazareth - Torre de Roveri (Bg) Buio e luce Di buon mattino.... Sul fondo della valle la notte lotta contro il giorno.
SCIENZA E FEDE un dialogo possibile
 Le difficoltà del passato: La fede vedeva nella scienza la volontà dell uomo e della sua ragione di fare a meno Di Dio... SCIENZA E FEDE un dialogo possibile La scienza vedeva nella fede qualcosa di primitivo
Le difficoltà del passato: La fede vedeva nella scienza la volontà dell uomo e della sua ragione di fare a meno Di Dio... SCIENZA E FEDE un dialogo possibile La scienza vedeva nella fede qualcosa di primitivo
Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ
 Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ Dio Padre è sempre con noi Non siamo mai soli Leggi il catechismo Cosa abbiamo imparato Nella fatica sei con noi, Signore Leggi il catechismo
Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ Dio Padre è sempre con noi Non siamo mai soli Leggi il catechismo Cosa abbiamo imparato Nella fatica sei con noi, Signore Leggi il catechismo
OMELIA : NOTTE DI NATALE
 OMELIA : NOTTE DI NATALE Che cosa significa essere qui? Ognuno può dare la sua risposta però la risposta vera è una sola. Il natale è contemporaneamente la grandezza di Dio e la sua benevola vicinanza
OMELIA : NOTTE DI NATALE Che cosa significa essere qui? Ognuno può dare la sua risposta però la risposta vera è una sola. Il natale è contemporaneamente la grandezza di Dio e la sua benevola vicinanza
Testo di riferimento: il NUOVO protagonisti e testi della filosofia
 LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN tot. Ore 98/99 Palermo ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE 3^ G Testo di riferimento: il NUOVO protagonisti e testi della filosofia N. Abbagnano
LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN tot. Ore 98/99 Palermo ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE 3^ G Testo di riferimento: il NUOVO protagonisti e testi della filosofia N. Abbagnano
9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana
 9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana 18.00 10.00 (Messa vigiliare del sabato: la voce guida prima che inizia la processione all altare) Chiamati anche oggi da Gesù per celebrare il suo
9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana 18.00 10.00 (Messa vigiliare del sabato: la voce guida prima che inizia la processione all altare) Chiamati anche oggi da Gesù per celebrare il suo
PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO CLIC SUL MONDO
 PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO CLIC SUL MONDO Anno scolastico 2013-2014 Perché questo progetto? Per il semplice motivo che l amicizia rimane uno dei valori più nobili dell essere umano. L uomo è per sua
PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO CLIC SUL MONDO Anno scolastico 2013-2014 Perché questo progetto? Per il semplice motivo che l amicizia rimane uno dei valori più nobili dell essere umano. L uomo è per sua
Violetta di campo. È il canto della violetta, non lasciamolo solo il dolore dell uomo
 Violetta di campo È il canto della violetta, non lasciamolo solo il dolore dell uomo Le immagini sono state realizzate dalla stessa autrice. Giannina Meloni VIOLETTA DI CAMPO È il canto della violetta,
Violetta di campo È il canto della violetta, non lasciamolo solo il dolore dell uomo Le immagini sono state realizzate dalla stessa autrice. Giannina Meloni VIOLETTA DI CAMPO È il canto della violetta,
PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE
 PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve
PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve
Amore, adulterio e separazione. Aspetti giuridici e non solo nell ordinamento giuridico italiano
 Amore, adulterio e separazione Aspetti giuridici e non solo nell ordinamento giuridico italiano Ogni riferimento a fatti realmente accaduti o luoghi e/o a persone realmente esistenti è da ritenersi puramente
Amore, adulterio e separazione Aspetti giuridici e non solo nell ordinamento giuridico italiano Ogni riferimento a fatti realmente accaduti o luoghi e/o a persone realmente esistenti è da ritenersi puramente
CORSO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA. Prof. Andrea Potestio Università degli studi di Bergamo
 CORSO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA Prof. Andrea Potestio Università degli studi di Bergamo 1 Ellenismo Fine delle polis greche Impero di Alessandro Magno Dissoluzione del suo Impero (323 a.c. data della sua
CORSO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA Prof. Andrea Potestio Università degli studi di Bergamo 1 Ellenismo Fine delle polis greche Impero di Alessandro Magno Dissoluzione del suo Impero (323 a.c. data della sua
Riti di introduzione. Il Signore ci invita alla sua mensa. Esercizi Spirituali - anno della Fede - Parrocchia SAN LORENZO -Lunedì.
 Riti di introduzione Esercizi Spirituali - anno della Fede - Parrocchia SAN LORENZO -Lunedì Il Signore ci invita alla sua mensa E' il giorno del Signore: le campane ci invitano alla festa; Dio, nostro
Riti di introduzione Esercizi Spirituali - anno della Fede - Parrocchia SAN LORENZO -Lunedì Il Signore ci invita alla sua mensa E' il giorno del Signore: le campane ci invitano alla festa; Dio, nostro
Parola di Vita. Agosto 2012
 Parola di Vita Agosto 2012 «Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò
Parola di Vita Agosto 2012 «Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò
CREDO IN CREDO LA PROFESSO ASPETTO DIO PADRE UN SOLO CREATORE GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CHIESA
 DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
il commento di p. Maggi al vangelo di natale
 il commento di p. Maggi al vangelo di natale IL VERBO SI FECE CARNE E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI commento al vangelo del giorno di natale (25 dicembre 2016) di p. Alberto Maggi: Gv 1,1-18 In principio
il commento di p. Maggi al vangelo di natale IL VERBO SI FECE CARNE E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI commento al vangelo del giorno di natale (25 dicembre 2016) di p. Alberto Maggi: Gv 1,1-18 In principio
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
1 IO -PERSONA. Nella costruzione dell amore Il corpo come espressione della mia persona
 Nella costruzione dell amore Il corpo come espressione della mia persona Il tuo corpo è tutto luminoso Lc, 6 Il tuo corpo è tutto luminoso Lc, 6 Abbiamo bisogno di comunicare con altre persone. I mezzi
Nella costruzione dell amore Il corpo come espressione della mia persona Il tuo corpo è tutto luminoso Lc, 6 Il tuo corpo è tutto luminoso Lc, 6 Abbiamo bisogno di comunicare con altre persone. I mezzi
ETICA E POLITICA E IMPOSSIBILE DISTINGUERE IN PLATONE MA NEL PENSIERO GRECO IN GENERALE LA POLITICA DALL ETICA VITA SOCIALE VITA PRIVATA
 PLATONE LA POLITICA ETICA E POLITICA E IMPOSSIBILE DISTINGUERE IN PLATONE MA NEL PENSIERO GRECO IN GENERALE LA POLITICA VITA SOCIALE DALL ETICA VITA PRIVATA LA REPUBBLICA O POLITÉIA (insieme dei cittadini)
PLATONE LA POLITICA ETICA E POLITICA E IMPOSSIBILE DISTINGUERE IN PLATONE MA NEL PENSIERO GRECO IN GENERALE LA POLITICA VITA SOCIALE DALL ETICA VITA PRIVATA LA REPUBBLICA O POLITÉIA (insieme dei cittadini)
Il mito della caverna
 Il mito della caverna PERCHE USARE IL MITO? Come evocazione: rende più affascinante il concetto filosofico. Come spiegazione là dove la ragione e la filosofia non riescono a rispondere. IL MITO DELLA CAVERNA
Il mito della caverna PERCHE USARE IL MITO? Come evocazione: rende più affascinante il concetto filosofico. Come spiegazione là dove la ragione e la filosofia non riescono a rispondere. IL MITO DELLA CAVERNA
Il Simposio di Platone. Platone, Simposio, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1997
 Il Simposio di Platone Platone, Simposio, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1997 Platone Nasce ad Atene nel 427 a.c. da famiglia aristocratica di grande tradizione Il suo vero nome è Aristocle (Platone
Il Simposio di Platone Platone, Simposio, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1997 Platone Nasce ad Atene nel 427 a.c. da famiglia aristocratica di grande tradizione Il suo vero nome è Aristocle (Platone
Filosofia o. Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia
 Filosofia o Storia della Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia della Filosofia! Utilità! È un po come per l interesse: della nostra materia non ha molto senso chiedere
Filosofia o Storia della Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia della Filosofia! Utilità! È un po come per l interesse: della nostra materia non ha molto senso chiedere
LOCKE. Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza:
 LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
Aristotele ARISTOTELE LA VITA E LE OPERE
 Aristotele ARISTOTELE LA VITA E LE OPERE Vita ARISTOTELE NACQUE A STAGIRA NEL NORD DELLA GRECIA NEL 384 A.C. NEL 367, ALL'ETÀ DI 17 ANNI, ANDÒ AD ATENE AL FINE DI ENTRARE A FAR PARTE DELL'ACCADEMIA DI
Aristotele ARISTOTELE LA VITA E LE OPERE Vita ARISTOTELE NACQUE A STAGIRA NEL NORD DELLA GRECIA NEL 384 A.C. NEL 367, ALL'ETÀ DI 17 ANNI, ANDÒ AD ATENE AL FINE DI ENTRARE A FAR PARTE DELL'ACCADEMIA DI
Argomenti LA SOFISTICA PROTAGORA E GORGIA IL PROBLEMA DELLE LEGGI SOCRATE
 I SOFISTI E SOCRATE Argomenti LA SOFISTICA PROTAGORA E GORGIA IL PROBLEMA DELLE LEGGI SOCRATE I FILOSOFI DELL'UOMO E DELLA CITTÀ Protagora, Gorgia Protagora Trasimaco, Prodico, Ippia, Callicle, Crizia
I SOFISTI E SOCRATE Argomenti LA SOFISTICA PROTAGORA E GORGIA IL PROBLEMA DELLE LEGGI SOCRATE I FILOSOFI DELL'UOMO E DELLA CITTÀ Protagora, Gorgia Protagora Trasimaco, Prodico, Ippia, Callicle, Crizia
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi
 avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra (At 1,8) Furono queste le ultime parole che Gesù pronunciò prima della Sua Ascensione
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra (At 1,8) Furono queste le ultime parole che Gesù pronunciò prima della Sua Ascensione
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si
 I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
Sebastiano Lo Monaco: Vi racconto il mio Ulisse
 Sebastiano Lo Monaco: Vi racconto il mio Ulisse di Elisa Guccione - 15, Gen, 2016 http://www.siciliajournal.it/sebastiano-lo-monaco/ di Elisa Guccione Foto Servizio Vincenzo Musumeci 1 / 5 CATANIA A poche
Sebastiano Lo Monaco: Vi racconto il mio Ulisse di Elisa Guccione - 15, Gen, 2016 http://www.siciliajournal.it/sebastiano-lo-monaco/ di Elisa Guccione Foto Servizio Vincenzo Musumeci 1 / 5 CATANIA A poche
Convento-Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Squinzano-
 Convento-Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Squinzano- . IL COMANDAMENTO DELL AMORE Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza. Ama il prossimo tuo come te stesso.
Convento-Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Squinzano- . IL COMANDAMENTO DELL AMORE Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza. Ama il prossimo tuo come te stesso.
Giovanni Casertano Giustizia, filosofia e felicità. Un introduzione a La Repubblica di Platone
 A11 Giovanni Casertano Giustizia, filosofia e felicità Un introduzione a La Repubblica di Platone Copyright MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Quarto Negroni,
A11 Giovanni Casertano Giustizia, filosofia e felicità Un introduzione a La Repubblica di Platone Copyright MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Quarto Negroni,
La Vocazione. Preghiera Ma.Gi. del 21 ottobre 2016
 Preghiera Ma.Gi. del 21 ottobre 2016 La Vocazione Iniziamo il percorso di preghiera 2016-2017 della Fraternità dei Ma.Gi., seguendo il tema delle vocazioni; religiose, sacerdotali, familiari, rispondono
Preghiera Ma.Gi. del 21 ottobre 2016 La Vocazione Iniziamo il percorso di preghiera 2016-2017 della Fraternità dei Ma.Gi., seguendo il tema delle vocazioni; religiose, sacerdotali, familiari, rispondono
Argomenti. Vita ed opere. La dottrina delle idee. La concezione dell'anima. Filosofia, amore, bellezza. Il pensiero politico.
 Argomenti Vita ed opere La dottrina delle idee La concezione dell'anima Filosofia, amore, bellezza Il pensiero politico L'ultimo Platone Apologia Lettere Dialoghi PLATONE (428/27-348/47) Filosofia come
Argomenti Vita ed opere La dottrina delle idee La concezione dell'anima Filosofia, amore, bellezza Il pensiero politico L'ultimo Platone Apologia Lettere Dialoghi PLATONE (428/27-348/47) Filosofia come
1. La famiglia ha come matrice la Trinità
 1. La famiglia ha come matrice la Trinità Quando Dio ha creato l uomo l ha creato in coppia (Gn 1, 26-27). Dio, creando la coppia, ha versato dentro se stesso. Dio in essa ha espresso l intimo di sé, l
1. La famiglia ha come matrice la Trinità Quando Dio ha creato l uomo l ha creato in coppia (Gn 1, 26-27). Dio, creando la coppia, ha versato dentro se stesso. Dio in essa ha espresso l intimo di sé, l
Lu c i a n o Ma n i c a r d i è nato a Campagnola Emilia (RE) il 26 novembre Laureato in Lettere indirizzo Classico presso l Università degli
 Terebinto 10 Il Terebinto è una pianta diffusa nella macchia mediterranea. Nella Bibbia è indicata come l albero alla cui ombra venne a sedersi l angelo del Signore (Gdc 6,11); la divina Sapienza è descritta
Terebinto 10 Il Terebinto è una pianta diffusa nella macchia mediterranea. Nella Bibbia è indicata come l albero alla cui ombra venne a sedersi l angelo del Signore (Gdc 6,11); la divina Sapienza è descritta
OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI
 OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI Nel Vangelo di Matteo Gesù agli inizi della sua attività pubblica vuole far conoscere a coloro che lo ascoltano che cosa vuole donare all umanità. Quello che abbiamo
OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI Nel Vangelo di Matteo Gesù agli inizi della sua attività pubblica vuole far conoscere a coloro che lo ascoltano che cosa vuole donare all umanità. Quello che abbiamo
Pater, Ave, 3 Gloria
 che hai riversato e che riversi ancora senza sosta sul mondo. Tu che sei l Autore di tutti i doni soprannaturali e che hai riempito d immenso piacere l anima della Beata Madre di Dio e di tue le consolazioni,
che hai riversato e che riversi ancora senza sosta sul mondo. Tu che sei l Autore di tutti i doni soprannaturali e che hai riempito d immenso piacere l anima della Beata Madre di Dio e di tue le consolazioni,
LICEO SCIENTIFICO STATALE TITO LUCREZIO CARO Cittadella PD. PROGRAMMA DI FILOSOFIA I liceo classico a.s
 LICEO SCIENTIFICO STATALE TITO LUCREZIO CARO Cittadella PD PROGRAMMA DI FILOSOFIA I liceo classico a.s. 2010-1011 Docente: Massimo Gomiero Testo in adozione: Itinerari di filosofia, Dalle origini alla
LICEO SCIENTIFICO STATALE TITO LUCREZIO CARO Cittadella PD PROGRAMMA DI FILOSOFIA I liceo classico a.s. 2010-1011 Docente: Massimo Gomiero Testo in adozione: Itinerari di filosofia, Dalle origini alla
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA
 LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
importanti della Settimana Santa e scoprire la risurrezione come vita nuova. -Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali.
 CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
Ad ognuno va il nostro GRAZIE più profondo... nostra opera. bene e in questi anni si sono presi a cuore la
 BAMBINI... sorrisi, storie, vite... è dedicato a chi ama i BAMBINI, a tutti gli amici e i benefattori che ci vogliono bene e in questi anni si sono presi a cuore la nostra opera. Ad ognuno va il nostro
BAMBINI... sorrisi, storie, vite... è dedicato a chi ama i BAMBINI, a tutti gli amici e i benefattori che ci vogliono bene e in questi anni si sono presi a cuore la nostra opera. Ad ognuno va il nostro
A cura di Chiesacattolica.it e LaChiesa.it. PRIMA LETTURA Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
 NATALE DEL SIGNORE Alla Messa del giorno PRIMA LETTURA Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Dal libro del profeta Isaìa 52, 7-10 Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
NATALE DEL SIGNORE Alla Messa del giorno PRIMA LETTURA Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Dal libro del profeta Isaìa 52, 7-10 Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
Io sono con voi anno catechistico
 Io sono con voi 7a unità Pag. 9-10 * Ti chiamo per nome Pag. 111-112 * Dio Padre ci chiama ad essere suoi figli Pag. 11-12 * Il Signore Dio è Padre di tutti Pag. 113-114 * Ci accoglie una grande famiglia:
Io sono con voi 7a unità Pag. 9-10 * Ti chiamo per nome Pag. 111-112 * Dio Padre ci chiama ad essere suoi figli Pag. 11-12 * Il Signore Dio è Padre di tutti Pag. 113-114 * Ci accoglie una grande famiglia:
Avanzati Federico. Casula Daniele. Lazzarelli Alessandro. Pinzi Davide
 Avanzati Federico Casula Daniele Lazzarelli Alessandro Pinzi Davide DISCORSO DI SOCRATE Il discorso di Socrate segna una netta cesura nello svolgimento del dialogo, sottolineata dallo stesso filosofo
Avanzati Federico Casula Daniele Lazzarelli Alessandro Pinzi Davide DISCORSO DI SOCRATE Il discorso di Socrate segna una netta cesura nello svolgimento del dialogo, sottolineata dallo stesso filosofo
I.I.S. Liceo Cicerone-Pollione LICEO CLASSICO VITRUVIO POLLIONE - FORMIA - Programma di Greco
 I.I.S. Liceo Cicerone-Pollione LICEO CLASSICO VITRUVIO POLLIONE - FORMIA - Programma di Greco Classe II D (4 DL) a.s. 2014-2015 Docente: Prof.ssa Paola Pacifico MODULO LINGUISTICO LA STRUTTURA DELLA LINGUA
I.I.S. Liceo Cicerone-Pollione LICEO CLASSICO VITRUVIO POLLIONE - FORMIA - Programma di Greco Classe II D (4 DL) a.s. 2014-2015 Docente: Prof.ssa Paola Pacifico MODULO LINGUISTICO LA STRUTTURA DELLA LINGUA
BREVI RIFLESSIONI SULLA PASSIONE DI GESU' SECONDO L'EVANGELISTA LUCA
 BREVI RIFLESSIONI SULLA PASSIONE DI GESU' SECONDO L'EVANGELISTA LUCA INTRODUZIONE Nei Vangeli Sinottici la passione viene predetta tre volte da Gesù, egli non si limita solo ad annunciarla ma ne indica
BREVI RIFLESSIONI SULLA PASSIONE DI GESU' SECONDO L'EVANGELISTA LUCA INTRODUZIONE Nei Vangeli Sinottici la passione viene predetta tre volte da Gesù, egli non si limita solo ad annunciarla ma ne indica
Un aiuto adeguato. LA MORALE
 UNITÀ 5: Il sovratelo. Un aiuto adeguato. LA MORALE 1ºESO 2 anno Scuola Superiore Per cercare la verità devo essere critico. Il mondo non mi offre la felicità. La verità è scritta nel mio cuore. La morale
UNITÀ 5: Il sovratelo. Un aiuto adeguato. LA MORALE 1ºESO 2 anno Scuola Superiore Per cercare la verità devo essere critico. Il mondo non mi offre la felicità. La verità è scritta nel mio cuore. La morale
scienza. Quando si parla di scienza, il pensiero va immediatamente alla
 PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro - Mercoledì, 21 maggio 2014 I doni dello Spirito Santo: 5. La Scienza Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei mettere in luce un altro dono dello
PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro - Mercoledì, 21 maggio 2014 I doni dello Spirito Santo: 5. La Scienza Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei mettere in luce un altro dono dello
Storia CONDIVIDERE UNA GRANDE PASSIONE PER LA NATURA,PER LA BELLEZZA, PER I GIOIELLI
 SINCE 1929 Storia CONDIVIDERE UNA GRANDE PASSIONE PER LA NATURA,PER LA BELLEZZA, PER I GIOIELLI 1929 Carlo Barberis, (1909-1994), dotato di un innata raffinatezza di gusti e di un naturale senso delle proporzioni,
SINCE 1929 Storia CONDIVIDERE UNA GRANDE PASSIONE PER LA NATURA,PER LA BELLEZZA, PER I GIOIELLI 1929 Carlo Barberis, (1909-1994), dotato di un innata raffinatezza di gusti e di un naturale senso delle proporzioni,
L'algebra Booleana. Generalità. Definizioni
 L'algebra Booleana Generalità L algebra booleana è stata sviluppata da George Boole nel 1854, ed è diventata famosa intorno al 1938 poiché permette l analisi delle reti di commutazione, i cui soli stati
L'algebra Booleana Generalità L algebra booleana è stata sviluppata da George Boole nel 1854, ed è diventata famosa intorno al 1938 poiché permette l analisi delle reti di commutazione, i cui soli stati
LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO
 LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO Argomenti Una definizione di FILOSOFIA Dal mito al logos Le peculiarità della società greca UNA DEFINIZIONE FILOSOFIA: RICERCA RAZIONALE SUI FONDAMENTI DELL ESSERE, DEL
LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO Argomenti Una definizione di FILOSOFIA Dal mito al logos Le peculiarità della società greca UNA DEFINIZIONE FILOSOFIA: RICERCA RAZIONALE SUI FONDAMENTI DELL ESSERE, DEL
PARTE SECONDA CAPITOLO 1 ZORBA RIMANE ACCANTO ALL UOVO PER MOLTI GIORNI CON IL CALORE DEL SUO CORPO. E DOPO VENTI GIORNI VEDE USCIRE DAL
 CAPITOLO 1 ZORBA RIMANE ACCANTO ALL UOVO PER MOLTI GIORNI COVANDOLO CON IL CALORE DEL SUO CORPO. E DOPO VENTI GIORNI VEDE USCIRE DAL GUSCIO UN BECCO GIALLO. IL PULCINO ESCE DAL GUSCIO E QUANDO VEDE ZORBA
CAPITOLO 1 ZORBA RIMANE ACCANTO ALL UOVO PER MOLTI GIORNI COVANDOLO CON IL CALORE DEL SUO CORPO. E DOPO VENTI GIORNI VEDE USCIRE DAL GUSCIO UN BECCO GIALLO. IL PULCINO ESCE DAL GUSCIO E QUANDO VEDE ZORBA
«Ode al pane» di Pablo Neruda
 «Ode al pane» di Pablo Neruda Silvia Filippini classe 2 E a.s. 2014/2015 Pablo Neruda Pablo Neruda, nome d arte di Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, nato il 12 Luglio del 1904. È stato un poeta,
«Ode al pane» di Pablo Neruda Silvia Filippini classe 2 E a.s. 2014/2015 Pablo Neruda Pablo Neruda, nome d arte di Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, nato il 12 Luglio del 1904. È stato un poeta,
Dagli OSA agli OBIETTIVI FORMATIVI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE I
 CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
Il signor Rigoni DAL MEDICO
 5 DAL MEDICO Per i giornali, Aristide Rigoni è l uomo più strano degli ultimi cinquant anni, dal giorno della sua nascita. È un uomo alto, forte, con due gambe lunghe e con una grossa bocca. Un uomo strano,
5 DAL MEDICO Per i giornali, Aristide Rigoni è l uomo più strano degli ultimi cinquant anni, dal giorno della sua nascita. È un uomo alto, forte, con due gambe lunghe e con una grossa bocca. Un uomo strano,
RICEVI LO SPIRITO SANTO
 RICEVI LO SPIRITO SANTO SONO DIVENTATO GRANDE... DECIDO DI ESSERE AMICO DI GESÚ FOTO PER DECIDERE DEVO CONOSCERE CONOSCO LA STORIA DI GESÚ: GESÚ E NATO E DIVENTATO GRANDE ED AIUTAVA IL PAPA GIUSEPPE E
RICEVI LO SPIRITO SANTO SONO DIVENTATO GRANDE... DECIDO DI ESSERE AMICO DI GESÚ FOTO PER DECIDERE DEVO CONOSCERE CONOSCO LA STORIA DI GESÚ: GESÚ E NATO E DIVENTATO GRANDE ED AIUTAVA IL PAPA GIUSEPPE E
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli
 FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
Messaggio di Gesù 2 Gennaio 2005
 2 Gennaio 2005 Figli, pace a voi. Il dolore che ha colpito molti figli, perché si vive spesso come Sodoma e Gomorra. Riflettete e apprezzate di più la vita, dono di Amore del Padre. Seppiatela gestire
2 Gennaio 2005 Figli, pace a voi. Il dolore che ha colpito molti figli, perché si vive spesso come Sodoma e Gomorra. Riflettete e apprezzate di più la vita, dono di Amore del Padre. Seppiatela gestire
Le poesie del divino amore
 Le poesie del divino amore Fernando Isacco Benato LE POESIE DEL DIVINO AMORE Poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2016 Fernando Isacco Benato Tutti i diritti riservati L amore di due angeli Ho visto
Le poesie del divino amore Fernando Isacco Benato LE POESIE DEL DIVINO AMORE Poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2016 Fernando Isacco Benato Tutti i diritti riservati L amore di due angeli Ho visto
HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A
 HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,
HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,
Un solo sogno diventare mamma
 Un solo sogno diventare mamma Venera Carratello UN SOLO SOGNO DIVENTARE MAMMA racconto Ai miei Angeli che con la loro presenza, le loro monellerie e i loro baci mi aiutano ad andare avanti in questa
Un solo sogno diventare mamma Venera Carratello UN SOLO SOGNO DIVENTARE MAMMA racconto Ai miei Angeli che con la loro presenza, le loro monellerie e i loro baci mi aiutano ad andare avanti in questa
I SOFISTI E SOCRATE LA PEDAGOGIA NELLA GRECIA CLASSICA CLEMENTE DANIELI «LA MENTE E L ALBERO»
 I SOFISTI E SOCRATE LA PEDAGOGIA NELLA GRECIA CLASSICA CLEMENTE DANIELI «LA MENTE E L ALBERO» LA STORIA IN BREVE 499-479 GUERRE PERSIANE CON LA VITTORIA DELLA GRECIA E IL PERIODO DI MASSIMO SPLENDORE DI
I SOFISTI E SOCRATE LA PEDAGOGIA NELLA GRECIA CLASSICA CLEMENTE DANIELI «LA MENTE E L ALBERO» LA STORIA IN BREVE 499-479 GUERRE PERSIANE CON LA VITTORIA DELLA GRECIA E IL PERIODO DI MASSIMO SPLENDORE DI
LEGGETE ( per favore!!! ) E FATELO FINO IN FONDO, PER ME' E' UN INNO ALLA VITA E ALL'AMORE OLTRE CHE ALLA PACE!!!
 LEGGETE ( per favore!!! ) E FATELO FINO IN FONDO, PER ME' E' UN INNO ALLA VITA E ALL'AMORE OLTRE CHE ALLA PACE!!! Questo scritto, lo ha fatto una ragazza di 21 anni, i più e magari soprattutto quelli della
LEGGETE ( per favore!!! ) E FATELO FINO IN FONDO, PER ME' E' UN INNO ALLA VITA E ALL'AMORE OLTRE CHE ALLA PACE!!! Questo scritto, lo ha fatto una ragazza di 21 anni, i più e magari soprattutto quelli della
Il monte Olimpo: la dimora degli dei
 Il monte Olimpo: la dimora degli dei La religione professata dai Greci era basata, come quella cretese da cui derivava, sulla personificazione delle forze della natura. Tali forze erano dominate dalle
Il monte Olimpo: la dimora degli dei La religione professata dai Greci era basata, come quella cretese da cui derivava, sulla personificazione delle forze della natura. Tali forze erano dominate dalle
il commento al vangelo
 il commento al vangelo SE IL CHICCO DI GRANO CADUTO IN TERRA MUORE, PRODUCE MOLTO FRUTTO commento al Vangelo della quinta domenica di quaresima (22 marzo 2015) di p. Alberto Maggi: Gv 12,20-33 In quel
il commento al vangelo SE IL CHICCO DI GRANO CADUTO IN TERRA MUORE, PRODUCE MOLTO FRUTTO commento al Vangelo della quinta domenica di quaresima (22 marzo 2015) di p. Alberto Maggi: Gv 12,20-33 In quel
Umberto Saba
 Umberto Saba 1883-1957 Vita e opere scelta dello pseudonimo Saba origine triestina matrimonio e lavoro rapporto conflittuale con la famiglia (abbandonato dal padre) memoria della balia (di cognome Sabaz)
Umberto Saba 1883-1957 Vita e opere scelta dello pseudonimo Saba origine triestina matrimonio e lavoro rapporto conflittuale con la famiglia (abbandonato dal padre) memoria della balia (di cognome Sabaz)
De la Tour Il neonato
 De la Tour Il neonato Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo
De la Tour Il neonato Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo
3. Una serata speciale 26
 3. Una serata speciale 26 1 Guarda i nomi scritti nella tabella Guarda i nomi scritti nella tabella: tutti hanno davanti (sono preceduti da) l articolo indeterminativo. L articolo indeterminativo maschile
3. Una serata speciale 26 1 Guarda i nomi scritti nella tabella Guarda i nomi scritti nella tabella: tutti hanno davanti (sono preceduti da) l articolo indeterminativo. L articolo indeterminativo maschile
BENVENUTO IO HO UNA GIOIA NEL CUORE
 Marina di Carrara, 12 ottobre 2014 BENVENUTO Benvenuto benvenuto, benvenuto a te! (x2) Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che... l'amore ci unisce nel Signore. (x2) IO HO UNA GIOIA NEL CUORE Io ho una gioia
Marina di Carrara, 12 ottobre 2014 BENVENUTO Benvenuto benvenuto, benvenuto a te! (x2) Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che... l'amore ci unisce nel Signore. (x2) IO HO UNA GIOIA NEL CUORE Io ho una gioia
Filosofia l origine. A cura di Pietro Gavagnin Pubblicato con Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.
 Filosofia l origine A cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Pubblicato con Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License. Uso Comune del termine Non fare il filosofo! Finché facciamo
Filosofia l origine A cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Pubblicato con Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License. Uso Comune del termine Non fare il filosofo! Finché facciamo
Guido Alliney Trento, 4 dicembre Libera volontà. Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto
 Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Io penso, dunque siamo
 Io penso, dunque siamo Verbania, 29 maggio 2010 La filosofia con i bambini nel Quarto Circolo di Verbania a cura di Chiara Colombo Tre elementi caratterizzanti Il forte legame tra educazione, filosofia
Io penso, dunque siamo Verbania, 29 maggio 2010 La filosofia con i bambini nel Quarto Circolo di Verbania a cura di Chiara Colombo Tre elementi caratterizzanti Il forte legame tra educazione, filosofia
Omelia Messa Capodanno 2016
 Omelia Messa Capodanno 2016 1. Buon Anno! Carissimi figli, celebriamo un mistero grande: Dio ha scelto di assumere un corpo, di entrare nella storia umana, prendendo la nostra carne. Si è fatto piccolo
Omelia Messa Capodanno 2016 1. Buon Anno! Carissimi figli, celebriamo un mistero grande: Dio ha scelto di assumere un corpo, di entrare nella storia umana, prendendo la nostra carne. Si è fatto piccolo
della porta accanto OSVALDO
 Il GENIO della porta accanto OSVALDO Voglio ringraziare Osvaldo, amico e per anni compagno di viaggio nella formazione in seminario e ora uomo d affari per una multinazionale tedesca che ha voluto donarmi
Il GENIO della porta accanto OSVALDO Voglio ringraziare Osvaldo, amico e per anni compagno di viaggio nella formazione in seminario e ora uomo d affari per una multinazionale tedesca che ha voluto donarmi
I Comandamenti sono la legge della vita che il Signore diede a Mosè sul monte Sinai. Essi sono il segno dell amicizia di Dio con tutti gli uomini.
 I Comandamenti sono la legge della vita che il Signore diede a Mosè sul monte Sinai. Essi sono il segno dell amicizia di Dio con tutti gli uomini. I Comandamenti sono dieci: 1. Io sono il Signore tuo Dio,
I Comandamenti sono la legge della vita che il Signore diede a Mosè sul monte Sinai. Essi sono il segno dell amicizia di Dio con tutti gli uomini. I Comandamenti sono dieci: 1. Io sono il Signore tuo Dio,
Presentazione realizzata dalla docente Rosaria Squillaci
 Presentazione realizzata dalla docente Rosaria Squillaci Presentazione dei canti a cura dei bambini di classe prima. Canti per coro e solisti eseguiti dagli alunni di seconda,
Presentazione realizzata dalla docente Rosaria Squillaci Presentazione dei canti a cura dei bambini di classe prima. Canti per coro e solisti eseguiti dagli alunni di seconda,
Liberamente tratto da: Luigi Giussani, Il senso religioso! !!!
 !!! Liberamente tratto da: Luigi Giussani, Il senso religioso! Le immagini sono riproduzioni di quadri di Paul Cezanne,! che riprodusse numerose volte la montagna Saint Victoire! e di Claude Monet, que
!!! Liberamente tratto da: Luigi Giussani, Il senso religioso! Le immagini sono riproduzioni di quadri di Paul Cezanne,! che riprodusse numerose volte la montagna Saint Victoire! e di Claude Monet, que
Vattene bella, vattene a dormire Niccolò Tommaseo. DIDATTIZZAZIONE: Fabio Caon e Michela Andreani
 Vattene bella, vattene a dormire Niccolò Tommaseo DIDATTIZZAZIONE: Fabio Caon e Michela Andreani Vattene bella, vattene a dormire: il letto ti sia fatto di viole: al capezzale ti possa venire dodici stelle,
Vattene bella, vattene a dormire Niccolò Tommaseo DIDATTIZZAZIONE: Fabio Caon e Michela Andreani Vattene bella, vattene a dormire: il letto ti sia fatto di viole: al capezzale ti possa venire dodici stelle,
IL TUO ANGELO CUSTODE: UN COMPAGNO PER LA VITA
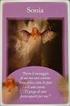 1 URIEL IL TUO ANGELO CUSTODE: UN COMPAGNO PER LA VITA Edizioni 2 DEDICO QUESTO LIBRO A MIA MADRE AGLI EDITORI CHE HANNO CREDUTO IN QUESTA MIA PICCOLA OPERA A MIA CUGINA CHE MI HA ISPIRATO A TUTTE LE GERARCHIE
1 URIEL IL TUO ANGELO CUSTODE: UN COMPAGNO PER LA VITA Edizioni 2 DEDICO QUESTO LIBRO A MIA MADRE AGLI EDITORI CHE HANNO CREDUTO IN QUESTA MIA PICCOLA OPERA A MIA CUGINA CHE MI HA ISPIRATO A TUTTE LE GERARCHIE
Indice. Prefazione... pag. XI. pag. 1. Prima parte Concreti aiuti alla vita...
 Indice Prefazione... Prima parte Concreti aiuti alla vita... pag. XI pag. 1 Gennaio Uomo e donna, visione d insieme Destra e sinistra, le altre dimensioni... Il mio corpo... L abbraccio... Esercizio L
Indice Prefazione... Prima parte Concreti aiuti alla vita... pag. XI pag. 1 Gennaio Uomo e donna, visione d insieme Destra e sinistra, le altre dimensioni... Il mio corpo... L abbraccio... Esercizio L
Kierkegaard l esistenza come possibilità e fede
 l esistenza come possibilità e fede Antitesi all idealismo: Singolo contro lo spirito universale Esistenza concreta contro ragione astratta Libertà come possibilità contro libertà come necessità Alternative
l esistenza come possibilità e fede Antitesi all idealismo: Singolo contro lo spirito universale Esistenza concreta contro ragione astratta Libertà come possibilità contro libertà come necessità Alternative
Lezioni XII-XIII. Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele
 Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Io non temo il tema!!!!
 Io non temo il tema!!!! 1. sviluppo i contenuti principali Penso a tutte le cose possibili che potrei dire: le appunto sulla brutta così come mi vengono in mente, senza preoccuparmi di come scriverle inizio
Io non temo il tema!!!! 1. sviluppo i contenuti principali Penso a tutte le cose possibili che potrei dire: le appunto sulla brutta così come mi vengono in mente, senza preoccuparmi di come scriverle inizio
Sussidio realizzato dall Azione Cattolica Ragazzi
 6-8 anni Sussidio realizzato dall Azione Cattolica Ragazzi Diocesi di Ferrara-Comacchio Hanno collaborato: Anna Cazzola, Giuseppina Di Martino, Raffaella Ferrari, Daniela Frondiani, Chiara Sgarbanti, don
6-8 anni Sussidio realizzato dall Azione Cattolica Ragazzi Diocesi di Ferrara-Comacchio Hanno collaborato: Anna Cazzola, Giuseppina Di Martino, Raffaella Ferrari, Daniela Frondiani, Chiara Sgarbanti, don
Per te L incontro che ha cambiato la mia vita
 Per te L incontro che ha cambiato la mia vita Lucia Pasculli PER TE L INCONTRO CHE HA CAMBIATO LA MIA VITA Testimonianza www.booksprintedizioni.it Copyright 2014 Lucia Pasculli Tutti i diritti riservati
Per te L incontro che ha cambiato la mia vita Lucia Pasculli PER TE L INCONTRO CHE HA CAMBIATO LA MIA VITA Testimonianza www.booksprintedizioni.it Copyright 2014 Lucia Pasculli Tutti i diritti riservati
Pensieri folli di un maestro yoga
 Pensieri folli di un maestro yoga Immagini realizzate dall autore. S. Hamsa Jacob Massimiliano Cadenazzi PENSIERI FOLLI DI UN MAESTRO YOGA Filosofia www.booksprintedizioni.it Copyright 2016 S. Hamsa Jacob
Pensieri folli di un maestro yoga Immagini realizzate dall autore. S. Hamsa Jacob Massimiliano Cadenazzi PENSIERI FOLLI DI UN MAESTRO YOGA Filosofia www.booksprintedizioni.it Copyright 2016 S. Hamsa Jacob
Quale Russell? APPROFONDIMENTO DI FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO. a cura del prof. Flaviano Scorticati
 Quale Russell? APPROFONDIMENTO DI FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO a cura del prof. Flaviano Scorticati Un piccolo gioco per riscaldare l atmosfera CHE COSA HANNO IN COMUNE QUESTE IMMAGINI? BABBO NATALE IL QUADRATO
Quale Russell? APPROFONDIMENTO DI FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO a cura del prof. Flaviano Scorticati Un piccolo gioco per riscaldare l atmosfera CHE COSA HANNO IN COMUNE QUESTE IMMAGINI? BABBO NATALE IL QUADRATO
Io e. mio padre. La cultura patriarcale
 Io e. mio padre La cacciata della Dea Madre lascia il posto al potere degli Dei, che controllano la vita e la morte con la guerra, il denaro, la paura La cultura patriarcale 1 Dio Padre Padri della Chiesa
Io e. mio padre La cacciata della Dea Madre lascia il posto al potere degli Dei, che controllano la vita e la morte con la guerra, il denaro, la paura La cultura patriarcale 1 Dio Padre Padri della Chiesa
IN ATTESA DEL S.NATALE ORATORIO SAN LUIGI ALBAIRATE
 IN ATTESA DEL S.NATALE ORATORIO SAN LUIGI ALBAIRATE Martedì 17 Dicembre C - T - T - Nel nome del Padre Amen! Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei
IN ATTESA DEL S.NATALE ORATORIO SAN LUIGI ALBAIRATE Martedì 17 Dicembre C - T - T - Nel nome del Padre Amen! Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei
PERMESSO, SCUSA, GRAZIE
 PERMESSO, SCUSA, GRAZIE Misericordia e famiglia dall incontro con Franco Miano e Pina De Simone Imola, 11 marzo 2016 suggerimenti per riflessioni personali e di gruppo PROBLEMA = OPPORTUNITÀ Nei luoghi
PERMESSO, SCUSA, GRAZIE Misericordia e famiglia dall incontro con Franco Miano e Pina De Simone Imola, 11 marzo 2016 suggerimenti per riflessioni personali e di gruppo PROBLEMA = OPPORTUNITÀ Nei luoghi
L imprevedibile senso della vita
 L imprevedibile senso della vita Ogni riferimento a fatti realmente accaduti o luoghi e/o a persone realmente esistenti è da ritenersi puramente casuale. Sabrina Brambilla L IMPREVEDIBILE SENSO DELLA VITA
L imprevedibile senso della vita Ogni riferimento a fatti realmente accaduti o luoghi e/o a persone realmente esistenti è da ritenersi puramente casuale. Sabrina Brambilla L IMPREVEDIBILE SENSO DELLA VITA
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA. del.
 CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA del culto battesimale Benedizione finale e AMEN cantato Attività della chiesa a martedì alterni
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA del culto battesimale Benedizione finale e AMEN cantato Attività della chiesa a martedì alterni
Era la storia del suo sogno.
 Eravamo in un prato pieno di fiori colorati con farfalle che andavano a prendere il polline. Si sentiva un profumo buonissimo. Veniva dai petali rossi, gialli, rosa e bianchi. Era giorno; il cielo era
Eravamo in un prato pieno di fiori colorati con farfalle che andavano a prendere il polline. Si sentiva un profumo buonissimo. Veniva dai petali rossi, gialli, rosa e bianchi. Era giorno; il cielo era
I 10 Comandamenti sono le Leggi che Dio diede a Mosè sul Monte Sinai.
 I 10 COMANDAMENTI I 10 Comandamenti sono le Leggi che Dio diede a Mosè sul Monte Sinai. Vediamo quali sono i veri 10 Comandamenti che troviamo scritti sulla Bibbia in Esodo 20:1-17: 1. Io Sono il Signore,
I 10 COMANDAMENTI I 10 Comandamenti sono le Leggi che Dio diede a Mosè sul Monte Sinai. Vediamo quali sono i veri 10 Comandamenti che troviamo scritti sulla Bibbia in Esodo 20:1-17: 1. Io Sono il Signore,
LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA
 JEAN DANIÉLOU LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA Postfazione all edizione italiana di Piero Coda terza edizione Queriniana Premessa alla seconda edizione L accoglienza riservata a questo libriccino
JEAN DANIÉLOU LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA Postfazione all edizione italiana di Piero Coda terza edizione Queriniana Premessa alla seconda edizione L accoglienza riservata a questo libriccino
E.G.W. (Historia de la Redención, cap. 3, p 26)
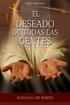 LEZIONE 2 DELLA SCUOLA DEL SABATO CRISI COSMICA: LA FRANTUMAZIONE DELL ORDINE PER SABATO 11 OTTOBRE 2008 Fu un essere creato Era il sigillo della perfezione Pieno di saggezza Pieno di bellezza Vestito
LEZIONE 2 DELLA SCUOLA DEL SABATO CRISI COSMICA: LA FRANTUMAZIONE DELL ORDINE PER SABATO 11 OTTOBRE 2008 Fu un essere creato Era il sigillo della perfezione Pieno di saggezza Pieno di bellezza Vestito
Ognuno nella propria vita ha dei sogni da voler realizzare, ed anche i poveri non fanno eccezione.
 Sostegno a distanza Ognuno nella propria vita ha dei sogni da voler realizzare, ed anche i poveri non fanno eccezione. Ma, se i sogni dei benestanti, di chi non ha problemi, insomma, di chi sta bene, sono,
Sostegno a distanza Ognuno nella propria vita ha dei sogni da voler realizzare, ed anche i poveri non fanno eccezione. Ma, se i sogni dei benestanti, di chi non ha problemi, insomma, di chi sta bene, sono,
Giornalino della II E: Intervista a Niccolò Ammaniti
 NICCOLO' AMMANITI Scuola Secondaria di I gr. E. Panzacchi Ozzano dell' Emilia Giornalino della II E: Intervista a Niccolò Ammaniti Notizie su Niccolò Ammaniti Niccolò Ammaniti è nato a Roma il 25 settembre
NICCOLO' AMMANITI Scuola Secondaria di I gr. E. Panzacchi Ozzano dell' Emilia Giornalino della II E: Intervista a Niccolò Ammaniti Notizie su Niccolò Ammaniti Niccolò Ammaniti è nato a Roma il 25 settembre
Nikolaj Konstantinovic Roerich
 Nikolaj Konstantinovic Roerich Costumista Scrittore Disegnatore Antropologo Archeologo Giurista Pittore Umanista Filosofo Esploratore La vita Roerich nasce a San Pietroburgo nel 1874. Trascorre lunghi
Nikolaj Konstantinovic Roerich Costumista Scrittore Disegnatore Antropologo Archeologo Giurista Pittore Umanista Filosofo Esploratore La vita Roerich nasce a San Pietroburgo nel 1874. Trascorre lunghi
Donato Panza UNA POESIA PER TE
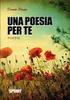 Una poesia per te Donato Panza UNA POESIA PER TE poesie Dedico questo libro alle persone a me più care, alla mia mamma, al mio papà, alla mia amata sorella Maria, e al mio secondo papà Donato. A tutti
Una poesia per te Donato Panza UNA POESIA PER TE poesie Dedico questo libro alle persone a me più care, alla mia mamma, al mio papà, alla mia amata sorella Maria, e al mio secondo papà Donato. A tutti
