Sviluppi nel 1700 e 1800
|
|
|
- Damiano Valle
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sviluppi nel 1700 e
2 Pierre S. Laplace Laplace, Lagrange, Poisson e molti altri (polytechnicien) con l ausilio dell analisi matematica sviluppata da Leibntz, Eulero ed i Bernouilli, tra la fine 700 ed inizio 800, hanno sviluppato la meccanica in forma rigorosamente matematica, ciò ha permesso lo sviluppo dell ingegneria meccanica e l industrializzazione e dell astronomia. Joseph l. Lagrange 18 Jean B. J. Fourier (successore di Laplace alla cattedra al Ecole Polytechnique di Parigi) Dimostra che è sufficiente definire tre grandezze tali quali: Massa (kg) - Lunghezza (m) - Tempo (s) per definire tutte le altre grandezze della meccanica. Inizia da ciò il calcolo dimensionale che si dimostra molto produttivo. Per gli altri fenomeni tipo il calore o l elettromagnetismo bisogna aggiungere altre grandezze.
3 Jean Bernard Leon Focault Focault, attorno al 1850 fece il famoso esperimento del pendolo al Pantheon di Parigi, dimostrando in modo evidente a tutti ed indiscutibilmente la rotazione della Terra, il sogno di Galileo. 3
4 L Energia e il Teorema delle Forze Vive Osservando il moto del pendolo si può notare che quando si trova nelle posizioni A di massimo spostamento la sua velocità è nulla mentre la potenzialità di cadere è massima, data l altezza della massa. Quando è nella posizione centrale C, la sua velocità è massima e la potenzialità di cadere è nulla dato che la massa si trova nel punto più basso. In tutte A A le altre posizioni la velocità della massa e la potenzialità di caduta assumono valori intermedi. Leibnitz fu il primo a mettere in evidenza C che l energia cinetica e quella potenziale si trasformavano l una nell altra con continuità e che la loro somma si conservava. Fu la prima formulazione di un principio della conservazione dell energia meccanica: il teorema delle forze vive. Questo teorema fu formulato in vari modi uno dei più importanti lo si deve a Hamilton, che ha messo il teorema delle forze vive un forma di una equazione differenziale che è chiamala Hamiltoniana, che è una delle importanti basi della meccanica quantistica,. 4
5 t A LANGRANGIANA e principio di minima azione x B Per andare dal punto A al punto B è piuttosto semplice basta applicare la formula di Newton f= m.a. Ma se il sistema è complesso o ci sono molti tipi di forze che agiscono può essere molto difficile trovare il giusto percorso, in linea piena, rispetto a quelli infiniti e non corretti in linee tratteggiate Lagrange propose di utilizzare il principio di minima azione, che Fermat aveva usato per dedurre le leggi di Snell della rifrazione, applicato a una funzione chiamata Langrangiana L(q.p) che è la differenza tra l energia cinetica e quella potenziale L = E c - E p Che integrata sul tempo da il cammino d azione Cammino d azione = Ldt Con questo metodo, Lagrange dedusse tutte le leggi della dinamica di Newton, comprese le traiettorie ellittiche planetarie. Questo formalismo ora è alla base della moderna teoria dei campi (Feynman). 5
6 Il movimento nella Fisica Moderna: (relatività ristretta e generale) 6
7 -1864 J.C. Maxwell pubblica: A Dinamical Theory of the Electromagnetic Field, dove mette in forma matematica le idee di Faraday sulle linee ed i campi di forza. Teorema di Ampere + correnti di spostamento di Maxwell Maxwell con queste equazioni non sviluppò solo le idee di Faraday. ma per la prima volta mostrò che un fenomeno fisico complesso come l elettromagnetismo poteva essere matematicizzato in modo semplice ma completo. Infatti con le 4 equazioni differenziali proposte si possono risolvere tutti i problemi di elettromagnetismo dando le condizioni al contorno e risolvendo matematicamente le equazioni. Queste equazioni che sembravano rappresentare la fine della fisica rappresentano l inizio della Fisica Moderna dive divb rotb rote div j B t j t Teorema di Gauss Leggi di Laplace E t Legge Induzione di Faraday Equazione di continuità 7
8 La relatività ristretta Galileo GALILEI enuncia che: Le leggi che governano la meccanica non variano per soggetti in quiete o in movimento rettilineo ed uniforme. Alla fine dell XIX sec si constata, che le stupende leggi dell elettromagnetismo, appena scoperte, variano per soggetti in quiete oppure in movimento rettilineo e uniforme. +q +Q +q v 0 FORZE SOLO ELETTRICHE FORZE ANCHE MAGNETICHE 8
9 Misure di velocità t 1 v 1 d t 1 t v d t d Le posizioni relative si calcolano con queste formule: d d 0 vt v v v 1 Trasformate di Galileo Le velocità si sommano 9
10 Le onde meccaniche tipo quelle acustiche si trasmettono attraverso i materiali. Le velocità di tali onde si sommano alla velocità della sorgente, come fanno i corpi. Ci si aspettava che la luce (onde elettromagnetiche) si comportasse nello stesso modo, anche se non si conosceva il mezzo (materiale) in cui si muove-vano queste onde. Questo mezzo si cercava da anni ed era chiamato ETERE Michelson e Morley Cercando l etere hanno dimostrato, con misure molto accurate, della velocità della luce al suolo, che questa vale c=99.000km/s nel vuoto, da qualunque direzione provenga. Quindi la luce ha una velocità costante che non si somma alla velocità della sorgente che la emette 30 km/sec sole terra All inizio del XX secolo la fisica si trovava di fronte a grandi inconsistenze teoriche: -La mancata invarianza delle leggi dell elettromagnetismo per osservatori diversi in moto rettilineo ed uniforme. -La difficoltà di trovare un etere materiale nel quale si possa propagare la luce. -La velocità della luce c che è indipendente da osservatori diversi in moto rettilineo uniforme. 10
11 -1905 A. Einstein risolve la questione in modo inusuale: prende atto dei fatti. L ETERE materiale non esiste. I - La velocità della luce è costante in ogni riferimento inerziale II Tutte le leggi della natura devono essere invarianti in sistemi inerziali comprese le leggi dell elettromagnetismo. Dato c= d/t è costante d e t non possono essere indipendenti. Quindi le trasformate di Galileo d d 0 vt Non sono valide per questi fenomeni!! Bisogna trovare delle trasformate per i movimenti che siano valide anche con c costante. 11
12 Se la velocità della luce deve essere la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali, ne segue che lo spazio ed il tempo devono essere relativi. t' L c
13 Se la velocità della luce deve essere la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali, ne segue che lo spazio ed il tempo devono essere relativi. t' L c Quale sarà il tempo misurato da questo orologio in moto?
14 La dilatazione dei tempi c h c h c h t d vt 1 L d h 1 t c vt ct h L d
15 La dilatazione dei tempi t t v 1 c coefficien te 1 1 v c di dilatazione Einstein dice che gli orologi in moto ritardano
16 La contrazione delle lunghezze v x 1 c x Se un corpo si muove appare più corto
17 La contrazione delle lunghezze v x 1 c x Se un corpo si muove appare più corto
18 La contrazione delle lunghezze v x 1 c x Se un corpo si muove appare più corto
19 La contrazione delle lunghezze v x 1 c x Se un corpo si muove appare più corto
20 v 0 v 0 Esiste una prova sperimentale? I muoni, particelle instabili, che si producono con i raggi cosmici nell alta atmosfera. Fermati a terra i muoni hanno una vita media di milionesimi di secondo che alla velocità c percorrono al massimo 600 m. Per arrivare a terra percorrono più di 0 Km. Ciò è spiegato dalla relatività con il fatto che tra il sistema di riferimento dei muoni e quello di noi a terra c è una contrazione delle distanze o un allungamento dei tempi. Conseguenze: critica al concetto di simultaneità Un impulso di luce è emesso nel centro di un treno. Per l uomo nel treno la luce raggiunge le pareti simultaneamentemente. Per l uomo fermo la luce raggiunge le pareti in tempi diversi, per lui non c è simultaneità. 0
21 La teoria ha delle conseguenze stupefacenti e paradossali sulla meccanica dei movimenti, da tutti ben conosciuta. Il tempo e lo spazio non sono indipendenti: Tra un osservatore in moto rispetto ad uno che consideriamo fermo: - Le distanze si accorciano. - I tempi corrono più lentamente. - Due avvenimenti distanti, che per il primo osservatore sono simultanei, per l altro non lo sono. - Le velocità non si sommano in modo lineare. SONO SEMBRATE DELLE AUTENTICHE ASSURDITÀ, ma: Tutti questi effetti che sono trascurabili a velocità a noi abituali, risultano evidenti solo per velocità superiori ad almeno 1/10 di c. Sono state trovate tutte vere, sperimentalmente. 1
22 Un volo relativistico attraverso Stonehenge
23 Un volo relativistico attraverso Stonehenge
24 La teoria della Relativita Generale Einstein cercava una nuova teoria della gravità che fosse compatibile con la relatività ristretta. Secondo la teoria della gravitazione universale di Newton, l attrazione gravitazionale fra due corpi si manifesterebbe istantaneamente, mentre in base alla relatività ristretta nessun tipo di informazione può assolutamente viaggiare ad una velocità superiore a quella della luce. La teoria di Newton non ci dice nulla sulla natura della forza di gravità: ne descrive accuratamente gli effetti, ma non l effettivo funzionamento. La relatività generale si basa sul principio di equivalenza, per il quale esiste un legame fra forza di gravità e moto accelerato. Non esiste infatti differenza fra un osservatore che non sente il campo gravitazionale ed uno che non sta accelerando: gravità e moto accelerato sono indistinguibili negli effetti. Un esempio, fornitoci dallo stesso Einstein, chiarisce il significato del principio di equivalenza. Consideriamo un uomo in ascensore sospeso dal suolo che lascia cadere il proprio accendino. Egli vede che l accendino cade sul pavimento, proprio come se fosse a terra. Conclude così che una forza, la gravità, attira verso il pavimento tutti i corpi presenti nell ascensore. Ammettiamo che l ascensore venga prelevato da una magica gru, allontanato dalla Terra e lasciato nello spazio senza che il suo ospite se ne accorga; ammettiamo anche che il moto dell ascensore venga costantemente accelerato verso l alto di 9,8 m/s. Lasciando l accendino, l osservatore lo vedrebbe di nuovo cadere sul pavimento, e potrebbe concludere che egli si trova ancora sulla Terra. Se non guarda dal finestrino, non ha nessuna possibilità di verificare che a far cadere l accendino stavolta è la forza inerziale e non la forza di gravità. La relatività generale estende le leggi della relatività ristretta, valide solo per i sistemi in moto relativo rettilineo uniforme, anche ai sistemi non inerziali. La relatività generale afferma che tutte le leggi della fisica devono avere la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento. Tutti i punti di vista si equivalgono.
25 Il famoso esperimento della caduta dei gravi, eseguito da Galileo è rimasto per secoli senza una vera spiegazione fisica. Se in un razzo in accelerazione, nello spazio senza gravità, un osservatore lascia liberi alcuni oggetti, questi rimangono fermi mentre lui accelera perché ancorato al suolo del razzo. Il pavimento raggiungerà tutti gli oggetti allo stesso tempo. L osservatore all interno del razzo vedrà cadere gli oggetti verso il pavimento, alla stessa velocità, nello stesso modo in cui Galileo vide cadere gli oggetti dalla torre. Einstein vide una forte analogia tra i due esperimenti. Vide cioè una simmetria tra il moto accelerato e la forza di gravità. - Galileo forma la legge cinematica dell indipendenza dell accelerazione di gravità dai gravi. - Newton dà una spiegazione dinamica individuando i concetti di massa inerziale e gravitazionale che sono «accidentalmente» identiche. - Einstein afferma che questa identità non è accidentale e dà un interpretazione geometrica dell accelerazione e della gravità. 5
26 L ascensore (oggi razzo ) di Einstien Einstein espone una teoria completa dell accelerazione e della gravitazione, matematicamente molto complesso, fa vedere che in un esperimento in un razzo accelerato la luce ha una traiettoria curva ma difficile da misurare perché, su 3 m, si sposta al massimo delle dimensioni di un nucleo 10-1 cm
27 Spazio e tempo su un disco rotante
28 Curvatura dello spazio-tempo Einstein si accorse che le relazioni spaziali della geometria piana non sono valide per un osservatore in moto accelerato. Ciò significa che il moto accelerato fa curvare lo spazio (ed il tempo). Secondo il principio di equivalenza, gravità e moto accelerato sono indistinguibili negli effetti: visto che il moto accelerato si accompagna alla curvatura dello spazio e del tempo, la gravità è la curvatura dello spazio e del tempo. Consideriamo una situazione tipica: la Terra in orbita attorno ad una stella come il Sole. Per Newton, la stella tiene il pianeta in orbita grazie ad un non ben identificato guinzaglio gravitazionale, che istantaneamente si propaga ed afferra il pianeta. Per Einstein, le cose sono diverse: - in assenza di materia ed energia, lo spazio è piatto; - la presenza di un oggetto massiccio come il Sole deforma la struttura dello spazio circostante -questo incurvamento produce un effetto sugli oggetti che si trovano nelle vicinanze del corpo - e il moto della Terra è determinato dal tipo di curvatura. Al contrario di Newton, Einstein è riuscito a mostrare il meccanismo con il quale la gravità si trasmette: la curvatura dello spazio. La gravità coincide cioè con la trama stessa del cosmo. Equazione di Einstein (R n tensore di curvatura di Ricci, R curvatura scalare, g n il tensore metrico, L costante cosmologica, Tn tensore stress energia, c velocità della luce. G costante di gravitazione universale)
29 Prove sperimentali relativita generale Lente gravitazionale
30 CURVATURA DELLO SPAZIO Se tre astronomi si collocano su Marte, Venere e Terra e triangolano, dato che la luce viene deviata dal Sole, troveranno che lo spazio intorno al Sole è sferico. Se ripetono l esperimento tra Giove, Saturno ed Urano troveranno che lo spazio è si sferico ma molto più debolmente dato che la gravità NGC 4388 del Sole devierà molto meno la luce che nel primo caso. Secondo la Relatività Generale di Einstein la presenza di una massa rende sferico lo spazio Le rette diventano ellissi La Forza di Gravità diventa una questione Geometrica Nei buchi neri la gravità è così forte, che lo spazio viene così fortemente curvato, che la stessa luce rimane intrappolata (orbitando) DOPO 00 ANNI, ENSTEIN MODIFICA SOSTANZIALMENTE, LA TEORIA DELLA GRAVITAZIONE DI NEWTON 30
31 Le domande della Fisica Moderna 1900 Meccanica quantistica Relatività ristretta Gravità (Leggi dell infinitamente piccolo) (Fenomeni alla velocità della luce) 000 Teoria quantistica dei campi (Modello Standard)? Perché le costanti (0) del MS hanno i valori che assumono? (Siamo nella situazione di Keplero prima di Newton?)? Relatività generale E la supersimmetria la risposta? (O stiamo riproponendo gli epicicli di Apollonio?) (0 -> 105 parametri) Nota: tutto ciò spiegherebbe in ogni caso solo il 4% del nostro universo 31
32 Dark Matter & Dark Energy 3
33 Le domande della Fisica Moderna 1900 Meccanica quantistica (Leggi dell infinitamente piccolo) Relatività ristretta (Fenomeni alla velocità della luce) Gravità Relatività Meccanica quantistica 000 Relatività Gravità Teoria quantistica dei campi (Modello Standard)? Perché le costanti (0) del MS hanno i valori che assumono? (Siamo nella situazione di Keplero prima di Newton?)? Relatività generale E la supersimmetria la risposta? (O stiamo riproponendo gli epicicli di Apollonio?) (0 -> 105 parametri) Nota: tutto ciò spiegherebbe in ogni caso solo il 4% del nostro universo ma il gioco è appena cominiciato! (meno di 400 anni fa) Grazie Galileo! 33
34 34
Il movimento nella Fisica Moderna: (relatività ristretta e generale)
 Il movimento nella Fisica Moderna: (relatività ristretta e generale) 1 La fisica alla fine del 1800 Tutti i fenomeni naturali si spiegano tramite l azione di due forze fondamentali: La forza di gravità
Il movimento nella Fisica Moderna: (relatività ristretta e generale) 1 La fisica alla fine del 1800 Tutti i fenomeni naturali si spiegano tramite l azione di due forze fondamentali: La forza di gravità
Il movimento nella Fisica Moderna: (relatività ristretta e generale)
 Il movimento nella Fisica Moderna: (relatività ristretta e generale) 1 La fisica alla fine del 1800 Tutti i fenomeni naturali si spiegano tramite l azione di due forze fondamentali: La forza di gravità
Il movimento nella Fisica Moderna: (relatività ristretta e generale) 1 La fisica alla fine del 1800 Tutti i fenomeni naturali si spiegano tramite l azione di due forze fondamentali: La forza di gravità
La fisica alla fine dell 800
 La fisica alla fine dell 800 Alla fine del 1800 tutti i fenomeni naturali si spiegano tramite l azione di due forze fondamentali: La forza di gravità interpretata da Newton (1686) L elettromagnetismo espresso
La fisica alla fine dell 800 Alla fine del 1800 tutti i fenomeni naturali si spiegano tramite l azione di due forze fondamentali: La forza di gravità interpretata da Newton (1686) L elettromagnetismo espresso
TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA
 TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA EVOLUZIONE DELLE TEORIE FISICHE Meccanica Classica Principio di Relatività Galileiano Meccanica Newtoniana Gravitazione (Newton) Costante Universale G = 6,67*10^-11Nm^2/Kg^2
TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA EVOLUZIONE DELLE TEORIE FISICHE Meccanica Classica Principio di Relatività Galileiano Meccanica Newtoniana Gravitazione (Newton) Costante Universale G = 6,67*10^-11Nm^2/Kg^2
MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO?
 MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO? Le basi delle teorie della RELATIVITA e della MECCANICA QUANTISTICA A cura di Giorgio PALAZZI e Alberto RENIERI EINSTEIN E LA RELATIVITA SIAMO ALL INIZIO DEL XX SECOLO
MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO? Le basi delle teorie della RELATIVITA e della MECCANICA QUANTISTICA A cura di Giorgio PALAZZI e Alberto RENIERI EINSTEIN E LA RELATIVITA SIAMO ALL INIZIO DEL XX SECOLO
Relatività Ristretta
 1. L invarianza della velocità della luce 2. L esperimento di Michelson Morley 3. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 4. Relatività della simultaneità 5. La contrazione delle lunghezze
1. L invarianza della velocità della luce 2. L esperimento di Michelson Morley 3. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 4. Relatività della simultaneità 5. La contrazione delle lunghezze
La teoria della Relatività Generale
 Liceo Classico Seneca La teoria della Relatività Generale Prof. E. Modica La massa Dipendenza della massa dalla velocità Se un corpo di massa m è soggetto ad una forza costante F nella direzione della
Liceo Classico Seneca La teoria della Relatività Generale Prof. E. Modica La massa Dipendenza della massa dalla velocità Se un corpo di massa m è soggetto ad una forza costante F nella direzione della
La Teoria della Relatività Ristretta. Prof. Michele Barcellona
 La Teoria della Relatività Ristretta Prof. Michele Barcellona I Postulati della Teoria della Relatività ristretta Per risolvere le contraddizioni tra Meccanica ed Elettromagnetismo Einstein propose una
La Teoria della Relatività Ristretta Prof. Michele Barcellona I Postulati della Teoria della Relatività ristretta Per risolvere le contraddizioni tra Meccanica ed Elettromagnetismo Einstein propose una
È tutta una questione di sistema di riferimento
 Silvia Penati (UNIMIB e INFN) È tutta una questione di sistema di riferimento Albert Einstein (1905) S. Penati GR100 Bicocca 5-6 Nov 2015 1 z 0 y x S. Penati GR100 Bicocca 5-6 Nov 2015 2 1) Principio d
Silvia Penati (UNIMIB e INFN) È tutta una questione di sistema di riferimento Albert Einstein (1905) S. Penati GR100 Bicocca 5-6 Nov 2015 1 z 0 y x S. Penati GR100 Bicocca 5-6 Nov 2015 2 1) Principio d
Fisica Introduzione
 Fisica 1 2011-2012 Introduzione 1 FISICA GENERALE Meccanica: -Studio del moto dei corpi -Forza di gravità Elettromagnetismo: - Cariche elettriche, magneti FISICA CLASSICA FISICA MODERNA Fenomeni a livello
Fisica 1 2011-2012 Introduzione 1 FISICA GENERALE Meccanica: -Studio del moto dei corpi -Forza di gravità Elettromagnetismo: - Cariche elettriche, magneti FISICA CLASSICA FISICA MODERNA Fenomeni a livello
ELENCO ANALITICO DEGLI ARGOMENTI
 PROGRAMMA PER ESAMI DI IDONEITÀ ALLA CLASSE II FISICA dipartimento e contiene gli argomenti essenziali per l accesso al II anno di corso. INTRODUZIONE ALLA FISICA: GRANDEZZE E MISURE Metodo scientifico,
PROGRAMMA PER ESAMI DI IDONEITÀ ALLA CLASSE II FISICA dipartimento e contiene gli argomenti essenziali per l accesso al II anno di corso. INTRODUZIONE ALLA FISICA: GRANDEZZE E MISURE Metodo scientifico,
all interno del vagone
 all interno del vagone all interno del vagone Qual è la velocità del pallone? Dipende!!!!! Dal sistema di riferimento scelto all interno del vagone Qual è la velocità del pallone? Dipende!!!!! Dal sistema
all interno del vagone all interno del vagone Qual è la velocità del pallone? Dipende!!!!! Dal sistema di riferimento scelto all interno del vagone Qual è la velocità del pallone? Dipende!!!!! Dal sistema
INDICE GRANDEZZE FISICHE
 INDICE CAPITOLO 1 GRANDEZZE FISICHE Compendio 1 1-1 Introduzione 2 1-2 Il metodo scientifico 2 1-3 Leggi della Fisica e Principi 4 1-4 I modelli in Fisica 7 1-5 Grandezze fisiche e loro misurazione 8 1-6
INDICE CAPITOLO 1 GRANDEZZE FISICHE Compendio 1 1-1 Introduzione 2 1-2 Il metodo scientifico 2 1-3 Leggi della Fisica e Principi 4 1-4 I modelli in Fisica 7 1-5 Grandezze fisiche e loro misurazione 8 1-6
CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE. 9.1 Introduzione.
 CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE 9.1 Introduzione. Un altro tipo di forza piuttosto importante è la forza gravitazionale. Innanzitutto, è risaputo che nel nostro sistema di pianeti chiamato sistema solare il
CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE 9.1 Introduzione. Un altro tipo di forza piuttosto importante è la forza gravitazionale. Innanzitutto, è risaputo che nel nostro sistema di pianeti chiamato sistema solare il
Liceo Classico V.Gioberti
 Liceo Classico V.Gioberti Prof.sse: P.Porta e T.Morgante Teoria della Relativita Ristretta Nel 1905 Einstein formula i postulati della Relativita Ristretta (riferita a sistemi non accelerati): 1. Le leggi
Liceo Classico V.Gioberti Prof.sse: P.Porta e T.Morgante Teoria della Relativita Ristretta Nel 1905 Einstein formula i postulati della Relativita Ristretta (riferita a sistemi non accelerati): 1. Le leggi
PARTE V TEORIA DELLA RELATIVITÀ GENERALE
 PARTE V TEORIA DELLA RELATIVITÀ GENERALE 2 TITOLO DEL VOLUME 1. Introduzione La Relatività Generale è, matematicamente, una teoria estremamente complessa. Einstein disse che era il problema più complicato
PARTE V TEORIA DELLA RELATIVITÀ GENERALE 2 TITOLO DEL VOLUME 1. Introduzione La Relatività Generale è, matematicamente, una teoria estremamente complessa. Einstein disse che era il problema più complicato
QUATTRO PASSI NELLO SPAZIOTEMPO
 QUATTRO PASSI NELLO SPAZIOTEMPO! LA VISIONE DEL MONDO NELLA RELATIVITA DI EINSTEIN Giuseppe Tormen Dip. di Fisica e Astronomia G.Galilei Università di Padova!1 Lewis Carroll Epstein UN PO DI STORIA...
QUATTRO PASSI NELLO SPAZIOTEMPO! LA VISIONE DEL MONDO NELLA RELATIVITA DI EINSTEIN Giuseppe Tormen Dip. di Fisica e Astronomia G.Galilei Università di Padova!1 Lewis Carroll Epstein UN PO DI STORIA...
La relatività generale. Lezioni d'autore
 La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
PROGRAMMA DEL CORSO DI FISICA TEORICA 1 PROF. E. PACE CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN FISICA A. A
 PROGRAMMA DEL CORSO DI FISICA TEORICA 1 PROF. E. PACE CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN FISICA A. A. 2013-2014 ELETTROSTATICA NEL VUOTO Equazione di Poisson ed equazione di Laplace. Teorema di Green; I e II
PROGRAMMA DEL CORSO DI FISICA TEORICA 1 PROF. E. PACE CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN FISICA A. A. 2013-2014 ELETTROSTATICA NEL VUOTO Equazione di Poisson ed equazione di Laplace. Teorema di Green; I e II
La teoria della relatività. Liceo scientifico Don Bosco Brescia Gennaio 2016
 La teoria della relatività Liceo scientifico Don Bosco Brescia Gennaio 2016 Indice 1. Introduzione 2. Relatività ristretta: postulati 3. Relatività generale: principio di equivalenza 4. Relatività generale:
La teoria della relatività Liceo scientifico Don Bosco Brescia Gennaio 2016 Indice 1. Introduzione 2. Relatività ristretta: postulati 3. Relatività generale: principio di equivalenza 4. Relatività generale:
DOMANDE PER CAPIRE LA FISICA
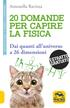 INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
MECCANICA QUANTISTICA
 La Meccanica MECCANICA: Studio del moto di un corpo in tutti i suoi aspetti. Si divide in: STATICA: Forze e Equilibrio. Studia delle condizioni per l equilibrio (corpi fermi). CINEMATICA: Descrizione il
La Meccanica MECCANICA: Studio del moto di un corpo in tutti i suoi aspetti. Si divide in: STATICA: Forze e Equilibrio. Studia delle condizioni per l equilibrio (corpi fermi). CINEMATICA: Descrizione il
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA MORESCHI. Programmazione didattica annuale
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA MORESCHI Programmazione didattica annuale Materia: FISICA classi: SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO LICEO SCIENTIFICO a.s. 2017/2018 Finalità e competenze Obiettivo
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA MORESCHI Programmazione didattica annuale Materia: FISICA classi: SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO LICEO SCIENTIFICO a.s. 2017/2018 Finalità e competenze Obiettivo
Indice. Meccanica. Le grandezze fsiche. Il moto in una dimensione. Il moto in due dimensioni. Le forze e l equilibrio III
 Indice Meccanica 1 2 3 4 Le grandezze fsiche 1 Grandezze fsiche 2 2 Il Sistema Internazionale di Unità 3 3 Notazione scientifca e approssimazioni 5 4 L intervallo di tempo 9 5 La lunghezza 9 6 La massa
Indice Meccanica 1 2 3 4 Le grandezze fsiche 1 Grandezze fsiche 2 2 Il Sistema Internazionale di Unità 3 3 Notazione scientifca e approssimazioni 5 4 L intervallo di tempo 9 5 La lunghezza 9 6 La massa
Lezione 3 Cinematica Velocità Moto uniforme Accelerazione Moto uniformemente accelerato Concetto di Forza Leggi di Newton
 Corsi di Laurea in Scienze motorie - Classe L-22 (D.M. 270/04) Dr. Andrea Malizia 1 Cinematica Velocità Moto uniforme Accelerazione Moto uniformemente accelerato Concetto di Forza Leggi di Newton Sistemi
Corsi di Laurea in Scienze motorie - Classe L-22 (D.M. 270/04) Dr. Andrea Malizia 1 Cinematica Velocità Moto uniforme Accelerazione Moto uniformemente accelerato Concetto di Forza Leggi di Newton Sistemi
Moti relativi. Cenni. Dott.ssa Elisabetta Bissaldi
 Moti relativi Cenni Dott.ssa Elisabetta Bissaldi Elisabetta Bissaldi (Politecnico di Bari) A.A. 2018-2019 2 In generale, la descrizione del moto dipende dal sistema di riferimento scelto Si consideri un
Moti relativi Cenni Dott.ssa Elisabetta Bissaldi Elisabetta Bissaldi (Politecnico di Bari) A.A. 2018-2019 2 In generale, la descrizione del moto dipende dal sistema di riferimento scelto Si consideri un
ALBERT EINSTEIN LA TEORIA della RELATIVITA U.T.E
 INGRESSO NELLA RELATIVITA 1) La nuova Fisica dei fenomeni elettrici e magnetici. - Scoperta e misura della carica elettrica positiva e negativa Le leggi della elettricità e magnetismo - Cariche opposte
INGRESSO NELLA RELATIVITA 1) La nuova Fisica dei fenomeni elettrici e magnetici. - Scoperta e misura della carica elettrica positiva e negativa Le leggi della elettricità e magnetismo - Cariche opposte
Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici
 Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici Il presente documento individua le conoscenze, abilità e competenze che lo studente dovrà aver acquisito al termine
Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici Il presente documento individua le conoscenze, abilità e competenze che lo studente dovrà aver acquisito al termine
Relatività e Meccanica Quantistica: concetti e idee. Relativity and Quantum Mechanics: concepts and ideas. Carlo Cosmelli
 Relatività e Meccanica Quantistica: concetti e idee Relativity and Quantum Mechanics: concepts and ideas Settimana 2 - La Teoria della Relatività speciale Carlo Cosmelli Relatività & Meccanica Quantistica
Relatività e Meccanica Quantistica: concetti e idee Relativity and Quantum Mechanics: concepts and ideas Settimana 2 - La Teoria della Relatività speciale Carlo Cosmelli Relatività & Meccanica Quantistica
LICEO SCIENTIFICO Galileo Galilei VERONA
 LICEO SCIENTIFICO Galileo Galilei PROGRAMMA PREVISTO Anno Scolastico 2006-2007 Testo di riferimento: "Le Vie della Fisica" vol. 1-2 (Battimelli - Stilli) Le unità didattiche a fondo chiaro sono irrinunciabili.
LICEO SCIENTIFICO Galileo Galilei PROGRAMMA PREVISTO Anno Scolastico 2006-2007 Testo di riferimento: "Le Vie della Fisica" vol. 1-2 (Battimelli - Stilli) Le unità didattiche a fondo chiaro sono irrinunciabili.
Incontri di introduzione alla Relatività Generale
 Incontri di introduzione alla Relatività Generale Prima parte La Torre del Sole - 11 Novembre 2015 Dr. Andrea Castelli, Ph.D. Università degli Studi di Bologna Struttura del corso PARTE PRIMA - 11 Novembre
Incontri di introduzione alla Relatività Generale Prima parte La Torre del Sole - 11 Novembre 2015 Dr. Andrea Castelli, Ph.D. Università degli Studi di Bologna Struttura del corso PARTE PRIMA - 11 Novembre
Il problema dei due corpi La dinamica planetaria
 Il problema dei due corpi La dinamica planetaria La Meccanica Classica Lagrange Hamilton Jacobi Vettori Per rendere conto della 3-dimensionalità in fisica, e in matematica, si usano delle grandezze più
Il problema dei due corpi La dinamica planetaria La Meccanica Classica Lagrange Hamilton Jacobi Vettori Per rendere conto della 3-dimensionalità in fisica, e in matematica, si usano delle grandezze più
Geometria dello Spaziotempo
 Geometria dello Spaziotempo Stefano Ansoldi Dipartimento di Fisica Teorica Università degli Studi di Trieste Corso di Laurea in Fisica Anno Accademico 2002/2003 Premesse algebriche. Strutture su uno spazio
Geometria dello Spaziotempo Stefano Ansoldi Dipartimento di Fisica Teorica Università degli Studi di Trieste Corso di Laurea in Fisica Anno Accademico 2002/2003 Premesse algebriche. Strutture su uno spazio
La legge di gravità. La mela
 La legge di gravità La caduta dei gravi La legge di Newton Il moto dei pianeti (Kepler) La misura della costante G (Cavendish) Masse estese Masse sferiche Verso il centro della terra... Il concetto di
La legge di gravità La caduta dei gravi La legge di Newton Il moto dei pianeti (Kepler) La misura della costante G (Cavendish) Masse estese Masse sferiche Verso il centro della terra... Il concetto di
Il linguaggio della relatività: le geometrie non euclidee
 Il linguaggio della relatività: le geometrie non euclidee Luca Lussardi Università Cattolica del Sacro Cuore Einstein 1916-2016 Università degli Studi di Brescia 6 Aprile 2016 Non sono certo che la geometria
Il linguaggio della relatività: le geometrie non euclidee Luca Lussardi Università Cattolica del Sacro Cuore Einstein 1916-2016 Università degli Studi di Brescia 6 Aprile 2016 Non sono certo che la geometria
PROFILO IN USCITA PER IL TERZO ANNO FISICA Sezioni internazionale Francese-Tedesca ad indirizzo scientifico
 PROFILO IN USCITA PER IL TERZO ANNO I vettori: componenti cartesiane, algebra dei vettori Il moto nel piano Moto circolare uniforme ed uniformemente accelerato Moto parabolico Il vettore forza Equilibrio
PROFILO IN USCITA PER IL TERZO ANNO I vettori: componenti cartesiane, algebra dei vettori Il moto nel piano Moto circolare uniforme ed uniformemente accelerato Moto parabolico Il vettore forza Equilibrio
MODULO DI FISICA (versione aggiornata 2018)
 Syllabus delle conoscenze per il modulo MODULO DI FISICA (versione aggiornata 2018) PREMESSA Il syllabus del modulo Fisica è volutamente limitato a quanto esposto nei testi delle scuole superiori e gli
Syllabus delle conoscenze per il modulo MODULO DI FISICA (versione aggiornata 2018) PREMESSA Il syllabus del modulo Fisica è volutamente limitato a quanto esposto nei testi delle scuole superiori e gli
Relativita speciale. A. Palano. Testo di riferimento: P.J. Nolan, Complementi di Fisica, fisica moderna, Zanichelli
 Relativita speciale A. Palano Testo di riferimento: P.J. Nolan, Complementi di Fisica, fisica moderna, Zanichelli Sistemi di riferimento in moto relativo. Moti relativi S: Assoluto, S : relativo, Moto
Relativita speciale A. Palano Testo di riferimento: P.J. Nolan, Complementi di Fisica, fisica moderna, Zanichelli Sistemi di riferimento in moto relativo. Moti relativi S: Assoluto, S : relativo, Moto
La Relatività Generale come Fonte di Ispirazione
 La Relatività Generale come Fonte di Ispirazione Augusto SAGNOTTI Scuola Normale Superiore e INFN - Pisa GR @ 100 s Parma, 20 Novembre 2015 Con l Europa nel pieno della I Guerra Mondiale, Einstein completava
La Relatività Generale come Fonte di Ispirazione Augusto SAGNOTTI Scuola Normale Superiore e INFN - Pisa GR @ 100 s Parma, 20 Novembre 2015 Con l Europa nel pieno della I Guerra Mondiale, Einstein completava
Le trasformazioni di Lorentz
 Le trasformazioni di Lorentz NASA, STS-41B 1 TRASFORMAZIONI DI GALILEO Il principio di relatività è stato enunciato per la prima volta da Galileo Galilei nel libro Dialogo sopra i due massimi sistemi del
Le trasformazioni di Lorentz NASA, STS-41B 1 TRASFORMAZIONI DI GALILEO Il principio di relatività è stato enunciato per la prima volta da Galileo Galilei nel libro Dialogo sopra i due massimi sistemi del
Indice. capitolo. capitolo. capitolo
 Indice Metodo scientifico 1 1. Introduzione 1 2. Definizione operativa delle grandezze fisiche 3 3. Sistemi di unità di misura ed equazioni dimensionali 5 4. Grandezza fisica tempo 9 5. Relazioni funzionali
Indice Metodo scientifico 1 1. Introduzione 1 2. Definizione operativa delle grandezze fisiche 3 3. Sistemi di unità di misura ed equazioni dimensionali 5 4. Grandezza fisica tempo 9 5. Relazioni funzionali
Tempi Moduli Unità /Segmenti. 2.1 La conservazione dell energia meccanica
 PERCORSO FORMATIVO DEL 3 ANNO - CLASSE 3 A L LSSA A. S. 2015/2016 Tempi Moduli Unità /Segmenti MODULO 0: Ripasso e consolidamento di argomenti del biennio MODULO 1: Il moto dei corpi e le forze. (Seconda
PERCORSO FORMATIVO DEL 3 ANNO - CLASSE 3 A L LSSA A. S. 2015/2016 Tempi Moduli Unità /Segmenti MODULO 0: Ripasso e consolidamento di argomenti del biennio MODULO 1: Il moto dei corpi e le forze. (Seconda
Argomenti del corso parte 1 : Fisica Meccanica
 Franco Guerrieri Obiettivi Fornire le informazioni di base della fisica finalizzate alla comprensione dei fenomeni astronomici Il modulo di fisica si limita alla sola parte della meccanica, escludendo
Franco Guerrieri Obiettivi Fornire le informazioni di base della fisica finalizzate alla comprensione dei fenomeni astronomici Il modulo di fisica si limita alla sola parte della meccanica, escludendo
Note a cura di M. Martellini e M. Zeni
 Università dell Insubria Corso di laurea Scienze Ambientali FISICA GENERALE Lezione 4 Dinamica Note a cura di M. Martellini e M. Zeni Queste note sono state in parte preparate con immagini tratte da alcuni
Università dell Insubria Corso di laurea Scienze Ambientali FISICA GENERALE Lezione 4 Dinamica Note a cura di M. Martellini e M. Zeni Queste note sono state in parte preparate con immagini tratte da alcuni
LICEO ARTISTICO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA RIFERITA ALLA SECONDO BIENNIO
 Istituto Istruzione Superiore A. Venturi Modena Liceo artistico - Istituto Professionale Grafica Via Rainusso, 66-41124 MODENA Sede di riferimento (Via de Servi, 21-41121 MODENA) tel. 059-222156 / 245330
Istituto Istruzione Superiore A. Venturi Modena Liceo artistico - Istituto Professionale Grafica Via Rainusso, 66-41124 MODENA Sede di riferimento (Via de Servi, 21-41121 MODENA) tel. 059-222156 / 245330
Lezione 3 Cinematica Velocità Moto uniforme Accelerazione Moto uniformemente accelerato Concetto di Forza Leggi di Newton
 Corsi di Laurea dei Tronchi Comuni 2 e 4 Dr. Andrea Malizia 1 Cinematica Velocità Moto uniforme Accelerazione Moto uniformemente accelerato Concetto di Forza Leggi di Newton Lezione 2 Sistemi di riferimento
Corsi di Laurea dei Tronchi Comuni 2 e 4 Dr. Andrea Malizia 1 Cinematica Velocità Moto uniforme Accelerazione Moto uniformemente accelerato Concetto di Forza Leggi di Newton Lezione 2 Sistemi di riferimento
PRINCIPI DELLA DINAMICA
 PRINCIPI DELLA DINAMICA Leggi fondamentali e Principi. Dinamica classica: velocità 8 piccola rispetto a c 3 10 m/s Relatività ristretta, Meccanica quantistica. Il comportamento di un corpo dipende dalla
PRINCIPI DELLA DINAMICA Leggi fondamentali e Principi. Dinamica classica: velocità 8 piccola rispetto a c 3 10 m/s Relatività ristretta, Meccanica quantistica. Il comportamento di un corpo dipende dalla
LE FORZE E IL MOTO. Il moto lungo un piano inclinato
 LE FORZE E IL MOTO Il moto lungo un piano inclinato Il moto di caduta lungo un piano inclinato un moto uniformemente accelerato in cui l accelerazione è diretta parallelamente al piano (verso il basso)
LE FORZE E IL MOTO Il moto lungo un piano inclinato Il moto di caduta lungo un piano inclinato un moto uniformemente accelerato in cui l accelerazione è diretta parallelamente al piano (verso il basso)
Meccanica parte seconda: Perche' i corpi. si muovono? la Dinamica: studio delle Forze
 Meccanica parte seconda: Perche' i corpi si muovono? la Dinamica: studio delle Forze Il concetto di forza Le forze sono le cause del moto o meglio della sua variazione Se la velocita' e' costante o nulla
Meccanica parte seconda: Perche' i corpi si muovono? la Dinamica: studio delle Forze Il concetto di forza Le forze sono le cause del moto o meglio della sua variazione Se la velocita' e' costante o nulla
Fisica Main Training Lorenzo Manganaro
 Fisica Main Training 2016-2017 Lorenzo Manganaro 18 lezioni: 3 blocchi 5+1 Programma: Meccanica (Cinematica Dinamica Energia e lavoro) Termodinamica Elettricità Magnetismo Elettromagnetismo Ottica geometrica
Fisica Main Training 2016-2017 Lorenzo Manganaro 18 lezioni: 3 blocchi 5+1 Programma: Meccanica (Cinematica Dinamica Energia e lavoro) Termodinamica Elettricità Magnetismo Elettromagnetismo Ottica geometrica
Principio di inerzia
 Dinamica abbiamo visto come si descrive il moto dei corpi (cinematica) ma oltre a capire come si muovono i corpi è anche necessario capire perchè essi si muovono Partiamo da una domanda fondamentale: qual
Dinamica abbiamo visto come si descrive il moto dei corpi (cinematica) ma oltre a capire come si muovono i corpi è anche necessario capire perchè essi si muovono Partiamo da una domanda fondamentale: qual
Da Maxwell a Einstein
 Da Maxwell a Einstein Le equazioni di Maxwell forniscono una spiegazione completa dei fenomeni elettromagnetici e ottici: La luce è un onda elettromagnetica e tutte le onde elettromagnetiche si propagano
Da Maxwell a Einstein Le equazioni di Maxwell forniscono una spiegazione completa dei fenomeni elettromagnetici e ottici: La luce è un onda elettromagnetica e tutte le onde elettromagnetiche si propagano
La Teoria della Relatività e la crisi del positivismo
 La Teoria della Relatività e la crisi del positivismo 1 A cavallo fra il sec XIX e XX, le certezze della scienza entrarono in crisi. I modelli matematici e fisici dei fenomeni si rivelarono non adeguati
La Teoria della Relatività e la crisi del positivismo 1 A cavallo fra il sec XIX e XX, le certezze della scienza entrarono in crisi. I modelli matematici e fisici dei fenomeni si rivelarono non adeguati
Relatività ristretta
 Relatività ristretta Tempo e spazio Per la fisica classica tempo e spazio erano due grandezze assolute (Newton) Con Maxwell si arrivò alla conclusione che le onde elettromagnetiche si propagassero alla
Relatività ristretta Tempo e spazio Per la fisica classica tempo e spazio erano due grandezze assolute (Newton) Con Maxwell si arrivò alla conclusione che le onde elettromagnetiche si propagassero alla
IISS Enzo Ferrari, Roma. Plesso Vallauri, Liceo delle Scienze Applicate. Programma svolto
 IISS Enzo Ferrari, Roma Plesso Vallauri, Liceo delle Scienze Applicate Programma svolto ANNO SCOLASTICO: 2015-2016 DISCIPLINA: FISICA CLASSE: 2ª F DOCENTE: MICHAEL ROTONDO Richiami sulle grandezze fisiche,
IISS Enzo Ferrari, Roma Plesso Vallauri, Liceo delle Scienze Applicate Programma svolto ANNO SCOLASTICO: 2015-2016 DISCIPLINA: FISICA CLASSE: 2ª F DOCENTE: MICHAEL ROTONDO Richiami sulle grandezze fisiche,
Risolviamo un esercizio per illustrare il fenomeno in modo dettagliato anche se,in alcuni punti, semplificato.
 PARADOSSO DEI GEMELLI Il cosiddetto paradosso dei gemelli è forse una delle conseguenze più popolari della teoria della relatività di Einstein. In realtà non si tratta di un vero e proprio paradosso, bensì
PARADOSSO DEI GEMELLI Il cosiddetto paradosso dei gemelli è forse una delle conseguenze più popolari della teoria della relatività di Einstein. In realtà non si tratta di un vero e proprio paradosso, bensì
Indice 3. Note di utilizzo 9. Ringraziamenti 10. Introduzione 11
 Indice Indice 3 Note di utilizzo 9 Ringraziamenti 10 Introduzione 11 Capitolo 1 Grandezze fisiche e schematizzazione dei sistemi materiali 13 1.1 Grandezze fisiche ed operazione di misura 13 1.2 Riferimento
Indice Indice 3 Note di utilizzo 9 Ringraziamenti 10 Introduzione 11 Capitolo 1 Grandezze fisiche e schematizzazione dei sistemi materiali 13 1.1 Grandezze fisiche ed operazione di misura 13 1.2 Riferimento
LA RELATIVITÀ GENERALE: SPAZIOTEMPO CURVO. Alessandro Tomasiello
 LA RELATIVITÀ GENERALE: SPAZIOTEMPO CURVO Alessandro Tomasiello Galileo [~1610]: la gravità ha lo stesso effetto su corpi di massa diversa Pisa?? Galileo [~1610]: la gravità ha lo stesso effetto su corpi
LA RELATIVITÀ GENERALE: SPAZIOTEMPO CURVO Alessandro Tomasiello Galileo [~1610]: la gravità ha lo stesso effetto su corpi di massa diversa Pisa?? Galileo [~1610]: la gravità ha lo stesso effetto su corpi
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018
 PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018 Materia: Fisica Classe: 3N Insegnante: prof. Sebastiano Porcino Libri di testo: L Amaldi per i licei scientifici. Blu/ Autore Ugo Amaldi - casa editrice Zanichelli MODULO
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018 Materia: Fisica Classe: 3N Insegnante: prof. Sebastiano Porcino Libri di testo: L Amaldi per i licei scientifici. Blu/ Autore Ugo Amaldi - casa editrice Zanichelli MODULO
Competenze Abilità Conoscenze
 CLASSI: TERZE fondamentali della disciplina acquisendo consapevolmente il suo valore culturale, la sua epistemologica. fenomeni. strumenti matematici del suo percorso didattico. * Avere consapevolezza
CLASSI: TERZE fondamentali della disciplina acquisendo consapevolmente il suo valore culturale, la sua epistemologica. fenomeni. strumenti matematici del suo percorso didattico. * Avere consapevolezza
approfondimento La dinamica e le interazioni fondamentali Il principio di inerzia secondo Galileo Sistemi inerziali
 approfondimento La dinamica e le interazioni fondamentali Il principio di inerzia secondo Galileo Sistemi inerziali Forza gravitazionale e forza peso massa e peso, peso apparente Forze normali Moto circolare
approfondimento La dinamica e le interazioni fondamentali Il principio di inerzia secondo Galileo Sistemi inerziali Forza gravitazionale e forza peso massa e peso, peso apparente Forze normali Moto circolare
Anna M. Nobili: Lezioni Fisica 1 per Chimici a.a
 Anna M. Nobili: Lezioni Fisica 1 per Chimici a.a. 2013-2014 26 Settembre 2013 Grandezze fisiche, dimensioni e unità di misura. Potenze di 10 e loro uso. 3 Ottobre 2013 Grandezze fisiche, dimensioni e
Anna M. Nobili: Lezioni Fisica 1 per Chimici a.a. 2013-2014 26 Settembre 2013 Grandezze fisiche, dimensioni e unità di misura. Potenze di 10 e loro uso. 3 Ottobre 2013 Grandezze fisiche, dimensioni e
Conoscenze FISICA LES CLASSE TERZA SAPERI MINIMI
 FISICA LES SAPERI MINIMI CLASSE TERZA LE GRANDEZZE FISICHE E LA LORO MISURA Nuovi principi per indagare la natura. Il concetto di grandezza fisica. Misurare una grandezza fisica. L impossibilità di ottenere
FISICA LES SAPERI MINIMI CLASSE TERZA LE GRANDEZZE FISICHE E LA LORO MISURA Nuovi principi per indagare la natura. Il concetto di grandezza fisica. Misurare una grandezza fisica. L impossibilità di ottenere
Liceo Scientifico Statale A. Einstein
 Liceo Scientifico Statale A. Einstein. PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE DI FISICA Prof.ssa Alessandra Desogus a.s. 2016/17 3^ I Libro di testo adottato : Ugo Amaldi L Amaldi per i licei scientifici.blu (Meccanica
Liceo Scientifico Statale A. Einstein. PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE DI FISICA Prof.ssa Alessandra Desogus a.s. 2016/17 3^ I Libro di testo adottato : Ugo Amaldi L Amaldi per i licei scientifici.blu (Meccanica
4. I principi della meccanica
 1 Leggi del moto 4. I principi della meccanica Come si è visto la cinematica studia il moto dal punto di vista descrittivo, ma non si sofferma sulle cause di esso. Ciò è compito della dinamica. Alla base
1 Leggi del moto 4. I principi della meccanica Come si è visto la cinematica studia il moto dal punto di vista descrittivo, ma non si sofferma sulle cause di esso. Ciò è compito della dinamica. Alla base
I.I.S. N. BOBBIO DI CARIGNANO - PROGRAMMAZIONE PER L A. S
 I.I.S. N. BOBBIO DI CARIGNANO - PROGRAMMAZIONE PER L A. S. 2014-15 DISCIPLINA: FISICA (Indirizzo linguistico) CLASSE: TERZA (tutte le sezioni) COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA CONTENUTI ORGANIZZATI PER
I.I.S. N. BOBBIO DI CARIGNANO - PROGRAMMAZIONE PER L A. S. 2014-15 DISCIPLINA: FISICA (Indirizzo linguistico) CLASSE: TERZA (tutte le sezioni) COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA CONTENUTI ORGANIZZATI PER
LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARCONI FOGGIA
 LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARCONI FOGGIA PROGRAMMA DI Fisica Classe VB Anno Scolastico 2014-2015 Insegnante: Prof.ssa La Salandra Incoronata 1 FORZA E CAMPI ELETTRICI (Richiami) Teoria sui vettori I
LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARCONI FOGGIA PROGRAMMA DI Fisica Classe VB Anno Scolastico 2014-2015 Insegnante: Prof.ssa La Salandra Incoronata 1 FORZA E CAMPI ELETTRICI (Richiami) Teoria sui vettori I
Curricolo di fisica CLASSE I
 CLASSE I Curricolo di fisica Le grandezze fisiche; il sistema internazionale e la notazione scientifica; misure di spazio, tempo, massa. Le incertezze sperimentali; la rappresentazione dei dati e gli errori
CLASSE I Curricolo di fisica Le grandezze fisiche; il sistema internazionale e la notazione scientifica; misure di spazio, tempo, massa. Le incertezze sperimentali; la rappresentazione dei dati e gli errori
Una formulazione equivalente è Il moto di un singolo punto materiale isolato è rettilineo uniforme (o è fermo):
 I PRINCIPI DELLA MECCANICA In queste note i principi della dinamica vengono formulati utilizzando soltanto le definizioni di accelerazione e velocità istantanee della Cinematica. Le lettere in grassetto
I PRINCIPI DELLA MECCANICA In queste note i principi della dinamica vengono formulati utilizzando soltanto le definizioni di accelerazione e velocità istantanee della Cinematica. Le lettere in grassetto
INDICE. 1 Ouverture 1
 INDICE 1 Ouverture 1 1.1 Sistemi dinamici ed equazioni differenziali 1 Lo spazio delle fasi e la cinematica (2) Le equazioni differenziali e la dinamica (3) 1.2 I primi esempi 5 Il decadimento radioattivo
INDICE 1 Ouverture 1 1.1 Sistemi dinamici ed equazioni differenziali 1 Lo spazio delle fasi e la cinematica (2) Le equazioni differenziali e la dinamica (3) 1.2 I primi esempi 5 Il decadimento radioattivo
Meccanica Introduzione
 Meccanica 2016-2017 Introduzione 1 FISICA GENERALE Meccanica: -Studio del moto dei corpi -Forza di gravità Termodinamica: - temperatura, calore, pressione, volume, composizione Elettromagnetismo: - Cariche
Meccanica 2016-2017 Introduzione 1 FISICA GENERALE Meccanica: -Studio del moto dei corpi -Forza di gravità Termodinamica: - temperatura, calore, pressione, volume, composizione Elettromagnetismo: - Cariche
L Induzione Elettromagnetica. Fabio Bevilacqua Dipartimento di Fisica A.Volta Università di Pavia
 L Induzione Elettromagnetica Fabio Bevilacqua Dipartimento di Fisica A.Volta Università di Pavia Il fenomeno Uno straordinario fenomeno avviene quando un filo conduttore è mosso in vicinanza di un magnete:
L Induzione Elettromagnetica Fabio Bevilacqua Dipartimento di Fisica A.Volta Università di Pavia Il fenomeno Uno straordinario fenomeno avviene quando un filo conduttore è mosso in vicinanza di un magnete:
LICEO CLASSICO Andrea Da Pontedera I.I.S. XXV Aprile
 LICEO CLASSICO Andrea Da Pontedera I.I.S. XXV Aprile a.s. 2016-2017 classi 3A, 3B PIANO DI LAVORO DI FISICA docente: Anna Maria Gennai LINEE GENERALI E COMPETENZE (INDICAZIONI NAZIONALI) Al termine del
LICEO CLASSICO Andrea Da Pontedera I.I.S. XXV Aprile a.s. 2016-2017 classi 3A, 3B PIANO DI LAVORO DI FISICA docente: Anna Maria Gennai LINEE GENERALI E COMPETENZE (INDICAZIONI NAZIONALI) Al termine del
Elettromagnetismo. Prof. Francesco Ragusa Università degli Studi di Milano. Lezione n
 Elettromagnetismo Prof. Francesco Ragusa Università degli Studi di Milano Lezione n. 25 6.04.2018 Campo elettrico di una carica accelerata Quadrivettori e trasformazioni di Lorentz Cinematica e dinamica
Elettromagnetismo Prof. Francesco Ragusa Università degli Studi di Milano Lezione n. 25 6.04.2018 Campo elettrico di una carica accelerata Quadrivettori e trasformazioni di Lorentz Cinematica e dinamica
Premessa: Si continua a studiare il moto degli oggetti in approssimazione di PUNTO MATERIALE
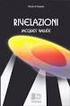 Leggi della Dinamica Premessa: Si continua a studiare il moto degli oggetti in approssimazione di PUNTO MATERIALE Fisica con Elementi di Matematica 1 Leggi della Dinamica Perché i corpi cambiano il loro
Leggi della Dinamica Premessa: Si continua a studiare il moto degli oggetti in approssimazione di PUNTO MATERIALE Fisica con Elementi di Matematica 1 Leggi della Dinamica Perché i corpi cambiano il loro
Dinamica: Forze e Moto, Leggi di Newton
 Dinamica: Forze e Moto, Leggi di Newton La Dinamica studia il moto dei corpi in relazione il moto con le sue cause: perché e come gli oggetti si muovono. La causa del moto è individuata nella presenza
Dinamica: Forze e Moto, Leggi di Newton La Dinamica studia il moto dei corpi in relazione il moto con le sue cause: perché e come gli oggetti si muovono. La causa del moto è individuata nella presenza
I grandi mutamenti nella fisica tra 800 e 900
 I grandi mutamenti nella fisica tra 800 e 900 Giulio Peruzzi Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Padova Padova tra Fisica e Musica dal 600 ai nostri giorni G. Peruzzi (Dip. di Fisica e Astronomia)
I grandi mutamenti nella fisica tra 800 e 900 Giulio Peruzzi Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Padova Padova tra Fisica e Musica dal 600 ai nostri giorni G. Peruzzi (Dip. di Fisica e Astronomia)
Fisica Main Training Lorenzo Manganaro
 Fisica Main Training 2016-2017 Lorenzo Manganaro 1. Lavoro di una forza 2. Energia meccanica e legge di conservazione 3. Forze dissipative 4. Potenza 30 25 20 15 1. Conservazione dell energia 2. Potenza
Fisica Main Training 2016-2017 Lorenzo Manganaro 1. Lavoro di una forza 2. Energia meccanica e legge di conservazione 3. Forze dissipative 4. Potenza 30 25 20 15 1. Conservazione dell energia 2. Potenza
CORSO di AGGIORNAMENTO di FISICA
 MATHESIS _ ROMA CORSO di AGGIORNAMENTO di FISICA RELATIVITA SPECIALE LEZIONE N. 1 RELATORE : SERGIO SAVARINO I.T:T. COLOMBO via Panisperna, 255 2 marzo 2016 Relatività Speciale 1 Einstein lavorava all
MATHESIS _ ROMA CORSO di AGGIORNAMENTO di FISICA RELATIVITA SPECIALE LEZIONE N. 1 RELATORE : SERGIO SAVARINO I.T:T. COLOMBO via Panisperna, 255 2 marzo 2016 Relatività Speciale 1 Einstein lavorava all
Dinamica. Giovanni Torrero maggio 2006
 Dinamica Giovanni Torrero maggio 006 1 I sistemi di riferimento inerziali Nello studio della dinamica sono molto importanti i sistemi di riferimento rispetto ai quali vengono studiati i fenomeni. L esperienza
Dinamica Giovanni Torrero maggio 006 1 I sistemi di riferimento inerziali Nello studio della dinamica sono molto importanti i sistemi di riferimento rispetto ai quali vengono studiati i fenomeni. L esperienza
Dinamica relativistica Cenni di relatività generale Corso Mathesis Roma 2016 Prof. Sergio Savarino
 Dinamica relativistica Cenni di relatività generale Corso Mathesis Roma 2016 Prof. Sergio Savarino Dinamica relativistica Quantità di moto relativistica: Massa relativistica: (1+z) 3 =1+3z+3z 2 +z 3 se
Dinamica relativistica Cenni di relatività generale Corso Mathesis Roma 2016 Prof. Sergio Savarino Dinamica relativistica Quantità di moto relativistica: Massa relativistica: (1+z) 3 =1+3z+3z 2 +z 3 se
Energia-quantita' di moto
 Energia-quantita' di moto quadri-vettore quantita' di moto E/c p=mu=m γ(c, v x, v y, v z ) cp = E = m c2 = Energia cinetica + Energia a riposo px Invariante: (P0)2 - P 2 = (m c)2 E R =m c 2 xxx Energia
Energia-quantita' di moto quadri-vettore quantita' di moto E/c p=mu=m γ(c, v x, v y, v z ) cp = E = m c2 = Energia cinetica + Energia a riposo px Invariante: (P0)2 - P 2 = (m c)2 E R =m c 2 xxx Energia
Main training FISICA. Lorenzo Manganaro. Lezione 5 Termodinamica
 Main training 2017-2018 FISICA Lorenzo Manganaro Lezione 5 Termodinamica 1. Lavoro di una forza 2. Energia meccanica e legge di conservazione 3. Forze dissipative 4. Potenza Sta$s$ca 30 25 20 15 1. Conservazione
Main training 2017-2018 FISICA Lorenzo Manganaro Lezione 5 Termodinamica 1. Lavoro di una forza 2. Energia meccanica e legge di conservazione 3. Forze dissipative 4. Potenza Sta$s$ca 30 25 20 15 1. Conservazione
FORZE E PRINCIPI DELLA DINAMICA (1/29)
 FORZE E PRINCIPI DELLA DINAMICA (1/29) una forza applicata ad un corpo, libero di muoversi, lo mette in movimento o lo arresta (effetto dinamico della forza); una forza, applicata ad un corpo vincolato,
FORZE E PRINCIPI DELLA DINAMICA (1/29) una forza applicata ad un corpo, libero di muoversi, lo mette in movimento o lo arresta (effetto dinamico della forza); una forza, applicata ad un corpo vincolato,
CURRICOLO DISCIPLINARE di fisica (INDICARE LA DISCIPLINA)
 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" Rosolini (SR) a.s. 2018/2019 CURRICOLO DISCIPLINARE di fisica (INDICARE LA DISCIPLINA) DIPARTIMENTO DI Matematica Fisica _ Informatica X LICEO ITIS
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" Rosolini (SR) a.s. 2018/2019 CURRICOLO DISCIPLINARE di fisica (INDICARE LA DISCIPLINA) DIPARTIMENTO DI Matematica Fisica _ Informatica X LICEO ITIS
Si chiama campo di forze una zona di spazio in cui sia possibile associare ad ogni punto un vettore forza
 Lavoro ed Energia Si chiama campo di forze una zona di spazio in cui sia possibile associare ad ogni punto un vettore forza F= F r cioè la forza agente sul punto dipende dalla sua posizione. Un campo di
Lavoro ed Energia Si chiama campo di forze una zona di spazio in cui sia possibile associare ad ogni punto un vettore forza F= F r cioè la forza agente sul punto dipende dalla sua posizione. Un campo di
Liceo Scientifico G. Galilei Macerata Anno Scolastico 2009/10 Contratto Formativo Individuale
 Liceo Scientifico G. Galilei Macerata Anno Scolastico 2009/10 Contratto Formativo Individuale Classe 3 Sez. F Materia : FISICA Docente: Manlio Bellesi 1.ANALISI DELLA CLASSE Conoscenze Il livello medio
Liceo Scientifico G. Galilei Macerata Anno Scolastico 2009/10 Contratto Formativo Individuale Classe 3 Sez. F Materia : FISICA Docente: Manlio Bellesi 1.ANALISI DELLA CLASSE Conoscenze Il livello medio
Automobile in corsa Volo di un gabbiano. Passeggero in aereo MOTO. Sole. Acqua dei fiumi. Treno in movimento
 IL MOTO dei CORPI Automobile in corsa Volo di un gabbiano Sole MOTO Passeggero in aereo Treno in movimento Acqua dei fiumi Libro sul banco Alberi Sole QUIETE Passeggero in aereo Treno in stazione Acqua
IL MOTO dei CORPI Automobile in corsa Volo di un gabbiano Sole MOTO Passeggero in aereo Treno in movimento Acqua dei fiumi Libro sul banco Alberi Sole QUIETE Passeggero in aereo Treno in stazione Acqua
produzione di particelle in laboratorio
 produzione di particelle in laboratorio In un urto tra due particelle, può essere prodotta una particella pesante a spese dell energia cinetica dello stato iniziale In questo modo possono essere prodotte
produzione di particelle in laboratorio In un urto tra due particelle, può essere prodotta una particella pesante a spese dell energia cinetica dello stato iniziale In questo modo possono essere prodotte
SR P. G. Bracco - Appunti di Fisica Generale
 Moti relativi Nel trattare i moti bisogna definire il sistema di riferimento (SR) rispetto a cui si descrive il moto. A volte è più semplice usare un SR particolare (in moto rispetto ad un altro) ed è
Moti relativi Nel trattare i moti bisogna definire il sistema di riferimento (SR) rispetto a cui si descrive il moto. A volte è più semplice usare un SR particolare (in moto rispetto ad un altro) ed è
PROGRAMMA PREVISTO Prof. F. Sigward A.S. 2018/19
 II S_SCA FISICA Statica dei fluidi La pressione, la legge di Pascal, il torchio idraulico La legge di Stevino La spinta di Archimede e il galleggiamento Pressione atmosferica ed esperimento di Torricelli
II S_SCA FISICA Statica dei fluidi La pressione, la legge di Pascal, il torchio idraulico La legge di Stevino La spinta di Archimede e il galleggiamento Pressione atmosferica ed esperimento di Torricelli
1 di 5 12/02/ :23
 Verifica: tibo5794_me08_test1 nome: classe: data: Esercizio 1. La traiettoria di un proiettile lanciato con velocità orizzontale da una certa altezza è: un segmento di retta obliqua percorso con accelerazione
Verifica: tibo5794_me08_test1 nome: classe: data: Esercizio 1. La traiettoria di un proiettile lanciato con velocità orizzontale da una certa altezza è: un segmento di retta obliqua percorso con accelerazione
Anna M. Nobili: Lezioni Fisica 1 per Chimici a.a Settembre 2013
 Anna M. Nobili: Lezioni Fisica 1 per Chimici a.a. 2013-2014 26 Settembre 2013 3 Ottobre 2013 10 Ottobre 2013 24 Ottobre 2013 31 Ottobre 2013 7 Novembre 2013 21 Novembre 2013 28 Novembre 2013 5
Anna M. Nobili: Lezioni Fisica 1 per Chimici a.a. 2013-2014 26 Settembre 2013 3 Ottobre 2013 10 Ottobre 2013 24 Ottobre 2013 31 Ottobre 2013 7 Novembre 2013 21 Novembre 2013 28 Novembre 2013 5
La rivoluzione scientifica. Copernico, Galileo, Newton
 La rivoluzione scientifica Copernico, Galileo, Newton La rivoluzione scientifica è quel movimento di idee che nel corso del XVI e XVII secolo portò all abbandono della precedente immagine della realtà,
La rivoluzione scientifica Copernico, Galileo, Newton La rivoluzione scientifica è quel movimento di idee che nel corso del XVI e XVII secolo portò all abbandono della precedente immagine della realtà,
4.Semplificare e modellizzare con strumenti matematici e disciplinari situazioni reali al fine della risoluzione di semplici problemi
 MODULO : CONTINUITA 12 ore COMPETENZE: 1.Osservare, identificare ed esplorare fenomeni; 2.Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 3.Costruire il linguaggio della fisica classica
MODULO : CONTINUITA 12 ore COMPETENZE: 1.Osservare, identificare ed esplorare fenomeni; 2.Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 3.Costruire il linguaggio della fisica classica
Liceo Ginnasio Luigi Galvani Classe 3GHI (scientifica) PROGRAMMA di FISICA a.s. 2017/2018 Prof.ssa Paola Giacconi
 Liceo Ginnasio Luigi Galvani Classe 3GHI (scientifica) PROGRAMMA di FISICA a.s. 2017/2018 Prof.ssa Paola Giacconi 1) Cinematica 1.1) Ripasso: Il moto rettilineo Generalità sul moto: definizione di sistema
Liceo Ginnasio Luigi Galvani Classe 3GHI (scientifica) PROGRAMMA di FISICA a.s. 2017/2018 Prof.ssa Paola Giacconi 1) Cinematica 1.1) Ripasso: Il moto rettilineo Generalità sul moto: definizione di sistema
Fisica Main Training Lorenzo Manganaro
 Fisica Main Training 2016-2017 Lorenzo Manganaro 1. Il concetto di forza 2. I tre principi della dinamica 3. Le forze più comuni (peso, forza elastica, tensioni, attrito) 30 25 20 15 1. Secondo principio
Fisica Main Training 2016-2017 Lorenzo Manganaro 1. Il concetto di forza 2. I tre principi della dinamica 3. Le forze più comuni (peso, forza elastica, tensioni, attrito) 30 25 20 15 1. Secondo principio
