Annamaria de Martino Ministero della Salute Dipartimento Prevenzione e Comunicazione Direzione Generale Prevenzione Sanitaria
|
|
|
- Tommasa Leona Gioia
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Annamaria de Martino Ministero della Salute Dipartimento Prevenzione e Comunicazione Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Introduzione L impatto delle malattie croniche in Italia e negli altri paesi industrializzati è in continua crescita. I dati forniti dall OMS 1 indicano che l 86% dei decessi, il 77% della perdita di anni di vita in buona salute ed il 75% delle spese sanitarie nei paesi europei sono causati da malattie cardiovascolari, tumori, diabete mellito, malattie respiratorie croniche, problemi di salute mentale, disturbi muscolosceletrici ed altre malattie croniche. Più del 33% delle malattie nei bambini al di sotto dei 5 anni è dovuto a fattori ambientali. Prevenire l esposizione a questi fattori di rischio salverebbe circa 4 milioni di vite all anno solo fra i bambini, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo 2 E stato ampiamente dimostrato che la correzione dei principali fattori di rischio(fumo di tabacco, l inquinamento ambientale, l obesità, l alimentazione scorretta, la sedentarietà, l abuso di alcool) conduce in genere ad una riduzione delle malattie ad essi correlati, oppure quando questi non sono identificabili o risultano difficilmente rimovibili, un appropriato approccio diagnostico-terapeutico, può contrastare l incremento di mortalità e morbosità, specialmente nei gruppi di popolazione socialmente ed economicamente più svantaggiati. La situazione italiana Le caratteristiche strutturali e epidemiologiche dell Italia quali l invecchiamento della popolazione, la ridotta natalità, l aumento della cronicità, indicano come prioritarie le aree delle malattie cardiovascolari (principale causa di morte e di consumo di risorse sanitarie), dei tumori (prima causa di anni di vita potenziali persi), il diabete che colpisce circa 2 milioni di persone; il 40% dei diabetici è in soprappeso mentre gli obesi sono il 32% ed il 2/5 del campione considerato non svolge alcuna attività fisica (Fonte. Piano Sanitario Nazionale ). L obesità inoltre è in aumento nell insieme della popolazione e nei bambini, i giovani continuano ad essere attratti dal fumo di tabacco, le classi economiche più disagiate restano le quelle maggiormente esposte ai fattori di rischio, specialmente il fumo di tabacco, e abuso di alcol, sedentarietà ed alimentazione non corretta.inoltre la prevalenza di patologie croniche dell anziano è aumentata di circa il 50% negli ultimi 10 anni. Tali condizioni influenzabili da comportamenti individuali, sono fortemente sostenute anche da fattori ambientali e socioeconomici. Questi dati sottolineano l importanza di iniziative volte a rilanciare la prevenzione sanitaria e della promozione della salute. L impegno nazionale Il Ministero della salute e le Regioni si sono impegnate nella lotta alle malattie croniche nel piano nazionale di prevenzione attiva condiviso a Cernobbio nell aprile del Il passo conseguente è stato l istituzione del CCM, per creare un coordinamento (tra regioni, ministero,iss, IZPS, IRRCS, la sanità militare, le agenzie regionali, gli osservatori ecc) per attuare in tutto il paese, in maniera uniforme, gli obiettivi di salute attraverso interventi di Prevenzione Attiva, offerti alla popolazione generale o ai gruppi più a rischio per malattie di rilevanza sociale, che vedono coinvolti in maniera integrata i vari attori del SSN impegnati nelle attività di prevenzione primaria e secondaria. le altre istituzioni anche non sanitarie (della scuola, del lavoro, dell ambiente, etc) devono cooperare attivamente per il raggiungimento degli obiettivi di salute. Gli ambiti del Piano nazionale di prevenzione attiva per il triennio , scaturiti dall Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, sono: la prevenzione della patologia cardiovascolare, la prevenzione delle complicanze del diabete, la diagnosi precoce dei tumori, le vaccinazioni, e la prevenzione degli incidenti stradali e domestici. 1 Preventing chronic diseases: a vital investment, WHO, Preventing disease through healthy environments:towards an estimate of the environmental burden of disease, WHO,2006
2 Il Piano riconosce un punto alto di integrazione istituzionale scientifico tra i livelli di governo centrale ed i governi territoriali che si realizza attraverso il CCM Inoltre il CCM con studio PASSI 3 Sostiene le Regioni e l Istituto Superiore di Sanità per sviluppare la sorveglianza sui fattori di rischio delle malattie croniche e le misure preventive e svolge anche attività disostegno agli interventi intersettoriali, sviluppo di progetti per sostenere interventi regionali, di coordinamento tra i diversi attori ed il monitoraggio degli interventi. Il PSN in continuità con gli obiettivi strategici previsti dal precedente Piano propone l implementazione delle attività di informazione ed educazione sulle specifiche fonti di rischio (lavoro ambiente domestico, traffico, stili di vita), alle fasce di popolazione più a rischio (bambini, giovani, anziani, lavoratori). Infine il Piano indica tra gli obiettivi strategici lo sviluppo di programmi per la tutela dell ambiente, inteso come fattore di qualità della salute e propone di implementare la sorveglianza dei fattori di rischio ambientali e comportamentali, un sistema di sorveglianza degli incidenti stradali negli ambienti domestici e negli ambienti di lavoro, l adozione di misure di prevenzione da adottare negli ambienti di vita indoor ed outdoor. Il Ministero si è impegnato in modo particolare in iniziative mirate a : ridurre l esposizione al fumo passivo, prevenire l iniziazione al fumo e sostenere la cessazione dal fumo attraverso azioni di sostegno per l applicazione del divieto di fumo e di contrasto al fumo (promozione di luoghi di lavoro senza fumo, campagne di informazione specifiche per i nuovi fumatori, campagne di informazione per i giovani non ancora fumatori, sistemi di valutazione di impatto delle attività preventive). Il Piano propone inoltre interventi mirati al mondo dell infanzia e dell adolescenza per la promozione di abitudini non sedentarie e la promozione di una corretta alimentazione. Contrastare il soprappeso e l obesità nelle giovani generazioni attraverso interventi che devono riguardare non soltanto l abitazione e la famiglia ma anche la scuola e la città (educare ed investire in attività motorie e spazi liberi per attività fisica e per piste ciclabili ed infine diffondere la cultura dei cibi sani e di una alimentazione corretta. La scuola è indicata come l ambito privilegiato di questi interventi, ma il patto con le altre istituzioni è fondamentale perché sono necessari investimenti individuali e collettivi. A titolo di esempio, abbiamo anche cercato di immaginare quali potessero essere le partnership da coinvolgere negli interventi, dalle Istituzioni ai privati, alle società scientifiche, alle associazioni, lasciando, comunque, le Regioni libere di decidere tra queste o le altre possibilità per ogni singola linea di intervento. Ad esempio la prevenzione dell iniziazione dei giovani al fumo può attuarsi tramite l attivazione di interventi integrati di educazione alla salute rivolti ai ragazzi in età scolare(scuola media inferiore e primi anni della scuola superiore); la disassuefazione può essere favorita tramite il contributo dei MMG, i Centri Antifumo, l attivazione presso ASL e Aziende ospedaliere di funzioni dedicate; la sospensione del fumo in gravidanza si può ottenere tramite interventi di informazione e l organizzazione di sistemi di assistenza per le donne che fumano in gravidanza. Per la protezione della salute dei non fumatori possono essere attivate azioni di sostegno e di monitoraggio all applicazione della legge 3/2003, attraverso una costante azione di informazione educazione sanitaria, accompagnate specie nei luoghi di lavoro da interventi educativi rivolti ai fumatori per favorire l adozione di comportamenti non nocivi alla salute dei non fumatori e promuovere la disassuefazione anche attraverso l offerta privilegiata di supporto. La nuova legge 3/2003, articolo 51, entrata in vigore il 10 gennaio 2005 che ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti strettamente privati (abitazioni) ha già prodotto i primi risultati positivi a distanza di poco tempo dalla sua applicazione. Dall indagine Multiscopo dell ISTAT sul fumo in Italia emerge che nel periodo dicembre 2004-marzo 2005 i fumatori in Italia sono 11 milioni e 221 mila, mentre i dati ISTAT del 2003 riferivano una prevalenza di fumatori pari al 23,9% della popolazione adulta 3
3 ultraquattordicenne. Dal confronto dei dati tra la rilevazione di dicembre 2004 e marzo 2005, cioè immediatamente prima e tre mesi dopo l introduzione del divieto, si evidenzia: un calo significativo della percentuale di fumatrici (da 17,5% a 15,8%) ed un aumento del numero di persone che hanno tentato di smettere di fumare (dal 20,9% al 23%) che risulta più marcato tra le persone con titolo di studio più elevato. L indagine Doxa condotta a marzo-aprile 2005 su un campione di 3114 persone di 15 anni e oltre ha rivelato rispetto a quanto emerso dall indagine condotta nel 2004 alcune differenze anche se lievi : diminuzione dei fumatori correnti dal 26,2% al 25,6%. Gli ex fumatori sono aumentati passando dal 17,9% al 18,6%. In totale circa 500 mila fumatori hanno smesso di fumare nell ultimo anno. Si è registrata anche un calo della vendita di sigarette nel periodo gennaio novembre 2005 rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. I dati disponibili indicano che da gennaio a settembre 2005 si è osservato anche un significativo aumento delle vendite di prodotti sostitutivi della nicotina, che sono quasi raddoppiate. Un altro punto forte del PSN è favorire le varie forme di partecipazione del cittadino. La partecipazione è intesa in senso ampio, sia come diretta partecipazione del cittadino/utente/paziente alle scelte preventive, terapeutiche e assistenziali. Il cittadino consapevole (empowered)deve essere il primo attore delle scelte che riguardano la sua salute. E fondamentale promuovere i processi di informazione e comunicazione tra cittadino ed istituzioni sanitarie e cittadini ed operatori. La non autosufficienza: gli anziani La classifica dei Paesi più vecchi stilata dall ONU vede al primo posto 4 il nostro Paese, con una percentuale di popolazione anziana del 25% I dati ISTAT attestano che al 1 gennaio 2005 la popolazione italiana di 65 anni e più è superiore a 11 milioni. Aumenta la percentuale di popolazione over 80 i grandi vecchi. Per il 2050 è previsto un ulteriore aumento soprattutto delle fasce di età compresa fra i 75 ed i 79 anni. Le conseguenze legate all invecchiamento della popolazione conducono ad alcune importanti implicazioni sociosanitarie ed economiche e pongono una serie di problemi urgenti ed indilazionabili: l estensione del periodo di morbilità ( aumento del periodo di vita con esposizione a malattie e/o patologie croniche, invalidità); I dati dello studio ILSA 5 e Studio Argento 6. hanno evidenziato un quadro non troppo rassicurante riguardo alla diffusione tra gli anziani di fattori di rischio per la salute, non solo sanitari (fumo alcol, soprappeso, obesità, alimentazione non corretta) ma anche socioeconomici, associati a tassi più elevati di patologie croniche invalidanti, disabilità e mortalità generale. Da alcuni studi sui bisogni socio-sanitari degli anziani in Italia (Studi Argento e ILSA, 2003)hanno evidenziato: - Aumento di prevalenza delle patologie croniche dell anziano (+50% negli ultimi 10 anni) - Aumento di diffusione tra gli anziani dei fattori di rischio ambientali e socioeconomici(tassi più elevati di patologie croniche invalidanti, disabilità e mortalità evitabili) - Aumento di isolamento o scarsa integrazione sociale dell anziano, per modificazione delle strutture familiari, dell organizzazione urbanistica e sociale delle città e > degli anziani hard to reach per condizioni di estremo isolamento Lo studio ILSA dimostra che possibili interventi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie croniche invalidanti e della disabilita e interventi strutturali, di sostegno alla famiglia e di rafforzamento della rete sociale formale ed informale, costituiscono un investimento in direzione del sostegno e della promozione dell anzianità attiva e si traduce in minori costi dovuti al sostegno della non autosufficienza, spesso attivata proprio dalla mancanza di promozione e di stimoli. Il PSN propone interventi in grado di affrontare la molteplicità de fattori che concorrono a determinare ad aggravare la situazione di non autosufficienza, fino all identificazione di forme di 4 Population aged 60 years or older Studio longitudinale italiano sull'invecchiamento) 6 Studio Argento. Indagine sulla salute nella terza età. Indagine campionaria,
4 presa n carico da parte dei servizi territoriali, in sinergia con i servizi sociali dei Comuni, di persone anziane più fragili. Si propone, quindi, una cultura promozionale dei servizi alla persona, in cui, sotto la guida delle istituzioni pubbliche, la collettività diviene soggetto facilitatore del benessere dei suoi anziani e il terzo settore viene chiamato ad un ruolo attivo nella progettazione, nell organizzazione e nella gestione di servizi per gli anziani, soprattutto in condizioni di maggiore fragilità. L ondata di caldo dell estate del 2003, in cui si verificò un incremento di mortalità nella popolazione anziana ed in particolare gli anziani di età superiore ai 75 anni, fragili per condizioni di salute, socioeconomiche e ambientali ma soprattutto per la solitudine, ha posto all attenzione i problemi nuovi posti dall invecchiamento della popolazione da un lato, e dalla frammentazione dei tessuti sociali e relazionali dei contesti urbani, dall altro. Nell estate del 2004 il Ministero della salute ha promosso e finanziato in 4 delle città (Genova, Milano, Torino, Roma) più colpite dagli eventi del 2003 un servizio innovativo di presa in carico dell anziano, il Servizio di custodia sociosanitaria, che da una parte sviluppa interventi mirati di sorveglianza attiva e di prevenzione sociale e sanitaria nei confronti di gruppi di popolazione anziana hard to rich e dall altra mira a sviluppare maggiori sinergie tra le politiche sanitarie e sociali e le altre politiche in grado di influenzare i fattori (ambientali e socioeconomici) che incidono sulla salute e la qualità della vita degli anziani più a rischio. Il servizio si fonda sull attività di servizi di prossimità di quartiere che svolgono azioni di supporto alla rete parentale/amicale o si sostituiscono ad essa, nei casi di persone anziane non autosufficienti che vivono da sole. I risultati attesi sono ridurre la mortalità evitabile correlata alle al temperature ambientali ma anche garantire alla persona anziana il diritto di vivere il più possibile in un ambiente di vita di tipo familiare attivando contatti con una serie di servizi ed interventi, sia pubblici sia privati, e programmando e attivando nei confronti degli anziani selezionati dal progetto risposte diversificate e personalizzate. Le principali finalità dei quattro progetti si possono così riassumere: creare un osservatorio attivo sul territorio o quartiere sulla condizione degli anziani ivi residenti( condizioni sociali, sanitarie, economiche, abitative e relazionali); individuare, far emergere le situazioni di maggior fragilità e rischio per favorire una adeguata programmazione degli interventi ed un organizzazione dei servizi più aderente ai bisogni della popolazione anziana target; sviluppare la sorveglianza attiva delle condizioni psicofisiche, igieniche ed ambientali delle persone anziane costituenti il campione in esame, in modo da garantire l efficace prevenzione di eventuali difficoltà e disagi provocati da eventi critici; potenziare i canali di comunicazione dell anziano, specialmente degli anziani che vivono in condizioni di particolare isolamento o difficoltà, attraverso un supporto telefonico (Call Center) e prevenire i casi di isolamento; creare una rete di protezione sociale e sanitaria formale ed informale ed una rete di relazioni, attorno agli anziani più fragili, che stabilisca un ponte fra i bisogni della singola persona anziana ed il sistema complessivo dei servizi e delle opportunità I primi risultati di due anni di sperimentazione dimostrano che l ulteriore implementazione della rete dei custodi sociali sviluppata nel 2005 ed il potenziamento delle azioni collegate a livello di sistema integrato socio-sanitario, hanno prodotto dei risultati positivi sul piano della riduzione della mortalità e dei ricoveri sia ospedalieri che in RSA. Lavorare per il futuro per ridurre le morti premature e vivere meglio Le conoscenze per raggiungere questo obiettivo sono già disponibili, le soluzioni sono efficaci ed economicamente convenienti. Per avere successo è necessaria un azione globale ed integrale, da parte dei governi, delle istituzioni, ma anche da parte della comunità e degli esperti della salute. Lavorare anche per il futuro, vuol dire promuovere politiche sanitarie in senso più egualitario verso gli obiettivi di salute, costruendo e diffondendo informazione scientifica sulle differenze sociali nella salute, promovendo la ricerca sui determinanti di salute, sviluppando azioni concrete per contrastare i fattori di rischio e creando reti locali di attori sanitari, sociali, professionali ed istituzionali interessati, facilitando il coordinamento e l integrazione delle politiche settoriali di lotta ai determinanti non sanitari e di moderazione delle conseguenze sulla salute. Come primo passo è
5 fondamentale diffondere le conoscenze più recenti, sia ai professionisti che operano in prima linea, sia al pubblico in generale. Per realizzare tutto ciò sono necessari alcuni interventi concreti e mirati a 1. Consolidare in tutto il territorio nazionale la rete per la prevenzione collettiva territoriale rappresentata dai dipartimenti di prevenzione, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi regionali e consolidare in tale rete la funzione epidemiologica 2. Promuovere sinergie tra ARPE, Dipartimenti di prevenzione, Istituti Zooprofilattici sperimentali, e le strutture tecniche del Ministero della salute 3. Promuovere l integrazione tra prevenzione, cure primarie e percorsi diagnostico-terapeutici, tenendo nella giusta considerazione il ruolo dei determinanti sociosanitari 4. Migliorare il coordinamento con le Istituzioni anche non sanitarie, promuovere politiche integrate e intersettoriali ai vari livelli 5. Migliorare il sistema informativo a supporto della rete per la prevenzione(amb e sanitaria), definizione di indicatori 6. Rendere più accessibili le informazioni sullo stato della salute e dell ambiente per ricercatori, operatori di sanità pubblica e cittadini anche ai fini di una efficace comunicazione istituzionale. 7. Inoltre è fondamentale promuovere iniziative er favorire lo sviluppo di comunità in grado di rafforzare i fattori protettivi della salute (Communities for health): Implementare le iniziative di promozione della salute in scuole, ospedali e luoghi di lavoro (Educazione sanitaria) Rafforzare le reti di sostegno e solidarietà sociale verso i gruppi più vulnerabili della popolazione Valorizzare il ruolo dell associazionismo (terzo settore, volontariato, associazioni pazienti e loro familiari) Su queste basi si fonda il programma promosso dal Ministero Guadagnare salute Rendere facili le scelte salutari che attraverso un azione sinergica tra più ministeri e un attività di informazione e comunicazione univoca intende promuovere scelte di vita salutari. Il programma propone un azione coordinata di contrasto ai principali fattori di rischio, un approccio integrato focalizzato non solo sugli aspetti sanitari ma anche sulle implicazioni ambientali, sociali ed economiche. I principali obiettivi sono: ridurre l iniziazione al fumo, promuovere un alimentazione corretta, ridurre l abuso di alcole e promuovere l attività fisica. Prevede il coinvolgimento e la condivisione degli obiettivi da parte di tutti gli attori coinvolti, dalle amministrazioni centrali e regionali e dagli enti locali ai settori privati. Tale programma è un investimento per ridurre nel lungo periodo il peso delle malattie croniche sul sistema sanitario e sulla società e nel breve periodo facilitare il processo di cambiamento in cui il cittadino diviene il primo attore del processo di promozione della salute per uno sviluppo sostenibile. Occorre progettare ed attuare nell immediato futuro misure volte a conoscere e affrontare efficacemente le malattie croniche, dando maggiore rilievo alle iniziative finalizzate alla promozione di azioni individuali e sociali mirate a ottenere sostegno politico e consenso sociale per ogni programma di salute teso a creare condizioni di vita favorevoli a stili di vita salutari; promuovere/coordinare politiche integrate a livello di sistema sanitario per modificare i determinanti sociali, giocare un ruolo essenziale nella prevenzione delle conseguenze negative delle condizioni di rischio, nella sorveglianza e nel sostenere che la prevenzione dei rischi è una priorità nelle altre politiche: educative, agricole, commerciali, ambientali,lavori pubblici ecc. implementare le iniziative di promozione della salute in scuole, ospedali e luoghi di lavoro (Communities for health) L azione della comunità per la salute implica persone che agiscono collettivamente per guadagnare maggior influenza e controllo sui determinanti della salute e la qualità della vita. Le situazioni in cui
6 le persone sono impegnate in attività quotidiane favoriscono la possibilità di agire insieme per avere un ambiente più favorevole alla salute e affrontare insieme I problemi associati alla salute. Lo sviluppo di partnership ed alleanze tra settore pubblico, società civile e settore privato possono aiutare gli sforzi cooperativi per ottenere migliori outcomes. Ogni amministrazione locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private e adottare una propria Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la costruzione del consenso, le Amministrazioni locali dovrebbero apprendere ed acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale, le informazioni necessarie per formulare le migliori strategie [Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) di Rio de Janeiro, 1992]
Stili di vita. Conferenza dei Servizi di Prevenzione della Regione Piemonte
 Conferenza dei Servizi di Prevenzione della Regione Piemonte Villa Gualino, Torino, 9 dicembre 2009 Modo di vivere fondato su modelli comportamentali riconoscibili, determinati a loro volta dall interazione
Conferenza dei Servizi di Prevenzione della Regione Piemonte Villa Gualino, Torino, 9 dicembre 2009 Modo di vivere fondato su modelli comportamentali riconoscibili, determinati a loro volta dall interazione
La Promozione della salute nei luoghi di lavoro
 La Promozione della salute nei luoghi di lavoro Modena 6 marzo 2014 Adriana Giannini I determinanti della salute Dahlgren G and Whitehead M (1991) La Promozione della salute Processo che mette in grado
La Promozione della salute nei luoghi di lavoro Modena 6 marzo 2014 Adriana Giannini I determinanti della salute Dahlgren G and Whitehead M (1991) La Promozione della salute Processo che mette in grado
Progetto interministeriale Scuola e salute Gli accordi interministeriali, filosofia e motivazioni del progetto
 Progetto interministeriale Scuola e salute Gli accordi interministeriali, filosofia e motivazioni del progetto Dott.ssa Daniela Galeone Ministero del Lavoro, della Salute e dellepolitiche Sociali Torino,
Progetto interministeriale Scuola e salute Gli accordi interministeriali, filosofia e motivazioni del progetto Dott.ssa Daniela Galeone Ministero del Lavoro, della Salute e dellepolitiche Sociali Torino,
Il fumo di tabacco: dalle norme alla prevenzione attiva
 Il fumo di tabacco: dalle norme alla prevenzione attiva Daniela Galeone Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria BACKGROUND Il fumo è la seconda causa di morte nel mondo I fumatori
Il fumo di tabacco: dalle norme alla prevenzione attiva Daniela Galeone Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria BACKGROUND Il fumo è la seconda causa di morte nel mondo I fumatori
CONSENSUS CONFERENCE 15 GIUGNO 2016 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO
 Promuovere il Patient Engagement nei processi di cura grazie a prove di efficacia e misure di impatto - CONSENSUS CONFERENCE 15 GIUGNO 2016 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Dr.ssa Valeria Mastrilli
Promuovere il Patient Engagement nei processi di cura grazie a prove di efficacia e misure di impatto - CONSENSUS CONFERENCE 15 GIUGNO 2016 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Dr.ssa Valeria Mastrilli
La prevenzione del sovrappeso e dell obesità nel PSR e nel PRP. Roberto Carloni
 La prevenzione del sovrappeso e dell obesità nel PSR e nel PRP Roberto Carloni OBESITA E SOVRAPPESO: UN EMERGENZA PER LA SALUTE PUBBLICA DATI WHO In Europa, come nel resto del mondo, l obesità è in netto
La prevenzione del sovrappeso e dell obesità nel PSR e nel PRP Roberto Carloni OBESITA E SOVRAPPESO: UN EMERGENZA PER LA SALUTE PUBBLICA DATI WHO In Europa, come nel resto del mondo, l obesità è in netto
Emanuela Bedeschi Responsabile Servizio Sanita' Pubblica Direzione Generale Sanita' e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna
 Le malattie croniche determinano la parte preponderante del carico di morti premature e di disabilità, incidendo pesantemente sulla qualità della vita dei nostri cittadini. Le persone in posizione di disagio
Le malattie croniche determinano la parte preponderante del carico di morti premature e di disabilità, incidendo pesantemente sulla qualità della vita dei nostri cittadini. Le persone in posizione di disagio
Fumo di sigaretta: dati PASSI utili al programma regionale di prevenzione. Elizabeth Tamang Venezia, 22 ottobre 2008
 Fumo di sigaretta: dati PASSI utili al programma regionale di prevenzione Elizabeth Tamang Venezia, 22 ottobre 2008 Fumatori tra la popolazione di 14 anni e più Anno 2007 Italia 22,1 % Veneto 18,9% Fonte:
Fumo di sigaretta: dati PASSI utili al programma regionale di prevenzione Elizabeth Tamang Venezia, 22 ottobre 2008 Fumatori tra la popolazione di 14 anni e più Anno 2007 Italia 22,1 % Veneto 18,9% Fonte:
Intersettorialità, multisettorialità e valutazione nel Piano Nazionale Prevenzione PNP
 Intersettorialità, multisettorialità e valutazione nel Piano Nazionale Prevenzione PNP Francesca Russo, Federica Michieletto, Annarosa Pettenò Sezione Attuazione e Programmazione Sanitaria Settore Promozione
Intersettorialità, multisettorialità e valutazione nel Piano Nazionale Prevenzione PNP Francesca Russo, Federica Michieletto, Annarosa Pettenò Sezione Attuazione e Programmazione Sanitaria Settore Promozione
Ministero della Salute. GUADAGNARE SALUTE rendere facili le scelte salutari
 Ministero della Salute GUADAGNARE SALUTE rendere facili le scelte salutari GUADAGNARE SALUTE L inattività fisica, la scorretta alimentazione, il soprappeso e/o l obesità, il consumo di alcol ed il tabagismo
Ministero della Salute GUADAGNARE SALUTE rendere facili le scelte salutari GUADAGNARE SALUTE L inattività fisica, la scorretta alimentazione, il soprappeso e/o l obesità, il consumo di alcol ed il tabagismo
Le azioni aziendali per Guadagnare Salute
 Dipartimento di Prevenzione Le azioni aziendali per Guadagnare Salute Fausta Ortu medico SISP Dipartimento di Prevenzione Azienda Ulss 15 Carta di Ottawa La carta di Ottawa (1986) è il documento ispirativo
Dipartimento di Prevenzione Le azioni aziendali per Guadagnare Salute Fausta Ortu medico SISP Dipartimento di Prevenzione Azienda Ulss 15 Carta di Ottawa La carta di Ottawa (1986) è il documento ispirativo
5. Approfondimento: confronto stime Banca Dati Assistiti vs Sistema di Sorveglianza Passi 9 per Diabete e Cardiovasculopatia
 5. Approfondimento: confronto stime Banca Dati Assistiti vs Sistema di Sorveglianza Passi 9 per Diabete e Cardiovasculopatia Il diabete e le malattie cardiovascolari sono condizioni di salute a forte impatto
5. Approfondimento: confronto stime Banca Dati Assistiti vs Sistema di Sorveglianza Passi 9 per Diabete e Cardiovasculopatia Il diabete e le malattie cardiovascolari sono condizioni di salute a forte impatto
D.ssa Lorella Cecconami Direttore Sanitario ATS della Montagna
 D.ssa Lorella Cecconami Direttore Sanitario ATS della Montagna MONTAGNA INSUBRIA BRIANZA BERGAMO BRESCIA VALPADANA PAVIA CITTA METROPOLITANA Come eravamo Come siamo Art. 6 comma 3 Negoziazione e acquisto
D.ssa Lorella Cecconami Direttore Sanitario ATS della Montagna MONTAGNA INSUBRIA BRIANZA BERGAMO BRESCIA VALPADANA PAVIA CITTA METROPOLITANA Come eravamo Come siamo Art. 6 comma 3 Negoziazione e acquisto
Alimentazione e prevenzione malattie neoplastiche. Reggio Emilia 2 3 dicembre 2013
 Alimentazione e prevenzione malattie neoplastiche Reggio Emilia 2 3 dicembre 2013 Percorso di Acquisizione conoscenze sulle relazioni tra fattori nutrizionali e m.n (fattori di rischio e fattori di protezione)
Alimentazione e prevenzione malattie neoplastiche Reggio Emilia 2 3 dicembre 2013 Percorso di Acquisizione conoscenze sulle relazioni tra fattori nutrizionali e m.n (fattori di rischio e fattori di protezione)
Il piano di prevenzione della Provincia Autonoma di Bolzano. Dr. Livia Borsoi, MPH
 Il piano di prevenzione della Provincia Autonoma di Bolzano Dr. Livia Borsoi, MPH Piano nazionale di prevenzione Piano provinciale di prevenzione Programma 0, Tavolo interdipartimentale di salute in tutte
Il piano di prevenzione della Provincia Autonoma di Bolzano Dr. Livia Borsoi, MPH Piano nazionale di prevenzione Piano provinciale di prevenzione Programma 0, Tavolo interdipartimentale di salute in tutte
Il Programma nazionale Guadagnare salute
 Il Programma nazionale Guadagnare salute Daniela Galeone Workshop Stili di vita e salute Trento 20 giugno 2014 Le malattie croniche: un allarme mondiale 57 milioni di decessi nel 2008 Il 63% (36 milioni)
Il Programma nazionale Guadagnare salute Daniela Galeone Workshop Stili di vita e salute Trento 20 giugno 2014 Le malattie croniche: un allarme mondiale 57 milioni di decessi nel 2008 Il 63% (36 milioni)
Le Buone Pratiche per Guadagnare salute
 Le Buone Pratiche per Guadagnare salute Dott.ssa Daniela Galeone ROMA, Auditorium Lungotevere Ripa 25 ottobre 2011 Un allarme mondiale: l impatto delle malattie croniche Le malattie croniche non trasmissibili
Le Buone Pratiche per Guadagnare salute Dott.ssa Daniela Galeone ROMA, Auditorium Lungotevere Ripa 25 ottobre 2011 Un allarme mondiale: l impatto delle malattie croniche Le malattie croniche non trasmissibili
PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SISTEMI DI SORVEGLIANZA
 PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SISTEMI DI SORVEGLIANZA Dott. Maurizio Castelli Direttore Dipartimento di Prevenzione Azienda USL della Valle d Aosta Aosta 26 ottobre 2016 Gli stili di vita non salutari determinano
PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SISTEMI DI SORVEGLIANZA Dott. Maurizio Castelli Direttore Dipartimento di Prevenzione Azienda USL della Valle d Aosta Aosta 26 ottobre 2016 Gli stili di vita non salutari determinano
Diario delle attività di prevenzione primaria Il contrasto ai principali fattori di rischio per la salute in Piemonte.
 Diario delle attività di prevenzione primaria Il contrasto ai principali fattori di rischio per la salute in Piemonte Monica Bonifetto LE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT) MCNT: cardiopatie, tumori,
Diario delle attività di prevenzione primaria Il contrasto ai principali fattori di rischio per la salute in Piemonte Monica Bonifetto LE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT) MCNT: cardiopatie, tumori,
Le strategie per la promozione della salute nell anziano del Piano Sociale e Sanitario Regionale
 Le strategie per la promozione della salute nell anziano del Piano Sociale e Sanitario Regionale dott. Raffaele FABRIZIO Bologna, 20 gennaio 2010 La società regionale oggi Invecchiamento popolazione (aumento
Le strategie per la promozione della salute nell anziano del Piano Sociale e Sanitario Regionale dott. Raffaele FABRIZIO Bologna, 20 gennaio 2010 La società regionale oggi Invecchiamento popolazione (aumento
Quale EBP nei Dipartimenti di Sanità Pubblica. Analizzare, condividere, sperimentare attività efficaci
 6 GIUGNO 2008 Lavoro di gruppo in area vasta Valutazione efficacia e coerenza con gli obiettivi di salute delle attività dei DSP utilizzando una griglia, contenente criteri sia legati all EBP sia a nuovi
6 GIUGNO 2008 Lavoro di gruppo in area vasta Valutazione efficacia e coerenza con gli obiettivi di salute delle attività dei DSP utilizzando una griglia, contenente criteri sia legati all EBP sia a nuovi
Daniela Galeone. Presentazione della STRATEGIA SULL ATTIVITÀ FISICA PER LA REGIONE EUROPEA DELL OMS
 Daniela Galeone Presentazione della STRATEGIA SULL ATTIVITÀ FISICA PER LA REGIONE EUROPEA DELL OMS 2016-2025 Roma - Camera dei Deputati 6 aprile 2016 Auletta dei gruppi parlamentari Via Campo Marzio 78
Daniela Galeone Presentazione della STRATEGIA SULL ATTIVITÀ FISICA PER LA REGIONE EUROPEA DELL OMS 2016-2025 Roma - Camera dei Deputati 6 aprile 2016 Auletta dei gruppi parlamentari Via Campo Marzio 78
Il Programma Guadagnare Salute a livello europeo e nazionale
 Il Programma Guadagnare Salute a livello europeo e nazionale Dott.ssa Maria Teresa Scotti Convegno: Progetto CCM Buone pratiche per l alimentazione e l attività fisica in età prescolare: promozione e sorveglianza
Il Programma Guadagnare Salute a livello europeo e nazionale Dott.ssa Maria Teresa Scotti Convegno: Progetto CCM Buone pratiche per l alimentazione e l attività fisica in età prescolare: promozione e sorveglianza
L infermiere e la prevenzione primaria dello scompenso cardiaco
 4 TH TURIN CARDIOVASCULAR NURSING CONVENTION L infermiere e la prevenzione primaria dello scompenso cardiaco GRAT INNOVATIONS IN CARDIOLOGY TORINO 20-21 NOVEMBRE 2008 Lucia Sabbadin Come cambia.. 2004
4 TH TURIN CARDIOVASCULAR NURSING CONVENTION L infermiere e la prevenzione primaria dello scompenso cardiaco GRAT INNOVATIONS IN CARDIOLOGY TORINO 20-21 NOVEMBRE 2008 Lucia Sabbadin Come cambia.. 2004
Prevenzione e solidarietà nella comunità di lavoro: l'impegno congiunto AVIS MIUR
 Prevenzione e solidarietà nella comunità di lavoro: l'impegno congiunto AVIS MIUR Roma, 14 luglio 2011 Dott.ssa Alessandra Moscaroli Segreteria Scientifica SEDE CENTRALE LILT La Lega Italiana per la Lotta
Prevenzione e solidarietà nella comunità di lavoro: l'impegno congiunto AVIS MIUR Roma, 14 luglio 2011 Dott.ssa Alessandra Moscaroli Segreteria Scientifica SEDE CENTRALE LILT La Lega Italiana per la Lotta
Il Progetto CCM SOCIAL NET SKILLS Il contributo della Regione Lazio
 Il Progetto CCM SOCIAL NET SKILLS Il contributo della Regione Lazio Dott.ssa Amalia Vitagliano Dirigente Area SanitàPubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e Screening Regione Lazio, 23
Il Progetto CCM SOCIAL NET SKILLS Il contributo della Regione Lazio Dott.ssa Amalia Vitagliano Dirigente Area SanitàPubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e Screening Regione Lazio, 23
Tavola rotonda: Prevenzione e stili di vita. Daniela Galeone
 Tavola rotonda: Prevenzione e stili di vita Daniela Galeone Primo Summit Mediterraneo Sanità Napoli, 12 febbraio 2016 Malattie croniche: un allarme mondiale 56 milioni di morti nel 2012 38 milioni (68%)
Tavola rotonda: Prevenzione e stili di vita Daniela Galeone Primo Summit Mediterraneo Sanità Napoli, 12 febbraio 2016 Malattie croniche: un allarme mondiale 56 milioni di morti nel 2012 38 milioni (68%)
STILI DI VITA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE. La Medicina Generale.. e non solo
 STILI DI VITA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE La Medicina Generale.. e non solo PROFILO DI SALUTE IN EMILIA- ROMAGNA PROFILO DI SALUTE IN EMILIA- ROMAGNA PROFILO DI SALUTE IN EMILIA- ROMAGNA PROFILO DI SALUTE
STILI DI VITA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE La Medicina Generale.. e non solo PROFILO DI SALUTE IN EMILIA- ROMAGNA PROFILO DI SALUTE IN EMILIA- ROMAGNA PROFILO DI SALUTE IN EMILIA- ROMAGNA PROFILO DI SALUTE
Il profilo di salute del Trentino
 Il profilo di salute del Trentino Pirous Fateh-Moghadam, Laura Battisti, Laura Ferrari Osservatorio per la salute Dipartimento lavoro e welfare Provincia autonoma di Trento La mortalità In Trentino ogni
Il profilo di salute del Trentino Pirous Fateh-Moghadam, Laura Battisti, Laura Ferrari Osservatorio per la salute Dipartimento lavoro e welfare Provincia autonoma di Trento La mortalità In Trentino ogni
WHP - Workplace Health Promotion La Rete lombarda delle aziende che promuovono salute
 Aziende che promuovono Salute WHP - Workplace Health Promotion La Rete lombarda delle aziende che promuovono salute A cura di M.A. Bianchi UOC Prevenzione e Promozione Salute nelle Comunità Programmi di
Aziende che promuovono Salute WHP - Workplace Health Promotion La Rete lombarda delle aziende che promuovono salute A cura di M.A. Bianchi UOC Prevenzione e Promozione Salute nelle Comunità Programmi di
TABAGISMO. Aosta, 5 6 novembre 2010 Gabriella FURFARO
 PROGRAMMA REGIONALE TABAGISMO Aosta, 5 6 novembre 2010 Gabriella FURFARO Atti programmatori DGR n. 4653 del 30 dicembre 2005: Piano regionale delle attività di Prevenzione sanitaria e promozione della
PROGRAMMA REGIONALE TABAGISMO Aosta, 5 6 novembre 2010 Gabriella FURFARO Atti programmatori DGR n. 4653 del 30 dicembre 2005: Piano regionale delle attività di Prevenzione sanitaria e promozione della
Il Programma nazionale Guadagnare salute
 Il Programma nazionale Guadagnare salute Daniela Galeone Workshop Stili di vita e salute Orvieto, 21 ottobre 2014 Sala dei 400 Centro Congressi Palazzo del Capitano del Popolo Le malattie croniche: un
Il Programma nazionale Guadagnare salute Daniela Galeone Workshop Stili di vita e salute Orvieto, 21 ottobre 2014 Sala dei 400 Centro Congressi Palazzo del Capitano del Popolo Le malattie croniche: un
LE INIZIATIVE DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL CCM
 La prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore Roma, 18 aprile 2007 LE INIZIATIVE DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL CCM Annamaria de Martino Dipartimento Prevenzione e Comunicazione Direzione
La prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore Roma, 18 aprile 2007 LE INIZIATIVE DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL CCM Annamaria de Martino Dipartimento Prevenzione e Comunicazione Direzione
Il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018. Lo stato di salute del Piemonte. Claudio Rabagliati
 Alessandria, 27 Ottobre 2015 Corso ECM PLP ASL AL incontra PRP. Il Piano Locale di Prevenzione ASL AL incontra il Piano Regionale di Prevenzione Il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018. Lo stato
Alessandria, 27 Ottobre 2015 Corso ECM PLP ASL AL incontra PRP. Il Piano Locale di Prevenzione ASL AL incontra il Piano Regionale di Prevenzione Il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018. Lo stato
con pillole di cultura TIPO DI PROGETTO Progetto sperimentale di promozione della salute AREA TEMATICA Stili di vita DATI GENERALI DEL PROGETTO
 con pillole di cultura TIPO DI PROGETTO Progetto sperimentale di promozione della salute AREA TEMATICA Stili di vita DATI GENERALI DEL PROGETTO Soggetto attuatore Gruppo Salute è Benessere Quartiere 4
con pillole di cultura TIPO DI PROGETTO Progetto sperimentale di promozione della salute AREA TEMATICA Stili di vita DATI GENERALI DEL PROGETTO Soggetto attuatore Gruppo Salute è Benessere Quartiere 4
La prevenzione dei tumori nel Piano di Prevenzione della Regione Emilia-Romagna. Marina Fridel. Bologna, 3 ottobre 2013
 La prevenzione dei tumori nel Piano di Prevenzione della Regione Emilia-Romagna Marina Fridel Bologna, 3 ottobre 2013 Piano Regionale della Prevenzione 2010 2013: Ha contribuito a orientare verso la salute
La prevenzione dei tumori nel Piano di Prevenzione della Regione Emilia-Romagna Marina Fridel Bologna, 3 ottobre 2013 Piano Regionale della Prevenzione 2010 2013: Ha contribuito a orientare verso la salute
11 MEETING ITALIANO CITTA SANE. Comunicazione e partecipazione per la promozione della salute Anno europeo dei cittadini
 11 MEETING ITALIANO CITTA SANE Comunicazione e partecipazione per la promozione della salute 2013 Anno europeo dei cittadini ASL E COMUNE DI MILANO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE Laura Agalbato Servizio
11 MEETING ITALIANO CITTA SANE Comunicazione e partecipazione per la promozione della salute 2013 Anno europeo dei cittadini ASL E COMUNE DI MILANO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE Laura Agalbato Servizio
Sorveglianza delle malattie croniche e dei comportamenti a rischio
 Sorveglianza delle malattie croniche e dei comportamenti a rischio Le malattie croniche sono la causa principale di morte nel mondo Secondo il rapporto Oms, circa 17 milioni di persone muoiono prematuramente
Sorveglianza delle malattie croniche e dei comportamenti a rischio Le malattie croniche sono la causa principale di morte nel mondo Secondo il rapporto Oms, circa 17 milioni di persone muoiono prematuramente
GUADAGNARE SALUTE: rendere facili le scelte salutari
 Ministero della Salute GUADAGNARE SALUTE: rendere facili le scelte salutari Daniela Galeone II Conferenza Nazionale BPCO Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva 14 novembre 2007 Inattività fisica, scorretta
Ministero della Salute GUADAGNARE SALUTE: rendere facili le scelte salutari Daniela Galeone II Conferenza Nazionale BPCO Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva 14 novembre 2007 Inattività fisica, scorretta
Diabete e prediabete :attualità e prospettive nel SSN. Annunziata Lapolla DPT di Medicina Università di Padova
 Diabete e prediabete :attualità e prospettive nel SSN Annunziata Lapolla DPT di Medicina Università di Padova L EPIDEMIA DEL DIABETE (WHO) Incremento della prevalenza del diabete Le cause: - Aumento dei
Diabete e prediabete :attualità e prospettive nel SSN Annunziata Lapolla DPT di Medicina Università di Padova L EPIDEMIA DEL DIABETE (WHO) Incremento della prevalenza del diabete Le cause: - Aumento dei
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria. Paolo Beltraminelli Direttore DSS
 Servizio di promozione e di valutazione sanitaria Attività e presentazione del Programma cantonale tabagismo 2015-2018 Paolo Beltraminelli Direttore DSS Bellinzona 6 febbraio 2015 Paolo Beltraminelli,
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria Attività e presentazione del Programma cantonale tabagismo 2015-2018 Paolo Beltraminelli Direttore DSS Bellinzona 6 febbraio 2015 Paolo Beltraminelli,
GLI STILI DI VITA E L EDUCAZIONE SANITARIA Referente dell Azienda USL6 Dr.D.Becherini
 GLI STILI DI VITA E L EDUCAZIONE SANITARIA Referente dell Azienda USL6 Dr.D.Becherini Gruppo di Lavoro Stili di Vita Educazione Sanitaria METODOLOGIA USATA Riunioni 19 Aprile 4 Maggio 27 Maggio Mail IPOTESI
GLI STILI DI VITA E L EDUCAZIONE SANITARIA Referente dell Azienda USL6 Dr.D.Becherini Gruppo di Lavoro Stili di Vita Educazione Sanitaria METODOLOGIA USATA Riunioni 19 Aprile 4 Maggio 27 Maggio Mail IPOTESI
MAMME LIBERE DAL FUMO: un esperienza che continua
 FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI OSTETRICHE MAMME LIBERE DAL FUMO: un esperienza che continua Rovigo, 29 gennaio e 5 febbraio 2007 Adria, 31 gennaio e 7 febbraio 2007 Rovigo, 30 marzo e 3 aprile 2007 Dr.ssa
FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI OSTETRICHE MAMME LIBERE DAL FUMO: un esperienza che continua Rovigo, 29 gennaio e 5 febbraio 2007 Adria, 31 gennaio e 7 febbraio 2007 Rovigo, 30 marzo e 3 aprile 2007 Dr.ssa
Il percorso delle SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE nelle Marche
 Il percorso delle SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE nelle Marche Da dove siamo partiti? Protocollo d Intesa siglato nel maggio 2011 tra Regione Marche e Ufficio Scolastico Regionale per Educazione alla Salute
Il percorso delle SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE nelle Marche Da dove siamo partiti? Protocollo d Intesa siglato nel maggio 2011 tra Regione Marche e Ufficio Scolastico Regionale per Educazione alla Salute
Partecipare al progetto salute Stili di vita e generazioni. Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari
 Partecipare al progetto salute Stili di vita e generazioni Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari Daniela Galeone Assemblea Nazionale di FederSanità ANCI Torino, 6-7 dicembre 2007 Sale Convegni
Partecipare al progetto salute Stili di vita e generazioni Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari Daniela Galeone Assemblea Nazionale di FederSanità ANCI Torino, 6-7 dicembre 2007 Sale Convegni
La prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore
 La prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore L esperienza della regione Emilia-Romagna a cura di Clara Curcetti Roma, 18 aprile 2007 Linee regionali di intervento per mitigare l impatto
La prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore L esperienza della regione Emilia-Romagna a cura di Clara Curcetti Roma, 18 aprile 2007 Linee regionali di intervento per mitigare l impatto
Ambulatorio Infermieristico Telemedicina
 Ambulatorio Infermieristico Telemedicina Dott. Orsatti Vincenzo Direttore N.O.D. Distretto n. 1 ASL 2 Abruzzo Dott. Falasca Pasquale Responsabile U.O. Integrazione Ospedale Territorio ASL 2 Abruzzo IL
Ambulatorio Infermieristico Telemedicina Dott. Orsatti Vincenzo Direttore N.O.D. Distretto n. 1 ASL 2 Abruzzo Dott. Falasca Pasquale Responsabile U.O. Integrazione Ospedale Territorio ASL 2 Abruzzo IL
L INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PER LA CONTINUITA ASSITENZIALE DELLA PERSONA FRAGILE
 L INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PER LA CONTINUITA ASSITENZIALE DELLA PERSONA FRAGILE L ospedale e il territorio: opportunità e criticità nell integrazione socio-sanitaria Francesca Busa Direttore Distretto
L INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PER LA CONTINUITA ASSITENZIALE DELLA PERSONA FRAGILE L ospedale e il territorio: opportunità e criticità nell integrazione socio-sanitaria Francesca Busa Direttore Distretto
Condizione di fumatore AULSS 3 Bassano del Grappa. nei due sessi. nelle classi di età. nei diversi livelli di istruzione
 L abitudine al fumo Il fumo di tabacco è il principale fattore di rischio di numerose patologie croniche, in particolare malattie cardiovascolari, respiratorie e neoplasie. Rappresenta inoltre il primo
L abitudine al fumo Il fumo di tabacco è il principale fattore di rischio di numerose patologie croniche, in particolare malattie cardiovascolari, respiratorie e neoplasie. Rappresenta inoltre il primo
CAPITOLO 17. ATTENZIONE DEI SANITARI E PROMOZIONE ALLA SALUTE
 Attenzione dei sanitari e promozione alla salute CAPITOLO 17. ATTENZIONE DEI SANITARI E PROMOZIONE ALLA SALUTE Sintesi. L indagine ISTMO indaga l attenzione dei sanitari nei confronto dei fattori di rischio
Attenzione dei sanitari e promozione alla salute CAPITOLO 17. ATTENZIONE DEI SANITARI E PROMOZIONE ALLA SALUTE Sintesi. L indagine ISTMO indaga l attenzione dei sanitari nei confronto dei fattori di rischio
Ministero della Salute
 Ministero della Salute JA Equity Action Attività, risultati e opportunità future La partecipazione dell Italia alla Joint Action Daniela Galeone Ministero della Salute Verona, 5 Febbraio 2014 Azienda Ospedaliera
Ministero della Salute JA Equity Action Attività, risultati e opportunità future La partecipazione dell Italia alla Joint Action Daniela Galeone Ministero della Salute Verona, 5 Febbraio 2014 Azienda Ospedaliera
I progetti di promozione della salute del PRP dell Emilia-RomagnaE
 Seminario La promozione della salute nei luoghi di lavoro Il ruolo del medico competente I progetti di promozione della salute del PRP dell Emilia-RomagnaE Emanuela Bedeschi Servizio Sanità Pubblica RER
Seminario La promozione della salute nei luoghi di lavoro Il ruolo del medico competente I progetti di promozione della salute del PRP dell Emilia-RomagnaE Emanuela Bedeschi Servizio Sanità Pubblica RER
Strategie e prospettive di Regione Lombardia per la promozione di stili di vita sani
 Strategie e prospettive di Regione Lombardia per la promozione di stili di vita sani Luigi Macchi,, Marina Bonfanti Anna Pavan, Maria Elena Pirola U.O. Governo della Prevenzione, tutela sanitaria,piano
Strategie e prospettive di Regione Lombardia per la promozione di stili di vita sani Luigi Macchi,, Marina Bonfanti Anna Pavan, Maria Elena Pirola U.O. Governo della Prevenzione, tutela sanitaria,piano
STRATEGIE CANTONALI. Promozione e Protezione della salute. Giorgio Merlani Medico cantonale. Dipartimento della sanità e della socialità
 STRATEGIE CANTONALI Promozione e Protezione della salute Giorgio Merlani Medico cantonale Il concetto di salute 1946 2014 Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non soltanto assenza di
STRATEGIE CANTONALI Promozione e Protezione della salute Giorgio Merlani Medico cantonale Il concetto di salute 1946 2014 Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non soltanto assenza di
La situazione attuale
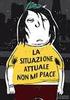 Convegno Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica ed operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell obesità e del diabete mellito Ministero della Salute 27 settembre 2011 Auditorium Biagio
Convegno Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica ed operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell obesità e del diabete mellito Ministero della Salute 27 settembre 2011 Auditorium Biagio
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E IL CONCETTO DI SALUTE
 GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E IL CONCETTO DI SALUTE Il concetto di salute OMS 1946: "la salute non è semplicemente l'assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 5
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E IL CONCETTO DI SALUTE Il concetto di salute OMS 1946: "la salute non è semplicemente l'assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 5
Il programma regionale WHP : una strategia riconosciuta dal Piano Nazionale della Prevenzione Liliana Coppola Direzione Generale Salute
 Il programma regionale WHP : una strategia riconosciuta dal Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 Liliana Coppola Direzione Generale Salute Il programma WHP - Lombardia Nasce da un percorso intersettoriale
Il programma regionale WHP : una strategia riconosciuta dal Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 Liliana Coppola Direzione Generale Salute Il programma WHP - Lombardia Nasce da un percorso intersettoriale
Piani per la salute e tabagismo Ferrara provincia senza fumo
 Piani per la Promozione della Salute Piani per la salute e tabagismo Ferrara provincia senza fumo Tabagismo in Emilia Romagna Nuove prospettive 4 giugno 2009 Maria Caterina Sateriale Piani di contrasto
Piani per la Promozione della Salute Piani per la salute e tabagismo Ferrara provincia senza fumo Tabagismo in Emilia Romagna Nuove prospettive 4 giugno 2009 Maria Caterina Sateriale Piani di contrasto
IL CONTRASTO DELL OBESITA : GLI INTERVENTI IN ATTO E IN PROGRAMMAZIONE
 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali IL CONTRASTO DELL OBESITA : GLI INTERVENTI IN ATTO E IN PROGRAMMAZIONE Dott.ssa Maria Teresa Menzano Roma - 20 novembre 2008 scorretta alimentazione,
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali IL CONTRASTO DELL OBESITA : GLI INTERVENTI IN ATTO E IN PROGRAMMAZIONE Dott.ssa Maria Teresa Menzano Roma - 20 novembre 2008 scorretta alimentazione,
PALMA SENZA FUMO. Progetto che si articola nel corso del 2009 e primi mesi del 2010
 PALMA SENZA FUMO Progetto che si articola nel corso del 2009 e primi mesi del 2010 Il fumo di tabacco è la prima causa di morte evitabile e rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo
PALMA SENZA FUMO Progetto che si articola nel corso del 2009 e primi mesi del 2010 Il fumo di tabacco è la prima causa di morte evitabile e rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo
Il protocollo con la UISP regionale Umbria. Strumento per una nuova alleanza nella rete
 Il protocollo con la UISP regionale Umbria Strumento per una nuova alleanza nella rete Orvieto 21 ottobre 2014 Mariadonata Giaimo Alimentazione e attività fisica degli umbri qualche dato dai sistemi di
Il protocollo con la UISP regionale Umbria Strumento per una nuova alleanza nella rete Orvieto 21 ottobre 2014 Mariadonata Giaimo Alimentazione e attività fisica degli umbri qualche dato dai sistemi di
Dati per sorvegliare: i PASSI dalla raccolta delle informazioni al loro utilizzo
 . La famiglia dei Sistemi di Sorveglianza: attualità e prospettive nell ASL CN1 Dati per sorvegliare: i PASSI dalla raccolta delle informazioni al loro utilizzo Cuneo 27 novembre 2012 a cura di Maria Teresa
. La famiglia dei Sistemi di Sorveglianza: attualità e prospettive nell ASL CN1 Dati per sorvegliare: i PASSI dalla raccolta delle informazioni al loro utilizzo Cuneo 27 novembre 2012 a cura di Maria Teresa
Prevenzione del fumo di sigaretta fra gli adolescenti del Veneto. Elizabeth Tamang Torino, 23 febbraio 2005
 Il Programma di prevenzione delle patologie fumo-correlate della Regione del Veneto Prevenzione del fumo di sigaretta fra gli adolescenti del Veneto Elizabeth Tamang Torino, 23 febbraio 2005 Cosa funziona
Il Programma di prevenzione delle patologie fumo-correlate della Regione del Veneto Prevenzione del fumo di sigaretta fra gli adolescenti del Veneto Elizabeth Tamang Torino, 23 febbraio 2005 Cosa funziona
4, milioni. milioni. POPOLAZIONE In aumento anziani e stranieri residenti 7,4% 14% 64,8% 21,2% più di
 POPOLAZIONE In aumento anziani e stranieri 60milioni più di 60.782.668 residenti Al 1 gennaio 2014 la popolazione residente supera i 60 milioni Continua il processo di invecchiamento della popolazione
POPOLAZIONE In aumento anziani e stranieri 60milioni più di 60.782.668 residenti Al 1 gennaio 2014 la popolazione residente supera i 60 milioni Continua il processo di invecchiamento della popolazione
LINEE D INDIRIZZO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA SUL TABAGISMO ( )
 ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2920 DEL 30 DICEMBRE 2008 LINEE D INDIRIZZO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA SUL TABAGISMO (2009 2011) PREMESSA Il fumo di tabacco rappresenta un problema prioritario, in quanto:
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2920 DEL 30 DICEMBRE 2008 LINEE D INDIRIZZO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA SUL TABAGISMO (2009 2011) PREMESSA Il fumo di tabacco rappresenta un problema prioritario, in quanto:
Piano Nazionale della Prevenzione
 Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 DAL SISTEMA DI SORVEGLIANZA AL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE Giulia Ciralli Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 Le strategie nazionali di settore in
Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 DAL SISTEMA DI SORVEGLIANZA AL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE Giulia Ciralli Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 Le strategie nazionali di settore in
Roberto Carloni Referente Istituzionale per la Regione Liguria dei Sistemi di Sorveglianza PASSI e PASSI d Argento
 L invecchiamento attivo e in salute: i risultati della sorveglianza PASSI d Argento 2012 in Liguria Genova 5 novembre 2013 - Teatro della Gioventù I sistemi di sorveglianza di popolazione: importanza per
L invecchiamento attivo e in salute: i risultati della sorveglianza PASSI d Argento 2012 in Liguria Genova 5 novembre 2013 - Teatro della Gioventù I sistemi di sorveglianza di popolazione: importanza per
Teorie e metodi della Promozione della Salute Corso base
 Teorie e metodi della Promozione della Salute Corso base ASL TO 4 Buone pratiche in Promozione della Salute Primum non nocere Promozione della salute e prevenzione basate su prove di efficacia e criteri
Teorie e metodi della Promozione della Salute Corso base ASL TO 4 Buone pratiche in Promozione della Salute Primum non nocere Promozione della salute e prevenzione basate su prove di efficacia e criteri
DELIBERAZIONE N. 53/28 DEL
 Oggetto: Recepimento dell Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014 (rep. Atti n. 156/CSR) recante Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2014-2018. Individuazione preliminare dei Programmi che saranno
Oggetto: Recepimento dell Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014 (rep. Atti n. 156/CSR) recante Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2014-2018. Individuazione preliminare dei Programmi che saranno
I dati dei sistemi di sorveglianza su sovrappeso, alimentazione, attività fisica
 La prevenzione del sovrappeso e dell obesità come strumento per la prevenzione del diabete e delle malattie croniche Genova 15 dicembre 2011 I dati dei sistemi di sorveglianza su sovrappeso, alimentazione,
La prevenzione del sovrappeso e dell obesità come strumento per la prevenzione del diabete e delle malattie croniche Genova 15 dicembre 2011 I dati dei sistemi di sorveglianza su sovrappeso, alimentazione,
PROGETTO WHP. Costruire una rete di aziende che promuovono salute
 PROGETTO Rete provinciale WHP Workplace Health Promotion Costruire una rete di aziende che promuovono salute 1 Pagina 2 Introduzione Da diversi anni, grazie anche all evoluzione della normativa in materia
PROGETTO Rete provinciale WHP Workplace Health Promotion Costruire una rete di aziende che promuovono salute 1 Pagina 2 Introduzione Da diversi anni, grazie anche all evoluzione della normativa in materia
Ambienti di lavoro liberi dal fumo.di tabacco
 Ambienti di lavoro liberi dal fumo.di tabacco D. Franchin, R. Paganoni, B. Pesenti, G.Luzzana Dipartimento di Prevenzione, ASL della Provincia di Bergamo; La IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca
Ambienti di lavoro liberi dal fumo.di tabacco D. Franchin, R. Paganoni, B. Pesenti, G.Luzzana Dipartimento di Prevenzione, ASL della Provincia di Bergamo; La IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca
LE PROSPETTIVE DELL ACTIVE AND HEALTHY AGEING
 LE PROSPETTIVE DELL ACTIVE AND HEALTHY AGEING DOTT.SSA MARIA TERESA MENZANO Convegno "Active and healthy ageing: il ruolo della sorveglianza epidemiologica PASSI D ARGENTO 26 settembre 2013 Roma Contesto
LE PROSPETTIVE DELL ACTIVE AND HEALTHY AGEING DOTT.SSA MARIA TERESA MENZANO Convegno "Active and healthy ageing: il ruolo della sorveglianza epidemiologica PASSI D ARGENTO 26 settembre 2013 Roma Contesto
L ABITUDINE AL FUMO. Reggio Emilia 19 maggio 2007
 L ABITUDINE AL FUMO Reggio Emilia 19 maggio 27 Dr.ssa Anna Maria Ferrari Dirigente Medico del Dipartimento di Sanità Pubblica Referente per l Educazione alla Salute dell AUSL di R.E. Il fumo di tabacco
L ABITUDINE AL FUMO Reggio Emilia 19 maggio 27 Dr.ssa Anna Maria Ferrari Dirigente Medico del Dipartimento di Sanità Pubblica Referente per l Educazione alla Salute dell AUSL di R.E. Il fumo di tabacco
I NUOVI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA. Giulia Cairella Area della Nutrizione SIAN ASL RMB
 I NUOVI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA Giulia Cairella Area della Nutrizione SIAN ASL RMB La revisione attuale prende le mosse dalla riflessione sull applicazione dei LEA dell Assistenza sanitaria collettiva
I NUOVI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA Giulia Cairella Area della Nutrizione SIAN ASL RMB La revisione attuale prende le mosse dalla riflessione sull applicazione dei LEA dell Assistenza sanitaria collettiva
Programmi di contrasto dell'isolamento e della solitudine: le esperienze promosse con il FRNA
 Salute e invecchiamento attivo in Emilia-Romagna. Il ruolo della sorveglianza PASSI d'argento Programmi di contrasto dell'isolamento e della solitudine: le esperienze promosse con il FRNA Bologna, 3 luglio
Salute e invecchiamento attivo in Emilia-Romagna. Il ruolo della sorveglianza PASSI d'argento Programmi di contrasto dell'isolamento e della solitudine: le esperienze promosse con il FRNA Bologna, 3 luglio
L IMPORTANZA DI STILI DI VITA SALUTARI. La prevenzione ha bisogno di sinergie e di comunicazione
 L IMPORTANZA DI STILI DI VITA SALUTARI La prevenzione ha bisogno di sinergie e di comunicazione I 5 FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI l alimentazione non sana, l inattivitl inattività fisica, l'uso di tabacco,
L IMPORTANZA DI STILI DI VITA SALUTARI La prevenzione ha bisogno di sinergie e di comunicazione I 5 FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI l alimentazione non sana, l inattivitl inattività fisica, l'uso di tabacco,
L abitudine al fumo. Come è distribuita l abitudine al fumo di sigaretta?
 L abitudine al fumo Il fumo di tabacco è tra i principali fattori di rischio nell insorgenza di numerose patologie cronicodegenerative (in particolare a carico dell apparato respiratorio e cardiovascolare)
L abitudine al fumo Il fumo di tabacco è tra i principali fattori di rischio nell insorgenza di numerose patologie cronicodegenerative (in particolare a carico dell apparato respiratorio e cardiovascolare)
Passi d Argento: la fotografia della popolazione anziana in Liguria. Rosamaria Cecconi Asl 3 Genovese Dipartimento di Prevenzione - Epidemiologia
 Passi d Argento: la fotografia della popolazione anziana in Liguria Rosamaria Cecconi Asl 3 Genovese Dipartimento di Prevenzione - Epidemiologia L obiettivo OMS per il 2020 è: ridurre di almeno 2 anni
Passi d Argento: la fotografia della popolazione anziana in Liguria Rosamaria Cecconi Asl 3 Genovese Dipartimento di Prevenzione - Epidemiologia L obiettivo OMS per il 2020 è: ridurre di almeno 2 anni
PROSPETTIVE DI PET THERAPY IN ASL3 GENOVESE
 PROSPETTIVE DI PET THERAPY IN ASL3 GENOVESE Giornata sulla «PET THERAPY» - Nuovi approcci in Liguria Genova, 17 Giugno 2016 - PALAZZO DUCALE Dottoressa Silvia A. Gotelli PERCHÉ IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE?
PROSPETTIVE DI PET THERAPY IN ASL3 GENOVESE Giornata sulla «PET THERAPY» - Nuovi approcci in Liguria Genova, 17 Giugno 2016 - PALAZZO DUCALE Dottoressa Silvia A. Gotelli PERCHÉ IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE?
Come è distribuita l abitudine al fumo di sigaretta e quali sono le caratteristiche dei fumatori di sigaretta? Uomini. Donne
 L abitudine al fumo Il fumo di tabacco è il principale fattore di rischio di numerose patologie croniche, in particolare malattie cardiovascolari, respiratorie e neoplasie. Rappresenta inoltre il primo
L abitudine al fumo Il fumo di tabacco è il principale fattore di rischio di numerose patologie croniche, in particolare malattie cardiovascolari, respiratorie e neoplasie. Rappresenta inoltre il primo
Guadagnare Salute Piemonte Comunità e ambienti di lavoro
 Programma 3 Guadagnare Salute Piemonte Situazione. Azioni previste nel periodo Sintesi complessiva Nel luglio 2016 è stato costituito il gruppo di lavoro regionale tematico, previsto per il 2015, denominato
Programma 3 Guadagnare Salute Piemonte Situazione. Azioni previste nel periodo Sintesi complessiva Nel luglio 2016 è stato costituito il gruppo di lavoro regionale tematico, previsto per il 2015, denominato
quali e quanti sono ed il loro peso economico LE MALATTIE CRONICHE CORRELATE AGLI STILI di VITA Il Sistema di Sorveglianza PASSI
 quali e quanti sono ed il loro peso economico LE MALATTIE CRONICHE CORRELATE AGLI STILI di VITA Il Sistema di Sorveglianza PASSI Michela Morri Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Rimini Le malattie cronico-degenerative
quali e quanti sono ed il loro peso economico LE MALATTIE CRONICHE CORRELATE AGLI STILI di VITA Il Sistema di Sorveglianza PASSI Michela Morri Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Rimini Le malattie cronico-degenerative
ELABORAZIONE DATI SONDAGGIO DIPENDENTI ASL
 ELABORAZIONE DATI SONDAGGIO DIPENDENTI ASL Premessa La sedentarietà è una delle prime dieci cause di mortalità e di morbilità. La quota di popolazione stimata di adulti sedentari a Lecco è intorno al 60-85%.
ELABORAZIONE DATI SONDAGGIO DIPENDENTI ASL Premessa La sedentarietà è una delle prime dieci cause di mortalità e di morbilità. La quota di popolazione stimata di adulti sedentari a Lecco è intorno al 60-85%.
Osservatorio Epidemiologico. L abitudine al fumo PASSI
 Osservatorio Epidemiologico L abitudine al fumo PASSI 2010-13 A cura di Antonio Fanolla, Sabine Weiss Osservatorio Epidemiologico della Provincia Autonoma di Bolzano Hanno contribuito alla realizzazione:
Osservatorio Epidemiologico L abitudine al fumo PASSI 2010-13 A cura di Antonio Fanolla, Sabine Weiss Osservatorio Epidemiologico della Provincia Autonoma di Bolzano Hanno contribuito alla realizzazione:
Che Cosa contiene la sigaretta. Dati statistici sul fumo. Fumo e gravidanza. I danni del fumo passivo
 Dr. Bernardi Simone MMG Pavullo 20/09/2014 Che Cosa contiene la sigaretta Dati statistici sul fumo Fumo e gravidanza I danni del fumo passivo CATRAME AGENTI OSSIDANTI MONOSSIDO DI CARBONIO NICOTINA TUMORI
Dr. Bernardi Simone MMG Pavullo 20/09/2014 Che Cosa contiene la sigaretta Dati statistici sul fumo Fumo e gravidanza I danni del fumo passivo CATRAME AGENTI OSSIDANTI MONOSSIDO DI CARBONIO NICOTINA TUMORI
Obiettivi di Salute & Informazione Epidemiologica
 Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Obiettivi di Salute & Informazione Epidemiologica Roma, 12 Ottobre 2004 Principali Cause di Morte Digerente Traumi MASCHI FEMMINE Respiratorie Tumori Cardiovascolari
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Obiettivi di Salute & Informazione Epidemiologica Roma, 12 Ottobre 2004 Principali Cause di Morte Digerente Traumi MASCHI FEMMINE Respiratorie Tumori Cardiovascolari
Suggerimenti per le azioni
 Indagine 2009: la salute delle persone con 65 anni ni e più in Emilia-Romagna Suggerimenti per le azioni Guido Federzoni Direzione Sanitaria, Programma fragilità Azienda USL di Modena Bologna, 20 gennaio
Indagine 2009: la salute delle persone con 65 anni ni e più in Emilia-Romagna Suggerimenti per le azioni Guido Federzoni Direzione Sanitaria, Programma fragilità Azienda USL di Modena Bologna, 20 gennaio
GUADAGNARE SALUTE ASL 4 DI TERNI
 GUADAGNARE SALUTE ASL 4 DI TERNI I DATI EPIDEMIOLOGICI Sez. II Abitudine al Fumo 2 Abitudine al Fumo Il fumo di tabacco è tra i principali fattori di rischio nell insorgenza di numerose patologie cronicodegenerative
GUADAGNARE SALUTE ASL 4 DI TERNI I DATI EPIDEMIOLOGICI Sez. II Abitudine al Fumo 2 Abitudine al Fumo Il fumo di tabacco è tra i principali fattori di rischio nell insorgenza di numerose patologie cronicodegenerative
U.C.C.P. San Giorgio del Sannio: presentazione primi dati di attività
 Emergenza cronicità in Campania: nuovi modelli organizzativi AFT e UCCP U.C.C.P. San Giorgio del Sannio: presentazione primi dati di attività Dott. Alessandro Cataffo Resp.le UOC Assistenza Sanitaria Distretto
Emergenza cronicità in Campania: nuovi modelli organizzativi AFT e UCCP U.C.C.P. San Giorgio del Sannio: presentazione primi dati di attività Dott. Alessandro Cataffo Resp.le UOC Assistenza Sanitaria Distretto
Azienda USL di Piacenza
 Azienda USL di Piacenza DGR 152 del 23.02.2015 Recepimento del PNP 2014-2018, approvazione del Profilo di Salute e delle indicazioni operative per la progettazione del PRP, individuazione dei programmi
Azienda USL di Piacenza DGR 152 del 23.02.2015 Recepimento del PNP 2014-2018, approvazione del Profilo di Salute e delle indicazioni operative per la progettazione del PRP, individuazione dei programmi
Monitoraggio di sovrappeso e obesità nelle donne in gravidanza e nei bambini in Friuli Venezia Giulia
 Monitoraggio di sovrappeso e obesità nelle donne in gravidanza e nei bambini in Friuli Venezia Giulia Dott. Luca Ronfani Dott.sa Claudia Carletti Dott.sa Paola Pani Epidemiologia Clinica e Ricerca sui
Monitoraggio di sovrappeso e obesità nelle donne in gravidanza e nei bambini in Friuli Venezia Giulia Dott. Luca Ronfani Dott.sa Claudia Carletti Dott.sa Paola Pani Epidemiologia Clinica e Ricerca sui
Segreteria di Stato Sanità, Segreteria di Stato Istruzione Authority Sanitaria, Istituto Sicurezza Sociale. OKkio alla SALUTE
 Segreteria di Stato Sanità, Segreteria di Stato Istruzione Authority Sanitaria, Istituto Sicurezza Sociale OKkio alla SALUTE PRESENTAZIONE TERZA RILEVAZIONE 2014 Dott. Andrea Gualtieri Coordinatore nazionale
Segreteria di Stato Sanità, Segreteria di Stato Istruzione Authority Sanitaria, Istituto Sicurezza Sociale OKkio alla SALUTE PRESENTAZIONE TERZA RILEVAZIONE 2014 Dott. Andrea Gualtieri Coordinatore nazionale
Corso di Sociologia della Salute. Promuovere, Comunicare, Educare alla salute: paradigmi e metodi
 Corso di Sociologia della Salute Promuovere, Comunicare, Educare alla salute: paradigmi e metodi Pre-venio o Pro-muovo?! Il paradigma preventivista: centratura sul rischio e sull istruttivo/informativo!
Corso di Sociologia della Salute Promuovere, Comunicare, Educare alla salute: paradigmi e metodi Pre-venio o Pro-muovo?! Il paradigma preventivista: centratura sul rischio e sull istruttivo/informativo!
SCHEMA DI PROTOCOLLO D INTESA tra. Regione Toscana. Il giorno del mese di dell anno 2016 presso Regione Toscana, Piazza del Duomo n.
 SCHEMA DI PROTOCOLLO D INTESA tra Regione Toscana Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale e Il giorno del mese di dell anno 2016 presso Regione Toscana, Piazza del Duomo n.10 sono
SCHEMA DI PROTOCOLLO D INTESA tra Regione Toscana Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale e Il giorno del mese di dell anno 2016 presso Regione Toscana, Piazza del Duomo n.10 sono
Tavolo Tecnico Intersettoriale Monza: città dei bambini e dei ragazzi 20 novembre 2003 settembre 2006
 Tavolo Tecnico Intersettoriale Monza: città dei bambini e dei ragazzi 20 novembre 2003 settembre 2006 Il bambino è un soggetto titolare di diritti, che la comunità ha il dovere di riconoscere. Il bambino
Tavolo Tecnico Intersettoriale Monza: città dei bambini e dei ragazzi 20 novembre 2003 settembre 2006 Il bambino è un soggetto titolare di diritti, che la comunità ha il dovere di riconoscere. Il bambino
IL DISTURBO MENTALE NELL ADOLESCENTE : Emergenza - priorità - sfida. Dott.ssa Zanetti Edda UONPIA A.O. SpedaliCivili
 IL DISTURBO MENTALE NELL ADOLESCENTE : Emergenza - priorità - sfida Dott.ssa Zanetti Edda UONPIA A.O. SpedaliCivili 12 Dicembre 2014 L infanzia e l adolescenza sono momenti cruciali per la costruzione
IL DISTURBO MENTALE NELL ADOLESCENTE : Emergenza - priorità - sfida Dott.ssa Zanetti Edda UONPIA A.O. SpedaliCivili 12 Dicembre 2014 L infanzia e l adolescenza sono momenti cruciali per la costruzione
Attività fisica nel Piano Prevenzione Daniela Galeone
 Attività fisica nel Piano Prevenzione 2014-2018 Daniela Galeone PROMUOVERE L ATTIVITÀ FISICA NEL PAZIENTE CON DIABETE TIPO 2 L esperienza di un progetto multicentrico Napoli, 5 giugno 2015 Le Malattie
Attività fisica nel Piano Prevenzione 2014-2018 Daniela Galeone PROMUOVERE L ATTIVITÀ FISICA NEL PAZIENTE CON DIABETE TIPO 2 L esperienza di un progetto multicentrico Napoli, 5 giugno 2015 Le Malattie
Il Ccm e la Sorveglianza delle Malattie Croniche Non Trasmissibili
 Il Ccm e la Sorveglianza delle Malattie Croniche Non Trasmissibili Informazioni sulla salute, i rischi e i determinanti a sostegno delle politiche e dei programmi di prevenzione Roma, 23 Giugno 2008 -
Il Ccm e la Sorveglianza delle Malattie Croniche Non Trasmissibili Informazioni sulla salute, i rischi e i determinanti a sostegno delle politiche e dei programmi di prevenzione Roma, 23 Giugno 2008 -
