mettere a punto modelli matematici per la simulazione dei fenomeni di degrado ambientale ed inquinamento delle acque dei laghi. Alcuni dei maggiori
|
|
|
- Emilio Gennaro Palla
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1. INTRODUZIONE I laghi rappresentano la maggiore risorsa d acqua dolce che può essere utilizzata in diversi modi: acqua per uso domestico, acqua per l agricoltura, per l estetica (bellezza del paesaggio e turismo). Vi sono, però, alcune attività antropiche che possono alterare questa delicata stabilità ambientale e minacciare la qualità di diversi ecosistemi mediante sostanze come: azoto, fosforo, particolati sospesi, metalli pesanti, pesticidi continuamente utilizzati dall uomo che possono provocare fenomeni generativi quali l eutrofizzazione o sversamenti accidentali di sostanze inquinanti. L utilizzo dell acqua è in grande crescita e le implicazioni economiche di questo aspetto non hanno bisogno di essere dimostrate. Per questo motivo l utilizzo del monitoraggio ambientale diviene una priorità fondamentale per la prevenzione e per assicurare che le generazioni future possano beneficiare di una risorsa ben conservata. I programmi di gestione del monitoraggio sono ostacolati dall insufficiente conoscenza che riguarda lo stato attuale della qualità e della quantità delle acque, conosc4nza che può essere incrementata dall integrazione di informazioni provenienti da dati di diverse scale spaziali e temporali. Tutti i fattori concernenti la qualità delle acque richiedono diverse misure in situ e diversi campioni per le analisi di laboratorio. Sebbene i metodi tradizionali diano accurate misure, spesso risulta difficoltosa la ripetibilità nel tempo delle misure con un incremento considerevole dei costi di attuazione e di gestione delle analisi in situ.in questo scenario acquista grande importanza il Remote Sensing, che in generale è un insieme di tecniche che portano alla raccolta, alla misura ed all analisi delle informazioni provenienti da sensori distanti dallo strumento impiegato dall osservatore. Il telrilevamento nasce, dunque, come strumento di utilizzo di sensori remoti in grado di fornire indicazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e che permettono di 1
2 mettere a punto modelli matematici per la simulazione dei fenomeni di degrado ambientale ed inquinamento delle acque dei laghi. Alcuni dei maggiori problemi ambientali dei laghi sono i seguenti: Sedimentazione; abbassamento del livello idrico; acidificazione; inquinamento tossico; eutrofizzazione; distruzione degli ecosistemi. Vi sono due metodi principali per la determinazione della qualità delle acque: Metodo fisico-chimico Metodo biologico il primo include la misura di parametri chimico-fisici come: il PH, la conduttività, l alcalinità, la temperatura, i solidi sospesi totali, la domanda chimica di ossigeno (COD), la domanda biochimica di ossigeno (BOD), l ossigeno disciolto, l azoto, i composti del fosforo e del cloro; i metodi biologici prendono in considerazione l inquinamento di un corpo idrico che potrà causare cambiamenti nell ambiente chimico e fisico dell acqua tali da provocare uno squilibri più o meno grave dell intero ecosistema. Per cui il metodo biologico è strettamente correlato al metodo chimico-fisico poiché senza la misura dei parametri relativi a quest ultimo metodo, non sarebbe possibile determinare se un corpo d acqua, in questo caso un lago, è soggetto a fenomeni di degrado e inquinamento delle proprie acque. Obiettivo del presente lavoro di tesi è la valutazione delle capacità e delle potenzialità del telerilevamento per il monitoraggio della qualità delle acque nei laghi, attraverso la descrizione delle tecniche, dei metodi e degli algoritmi allo stato attuale utilizzati e dall analisi di alcuni casi studio. Altri aspetti significativi: l interazione con gli utenti finali nel definire i loro bisogni per il monitoraggio della qualità delle acque; l acquisizione ed il confronto tra i dati telerilevati e quelli in situ; il perfezionamento dei metodi di acquisizione dei dati che includono la calibrazione e la correzione atmosferica; 2
3 la definizione dei sensori più adatti a monitorare la qualità delle acque nei laghi. L uso dei satelliti per la determinazione delle acque di un lago trae origine dall inizio del 1970; è ragionevole chiedersi come mai l adozione dei metodi satellitari per lo studio dei laghi non è stata attuata prima di quell anno. Ci sono tre ragioni principali: le infrastrutture e le capacità geospaziali del mondo di oggi non esistevano allora; le risorse dei dati satellitari erano limitate e i costi erano elevati; c era una insufficienza generale nel capire l interazione tra le immagini da satellite e la qualità dell acqua a scala non solo locale, ma anche regionale. Allo stato attuale vi sono ancora difficoltà tecniche e metodologiche che devono essere affrontate prima che la stima della qualità dell acqua attraverso il remote sensingvenga applicata su una base operazionale estesa. Tali impedimenti includono: Il bisogno di incrementare la conoscenza sulle proprietà riflessive spettrali intrinseche; Il bisogno di sviluppare programmi di campionamenti di campo ad hoc e per calibrare i dati dell immagine satellitare; Il bisogno di sviluppare algoritmi per l integrazione di dati di diversa natura e scala spaziale e temporale. Per tale ragione negli ultimi anni sono stati sviluppati, e se ne svilupperanno ancora, una serie di progetti della NASA e dell Upper Midwest RESEARCH, nonché da numerose università e centri di ricerca. In tal senso si stà provvedendo all utilizzo di spettroradiometri di campo per la creazione di un data-base che contenga al suo interno un archivio di dati limnologici di tipo biologico, chimico e fisico. Per il secondo ed il terzo aspetto sono state programmate nel tempo diverse missioni spaziali per il monitoraggio con sistemi satellitari multipli che includono il Landsat 5 Thematic Mapper TM, il Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+),il MODIS, etc. La risoluzione spaziale, una caratteristica molto importante dei sensori satellitari, è stata migliorata negli ultimi decenni, come risulta dalla risoluzione attualmente 3
4 utilizzata dalla Landsat Thematic Mapper di 30 m e con una risoluzione spettrale di 7 bande; questa sembra essere la più adatta allo stato attuale per monitorare le acque dei laghi. D altra parte la frequenza temporale di acquisizione delle immagini può a volte costituire un problema poiché varie sostanze, come il fitoplancton, i detriti, le sostanze inorganiche sospese e le sostanze organiche disciolte potrebbero variare in intervalli di tempo più piccoli della frequenza di acquisizione delle immagini telerilevate oltre alla loro distribuzione spaziale.di conseguenza appare chiaro come l utilizzo del remote sensing risulta uno strumento di notevole interesse e di forte sviluppo per il futuro, ma che va inteso come integrazione dei dati di campo per l incremento della conoscenza delle fenomenologie osservate. 4
5 2.ANALISI OTTICA DELL ACQUA Introduzione I parametri limnologici ultimamente sono spesso stimati grazie all applicazione del telerilevamento riferito ai laghi. Questo capitolo parla della teoria e della metodologia che è servita a correlare i parametri limnologici alle misure del telerilevamento. È stata, inoltre, presentata una revisione dei parametri ottici dell acqua dolce e come le variazioni in questi influenzeranno le misure di telerilevamento. Si è provveduto anche ad illustrare l informazione pratica sulla misura delle proprietà ottiche e gli esempi di come le proprietà ottiche possono essere usate per interpretare le immagini telerilevate. 2.1 Confronto tra il telerilevamento dei laghi e quello degli oceani Quando si considera l applicazione dei metodi per il telerilevamento relativi all acqua dolce è importante sottolineare che le proprietà ottiche dell acqua dolce sono molto più complesse di quelle dell oceano aperto (quando è maggiormente influenzato dal fitoplancton) e dell acqua pura stessa (in cui è intaccata la riflessione e l attenuazione delle radiazioni). Le differenze delle proprietà dell acqua dolce che devono essere considerate sono le seguenti: Materia Organica Colorata Disciolta (CDOM) o Gelbstoff che rientra nella maggior parte delle concentrazioni, e grandi parti di essa possono avere una sorgente alloctona. Materiale Particolato Inorganico Sospeso (SPIM) può intervenire sia nella maggior parte delle concentrazioni delle entrate fluviali e dei processi di risospensione. Gli spettri delle distribuzioni di misura del particolato organico possono differire significativamente da quelli trovati negli oceani. Le concentrazioni di materiale detritico organico può essere presentato da differenti sorgenti. 5
6 Le profondità ottiche più alte della colonna d acqua che saranno influenzate dalle informazioni raccolte dal telerilevamento possono essere meglio stratificate verticalmente, e la stratificazione spesso avviene con il massimo della biomassa nella prima misura. A causa dei fattori sopra descritti, le misure di telerilevamento delle risorse d acqua dolce sono molto complesse e meno determinabili di quelle dell acqua negli oceani. Nell acqua dolce l influenza dei pigmenti del fitoplancton (il parametro di maggiore interesse) sulla radiazione riflessa è spesso nascosto dall assorbimento del CDOM e del materiale detritico, e l interpretazione della radiazione riflessa è ancora più complicata a causa della dispersione che cambia in relazione alla concentrazione dell SPIM e alla sorgente. Una ragione per il successo delle scoperte del telerilevamento dei pigmenti del fitoplancton nelle acque degli oceani aperti è stata la relazione casuale tra i pigmenti, il CDOM e i materiali detritici (Aiken et al.,1995); gli ultimi due fattori sono dati da una sorgente autoctona che è il fitoplancton.sia i materiali detritici che il CDOM hanno delle sorgenti importanti alloctone che variano indipendentemente dalle concentrazioni del fitoplancton. Gli strumenti di telerilevamento registrano l energia elettromagnetica (riflessa o emessa ) da alcune combinazioni dei componenti di sostanza organica e inorganica della biosfera. Conseguentemente le informazioni elettromagnetiche devono essere convertite, attraverso attività di modellazione multidisciplinare appropriata, in stime delle variabili chimiche, fisiche o biologiche. I successi o i fallimenti dell uso degli strumenti di telerilevamento nella valutazione degli impatti ambientali sono, dunque, chiaramente dipendenti dai modelli e dagli algoritmi sviluppati e usati per la determinazione dei dati dei parametri ambientali determinati dai sensori del telerilevamento. Solo recentemente il telerilevamento e la strumentazione in situ hanno raggiunto una risoluzione spettrale capace di determinare gli spettri di assorbimento e di diffusione che sono caratteristici per le acque dolci. Inoltre, questi strumenti danno grandi opportunità di interpretare correttamente le caratteristiche delle acque dolci, essi richiedono anche un approccio diverso da quello che veniva usato nel passato. I miglioramenti della strumentazione hanno determinato un boom nella oceanografia e limnologia ottica e specialmente nel telerilevamento passivo. E ora possibile caratterizzare gli spettri di telerilevamento non solo dai colori o da altre caratteristiche spettrali ma anche dall utilizzo di caratteristiche integrali e modelli spettrali. 6
7 Storicamente c è stato un numero differente di metodi per determinare l informazione sulla qualità dell acqua dai dati di telerilevamento. Uno di questi è il classico metodo della correlazione, dove gli algoritmi sulla qualità specifica dell acqua sono derivati solamente dalle tecniche di regressione. Un altro metodo è la costruzione di un modello, che è utilizzato per determinare una banca dati degli spettri di riflessione per un largo range di combinazioni di sostanze attive otticamente, oppure l uso di questo tipo di modello per l interpretazione delle misure di telerilevamento per la stima di alcuni fenomeni nel corpo d acqua. Alcuni autori presentano la tecnica inversa per il telerilevamento, ottenuta dalla risoluzione dell equazione di trasmissione delle radiazioni o attraverso la determinazione delle deviazioni standard degli spettri di riflessione. Smith e Wilson (1981) proposero un approccio iterattivo. Mc Clain et al (1994) descrivono il così chiamato Metodo Europeo (Bricaud e Morel,1987).Differenti metodi sono utilizzati simultaneamente e non vi è differenza nella scelta di un metodo al posto di un altro. 2.2 Basi fisiche Il segnale misurato dal sensore di telerilevamento è una parte della radiazione emergente dalla superficie dell acqua (Lu, anche chiamato raggio di partenza) e il raggio aggiunto deriva dalla dispersione atmosferica. Inoltre, ogni stima della qualità dell acqua derivata dalle misure del telerilevamento dovrà essere basata su un effetto dei parametri della qualità dell acqua. La radiazione di partenza è una funzione dell intensità solare e dell angolo dei raggi solari, le quali sono variabili nel tempo, e sono proprietà ottiche dell acqua (IOPs) indipendenti dalla intensità e dalla geometria del raggio solare, ma variano in relazione alla concentrazione dei materiali disciolti e sospesi nell acqua. La riflessione dei raggi (anche conosciuta come riflessione RR (λ)) è il rapporto tra la upwelling radiance(lu)del corpo d acqua e la sua downwelling irradiance (Ed). Questa quantità è relativamente indipendente dalla luce ed è spesso stata approssimata ad una funzione empirica di due delle IOPs dell acqua RR( λ) = Lu( λ)/ed( λ) = 0.083bb( λ) / a ( λ) + bb( λ) (1) 7
8 ove: b b è il coefficiente di diffusione a (λ) è il coefficiente di assorbimento λ è la lunghezza d onda Generalmente si assume che le IOPs siano costanti nel tempo in un certo intervallo di tempo di campionamento. L equazione su scritta illustra chiaramente due relazioni tra le IOPs dell acqua e la radiazione riflessa. 2.3 MISURA DELLE PROPRIETA OTTICHE INTRISECHE (IOPs) La misura del telerilevamento dei laghi sarà sempre limitata dalla nostra abilità nel determinare a e b b, uno è determinato con due possibili scelte riguardanti la strategia di campionamento utilizzata per correggere o verificare le misure telerilevate della qualità dell acqua. L altro può essere determinato con un approccio più semplice della misura di una o più concentrazioni conosciute che riguardano le IOPs dell acqua e direttamente correlate ai dati di telerilevamento, oppure questo può essere determinato con un approccio diretto della misura delle IOPs stesse. Questi due approcci hanno entrambi i loro vantaggi e svantaggi, come si è discusso prima, ed essi risultano essere complementari. Per lo sviluppo, la determinazione e la verifica degli algoritmi di telerilevamento il Progetto Salmon ha adottato un approccio di due stadi per il campionamento e l analisi: 1. Simultaneo campionamento delle concentrazioni ottiche più importanti al tempo di raccolta dei dati di telerilevamento. Una importante componente di questo campionamento è la raccolta dei dati orizzontali dei parametri come la fluorescenza della clorofilla che può essere continuamente registrata usando il sistema di campionamento del flusso. Considerando la relazione tra le IOPs e le concentrazioni dell acqua può essere stabilito che il coefficiente di assorbimento varia come una funzione della materia organica sospesa e dell humus acquatico che può essere ripartito in Fitoplancton e tripton. La Backscattering sarà una funzione della materia organica e inorganica, ma nella maggior parte dei casi l influenza del materiale inorganico è maggiore di quello del materiale organico. 8
9 2. Mettere in relazione la stima delle IOPs, con le concentrazione dei pigmenti di Fitoplancton, concentrazioni di humus acquatico e concentrazioni del tripton e seston. La base di questo campionamento è quella di utilizzare le IOPs e le loro relazioni con le concentrazioni utilizzate per definire le variazioni di potenziale nella riflessione dei raggi, e di provvedere a dare una spiegazione meccanicistica che può essere successivamente utilizzata per sviluppare gli algoritmi di telerilevamento. Quando utilizziamo il secondo metodo descritto sopra, abbiamo bisogno di raccogliere dati sulle caratteristiche spettrali delle IOPs, e di modellare i risultati degli spettri dei raggi. L approccio migliore è quello di raccogliere direttamente l informazione sull assorbimento e la diffusione in modo tale che il riflesso dei raggi possa essere direttamente stimato con l equazione (1). Il vantaggio di questo approccio è stato quello di portare ad una visione meccanicistica dei processi ottici che determinano la riflessione dei raggi, e nella maggior parte dei casi è stato possibile collegare un IOP ai parametri di qualità dell acqua derivabili dall equazione (2). Questa conoscenza ci aiuterà nella interpretazione dei dati di telerilevamento e ridurrà grandemente la cattiva interpretazione di questi dati. Questo tipo di informazione permetterà anche di determinare modelli matematici di riflessione delle radiazioni. Con questi modelli diviene possibile non solo la stima della riflessione delle radiazioni da parte delle IOPs, ma anche la determinazione delle stime inverse delle IOPs. Le tecniche di modellazione inversa, usando le IOPs, devono essere ricondotte a modelli che collegano le caratteristiche ottiche di un corpo d acqua ad una regione geografica, che sono relativamente stabili nel tempo e nello spazio. Conseguentemente, i dati che mettono insieme una fase hanno bisogno non solo di includere il campionamento simultaneamente con il passaggio del satellite, ma devono anche ricoprire un vasto range di condizioni per creare un database che potrà essere utilizzato per il modello finale. Questo approccio è particolarmente vantaggioso se noi volessimo monitorare i laghi su una regolare e duratura base. Esso è stato scelto per il progetto Salmon ed è necessario per lo studio dei laghi Europei. Sarà estremamente necessario se il tempo di raccolta dati sarà separato dal tempo di misura del telerilevamento, questo semplificherà le logistiche e ridurrà i costi del tempo di campionamento. I maggiori svantaggi per la misura diretta delle IOPs sono dati dalle richieste di strumenti costosi e dalla lunga durata per mettere insieme i dati e per raccogliere i campioni da ogni stazione. 9
10 2.3.1 Sostanze che determinano le IOPs Nelle acque dolci l assorbimento e la diffusione sono dovute all acqua stessa, alle sostanze disciolte e al particolato. Qualche confusione può essere fatta sulla terminologia di queste componenti, ma Dekker (1993) utilizzò la seguente che risulta essere la meno ambigua. Essa sarà utilizzata in ciò che segue di questo capitolo: Acqua otticamente pura (w) Humus acquatico (ah) è il nome utilizzato per tutte le sostanze disciolte nelle acque dolci per scopi riguardanti il telerilevamento. Altri nomi utilizzati sono sostanza gialla, Gelbstoff e gilvin. Phitoplancton (ph) sono tutte le particelle pigmentate Tripton (t), particolato escluso il Fitoplancton, Alcune volte chiamato detrito. Seston (s) è il particolato totale, spesso chiamato semplicemente particolato. Il coefficiente di assorbimento può essere scomposto in altri quattro coefficienti: a( λ) = a w ( λ) + a ( λ) + a ( λ) + a ( λ) (2) ah ph t a(λ ) è il coeff. di assorbimento alla lunghezza d onda λ a w ( λ ) è il coefficiente di assorbimento dell acqua pura alla lunghezza d onda λ a ah(λ) è il coefficiente di assorbimento dell humus acquatico alla lunghezza d onda λ a ph(λ) è il coefficiente di assorbimento del fitoplancton alla lunghezza d onda λ a t (λ) è il coefficiente di assorbimento del tripton alla lunghezza d onda λ Le equazioni della backscattering (b b ) sono più complesse e di meccanica descrizione e variano non solo con la lunghezza d onda ma anche con la misura e l indice di rifrazione delle particelle sospese. Per la stima diretta della diffusione dalle concentrazioni dei solidi sospesi può essere richiesta la determinazione separata delle distribuzioni di misura delle particelle per entrambi le particelle organiche e inorganiche. Le proprietà ottiche connesse delle acque naturali seguono la Legge di Beer, secondo cui i coefficienti di assorbimento e diffusione sono proporzionali alle concentrazioni di differenti componenti dell acqua. Questo è il campo per la determinazione delle concentrazioni delle differenti componenti delle acque naturali dalle misure delle proprietà 10
11 ottiche ed inoltre per un approccio meccanicistico al telerilevamento.di seguito vi è una descrizione di come le componenti disciolte e particolate sono state descritte con l influenza dell assorbimento e della diffusione nelle acque dolci. Acqua pura L acqua pura assorbe inizialmente a circa 550 nm, e l assorbimento si accresce con l accrescersi della lunghezza d onda, mentre la diffusione è più grande per lunghezze d onda più piccole. Per queste ragioni l acqua pura è di colore blu. a w (λ) e b w (λ) possono essere considerati costanti. I valori di Pope e Fry (1997) sono riportati nella figura 1. FIGURA 1 11
12 Humus acquatico Il coefficiente di assorbimento dell humus acquatico segue una diminuzione esponenziale, spesso espressa da: aah λ) = aah( λ )exp( S( λ )) (3) ( 0 λ0 aah( λ 0 ) è il coefficiente di assorbimento alla lunghezza d onda compresa tra 30 e 450 nm S è la pendenza della funzione, che generalmente varia tra 0.01 e 0.02 La variazione temporale dell humus acquatico nell acqua dolce può diminuire molto nel tempo. La figura 2 mostra l assorbimento spettrale dell humus acquatico (gilvin) studiato durante il progetto Salmon. FIGURA 2 12
13 Fitoplancton L assorbimento del fitoplancton è dovuto maggiormente ai pigmenti fotosintetici. In generale, Dekker (1993) descrisse le caratteristiche di assorbimento del fitoplancton nell acqua dolce nel modo seguente: La clorofilla a assorbe maggiormente a 438 e 676 nm; β- carotene assorbe a 480 nm; il cianoficocianino può, se presente, assorbire a 624 nm; l assorbimento è circa 0 a 720 nm e più Kirk (1994) studiò come i pigmenti assorbono la luce, estendendo ciò ai diversi tipi di Fitoplancton. Possiamo definire il coefficiente di assorbimento specifico del Fitoplancton, denotato con a ph *(λ) come il coefficiente di sospensione del Fitoplancton corrispondente alla concentrazione di 1 mg di Chl-a m -3. Essa è espressa in m 2 mg Chl-a -1 (m -1 /mg Chl-a m -3 ). a ph *(λ) non è costante, ma varia, ad esempio con la misura, con il tipo e la concentrazione di pigmento del Fitoplancton e questo effetto del pigmento è stato discusso da molti autori (Kirk,1975; Morel e Bricaud,1981). Altri (Morel e Prieur,1977; Davies Colley et al,1986) hanno calcolato a ph *(λ) per diversi ambienti e Dekker (1993) trovò che a ph * a 676 nm variava tra e m 2 mg Chl-a -1 con una media di m 2 mg Chl-a -1 in 26 laghi mesotropici ed eutropici in Olanda. La Figura 3 mostra gli spettri di assorbimento della chlorophylla a per il Phitoplancton di acqua dolce. FIGURA 3 13
14 Tripton L assorbimento del Tripton è maggiormente dovuto alla frazione organica delle particelle e gli spettri spesso assomigliano a quelli dell humus acquatico. Questo significa che l assorbimento è alto a basse lunghezze d onda e decresce esponenzialmente fino a tendere a zero ad alte lunghezze d onda nel rosso.(figura 4). FIGURA 4 La diffusione del tripton è principalmente causata dalla frazione organica. Esistono poche misure spettrali ma la teoria (Morel e Prieur, 1977) e gli studi (Gallie e Murtha, 1992) suggeriscono che la diffusione è alta a piccole lunghezze d onda e viceversa, seguendo una legge esponenziale del tipo λ k, dove λ è la lunghezza d onda e k un esponente variabile tra 0 e 1 (Figura 5). Nella maggior parte delle acque dolci la diffusione totale è dominata da questa frazione organica di tripton. FIGURA 5 14
15 2.3.2 Analisi di laboratorio delle IOPs Le misure dei coefficienti di assorbimento dell acqua sono spesso fatte dalle analisi di laboratorio, e grazie alle recenti innovazioni nella strumentazione ora è possibile anche effettuare misurazioni in situ. Il maggiore vantaggio delle analisi di laboratorio riguardanti l assorbimento è che esse permettono di separare i coefficienti di assorbimento dell equazione (2). Lo svantaggio di questo metodo è che ci sono sempre alcuni cambiamenti nelle caratteristiche di assorbimento dovute al trattamento e all immagazzinamento dei campioni, e alcuni cambiamenti sono difficili da quantificare. Inoltre le misure di laboratorio dell assorbimento sono difficili e sottoposte al tempo che limita la risoluzione spaziale e temporale che potrebbe essere effettuata. Assorbimento dei particolati Ci sono diverse tecniche per determinare l assorbimento del particolato in laboratorio. Tutte hanno in comune il fatto di utilizzare uno spettrofotometro commercialmente avanzato, di solito equipaggiato con un accessorio di trasmissione della luce, che rende possibile misurare i campioni che contengono diverso materiale. L accessorio è costituito da un vetro di opale davanti al ricercatore di luce o da una sfera. Entrambi gli accessori sono utilizzati per catturare la maggior parte della luce diffusa dal campione se esso è posto all interno di essi. Le differenti tecniche utilizzano anche diversi metodi per raccogliere i campioni d acqua del lago prima delle misure, normalmente l acqua del lago ha un basso contenuto di particolato che sarà misurato direttamente in uno spettrometro. Il primo metodo fu descritto per la prima volta da Yentsch (1962) ed è stato ripreso da diversi autori, Mitchell (1990), Cleveland e Weidemann (1993), Tassan e Ferrari (1995). L acqua viene filtrata attraverso un filtro GF/F, a bassa pressione (< 120 mm Hg). Per immagazzinare gli aggregati delle particelle-filtro devono essere posti in un frigorifero senza luce. L aggregato della particella-filtro viene bagnato con acqua filtrata, e successivamente messo in uno spettrofotometro con la particella posta di fronte all accessorio di trasmissione della luce.un filtro GF/F bagnato nell acqua del lago è utilizzato come riferimento per tutte le lunghezze d onda.il filtro di riferimento può essere utilizzato per tutte le misure. Le misure sono generalmente fatte tra 350 e 750 nm. 15
Telerilevamento: una panoramica sui sistemi
 Telerilevamento: una panoramica sui sistemi Il telerilevamento: cos è? Il telerilevamento è la scienza (o l arte) di ottenere informazioni riguardanti un oggetto, un area o un fenomeno utilizzando dati
Telerilevamento: una panoramica sui sistemi Il telerilevamento: cos è? Il telerilevamento è la scienza (o l arte) di ottenere informazioni riguardanti un oggetto, un area o un fenomeno utilizzando dati
Convezione Conduzione Irraggiamento
 Sommario Cenni alla Termomeccanica dei Continui 1 Cenni alla Termomeccanica dei Continui Dai sistemi discreti ai sistemi continui: equilibrio locale Deviazioni dalle condizioni di equilibrio locale Irreversibilità
Sommario Cenni alla Termomeccanica dei Continui 1 Cenni alla Termomeccanica dei Continui Dai sistemi discreti ai sistemi continui: equilibrio locale Deviazioni dalle condizioni di equilibrio locale Irreversibilità
Respirometria applicata alla depurazione delle acque
 Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Università degli Studi di Trento Respirometria applicata alla depurazione delle acque Principi e metodi G.
Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Università degli Studi di Trento Respirometria applicata alla depurazione delle acque Principi e metodi G.
Figura 3.1: spettro elettromagnetico
 3 INDICI DI VEGETAZIONE Gli indici di vegetazione, derivanti da immagini satellitari o aeree sono un efficace fonte di informazioni per il monitoraggio della copertura vegetale. Questi indici si basano
3 INDICI DI VEGETAZIONE Gli indici di vegetazione, derivanti da immagini satellitari o aeree sono un efficace fonte di informazioni per il monitoraggio della copertura vegetale. Questi indici si basano
TECNICHE SPETTROSCOPICHE
 TECNICHE SPETTROSCOPICHE L interazione delle radiazioni elettromagnetiche con la materia e essenzialmente un fenomeno quantico, che dipende sia dalle proprieta della radiazione sia dalla natura della materia
TECNICHE SPETTROSCOPICHE L interazione delle radiazioni elettromagnetiche con la materia e essenzialmente un fenomeno quantico, che dipende sia dalle proprieta della radiazione sia dalla natura della materia
Misurare dallo spazio la produttività di foreste e colture agricole
 Misurare dallo spazio la produttività di foreste e colture agricole Perchè e come si fa? Federico Magnani Dipartimento di Scienze Agrarie Alma Mater - Università di Bologna Perchè misurare la produttività
Misurare dallo spazio la produttività di foreste e colture agricole Perchè e come si fa? Federico Magnani Dipartimento di Scienze Agrarie Alma Mater - Università di Bologna Perchè misurare la produttività
Lo Spettro Elettromagnetico
 Spettroscopia 1 Lo Spettro Elettromagnetico Lo spettro elettromagnetico è costituito da un insieme continuo di radiazioni (campi elettrici e magnetici che variano nel tempo, autogenerandosi) che va dai
Spettroscopia 1 Lo Spettro Elettromagnetico Lo spettro elettromagnetico è costituito da un insieme continuo di radiazioni (campi elettrici e magnetici che variano nel tempo, autogenerandosi) che va dai
PRESENZA DI METALLI PESANTI NELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO SU STRADE E PIAZZALI DELLE AREE INDUSTRIALI E IMPLICAZIONI PER IL TRATTAMENTO
 PRESENZA DI METALLI PESANTI NELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO SU STRADE E PIAZZALI DELLE AREE INDUSTRIALI E IMPLICAZIONI PER IL TRATTAMENTO Qualità delle acque. In prima analisi, a partire dagli idrogrammi
PRESENZA DI METALLI PESANTI NELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO SU STRADE E PIAZZALI DELLE AREE INDUSTRIALI E IMPLICAZIONI PER IL TRATTAMENTO Qualità delle acque. In prima analisi, a partire dagli idrogrammi
1. La luce delle stelle
 1. La luce delle stelle 2. La scala delle magnitudini La luminosità delle stelle appare diversa a occhio nudo. Ipparco di Nicea creò, intorno al 120 a.c., una scala di luminosità che assegnava il valore
1. La luce delle stelle 2. La scala delle magnitudini La luminosità delle stelle appare diversa a occhio nudo. Ipparco di Nicea creò, intorno al 120 a.c., una scala di luminosità che assegnava il valore
3. (Da Veterinaria 2006) Perché esiste il fenomeno della dispersione della luce bianca quando questa attraversa un prisma di vetro?
 QUESITI 1 FENOMENI ONDULATORI 1. (Da Medicina 2008) Perché un raggio di luce proveniente dal Sole e fatto passare attraverso un prisma ne emerge mostrando tutti i colori dell'arcobaleno? a) Perché riceve
QUESITI 1 FENOMENI ONDULATORI 1. (Da Medicina 2008) Perché un raggio di luce proveniente dal Sole e fatto passare attraverso un prisma ne emerge mostrando tutti i colori dell'arcobaleno? a) Perché riceve
DATABASE SOSTANZE Modulo TOXI
 DATABASE SOSTANZE Modulo TOXI All interno del modulo TOXI è stato previsto un Database sostanze che potesse raccogliere al suo interno tutti composti tossici d interesse per l utente e le loro proprietà
DATABASE SOSTANZE Modulo TOXI All interno del modulo TOXI è stato previsto un Database sostanze che potesse raccogliere al suo interno tutti composti tossici d interesse per l utente e le loro proprietà
Elaborazione dei dati. pkt /9
 Elaborazione dei dati pkt006-89-1.0 4/9 1 Argomenti 1. Analisi delle immagini multispettrali 2. Analisi dell istogramma e enfatizzazione del contrasto 3. Trasformata RGB-IHS 4. Filtraggio 5. Estrazione
Elaborazione dei dati pkt006-89-1.0 4/9 1 Argomenti 1. Analisi delle immagini multispettrali 2. Analisi dell istogramma e enfatizzazione del contrasto 3. Trasformata RGB-IHS 4. Filtraggio 5. Estrazione
Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/2010.
 Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/. Il recente Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali,
Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/. Il recente Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali,
TESI DI LAUREA in TECNICHE DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO M. Candidato: Lorenzo Panciroli
 TESI DI LAUREA in TECNICHE DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO M CONFRONTO TRA DATI TELERILEVATI AD ALTA E MEDIA RISOLUZIONE GEOMETRICA (WORLDVIEW E ASTER) PER LO STUDIO DEGLI EFFETTI DELL'
TESI DI LAUREA in TECNICHE DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO M CONFRONTO TRA DATI TELERILEVATI AD ALTA E MEDIA RISOLUZIONE GEOMETRICA (WORLDVIEW E ASTER) PER LO STUDIO DEGLI EFFETTI DELL'
Determinazione dell azoto totale e ammoniacale in spettrofotometria: modalità di calibrazione e confrontabilità nel tempo
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN BIOTECNOLOGIE Determinazione dell azoto totale e ammoniacale in spettrofotometria: modalità di calibrazione e confrontabilità nel tempo Relatore:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN BIOTECNOLOGIE Determinazione dell azoto totale e ammoniacale in spettrofotometria: modalità di calibrazione e confrontabilità nel tempo Relatore:
La spettrofotometria è una tecnica analitica, qualitativa e quantitativa e permette il riconoscimento e la quantizzazione di una sostanza in base al
 SPETTROFOTOMETRIA Tecnica che si basa sulla misura diretta dell intensitàdi colorecioènel potere da parte di una data soluzione di assorbire della luce in una regione specifica dello spettro. La spettrofotometria
SPETTROFOTOMETRIA Tecnica che si basa sulla misura diretta dell intensitàdi colorecioènel potere da parte di una data soluzione di assorbire della luce in una regione specifica dello spettro. La spettrofotometria
SEMINARIO TECNICO SISTEMI DI DIAGNOSTICA MOBILE DELLA INFRASTRUTTURA E DEL MATERIALE ROTABILE
 SEMINARIO TECNICO SISTEMI DI DIAGNOSTICA MOBILE DELLA INFRASTRUTTURA E DEL MATERIALE ROTABILE «Tecniche di interferometria satellitare per l individuazione di aree con dissesti non cartografati» Bologna
SEMINARIO TECNICO SISTEMI DI DIAGNOSTICA MOBILE DELLA INFRASTRUTTURA E DEL MATERIALE ROTABILE «Tecniche di interferometria satellitare per l individuazione di aree con dissesti non cartografati» Bologna
LA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA
 LA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA CONFIGURAZIONE DELLA RETE Il sistema di controllo della qualità dell aria in Valle d Aosta è finalizzato al monitoraggio della qualità dell aria dell intero
LA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA CONFIGURAZIONE DELLA RETE Il sistema di controllo della qualità dell aria in Valle d Aosta è finalizzato al monitoraggio della qualità dell aria dell intero
fenomeno livelli interni atomici legami chimici vibrazioni nm Å
 Spettroscopia Misura e studio dell andamento dell intensità della radiazione elettromagnetica/corpuscolare in funzione della frequenza (energia/lunghezza d onda) della radiazione stessa Quale tipo di informazione
Spettroscopia Misura e studio dell andamento dell intensità della radiazione elettromagnetica/corpuscolare in funzione della frequenza (energia/lunghezza d onda) della radiazione stessa Quale tipo di informazione
DAL SATELLITE POR CAMPANIA MISURA 1.9 PROGETTI MONOSETTORIALI
 LA CARTA DELLA VEGETAZIONE DAL SATELLITE POR CAMPANIA 2000-2006 MISURA 1.9 PROGETTI MONOSETTORIALI Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale, archeologico, naturale etnografico
LA CARTA DELLA VEGETAZIONE DAL SATELLITE POR CAMPANIA 2000-2006 MISURA 1.9 PROGETTI MONOSETTORIALI Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale, archeologico, naturale etnografico
Corso di Telerilevamento Lezione 2
 Corso di Telerilevamento Lezione 2 Curve di riflettanza Immagini digitali e visualizzazione La riflessione La radiazione incidente su di una determinata superficie può essere assorbita, riflessa o trasmessa
Corso di Telerilevamento Lezione 2 Curve di riflettanza Immagini digitali e visualizzazione La riflessione La radiazione incidente su di una determinata superficie può essere assorbita, riflessa o trasmessa
Schema a blocchi di uno spettrofluorimetro
 MONOCROMATORE EMISSIONE EM Schema a blocchi di uno spettrofluorimetro MONOCROMATORE ECCITAZIONE SORGENTE EXC RIVELATORE (TUBO FOTOMOLTIPLICATORE) Anche il DNA assorbe nell UV Cosa determina l assorbanza
MONOCROMATORE EMISSIONE EM Schema a blocchi di uno spettrofluorimetro MONOCROMATORE ECCITAZIONE SORGENTE EXC RIVELATORE (TUBO FOTOMOLTIPLICATORE) Anche il DNA assorbe nell UV Cosa determina l assorbanza
Astronomia Lezione 17/10/2011
 Astronomia Lezione 17/10/2011 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics B. W. Carroll, D. A. Ostlie, Addison Wesley
Astronomia Lezione 17/10/2011 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics B. W. Carroll, D. A. Ostlie, Addison Wesley
Applicazioni di Telerilevamento per studi agronomici
 Applicazioni di Telerilevamento per studi agronomici Dott. Mirco Boschetti 1 parte TLR Risposta spettrali della superfici Il comportamento della Influenza dei biofisici 2 parte Cos è un immagine Visualizzazione
Applicazioni di Telerilevamento per studi agronomici Dott. Mirco Boschetti 1 parte TLR Risposta spettrali della superfici Il comportamento della Influenza dei biofisici 2 parte Cos è un immagine Visualizzazione
I RISULTATI WQI 1) BOD
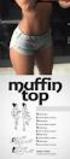 WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO
 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE TESI DI LAUREA Analisi dei dati di due campagne
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE TESI DI LAUREA Analisi dei dati di due campagne
Introduzione al corso di Econometria
 Università di Pavia Introduzione al corso di Econometria Eduardo Rossi Che cos è l econometria? Gli economisti sono interessati alle relazioni fra diverse variabili, per esempio la relazione tra salari
Università di Pavia Introduzione al corso di Econometria Eduardo Rossi Che cos è l econometria? Gli economisti sono interessati alle relazioni fra diverse variabili, per esempio la relazione tra salari
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA STRUTTURA DEL CORSO
 Prof.. Marino Mazzini UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA DIPARTIMENTO DI COSTRUZIONI MECCANICHE E NUCLEARI MODULO AMBIENTE STRUTTURA DEL CORSO Legislazione italiana di protezione dell ambiente La dispersione
Prof.. Marino Mazzini UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA DIPARTIMENTO DI COSTRUZIONI MECCANICHE E NUCLEARI MODULO AMBIENTE STRUTTURA DEL CORSO Legislazione italiana di protezione dell ambiente La dispersione
LETTURA CRITICA DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA
 LA STATISTICA NELLA RICERCA Raccolta dei dati Elaborazione Descrizione Una raccolta di dati non corretta, una loro presentazione inadeguata o un analisi statistica non appropriata rendono impossibile la
LA STATISTICA NELLA RICERCA Raccolta dei dati Elaborazione Descrizione Una raccolta di dati non corretta, una loro presentazione inadeguata o un analisi statistica non appropriata rendono impossibile la
Correzione radiometrica
 Correzione radiometrica Correzione delle immagini I dati raccolti dai sensori per telerilevamento necessitano, prima dell utilizzo nelle applicazioni, di una serie di correzioni per eliminare o limitare
Correzione radiometrica Correzione delle immagini I dati raccolti dai sensori per telerilevamento necessitano, prima dell utilizzo nelle applicazioni, di una serie di correzioni per eliminare o limitare
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 2. Laboratorio per l Osservazione e l Analisi della Terra e del Clima, ENEA 4
 H 2 O e processi radiative nell Artico: presentazione dei risultati preliminari dello spettrometro VESPA-22 ottenuti durante la campagna di misura SVAAP a Thule, Groenlandia G. Mevi 1,2, G. Muscari 1,
H 2 O e processi radiative nell Artico: presentazione dei risultati preliminari dello spettrometro VESPA-22 ottenuti durante la campagna di misura SVAAP a Thule, Groenlandia G. Mevi 1,2, G. Muscari 1,
La radiazione solare al suolo
 UNIVERSITÀ DI PISA La radiazione solare al suolo La radiazione solare rappresenta una importante fonte energetica rinnovabile, d altra parte la sua componente ultravioletta può avere effetti biologici
UNIVERSITÀ DI PISA La radiazione solare al suolo La radiazione solare rappresenta una importante fonte energetica rinnovabile, d altra parte la sua componente ultravioletta può avere effetti biologici
CAPITOLO 5. Stima della frequenza dei segnali dovuta al 40 K
 CAPITOLO 5 Stima della frequenza dei segnali dovuta al 40 K 5.1 Simulazione dei segnali registrabili con i fotomoltiplicatori. Nei capitoli precedenti, dopo aver illustrato brevemente la motivazione per
CAPITOLO 5 Stima della frequenza dei segnali dovuta al 40 K 5.1 Simulazione dei segnali registrabili con i fotomoltiplicatori. Nei capitoli precedenti, dopo aver illustrato brevemente la motivazione per
5.4. La matrice di correlazione
 6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote
 Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote Filippo Dalla, Angelo La Rocca, Luca Palmieri ABSTRACT La spettroscopia è la scienza che si occupa dello studio e della misura di uno spettro, i dati che
Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote Filippo Dalla, Angelo La Rocca, Luca Palmieri ABSTRACT La spettroscopia è la scienza che si occupa dello studio e della misura di uno spettro, i dati che
INTRODUZIONE ALLA SPETTROMETRIA
 INTRODUZIONE ALLA SPETTROMETRIA La misurazione dell assorbimento e dell emissione di radiazione da parte della materia è chiamata spettrometria. Gli strumenti specifici usati nella spettrometria sono chiamati
INTRODUZIONE ALLA SPETTROMETRIA La misurazione dell assorbimento e dell emissione di radiazione da parte della materia è chiamata spettrometria. Gli strumenti specifici usati nella spettrometria sono chiamati
Candidato: Alice Lucetta Giolitto Relatore: prof. A. Longhetto Co-Relatore: dott. M. Manfrin
 Università degli studi di Torino Facoltà di Scienze M.F.N. Corso di laurea in Fisica Candidato: Alice Lucetta Giolitto Relatore: prof. A. Longhetto Co-Relatore: dott. M. Manfrin 1 Sfruttando la teoria
Università degli studi di Torino Facoltà di Scienze M.F.N. Corso di laurea in Fisica Candidato: Alice Lucetta Giolitto Relatore: prof. A. Longhetto Co-Relatore: dott. M. Manfrin 1 Sfruttando la teoria
Capitolo 5 PROFILI IDROLOGICI DELLA COLONNA D ACQUA
 Capitolo Profili idrologici della colonna d acqua Capitolo PROFILI IDROLOGICI DELLA COLONNA D ACQUA.1 Materiali e metodi Per la caratterizzazione fisico-chimica della colonna d acqua le attività di misurazione
Capitolo Profili idrologici della colonna d acqua Capitolo PROFILI IDROLOGICI DELLA COLONNA D ACQUA.1 Materiali e metodi Per la caratterizzazione fisico-chimica della colonna d acqua le attività di misurazione
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI
 SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
LED 1/2012 ORTOFLORICULTURA
 LED 1/2012 ORTOFLORICULTURA Risparmiare energia La prima e miglior forma per produrre energia Assorbimento La natura della Luce Normalmente l energia prodotta da sole che raggiunge la terra come radiazione
LED 1/2012 ORTOFLORICULTURA Risparmiare energia La prima e miglior forma per produrre energia Assorbimento La natura della Luce Normalmente l energia prodotta da sole che raggiunge la terra come radiazione
Capitolo 2. Il Suono in Acqua. Propagazione di un segnale acustico in ambiente sottomarino
 Capitolo 2 Il Suono in Acqua Propagazione di un segnale acustico in ambiente sottomarino Nel seguito presentiamo, in forma schematica, i concetti fondamentali per la descrizione della propagazione del
Capitolo 2 Il Suono in Acqua Propagazione di un segnale acustico in ambiente sottomarino Nel seguito presentiamo, in forma schematica, i concetti fondamentali per la descrizione della propagazione del
Siti potenzialmente contaminati
 Regione del Veneto, Direzione Tutela dell Ambiente Magistrato alle Acque Servizio Informativo PROGETTO DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO METODOLOGIE DI TELERILEVAMENTO Siti potenzialmente contaminati
Regione del Veneto, Direzione Tutela dell Ambiente Magistrato alle Acque Servizio Informativo PROGETTO DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO METODOLOGIE DI TELERILEVAMENTO Siti potenzialmente contaminati
Spettroscopia. Spettroscopia
 Spettroscopia Spettroscopia IR Spettroscopia NMR Spettrometria di massa 1 Spettroscopia E un insieme di tecniche che permettono di ottenere informazioni sulla struttura di una molecola attraverso l interazione
Spettroscopia Spettroscopia IR Spettroscopia NMR Spettrometria di massa 1 Spettroscopia E un insieme di tecniche che permettono di ottenere informazioni sulla struttura di una molecola attraverso l interazione
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE. Procedura operativa del modello pressioni-impatti-misure
 AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE Procedura operativa del modello pressioni-impatti-misure Generalità Il modello è articolato su due distinti livelli applicativi: il primo a scala di distretto/subdistretto
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE Procedura operativa del modello pressioni-impatti-misure Generalità Il modello è articolato su due distinti livelli applicativi: il primo a scala di distretto/subdistretto
Sperimentazione NIR 2004
 Sperimentazione NIR 2004 Applicazione sui filtrati Pagina 1 di 6 Introduzione La breve sperimentazione di quest'anno è stata condotta al fine di valutare l'applicabilità della tecnologia NIR sui liquidi
Sperimentazione NIR 2004 Applicazione sui filtrati Pagina 1 di 6 Introduzione La breve sperimentazione di quest'anno è stata condotta al fine di valutare l'applicabilità della tecnologia NIR sui liquidi
Il 5 Rapporto IPCC. Nuove evidenze sul riscaldamento globale. Sandro Fuzzi Istituto di Scienze dell Atmosfera e del Clima CNR, Bologna
 Il 5 Rapporto IPCC Nuove evidenze sul riscaldamento globale Sandro Fuzzi Istituto di Scienze dell Atmosfera e del Clima CNR, Bologna Review Editor Chapter 7: Clouds and Aerosols Yann Arthus-Bertrand /
Il 5 Rapporto IPCC Nuove evidenze sul riscaldamento globale Sandro Fuzzi Istituto di Scienze dell Atmosfera e del Clima CNR, Bologna Review Editor Chapter 7: Clouds and Aerosols Yann Arthus-Bertrand /
SPETTROFOTOMETRIA. Tutti sinonimi
 SPETTROFOTOMETRIA SPETTROSCOPIA SPETTROMETRIA SPF FORS (Fiber Optics Reflectance Spectroscopy) RS (Reflectance Spectroscopy ma anche Raman Spectroscopy!!! ) Tutti sinonimi Analisi scientifiche per i Beni
SPETTROFOTOMETRIA SPETTROSCOPIA SPETTROMETRIA SPF FORS (Fiber Optics Reflectance Spectroscopy) RS (Reflectance Spectroscopy ma anche Raman Spectroscopy!!! ) Tutti sinonimi Analisi scientifiche per i Beni
MONITORAGGIO DEL PM10 MEDIANTE STAZIONE RILOCABILE VICENZA. Località Maddalene - Strada Pasubio (Cortile Scuole Elementari J.
 MONITORAGGIO DEL PM10 MEDIANTE STAZIONE RILOCABILE VICENZA Località Maddalene - Strada Pasubio (Cortile Scuole Elementari J. Cabianca) ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza Vincenzo Restaino Progetto
MONITORAGGIO DEL PM10 MEDIANTE STAZIONE RILOCABILE VICENZA Località Maddalene - Strada Pasubio (Cortile Scuole Elementari J. Cabianca) ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza Vincenzo Restaino Progetto
AZIENDE VENETE CHE ESPORTANO:
 PAOLA GAZZOLA, UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA SIMONE NOVELLO, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN AZIENDE VENETE CHE ESPORTANO: PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA CONDOTTA NEL 2008 La ricerca condotta nel 2008 sulle
PAOLA GAZZOLA, UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA SIMONE NOVELLO, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN AZIENDE VENETE CHE ESPORTANO: PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA CONDOTTA NEL 2008 La ricerca condotta nel 2008 sulle
CAPITOLO 6 Modelli matematici per la previsione delle fioriture di cianobatteri
 Presentazione delle nuove linee guida per la gestione delle fioriture dei cianobatteri nelle acque di balneazione Istituto Superiore di Sanità, 21 Aprile 2015 CAPITOLO 6 Modelli matematici per la previsione
Presentazione delle nuove linee guida per la gestione delle fioriture dei cianobatteri nelle acque di balneazione Istituto Superiore di Sanità, 21 Aprile 2015 CAPITOLO 6 Modelli matematici per la previsione
Le onde elettromagnetiche
 Campi elettrici variabili... Proprietà delle onde elettromagnetiche L intuizione di Maxwell (1831-1879) Faraday ed Henry misero in evidenza che un campo magnetico variabile genera un campo elettrico indotto.
Campi elettrici variabili... Proprietà delle onde elettromagnetiche L intuizione di Maxwell (1831-1879) Faraday ed Henry misero in evidenza che un campo magnetico variabile genera un campo elettrico indotto.
Antonio Triglia. Strumenti e misurazioni dei Campi Elettromagnetici
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA FONDAZIONE DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA CONVEGNO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO Aspetti normativi e tecnici Sala Riunioni - Ordine
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA FONDAZIONE DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA CONVEGNO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO Aspetti normativi e tecnici Sala Riunioni - Ordine
CORSO ANALISI CHIMICA MOD Analisi terreni ITIS VIOLA A.S. 2016/2017 SUOLO LEZIONE 1: INTRODUZIONE E CAMPIONAMENTO
 SUOLO LEZIONE 1: INTRODUZIONE E CAMPIONAMENTO 1 DEFINIZIONI SUOLO: Strato superficiale della crosta terrestre formatosi in seguito all alterazione del substrato roccioso per successive azioni fisiche,
SUOLO LEZIONE 1: INTRODUZIONE E CAMPIONAMENTO 1 DEFINIZIONI SUOLO: Strato superficiale della crosta terrestre formatosi in seguito all alterazione del substrato roccioso per successive azioni fisiche,
I PARAMETRI MICROCLIMATICI PER AMBIENTI INTERNI
 I PARAMETRI MICROCLIMATICI PER AMBIENTI INTERNI I PARAMETRI MICROCLIMATICI Temperatura Umidità Illuminazione TEMPERATURA TEMPERATURA La temperatura è la proprietà che caratterizza lo stato termico di un
I PARAMETRI MICROCLIMATICI PER AMBIENTI INTERNI I PARAMETRI MICROCLIMATICI Temperatura Umidità Illuminazione TEMPERATURA TEMPERATURA La temperatura è la proprietà che caratterizza lo stato termico di un
LAI-2000 Plant Canopy Analyzer. LAI-meter. Analizzatore di copertura fogliare
 LAI-2000 Plant Canopy Analyzer. LAI-meter. Analizzatore di copertura fogliare Sensore ottico a occhio di pesce (grandangolo) collegato ad una console munita di due porte seriali ed alimentata a batterie
LAI-2000 Plant Canopy Analyzer. LAI-meter. Analizzatore di copertura fogliare Sensore ottico a occhio di pesce (grandangolo) collegato ad una console munita di due porte seriali ed alimentata a batterie
L impatto delle acque piovane sulla qualità delle acque superficiali di una rete idraulica complessa: i canali della città di Padova
 L impatto delle acque piovane sulla qualità delle acque superficiali di una rete idraulica complessa: i canali della città di Padova Alberto Barausse Laboratorio di Analisi dei Sistemi Ambientali Dipartimento
L impatto delle acque piovane sulla qualità delle acque superficiali di una rete idraulica complessa: i canali della città di Padova Alberto Barausse Laboratorio di Analisi dei Sistemi Ambientali Dipartimento
Telerilevamento e Modellistica Forestale
 Telerilevamento e Modellistica Forestale Lezione 9 Indici di vegetazione Dario Papale Contributi: Vern Vanderbilt, TA- Quinn Hart, M. Meroni, CCRS Fattori che determinano la riflettanza della canopy 1.
Telerilevamento e Modellistica Forestale Lezione 9 Indici di vegetazione Dario Papale Contributi: Vern Vanderbilt, TA- Quinn Hart, M. Meroni, CCRS Fattori che determinano la riflettanza della canopy 1.
Il processo inferenziale consente di generalizzare, con un certo grado di sicurezza, i risultati ottenuti osservando uno o più campioni
 La statistica inferenziale Il processo inferenziale consente di generalizzare, con un certo grado di sicurezza, i risultati ottenuti osservando uno o più campioni E necessario però anche aggiungere con
La statistica inferenziale Il processo inferenziale consente di generalizzare, con un certo grado di sicurezza, i risultati ottenuti osservando uno o più campioni E necessario però anche aggiungere con
Quantificare la variabilità dei processi ecologici
 Scopo ecologia Quantificare la variabilità dei processi ecologici Comprensione dei meccanismi fondamentale per identificare gli effetti del disturbo antropico e per prevenire alterazioni su scala globale
Scopo ecologia Quantificare la variabilità dei processi ecologici Comprensione dei meccanismi fondamentale per identificare gli effetti del disturbo antropico e per prevenire alterazioni su scala globale
Campagna di monitoraggio della qualità dell aria Cogne
 Campagna di monitoraggio della qualità dell aria Cogne - 2016 Perché La campagna è stata effettuata per iniziativa di ARPA, al fine di valutare lo stato della qualità dell aria nel comune di Cogne, una
Campagna di monitoraggio della qualità dell aria Cogne - 2016 Perché La campagna è stata effettuata per iniziativa di ARPA, al fine di valutare lo stato della qualità dell aria nel comune di Cogne, una
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica
 Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
e che effetti ha sull ambiente
 Festival della Scienza Genova, 4 Novembre 2006 Il particolato atmosferico: cos è e che effetti ha sull ambiente Roberta Vecchi Istituto di Fisica Generale Applicata Università degli Studi di Milano & INFN
Festival della Scienza Genova, 4 Novembre 2006 Il particolato atmosferico: cos è e che effetti ha sull ambiente Roberta Vecchi Istituto di Fisica Generale Applicata Università degli Studi di Milano & INFN
POSSIBILI DOMANDE PER L ESAME DI CHIMICA ANALITICA
 POSSIBILI DOMANDE PER L ESAME DI CHIMICA ANALITICA 1 Come si definisce la chimica analitica? 2 Come si definisce un componente da determinare? 3 Quali sono i metodi di analisi in chimica analitica? Descriverli
POSSIBILI DOMANDE PER L ESAME DI CHIMICA ANALITICA 1 Come si definisce la chimica analitica? 2 Come si definisce un componente da determinare? 3 Quali sono i metodi di analisi in chimica analitica? Descriverli
Capitolo 5 Variabili aleatorie discrete notevoli Insegnamento: Statistica Applicata Corso di Laurea in "Scienze e Tecnologie Alimentari"
 Levine, Krehbiel, Berenson Statistica Capitolo 5 Variabili aleatorie discrete notevoli Insegnamento: Statistica Applicata Corso di Laurea in "Scienze e Tecnologie Alimentari" Unità Integrata Organizzativa
Levine, Krehbiel, Berenson Statistica Capitolo 5 Variabili aleatorie discrete notevoli Insegnamento: Statistica Applicata Corso di Laurea in "Scienze e Tecnologie Alimentari" Unità Integrata Organizzativa
Statistica. Capitolo 12. Regressione Lineare Semplice. Cap. 12-1
 Statistica Capitolo 1 Regressione Lineare Semplice Cap. 1-1 Obiettivi del Capitolo Dopo aver completato il capitolo, sarete in grado di: Spiegare il significato del coefficiente di correlazione lineare
Statistica Capitolo 1 Regressione Lineare Semplice Cap. 1-1 Obiettivi del Capitolo Dopo aver completato il capitolo, sarete in grado di: Spiegare il significato del coefficiente di correlazione lineare
MA + H + MAH + Materiale: 500 cc di soluzione di NaOH 0.01 M 500 cc di soluzione di HCl 0.01 M fresca Metil-arancio (MA) Etanolo Acqua distillata
 Cambiamenti nell aspetto degli spettri di assorbimento elettronico del metilarancio in funzione del ph a seguito della reazione di protonazione del metilarancio. Scopo dell esperimento è osservare la variazione
Cambiamenti nell aspetto degli spettri di assorbimento elettronico del metilarancio in funzione del ph a seguito della reazione di protonazione del metilarancio. Scopo dell esperimento è osservare la variazione
0 altimenti 1 soggetto trova lavoroentro 6 mesi}
 Lezione n. 16 (a cura di Peluso Filomena Francesca) Oltre alle normali variabili risposta che presentano una continuità almeno all'interno di un certo intervallo di valori, esistono variabili risposta
Lezione n. 16 (a cura di Peluso Filomena Francesca) Oltre alle normali variabili risposta che presentano una continuità almeno all'interno di un certo intervallo di valori, esistono variabili risposta
INTRODUZIONE ALLA SPETTROMETRIA
 INTRODUZIONE ALLA SPETTROMETRIA La misurazione dell assorbimento e dell emissione di radiazione da parte della materia è chiamata spettrometria. Gli strumenti specifici usati nella spettrometria sono chiamati
INTRODUZIONE ALLA SPETTROMETRIA La misurazione dell assorbimento e dell emissione di radiazione da parte della materia è chiamata spettrometria. Gli strumenti specifici usati nella spettrometria sono chiamati
La mobilità degli elementi chimici
 La mobilità degli elementi chimici Gli ioni contenuti nella parte sinistra del diagramma sono quelli che in soluzione si presentano sotto forma di cationi semplici. Gli ioni nella parte centrale del diagramma
La mobilità degli elementi chimici Gli ioni contenuti nella parte sinistra del diagramma sono quelli che in soluzione si presentano sotto forma di cationi semplici. Gli ioni nella parte centrale del diagramma
Proprio il diverso comportamento di una superficie, in relazione alla luce solare che la colpisce, ne determina il colore
 Cos è un immagine delle immagini IL Colore delle immagini Proprio il diverso comportamento di una superficie, in relazione alla luce solare che la colpisce, ne determina il colore Il colore è però una
Cos è un immagine delle immagini IL Colore delle immagini Proprio il diverso comportamento di una superficie, in relazione alla luce solare che la colpisce, ne determina il colore Il colore è però una
Allegato B Contenuti generali per un corso di perfezionamento rivolto a tecnici in acustica (durata minima di 180 ore).
 Allegato B Contenuti generali per un corso di perfezionamento rivolto a tecnici in acustica (durata minima di 180 ore). Il corso deve rispondere ai requisiti tipici di un corso annuale di perfezionamento
Allegato B Contenuti generali per un corso di perfezionamento rivolto a tecnici in acustica (durata minima di 180 ore). Il corso deve rispondere ai requisiti tipici di un corso annuale di perfezionamento
LIDAR (Light Detection and Ranging)
 LIDAR (Light Detection and Ranging) Si usano laser a infrarossi con ricevitore (fotodiodo) co-locato o dis-locato. Si basano sul back-scattering. Utilizzano lo stesso principio del Radar: lo strumento
LIDAR (Light Detection and Ranging) Si usano laser a infrarossi con ricevitore (fotodiodo) co-locato o dis-locato. Si basano sul back-scattering. Utilizzano lo stesso principio del Radar: lo strumento
Esperienze di spettrofotometria per la scuola, con arduino
 Esperienze di spettrofotometria per la scuola, con arduino Andrea Canesi (1), Daniele Grosso (2) 1. Ministero della Pubblica Istruzione Liceo Classico e Linguistico C. Colombo, Genova 2. Università di
Esperienze di spettrofotometria per la scuola, con arduino Andrea Canesi (1), Daniele Grosso (2) 1. Ministero della Pubblica Istruzione Liceo Classico e Linguistico C. Colombo, Genova 2. Università di
La Laguna di Venezia. I Parametri
 La Laguna di Venezia La Laguna di Venezia rappresenta un ambiente unico al mondo. È collegata al mare Adriatico attraverso 3 bocche di porto: Chioggia, Malamocco e Porto Lido. Si tratta di un ecotono,
La Laguna di Venezia La Laguna di Venezia rappresenta un ambiente unico al mondo. È collegata al mare Adriatico attraverso 3 bocche di porto: Chioggia, Malamocco e Porto Lido. Si tratta di un ecotono,
Report mensile sulla qualita dell aria
 Sezione provinciale di Report mensile sulla qualita dell aria provincia: periodo di riferimento: 01/01/2017 - Stazioni di monitoraggio stazioni di monitoraggio 1 2 3 Flaminia 4 5 2 3 5 1 4 zone Appennino
Sezione provinciale di Report mensile sulla qualita dell aria provincia: periodo di riferimento: 01/01/2017 - Stazioni di monitoraggio stazioni di monitoraggio 1 2 3 Flaminia 4 5 2 3 5 1 4 zone Appennino
 Pirometro Ottico Fig. 8 - Pirometro ottico a filamento evanescente. Questo tipo di termometro sfrutta il colore per indicare la temperatura di un corpo. Infatti, ogni corpo emette radiazione elettromagnetica
Pirometro Ottico Fig. 8 - Pirometro ottico a filamento evanescente. Questo tipo di termometro sfrutta il colore per indicare la temperatura di un corpo. Infatti, ogni corpo emette radiazione elettromagnetica
HUMAN CENTRIC LIGHTING nel settore industriale
 HUMAN CENTRIC LIGHTING nel settore industriale Direttore Commerciale & Marketing Light Totale dei consumi finali di energia elettrica in Italia nei diversi settori (309,8 TWh) Fonte Terna Agricoltura 5,4
HUMAN CENTRIC LIGHTING nel settore industriale Direttore Commerciale & Marketing Light Totale dei consumi finali di energia elettrica in Italia nei diversi settori (309,8 TWh) Fonte Terna Agricoltura 5,4
Statistica di base per l analisi socio-economica
 Laurea Magistrale in Management e comunicazione d impresa Statistica di base per l analisi socio-economica Giovanni Di Bartolomeo gdibartolomeo@unite.it Definizioni di base Una popolazione è l insieme
Laurea Magistrale in Management e comunicazione d impresa Statistica di base per l analisi socio-economica Giovanni Di Bartolomeo gdibartolomeo@unite.it Definizioni di base Una popolazione è l insieme
Grandezze fotometriche
 Capitolo 3 Grandezze fotometriche 3.1 Intensità luminosa E una grandezza vettoriale di simbolo I. Ha come unità di misura la candela(cd). La candela è l unità di misura fondamentale del sistema fotometrico.
Capitolo 3 Grandezze fotometriche 3.1 Intensità luminosa E una grandezza vettoriale di simbolo I. Ha come unità di misura la candela(cd). La candela è l unità di misura fondamentale del sistema fotometrico.
Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Fisica Corso di laurea triennale in FISICA. Anno accademico 2013/14. Figure utili da libri di testo
 Università degli Studi di Milano Dipartimento di Fisica Corso di laurea triennale in FISICA Anno accademico 2013/14 Figure utili da libri di testo Onde & Oscillazioni Corso A Studenti con il cognome che
Università degli Studi di Milano Dipartimento di Fisica Corso di laurea triennale in FISICA Anno accademico 2013/14 Figure utili da libri di testo Onde & Oscillazioni Corso A Studenti con il cognome che
Grandezze fisiche e loro misura
 Grandezze fisiche e loro misura Cos è la fisica? e di che cosa si occupa? - Scienza sperimentale che studia i fenomeni naturali suscettibili di sperimentazione e caratterizzati da entità o grandezze misurabili.
Grandezze fisiche e loro misura Cos è la fisica? e di che cosa si occupa? - Scienza sperimentale che studia i fenomeni naturali suscettibili di sperimentazione e caratterizzati da entità o grandezze misurabili.
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI
 SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
Metodi spettroscopici
 Metodi spettroscopici I metodi spettroscopici sono tecniche sperimentali basate sull interazione tra energia e materia per la determinazione di proprietà fisiche e chimiche. Metodi spettroscopici L interazione
Metodi spettroscopici I metodi spettroscopici sono tecniche sperimentali basate sull interazione tra energia e materia per la determinazione di proprietà fisiche e chimiche. Metodi spettroscopici L interazione
L irraggiamento termico
 L irraggiamento termico Trasmissione del Calore - 42 Il calore può essere fornito anche mediante energia elettromagnetica; ciò accade perché quando un fotone, associato ad una lunghezza d onda compresa
L irraggiamento termico Trasmissione del Calore - 42 Il calore può essere fornito anche mediante energia elettromagnetica; ciò accade perché quando un fotone, associato ad una lunghezza d onda compresa
Il processo di macinazione spesso serve anche per la miscelazione.
 La macinazione rappresenta una fase fondamentale e molto onerosa nella produzione ceramica. Può essere condotta attraverso diversi processi: 1) Mulino a rulli (in acciaio alto-legato o con rivestimento
La macinazione rappresenta una fase fondamentale e molto onerosa nella produzione ceramica. Può essere condotta attraverso diversi processi: 1) Mulino a rulli (in acciaio alto-legato o con rivestimento
Misura del coefficiente di assorbimento di vari materiali in funzione dell'energia del fascio dei fotoni incidenti
 materiali in funzione dell'energia del fascio dei fotoni Esperto Qualificato LNF - INFN Interazioni delle particelle indirettamente ionizzanti con la materia Le particelle indirettamente ionizzanti, principalmente
materiali in funzione dell'energia del fascio dei fotoni Esperto Qualificato LNF - INFN Interazioni delle particelle indirettamente ionizzanti con la materia Le particelle indirettamente ionizzanti, principalmente
Esploriamo la chimica
 1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 1 Misure e grandezze 1. Il Sistema Internazionale di Unità di misura 2. Grandezze estensive
1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 1 Misure e grandezze 1. Il Sistema Internazionale di Unità di misura 2. Grandezze estensive
Profili di trasmissione dei filtri interferenziali del telescopio PSPT
 I.N.A.F Osservatorio Astronomico di Roma Profili di trasmissione dei filtri interferenziali del telescopio PSPT Mauro Centrone Fabrizio Giorgi Nota tecnica - 2003 1 Introduzione I filtri interferenziali
I.N.A.F Osservatorio Astronomico di Roma Profili di trasmissione dei filtri interferenziali del telescopio PSPT Mauro Centrone Fabrizio Giorgi Nota tecnica - 2003 1 Introduzione I filtri interferenziali
Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS)
 Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS) adacher@dia.uniroma3.it Programma La simulazione ad eventi discreti, è una metodologia fondamentale per la valutazione delle prestazioni di sistemi complessi (di
Modelli e Metodi per la Simulazione (MMS) adacher@dia.uniroma3.it Programma La simulazione ad eventi discreti, è una metodologia fondamentale per la valutazione delle prestazioni di sistemi complessi (di
DINAMICA DEGLI INQUINANTI A.A PROPRIETA DELL ATMOSFERA PROF. RENATO BACIOCCHI
 DINAMICA DEGLI INQUINANTI A.A. 2012 2013 PROPRIETA DELL ATMOSFERA PROF. RENATO BACIOCCHI ARGOMENTI TRATTATI: 1. ATMOSFERA Estensione e struttura dell atmosfera Composizione dell aria Principali parametri
DINAMICA DEGLI INQUINANTI A.A. 2012 2013 PROPRIETA DELL ATMOSFERA PROF. RENATO BACIOCCHI ARGOMENTI TRATTATI: 1. ATMOSFERA Estensione e struttura dell atmosfera Composizione dell aria Principali parametri
La Spettroscopia in Biologia
 La Spettroscopia in Biologia Linda Avesani Dip. Scientifico e Tecnologico Università di Verona Spettroscopia e Proprietà della luce La spettroscopia in biologia studia la struttura e la dinamica delle
La Spettroscopia in Biologia Linda Avesani Dip. Scientifico e Tecnologico Università di Verona Spettroscopia e Proprietà della luce La spettroscopia in biologia studia la struttura e la dinamica delle
La qualità nella statistica ambientale
 X CONFERENZA NAZIONALE DI STATISTICA Sessione Qualità della statistica ufficiale La qualità nella statistica ambientale Daniela Cocchi, Università di Bologna Roma, 16 dicembre 2010 I cambiamenti ambientali
X CONFERENZA NAZIONALE DI STATISTICA Sessione Qualità della statistica ufficiale La qualità nella statistica ambientale Daniela Cocchi, Università di Bologna Roma, 16 dicembre 2010 I cambiamenti ambientali
A cura di Arpa Emilia-Romagna Autori: S. Violanti, M. Ricciotti, F. Zinoni. Che cosa è la radiazione ultravioletta (RUV)?
 A cura di Arpa Emilia-Romagna Autori: S. Violanti, M. Ricciotti, F. Zinoni Che cosa è la radiazione ultravioletta (RUV)? Lo spettro elettromagnetico è costituito da diversi tipi di radiazioni a seconda
A cura di Arpa Emilia-Romagna Autori: S. Violanti, M. Ricciotti, F. Zinoni Che cosa è la radiazione ultravioletta (RUV)? Lo spettro elettromagnetico è costituito da diversi tipi di radiazioni a seconda
Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali Ambientali e per la Mobilità
 WORKSHOP Progetto regionale PATOS L inquinamento da materiale particolato fine PM10 e PM2,5 in Toscana: cause e soluzioni 29 Novembre 2012 Sala Pegaso Palazzo Strozzi Sacrati - Piazza Duomo, 10 - Firenze
WORKSHOP Progetto regionale PATOS L inquinamento da materiale particolato fine PM10 e PM2,5 in Toscana: cause e soluzioni 29 Novembre 2012 Sala Pegaso Palazzo Strozzi Sacrati - Piazza Duomo, 10 - Firenze
La misura della temperatura
 Calore e temperatura 1. La misura della temperatura 2. La dilatazione termica 3. La legge fondamentale della termologia 4. Il calore latente 5. La propagazione del calore La misura della temperatura La
Calore e temperatura 1. La misura della temperatura 2. La dilatazione termica 3. La legge fondamentale della termologia 4. Il calore latente 5. La propagazione del calore La misura della temperatura La
DEFINIZIONE DI RADIANZA La radiazione è caratterizzata tramite la Radianza Spettrale, I (λ, θ, φ, T), definita come la densità di potenza per unità di
 SISTEMI PASSIVI Ogni corpo a temperatura T diversa da 0 K irradia spontaneamente potenza elettromagnetica distribuita su tutto lo spettro Attraverso un elemento da della superficie del corpo, fluisce p
SISTEMI PASSIVI Ogni corpo a temperatura T diversa da 0 K irradia spontaneamente potenza elettromagnetica distribuita su tutto lo spettro Attraverso un elemento da della superficie del corpo, fluisce p
Strumenti per la misura continua di polvere, portata, mercurio nel processo e nelle emissioni
 Strumenti per la misura continua di polvere, portata, mercurio nel processo e nelle emissioni Misura in situ delle polveri Strumenti trasmissometrici Strumenti per zone antideflagranti Strumenti diffrattometrici
Strumenti per la misura continua di polvere, portata, mercurio nel processo e nelle emissioni Misura in situ delle polveri Strumenti trasmissometrici Strumenti per zone antideflagranti Strumenti diffrattometrici
INDICE DELLA PRESENTAZIONE 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO 2. LA PIEZOMETRIA 3. L INQUINAMENTO 4. LA BARRIERA IDRAULICA
 INDICE DELLA PRESENTAZIONE 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO 2. LA PIEZOMETRIA 3. L INQUINAMENTO 4. LA BARRIERA IDRAULICA 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO? Il "modello concettuale idrogeologico
INDICE DELLA PRESENTAZIONE 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO 2. LA PIEZOMETRIA 3. L INQUINAMENTO 4. LA BARRIERA IDRAULICA 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO? Il "modello concettuale idrogeologico
La struttura elettronica degli atomi
 1 In unità atomiche: a 0 me 0,59A unità di lunghezza e H 7, ev a H=Hartree unità di energia L energia dell atomo di idrogeno nello stato fondamentale espresso in unità atomiche è: 4 0 me 1 e 1 E H 13,
1 In unità atomiche: a 0 me 0,59A unità di lunghezza e H 7, ev a H=Hartree unità di energia L energia dell atomo di idrogeno nello stato fondamentale espresso in unità atomiche è: 4 0 me 1 e 1 E H 13,
Università degli studi di Catania Facoltà di scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Informatica Magistrale
 Università degli studi di Catania Facoltà di scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Informatica Magistrale Alessandro Ortis Estensione del software ImageJ con l implementazione di un
Università degli studi di Catania Facoltà di scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Informatica Magistrale Alessandro Ortis Estensione del software ImageJ con l implementazione di un
