CARATTERISTICHE DEL DIO DANTESCO
|
|
|
- Fausta Fortunato
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CARATTERISTICHE DEL DIO DANTESCO ATTRAVERSO LE TEORIE RELATIVISTICHE DI EINSTEIN Gustave Dorè Paradiso, Canto XXXI GEMMA DI PETRILLO, LICEO SCIENTIFICO A. VOLTA, A.S. 2014\2015 1
2 INDICE Introduzione. 3 Un Dio luminoso: interpretazione attraverso la relatività ristretta.. 5 L universo-muffin e il Dio puntiforme: interpretazione attraverso la relatività generale e la cosmologia moderna 7 La struttura del Paradiso dantesco: un'ipersfera in 3 dimensioni...10 Conclusione filosofica (a mo di scusa). 12 Bibliografia e sitografia..13 2
3 INTRODUZIONE Spesso, si sente dire che le migliori idee vengono per caso e nei momenti più inaspettati. Non ho mai dato molto credito a questo modo di pensare, ritenendola tutt al più una trovata per romanzare e rendere più accattivanti i processi motori di grandi intuizioni, che consistono, in realtà, solo e soltanto di ricerca e studio. Dicevo, non gli ho mai dato molto credito finché non mi sono ritrovata ad esserne protagonista io stessa. Erano i primi giorni di maggio e, come ogni studente che si appresti a sostenere l esame di stato, ero alla disperata ricerca di un argomento abbastanza interessante da poter essere trattato nella mia tesina. Avevo ben chiare le caratteristiche generali: doveva essere particolare, ma semplice; avrebbe dovuto incuriosire, ma non confondere; soprattutto, avrebbe dovuto girare intorno ai due mondi da me più amati: la matematica e la letteratura. Fissati questi punti, si trattava ora, dal mio punto di vista, soltanto di prendersi una breve pausa dal mondo esterno e intraprendere questo viaggio alla ricerca del mio Santo Graal. Ma, ahimè, il tempo non si ferma quando si chiudono gli occhi ed i professori, a buon diritto, continuavano a fissare interrogazioni e verifiche di cui non riuscivo a vedere la fine. Un po sconsolata, decisi di dare una possibilità al motto che apre questa introduzione (anche perché di alternative proprio non ce n erano!), ed iniziai quello che, ai miei occhi, era uno studio matto e disperatissimo (e qui, forse, il poeta-filosofo di Recanati avrebbe qualcosa da ridire) in vista delle faciturae verifiche, le quali vedevano, al primo posto, una temibile interrogazione sul Paradiso dantesco. Dopo qualche giorno, giunsi alla lettura del XXXIII ed ultimo canto, attraversata dal tipico, ambivalente sentimento che si prova quando si avvicina la fine di un libro che ci è stato particolarmente caro: da un lato, siamo logorati dalla smania per il tanto a lungo bramato finale; dall altro, vorremmo dopo quell ultima pagina scoprire un ulteriore capitolo (o, in questo caso, canto), in modo da non terminare l avventura. L unica sintesi possibile tra queste due maniere di sentire, è dare ad ogni parola un peso maggiore di sempre, elevare al massimo la propria attenzione al testo e non lasciarsi sfuggire niente. È con questo atteggiamento che mi stavo avvicinando alla nota conclusione, quando poi, al novantesimo verso, mi cadde in testa la mela di Newton: in un istante, vidi la linguaccia di Einstein, la luce, i fotoni tutto era chiaro! *** Prima di iniziare la trattazione dei punti che mi sono preposta, è necessario chiarire che questo 3
4 lavoro non ha le pretese di individuare un esatta corrispondenza biunivoca tra le terzine dantesche e la teoria relativistica di Einstein (con le sue conseguenze): nasce, in primo luogo, come un gioco, e con tale spirito è bene che ci si appresti alla lettura di queste poche pagine. 4
5 UN DIO LUMINOSO: INTERPRETAZIONE ATTRAVERSO LA RELATIVITÀ RISTRETTA Nel XXXIII canto del Paradiso, Dante raggiunge quello che era il fine noto (e salvifico) del suo viaggio: la visione di Dio. Così ce lo descrive: Nel suo profondo vidi che s interna legato con amore in un volume, ciò che per l universo si squaderna; sustanze e accidenti e lor costume, quasi conflati insiem, per tal modo che ciò ch i dico è un semplice lume 1 Secondo la critica, i termini evidenziati hanno i seguenti significati: - sustanza: ciò che sussiste di per sé - accidenti: trasformazioni nello spazio e nel tempo della forma delle sostanze; esistono, dunque, solo relativamente ad esse - lor costume : le relazioni reciproche tra sustanze e accidenti, i comportamenti. Ora, tutte queste cose che sono sparse nell universo risultano quasi conflate insieme nella mente divina, che contiene, dunque, passato presente e futuro in un unico punto. Difficile da capire da una parte, arduo da accettare dall altra; tuttavia, se a queste considerazioni aggiungiamo la caratteristica prima del Dio dantesco, ossia il suo essere luce, ecco che la questione si fa più chiara. Secondo la teoria della relatività ristretta, formulata da Albert Einstein intorno al 1905, le durate dei fenomeni e le lunghezze dei corpi non sono assolute ma dipendono dal sistema di riferimento rispetto al quale sono misurate. Se due sistemi di riferimento S ed S misurano la durata di uno stesso fenomeno e sono in moto relativo rettilineo uniforme con velocità relativa v, le loro misure risultano legate dalla relazione: 1 cit. Dante Alighieri, Divina Commedia Paradiso, Canto XXXIII, vv
6 in cui ɣ 1, c è la velocità della luce (=299792,458 km/s), t è il tempo proprio del fenomeno (che risulta essere il minimo misurabile), ossia quello misurato da un osservatore per il quale l inizio e la fine del fenomeno avvengono nella stessa posizione spaziale. Inoltre, se nei due sistemi di riferimento di cui sopra si misura la lunghezza di uno stesso corpo nella direzione del moto relativo, si ottengono risultati legati dalla relazione In cui L è la lunghezza relativa alla misura effettuata nel sistema di riferimento in cui il corpo è in quiete ed è detta lunghezza propria (è la massima misurabile per quel corpo). Nel nostro caso, Lˈ e tˈ sono misurate dal sistema si riferimento S in cui si trova Dante e t è il tempo proprio del Dio-luce; inoltre, la v relativa tende a c (in realtà è uguale a c per il secondo postulato di Einstein, ma vedremo in seguito questo punto), pertanto: Il significato di questi calcoli è che Dante, volgendo gli occhi a Dio, vede un tempo infinito, l eternità concentrata in uno spazio nullo, in un punto adimensionale: Così vedi le cose contingenti Anzi che sieno in sé, mirando il punto A cui tutti li tempi son presenti 2 2 cit. Dante Alighieri, Divina Commedia Paradiso, Canto XVII, vv
7 L UNIVERSO-MUFFIN E IL DIO PUNTIFORME: INTERPRETAZIONE ATTRAVERSO LA RELATIVITÀ GENERALE E LA COSMOLOGIA MODERNA Un altra chiave di lettura delle terzine sopra riportate, ci è fornita da quella che è, con ogni probabilità, una delle conseguenze più affascinanti delle teorie di Einstein, la quale si potrebbe riassumere con una sorta di massima: se vuoi conoscere il tuo passato, guarda il cielo. Certo, questa minutissima sententia non esplicita affatto la realtà fisica in analisi (tutt al più, potrebbe essere lo slogan di un gruppo di sognatori), tuttavia, sostituendo il tuo passato con il passato del tuo universo e il cielo con quanto più lontano possibile [nel cielo], non si è molto lontani da quello che, in effetti, accade realmente. Per il secondo postulato di Einstein, la velocità della luce nel vuoto ha lo stesso valore in tutti i sistemi di riferimento inerziali, indipendentemente dalla velocità relativa tra i sistemi di riferimento dell osservatore e della sorgente di luce. A questo, va aggiunto che nessun corpo che abbia una massa potrà mai raggiungere c e, soprattutto, che, anche nel caso di particelle senza massa (come i fotoni), tale valore non può essere superato, in quanto il fattore ɣ (di cui in precedenza si è data l espressione) assumerebbe un valore non compreso nell insieme dei numeri reali (inoltre, secondo la relatività ristretta, andando a velocità maggiori di quella della luce nel vuoto si potrebbe misurare un tempo negativo e, dunque, tornare indietro nel tempo per quanto allettante, questa possibilità è, ahimè, altamente improbabile sul piano pratico). Ricapitolando: la velocità della luce nel vuoto non è soltanto una costante della fisica e, dunque, finita, ma è anche la velocità limite del nostro universo (e, a dirla tutta, anche degli altri); di conseguenza, essendo il nostro occhio in grado di vedere grazie alle onde elettromagnetiche della luce (la luce visibile ha una lunghezza compresa tra i 380 e i 760 nm), se osserviamo un oggetto che si trovi ad una sufficiente distanza da noi, possiamo a buon diritto affermare che stiamo vedendo il suo passato. Prendiamo in considerazione che cosa accadrebbe se, paradossalmente, il nostro amico Virgilio vivesse sul Sole e noi fossimo in grado di vederlo: alle 13.50, alziamo gli occhi al cielo e scorgiamo, sulla nostra stella, una mano alzata in segno di saluto. Il primo istinto, ovviamente, è quello di rispondervi; tuttavia, dopo un attimo di riflessione, ci si rende conto che sarebbe del tutto inutile: la Terra ed il Sole distano circa 150 milioni di chilometri, e la luce ne percorre soltanto in un secondo! Questo significa che quello che abbiamo visto è, in realtà, accaduto poco più di 8 minuti fa (tale valore è il tempo che la luce impiega per percorrere la distanza Sole-Terra) e che, probabilmente, alle solari Virgilio starà prendendo un caffè. Insomma, ciò che è 7
8 lontano da noi nello spazio, lo è anche nel tempo, e spingere i nostri occhi più remotamente possibile equivale ad approfondire la nostra conoscenza della storia del cosmo. Cosa c entra questo con la Divina Commedia e, in particolare, con il Dio-luce? Intorno agli anni 20 del XX secolo, il fisico e matematico russo Aleksandr Fridman risolse l equazione di campo di Einstein (1915, punto di arrivo della relatività generale) nel caso semplice di un universo omogeneo, osservando che la maggior parte delle soluzioni cambiavano col tempo e che, dunque, la condizione del nostro universo non è statica, ma dinamica! In particolare, si tratta di un movimento di espansione o di contrazione. Per spiegare meglio questa situazione, riporto un esempio utilizzato dal cosmologo svedese Max Tegmark nel libro L universo matematico: immaginiamo che il nostro cosmo sia un muffin in lievitazione, in cui le gocce di cioccolato giocano il ruolo delle galassie: Dal punto di vista di ogni galassia, tutte le altre si stanno allontanando con una velocità proporzionale alla loro distanza. Se invece immaginiamo che lo spazio si stia dilatando proprio come l impasto del muffin, allora le galassie non si stanno muovendo rispetto allo spazio, ma è quest ultimo, più semplicemente, a vedere tutte le sue distanze dilatate in maniera uniforme; è come se ribattezzassimo le tacche sui nostri righelli da millimetri a centimetri 3. Ora, se, nell ottica del nostro universo in espansione, riavvolgessimo il nastro del tempo, vedremmo le galassie avvicinarsi sempre di più, finché, in accordo con le soluzioni ottenute da Fridman, giungeremmo ad un istante iniziale in cui tutta la materia, tutto ciò che vediamo (e non vediamo) oggi sarebbe concentrato in un unico punto di densità infinita: La forma universal di questo nodo credo ch i vidi, perché più di largo, dicendo questo, mi sento ch i godo. 4 Al pari di un cosmologo di fronte alle immagini del neonato universo, Dante, incatenando il suo sguardo nella divinità, si immerge nei segreti più oscuri e bramati dall animo umano; vi si immerge, ma non ne viene a capo, qual è l geomètra che tutto s affige / per misurar lo cerchio, e non ritrova, / pensando, quel principio ond elli indige 5. Ma quali sono le difficoltà che entrambi gli indagatori del vero trovano in questa lettura? Da un punto di vista letterario e filologico, ciò che atterra, suscita, affanna e consola 6 il Sommo Poeta è la visione della nostra effige nella Trinità: il concetto teologico dell incarnazione. Tuttavia, nell ottica di questa ricerca dei punti di 3 cit. Max Tegmark, L universo Matematico, Bollati Boringhieri, Torino, 2014, pag cit. Dante Alighieri, Divina Commedia Paradiso, Canto XXXIII, vv cit. Dante Alighieri, Divina Commedia Paradiso, Canto XXXIII, vv cfr. Alessandro Manzoni, Il cinque Maggio, vv
9 contatto tra la Divina Commedia e la fisica moderna, è necessario considerare un altro fattore: per quanto definite e accurate siano le foto del nostro universo scattate dai migliori satelliti, c è una fase della sua storia (ossia, gli istanti immediatamente successivi al Big Bang, dal tempo zero ai secondi: hic sunt leones!) che non possiamo, ad oggi, conoscere (e, a mio avviso, ciò non sarà possibile neanche in futuro: credo in un avvicinamento asintotico a quel primo momento che mai diventerà perfetta congiunzione). Se consideriamo il Dio dantesco come il punto più lontano nello spazio-tempo, un punto che, a ben pensarci, solo all autore fiorentino è stato concesso di vedere, sul piano teorico niente ci può impedire di affermare che quest ultimo abbia potuto ammirare il tutto quando era nulla; dunque, comprendere quegli inspiegabili istanti che sono celati alle umane genti. Per far sì che tale sovrapposizione tra la divinità del canto XXXIII del Paradiso e il materiale a densità infinita a cui si è fatto riferimento in precedenza sia pressoché completa, è necessario analizzare un ulteriore punto: la struttura geometrica del nostro cosmo e di quello dantesco. 9
10 LA STRUTTURA DEL PARADISO DANTESCO: UN IPERSFERA IN 3 DIMENSIONI L universo è infinito? E, se non lo fosse, cosa c è oltre il bordo? Come se si trattasse di un processo dialettico di matrice hegeliana, nessuna delle due opzioni è giusta di per sé: bisogna considerare la sintesi tra le due. Questo è proprio quello che fa Einstein nel 1917, formulando una terza ipotesi: l universo è finito, ma non ha un bordo. Come è possibile? Ecco che la matematica ci viene in aiuto: potrebbe trattarsi di un ipersfera in 4 dimensioni, una 3-sfera! Di cosa si tratta? Intuitivamente, potremmo definirla l evoluzione di una comune sfera in 3 dimensioni (2-sfera), la quale, a sua volta, è l evoluzione della circonferenza in 2 dimensioni (1-sfera). Essendo la nostra mente limitata alla concezione di uno spazio tridimensionale ed euclideo, è impossibile, per quanto ci si sforzi, cercare di visualizzare la 3-sfera da un punto di vista esterno; pertanto, ne adotteremo uno interno, procedendo per analogia con la 2- sfera. Prendiamo in considerazione Gaia, il nostro pianeta: spostandosi sempre nella stessa direzione, prima o poi torneremo al punto di partenza! Questo accade anche nel nostro universo, poiché entrambi sono finiti ma senza bordi. Inoltre, una 2-sfera può essere rappresentata, sul piano, da due dischi corrispondenti ai due emisferi; scrive il fisico italiano Carlo Rovelli, in La realtà non è come ci appare: Si noti che un abitante dell emisfero sud è in un certo senso circondato dall emisfero nord, perché in qualunque direzione si muova per uscire dal suo emisfero arriverà sempre all emisfero nord. Ma è vero anche il contrario ovviamente. Ciascuno dei due emisferi circonda e insieme è circondato dall altro emisfero. 7. In modo analogo, si può rappresentare una 3-sfera immaginandoci due 2-sfere incollate per il bordo, tali che l una circondi l altra e viceversa. Ed è qui che entra in gioco Dante: l universo che ci descrive nella Divina Commedia è formato da una serie di sfere concentriche (in primis la Terra), i sette cieli planetari, il cielo delle stelle fisse ed il Primo Mobile, circondate, infine, dall Empireo, in cui ha sede Dio: Luce e Amor d un cerchio lui comprende, sì come questo li altri; e quel precinto colui che l cinge solamente intende 8 7 cit. Carlo Rovelli, La realtà non è come ci appare, Raffaello Cortina Editore, 2014, pag 85 8 cit. Dante Alighieri, Divina Commedia Paradiso, Canto XXVII, vv
11 O almeno, questo è la visione che Dante ha quando si trova sotto al Primo Mobile: cosa succede quando lo raggiunge? Guardando verso l alto, egli scorge un punto luminoso, il Dio-luce, circondato da un altra serie di sfere concentriche: i cori angelici. Insomma, quel Dio-luce che prima, avendo sede nell Empireo, circondava il Primo Mobile e le altre sfere, ora ne è a sua volta circondato: Non altrimenti il triunfo che lude Sempre dintorno al punto che mi vinse, parendo inchiuso da quel ch elli nchiude a poco a poco al mio veder si stinse 9 Ebbene, anche l universo dantesco, così come il nostro, secondo l ipotesi einsteiniana, è una 3- sfera! Al fine di consolidare ulteriormente questa idea, si noti come, per Dante, una volta giunto nel Primo Mobile, è indifferente in quale punto della sfera di confine egli sia, poiché da ognuno si ha la stessa visione; parimenti sulla Terra, trovandosi sull equatore, non esiste un meridiano privilegiato per raggiungere uno dei due poli (in via teorica): Le parti sue vivissime ed eccelse Sì uniforme son, ch i non so dire Qual Beatrice per loco mi scelse 10 9 cit. Dante Alighieri, Divina Commedia Paradiso, Canto XXX, vv cit. Dante Alighieri, Divina Commedia Paradiso, Canto XXVII, vv
12 CONCLUSIONE FILOSOFICA (A MO DI SCUSA) La scienza (con la matematica) e la letteratura costituiscono due mondi che, dal mio punto di vista, non dovrebbero mai avere la superba pretesa di vivere separati: ogni volta che si toccano, nascono capolavori di folle genialità (basti pensare alle opere di Lucrezio, Galileo Galilei, Italo Calvino!) che, talvolta, come nel caso del Sommo Poeta, contengono intuizioni che superano di buon grado la soglia dell immaginabile; possono essere una reciproca fonte d ispirazione; possono contaminarsi (consapevolmente o inconsapevolmente); possono addirittura costituire l una la struttura dell altra 11! Pur non potendo sostituirsi in quella che è la loro funzione e il loro scopo principale, entrambe muovono da quel desiderio insito nell uomo di ricercare una verità di fondo, una sorta di causa incausata; dalla necessità di compiere un indagine e di interrogarsi, di essere critici. Partendo entrambe da questo principio, poi scienza e letteratura si diramano (orientandosi ciascuna in un proprio ambito di ricerca) e, quando tornano ad intrecciarsi, non ci si può certo aspettare che siano in grado di esaurirsi vicendevolmente! Eppure eppure, in certi casi ci vanno talmente vicine che per poco il cor non si spaura Per esempio, si pensi al libro Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino, basato sul calcolo combinatorio, o alla poesia composta dal matematico Tartaglia per spiegare al suo collega Cardano il metodo per trovare una soluzione delle equazioni di terzo grado (nella forma x 3 +px+q=0): Quando che'l cubo con le cose appresso Se agguaglia à qualche numero discreto Trovan dui altri differenti in esso. Dapoi terrai questo per consueto Che'llor produtto sempre sia eguale Al terzo cubo delle cose neto, El residuo poi suo generale Delli lor lati cubi ben sottratti Varra la tua cosa principale. 12 cit. Giacomo Leopardi, L infinito, vv
13 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 1. Carlo Rovelli, La realtà non è come ci appare, Raffaello Cortina Editore, Max Tegmark, L universo Matematico, Bollati Boringhieri, Torino, Bertrand Russell, L ABC della relatività, TEA, Milano, Dante Alighieri, La Divina commedia, Natalino Sapegno (a cura di), La <<Nuova Italia>> Editrice, Firenze, Claudio Romeni, Fisica e realtà. Campo Magnetico, Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti, Zanichelli, Bologna,
G. Doré, La moltitudine degli angeli
 G. Doré, La moltitudine degli angeli La Commedia è un poema del fiorentino Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di versi endecasillabi, in lingua volgare toscana. Nella Divina Commedia, e in
G. Doré, La moltitudine degli angeli La Commedia è un poema del fiorentino Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di versi endecasillabi, in lingua volgare toscana. Nella Divina Commedia, e in
Il GPS e la Relatività
 Il GPS e la Relatività Il sistema GPS Qualche idea sulla Relatività Ristretta e sulla Relatività Generale Il GPS non funzionerebbe se non si conoscessero entrambe 1 Il sistema GPS: Global Positioning System
Il GPS e la Relatività Il sistema GPS Qualche idea sulla Relatività Ristretta e sulla Relatività Generale Il GPS non funzionerebbe se non si conoscessero entrambe 1 Il sistema GPS: Global Positioning System
Qualche cenno al Sole
 Qualche cenno al Sole Corso di Astronomia Daniele Gasparri Lezione 1, 25/11/2011: Breve viaggio attraverso l Universo - Sfera celeste ed orientamento - Cenni al Sistema Solare - Corpi e proprietà dell
Qualche cenno al Sole Corso di Astronomia Daniele Gasparri Lezione 1, 25/11/2011: Breve viaggio attraverso l Universo - Sfera celeste ed orientamento - Cenni al Sistema Solare - Corpi e proprietà dell
La Teoria della Relatività Ristretta. Prof. Michele Barcellona
 La Teoria della Relatività Ristretta Prof. Michele Barcellona I Postulati della Teoria della Relatività ristretta Per risolvere le contraddizioni tra Meccanica ed Elettromagnetismo Einstein propose una
La Teoria della Relatività Ristretta Prof. Michele Barcellona I Postulati della Teoria della Relatività ristretta Per risolvere le contraddizioni tra Meccanica ed Elettromagnetismo Einstein propose una
3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine
 Introduzione 3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine Ogni volta che vogliamo individuare un punto sulla superficie terrestre gli associamo due numeri, le coordinate geografiche: la latitudine
Introduzione 3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine Ogni volta che vogliamo individuare un punto sulla superficie terrestre gli associamo due numeri, le coordinate geografiche: la latitudine
Le Derivate. Appunti delle lezioni di matematica di A. Pisani Liceo Classico Dante Alighieri
 Le Derivate Appunti delle lezioni di matematica di A. Pisani Liceo Classico Dante Alighieri Nota bene Questi appunti sono da intendere come guida allo studio e come riassunto di quanto illustrato durante
Le Derivate Appunti delle lezioni di matematica di A. Pisani Liceo Classico Dante Alighieri Nota bene Questi appunti sono da intendere come guida allo studio e come riassunto di quanto illustrato durante
Einstein e la matematica
 Einstein e la matematica Nell agosto 1912, così Einstein si rivolge all amico e compagno di studi Marcel Grossmann: Grossmann, aiutami, altrimenti divento pazzo! In quel tempo, Einstein era già un fisico
Einstein e la matematica Nell agosto 1912, così Einstein si rivolge all amico e compagno di studi Marcel Grossmann: Grossmann, aiutami, altrimenti divento pazzo! In quel tempo, Einstein era già un fisico
Risolviamo un esercizio per illustrare il fenomeno in modo dettagliato anche se,in alcuni punti, semplificato.
 PARADOSSO DEI GEMELLI Il cosiddetto paradosso dei gemelli è forse una delle conseguenze più popolari della teoria della relatività di Einstein. In realtà non si tratta di un vero e proprio paradosso, bensì
PARADOSSO DEI GEMELLI Il cosiddetto paradosso dei gemelli è forse una delle conseguenze più popolari della teoria della relatività di Einstein. In realtà non si tratta di un vero e proprio paradosso, bensì
IASF-INAF Milano, 21 Dicembre 2011 AstroSiesta Natalizia. L universo di Dante
 IASF-INAF Milano, 21 Dicembre 2011 AstroSiesta Natalizia L universo di Dante Gustave Dorè (1832-1883),The white rose. Engraving Marco Bersanelli Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano
IASF-INAF Milano, 21 Dicembre 2011 AstroSiesta Natalizia L universo di Dante Gustave Dorè (1832-1883),The white rose. Engraving Marco Bersanelli Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano
5 CORSO DI ASTRONOMIA
 5 CORSO DI ASTRONOMIA Evoluzione dell Universo e Pianeti Extrasolari 13 febbraio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Parte Prima La Teoria
5 CORSO DI ASTRONOMIA Evoluzione dell Universo e Pianeti Extrasolari 13 febbraio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Parte Prima La Teoria
Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi.
 Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi. Se stasera è sereno, alza il naso al cielo e guarda le stelle. Tutte quelle che vedi fanno
Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi. Se stasera è sereno, alza il naso al cielo e guarda le stelle. Tutte quelle che vedi fanno
1. Le caratteristiche delle stelle 2. La vita e la morte delle stelle 3. Le galassie 4. L universo e il Big Bang
 1. Le caratteristiche delle stelle 2. La vita e la morte delle stelle 3. Le galassie 4. L universo e il Big Bang Le caratteristiche delle stelle le stelle sono lontanissime dalla Terra; le loro distanze
1. Le caratteristiche delle stelle 2. La vita e la morte delle stelle 3. Le galassie 4. L universo e il Big Bang Le caratteristiche delle stelle le stelle sono lontanissime dalla Terra; le loro distanze
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO).
 L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
TEORIA DELLA RELATIVITA
 Cenni sulle teorie cosmologiche TEORIA DELLA RELATIVITA Nasce dalla constatazione che il movimento è relativo, e dipende dal sistema di riferimento. La teoria è formulata da Einstein che coniuga la precedente
Cenni sulle teorie cosmologiche TEORIA DELLA RELATIVITA Nasce dalla constatazione che il movimento è relativo, e dipende dal sistema di riferimento. La teoria è formulata da Einstein che coniuga la precedente
Come vediamo. La luce: aspetti fisici. Cos è la luce? Concetti fondamentali:
 La luce in fisica La luce: aspetti fisici Cos è la luce? Concetti fondamentali: - velocità, ampiezza, lunghezza d onda - assorbimento - riflessione -rifrazione - diffrazione - indice di rifrazione - temperatura
La luce in fisica La luce: aspetti fisici Cos è la luce? Concetti fondamentali: - velocità, ampiezza, lunghezza d onda - assorbimento - riflessione -rifrazione - diffrazione - indice di rifrazione - temperatura
Che cos è la Fisica? Ing. Luca Basteris
 Che cos è la Fisica? Ing. Luca Basteris Che cos è la Fisica? Perché i corpi cadono? Perché i corpi cadono? Come si formano le nuvole? Come si formano le nuvole? Come fa la lampadina ad accendersi? Come
Che cos è la Fisica? Ing. Luca Basteris Che cos è la Fisica? Perché i corpi cadono? Perché i corpi cadono? Come si formano le nuvole? Come si formano le nuvole? Come fa la lampadina ad accendersi? Come
Unità di misura di lunghezza usate in astronomia
 Unità di misura di lunghezza usate in astronomia In astronomia si usano unità di lunghezza un po diverse da quelle che abbiamo finora utilizzato; ciò è dovuto alle enormi distanze che separano gli oggetti
Unità di misura di lunghezza usate in astronomia In astronomia si usano unità di lunghezza un po diverse da quelle che abbiamo finora utilizzato; ciò è dovuto alle enormi distanze che separano gli oggetti
La Matematica nell Astronomia. Una (breve) introduzione. Roberto Ferretti
 La Matematica nell Astronomia Una (breve) introduzione Roberto Ferretti Il cielo: un fascino intramontabile Come si puó parlare di astronomia senza fermarsi un attimo a guardare il cielo? E un fascino
La Matematica nell Astronomia Una (breve) introduzione Roberto Ferretti Il cielo: un fascino intramontabile Come si puó parlare di astronomia senza fermarsi un attimo a guardare il cielo? E un fascino
L ATOMO SECONDO LA MECCANICA ONDULATORIA IL DUALISMO ONDA-PARTICELLA. (Plank Einstein)
 L ATOMO SECONDO LA MECCANICA ONDULATORIA IL DUALISMO ONDA-PARTICELLA POSTULATO DI DE BROGLIÈ Se alla luce, che è un fenomeno ondulatorio, sono associate anche le caratteristiche corpuscolari della materia
L ATOMO SECONDO LA MECCANICA ONDULATORIA IL DUALISMO ONDA-PARTICELLA POSTULATO DI DE BROGLIÈ Se alla luce, che è un fenomeno ondulatorio, sono associate anche le caratteristiche corpuscolari della materia
Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina?
 Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Enzo Casagni SCINTILLE D AMORE... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Diario autobiografico www.booksprintedizioni.it
Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Enzo Casagni SCINTILLE D AMORE... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Diario autobiografico www.booksprintedizioni.it
Dinamica: Forze e Moto, Leggi di Newton
 Dinamica: Forze e Moto, Leggi di Newton La Dinamica studia il moto dei corpi in relazione il moto con le sue cause: perché e come gli oggetti si muovono. La causa del moto è individuata nella presenza
Dinamica: Forze e Moto, Leggi di Newton La Dinamica studia il moto dei corpi in relazione il moto con le sue cause: perché e come gli oggetti si muovono. La causa del moto è individuata nella presenza
circostanze che lo determinano e lo modificano. Secondo alcuni studi portati avanti da Galileo GALILEI e Isac
 La DINAMICA è il ramo della meccanica che si occupa dello studio del moto dei corpi e delle sue cause o delle circostanze che lo determinano e lo modificano. Secondo alcuni studi portati avanti da Galileo
La DINAMICA è il ramo della meccanica che si occupa dello studio del moto dei corpi e delle sue cause o delle circostanze che lo determinano e lo modificano. Secondo alcuni studi portati avanti da Galileo
Gli indizi a favore di questa ipotesi erano molteplici:
 La forma della Terra Nell antichità la forma della Terra è stata oggetto di numerose ipotesi. Nonostante la limitatezza degli strumenti di osservazione di allora, già gli antichi svilupparono l idea che
La forma della Terra Nell antichità la forma della Terra è stata oggetto di numerose ipotesi. Nonostante la limitatezza degli strumenti di osservazione di allora, già gli antichi svilupparono l idea che
Dante e la Quarta Dimensione. Stefano Spagocci GACB
 Dante e la Quarta Dimensione Stefano Spagocci GACB L'Astronomia Dantesca Vi sono numerosi riferimenti astronomici nella Divina Commedia. Dante menziona, tra l'altro, le costellazioni australi, la precessione
Dante e la Quarta Dimensione Stefano Spagocci GACB L'Astronomia Dantesca Vi sono numerosi riferimenti astronomici nella Divina Commedia. Dante menziona, tra l'altro, le costellazioni australi, la precessione
Insegnare relatività. nel XXI secolo
 Insegnare relatività nel XXI secolo E s p a n s i o n e d e l l ' U n i v e r s o e l e g g e d i H u b b l e La legge di Hubble Studiando distanze e moto delle galassie si trova che quelle più vicine
Insegnare relatività nel XXI secolo E s p a n s i o n e d e l l ' U n i v e r s o e l e g g e d i H u b b l e La legge di Hubble Studiando distanze e moto delle galassie si trova che quelle più vicine
Limiti di successioni
 Capitolo 5 Limiti di successioni 5.1 Successioni Quando l insieme di definizione di una funzione coincide con l insieme N costituito dagli infiniti numeri naturali 1, 2, 3,... talvolta si considera anche
Capitolo 5 Limiti di successioni 5.1 Successioni Quando l insieme di definizione di una funzione coincide con l insieme N costituito dagli infiniti numeri naturali 1, 2, 3,... talvolta si considera anche
Massimi e minimi vincolati
 Massimi e minimi vincolati Data una funzione G C 1 (D), dove D è un aperto di R 2, sappiamo bene dove andare a cercare gli eventuali punti di massimo e minimo relativi. Una condizione necessaria affinché
Massimi e minimi vincolati Data una funzione G C 1 (D), dove D è un aperto di R 2, sappiamo bene dove andare a cercare gli eventuali punti di massimo e minimo relativi. Una condizione necessaria affinché
Una avventura millenaria: le geometrie non euclidee
 Una avventura millenaria: le geometrie non euclidee Renato Betti Politecnico di Milano San Pellegrino Terme 4 settembre 2006 Il fatto A metà 800 giunge a conclusione il problema delle parallele, originato
Una avventura millenaria: le geometrie non euclidee Renato Betti Politecnico di Milano San Pellegrino Terme 4 settembre 2006 Il fatto A metà 800 giunge a conclusione il problema delle parallele, originato
6. IL MOTO Come descrivere un moto.
 6. IL MOTO Per definire il movimento di un corpo o il suo stato di quiete deve sempre essere individuato un sistema di riferimento e ogni movimento è relativo al sistema di riferimento in cui esso avviene.
6. IL MOTO Per definire il movimento di un corpo o il suo stato di quiete deve sempre essere individuato un sistema di riferimento e ogni movimento è relativo al sistema di riferimento in cui esso avviene.
Insegnare relatività. nel XXI secolo
 Insegnare relatività nel XXI secolo L ' o r o l o g i o a l u c e e i l t e m p o p r o p r i o L'orologio a luce serve a connettere l'invarianza della velocità della luce col carattere non più assoluto
Insegnare relatività nel XXI secolo L ' o r o l o g i o a l u c e e i l t e m p o p r o p r i o L'orologio a luce serve a connettere l'invarianza della velocità della luce col carattere non più assoluto
Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle.
 1 Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle. Si, proprio le stelle che si vedono ogni volta che fa buio, se è sereno, come puntolini
1 Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle. Si, proprio le stelle che si vedono ogni volta che fa buio, se è sereno, come puntolini
Capitolo 2. Statica del corpo rigido. 2.1 Azioni su un corpo rigido
 Capitolo 2 Statica del corpo rigido La statica è la parte della meccanica che si occupa dello studio dell equilibrio di corpi in quiete, ossia fermi, o mobili di moto rettilineo uniforme. In effetti applichiamo
Capitolo 2 Statica del corpo rigido La statica è la parte della meccanica che si occupa dello studio dell equilibrio di corpi in quiete, ossia fermi, o mobili di moto rettilineo uniforme. In effetti applichiamo
MODELLO DI UNIVERSO NELLA BIBBIA
 PIANO DEL SEMINARIO La Cosmologia dall An8co Testamento fino ad Einstein. La visione dell Universo con la teoria di Einstein della gravità. Lo teoria dello stato stazionario e del Big- Bang. La ques8one
PIANO DEL SEMINARIO La Cosmologia dall An8co Testamento fino ad Einstein. La visione dell Universo con la teoria di Einstein della gravità. Lo teoria dello stato stazionario e del Big- Bang. La ques8one
L Universo secondo la Fisica moderna
 Jesi 16 aprile 2005 L Universo secondo la Fisica moderna Cesare Bini Universita La Sapienza Roma Come la Fisica del XX secolo ha affrontato il problema dell origine dell Universo e quali sono i problemi
Jesi 16 aprile 2005 L Universo secondo la Fisica moderna Cesare Bini Universita La Sapienza Roma Come la Fisica del XX secolo ha affrontato il problema dell origine dell Universo e quali sono i problemi
Teoria intuitiva degli insiemi
 Teoria intuitiva degli insiemi Il concetto di insieme. lcuni esempi Tutta la matematica moderna è fondata sul concetto di insieme. Un insieme è da considerarsi nella sua nozione intuitiva di collezione,
Teoria intuitiva degli insiemi Il concetto di insieme. lcuni esempi Tutta la matematica moderna è fondata sul concetto di insieme. Un insieme è da considerarsi nella sua nozione intuitiva di collezione,
MOTO DI UNA PARTICELLA IN UN CAMPO ELETTRICO
 MOTO DI UNA PARTICELLA IN UN CAMPO ELETTRICO Sappiamo che mettendo una carica positiva q chiamata carica di prova o carica esploratrice in un punto vicino all oggetto carico si manifesta un vettore campo
MOTO DI UNA PARTICELLA IN UN CAMPO ELETTRICO Sappiamo che mettendo una carica positiva q chiamata carica di prova o carica esploratrice in un punto vicino all oggetto carico si manifesta un vettore campo
TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA
 TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA EVOLUZIONE DELLE TEORIE FISICHE Meccanica Classica Principio di Relatività Galileiano Meccanica Newtoniana Gravitazione (Newton) Costante Universale G = 6,67*10^-11Nm^2/Kg^2
TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA EVOLUZIONE DELLE TEORIE FISICHE Meccanica Classica Principio di Relatività Galileiano Meccanica Newtoniana Gravitazione (Newton) Costante Universale G = 6,67*10^-11Nm^2/Kg^2
Studio di funzioni goniometriche. di Carmelo Di Stefano 1
 Studio di funzioni goniometriche di Carmelo Di Stefano 1 Sommario. Lo studio della goniometria è considerato, non del tutto a torto, uno dei più noiosi da parte degli studenti. L argomento viene visto
Studio di funzioni goniometriche di Carmelo Di Stefano 1 Sommario. Lo studio della goniometria è considerato, non del tutto a torto, uno dei più noiosi da parte degli studenti. L argomento viene visto
QUATTRO PASSI NELLO SPAZIOTEMPO
 QUATTRO PASSI NELLO SPAZIOTEMPO! LA VISIONE DEL MONDO NELLA RELATIVITA DI EINSTEIN Giuseppe Tormen Dip. di Fisica e Astronomia G.Galilei Università di Padova!1 Lewis Carroll Epstein UN PO DI STORIA...
QUATTRO PASSI NELLO SPAZIOTEMPO! LA VISIONE DEL MONDO NELLA RELATIVITA DI EINSTEIN Giuseppe Tormen Dip. di Fisica e Astronomia G.Galilei Università di Padova!1 Lewis Carroll Epstein UN PO DI STORIA...
Generalità delle onde elettromagnetiche
 Generalità delle onde elettromagnetiche Ampiezza massima: E max (B max ) Lunghezza d onda: (m) E max (B max ) Periodo: (s) Frequenza: = 1 (s-1 ) Numero d onda: = 1 (m-1 ) = v Velocità della luce nel vuoto
Generalità delle onde elettromagnetiche Ampiezza massima: E max (B max ) Lunghezza d onda: (m) E max (B max ) Periodo: (s) Frequenza: = 1 (s-1 ) Numero d onda: = 1 (m-1 ) = v Velocità della luce nel vuoto
LA LUCE. Perché vediamo gli oggetti Che cos è la luce La propagazione della luce La riflessione La rifrazione
 LA LUCE Perché vediamo gli oggetti Che cos è la luce La propagazione della luce La riflessione La rifrazione Perché vediamo gli oggetti? Perché vediamo gli oggetti? Noi vediamo gli oggetti perché da essi
LA LUCE Perché vediamo gli oggetti Che cos è la luce La propagazione della luce La riflessione La rifrazione Perché vediamo gli oggetti? Perché vediamo gli oggetti? Noi vediamo gli oggetti perché da essi
Bilancio di energia: il Primo Principio della Termodinamica. Termodinamica dell Ingegneria Chimica
 Bilancio di energia: il Primo Principio della Termodinamica Termodinamica dell Ingegneria Chimica 1 I Sistemi termodinamici Un sistema è definito da una superficie di controllo, reale o immaginaria, che
Bilancio di energia: il Primo Principio della Termodinamica Termodinamica dell Ingegneria Chimica 1 I Sistemi termodinamici Un sistema è definito da una superficie di controllo, reale o immaginaria, che
approfondimento La dinamica e le interazioni fondamentali Il principio di inerzia secondo Galileo Sistemi inerziali
 approfondimento La dinamica e le interazioni fondamentali Il principio di inerzia secondo Galileo Sistemi inerziali Forza gravitazionale e forza peso massa e peso, peso apparente Forze normali Moto circolare
approfondimento La dinamica e le interazioni fondamentali Il principio di inerzia secondo Galileo Sistemi inerziali Forza gravitazionale e forza peso massa e peso, peso apparente Forze normali Moto circolare
LA GRAVITAZIONE. Legge di Gravitazione Universale 08/04/2015 =6, /
 LA GRAVITAZIONE Definizione (forza di attrazione gravitazionale) Due corpi puntiformi di massa e si attraggono vicendevolmente con una forza (forza che il corpo A esercita sul corpo B), o (forza che il
LA GRAVITAZIONE Definizione (forza di attrazione gravitazionale) Due corpi puntiformi di massa e si attraggono vicendevolmente con una forza (forza che il corpo A esercita sul corpo B), o (forza che il
IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI
 IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI Prof. Luciana Carrieri (responsabile del planetario) Il Planetario del Liceo Scacchi di Bari è uno strumento ottico che proietta su una cupola di 5 metri di diametro l immagine
IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI Prof. Luciana Carrieri (responsabile del planetario) Il Planetario del Liceo Scacchi di Bari è uno strumento ottico che proietta su una cupola di 5 metri di diametro l immagine
L origine dell universo
 LE STELLE Le stelle sono corpi celesti luminosi, formati da enormi quantità di gas caldissimo (principalmente idrogeno ed elio), che producono energia attraverso un processo di fusione nucleare dove 4
LE STELLE Le stelle sono corpi celesti luminosi, formati da enormi quantità di gas caldissimo (principalmente idrogeno ed elio), che producono energia attraverso un processo di fusione nucleare dove 4
Appunti di Cinematica
 Appunti di Cinematica Thomas Bellotti 28 novembre 2010 Indice 1 Punto materiale, traiettoria e legge oraria 1 1.1 Il punto materiale.......................... 1 1.2 La traiettoria.............................
Appunti di Cinematica Thomas Bellotti 28 novembre 2010 Indice 1 Punto materiale, traiettoria e legge oraria 1 1.1 Il punto materiale.......................... 1 1.2 La traiettoria.............................
4. LE FORZE E LA LORO MISURA
 4. LE FORZE E LA LORO MISURA 4.1 - Le forze e i loro effetti Tante azioni che facciamo o vediamo non sono altro che il risultato di una o più forze. Le forze non si vedono e ci accorgiamo della loro presenza
4. LE FORZE E LA LORO MISURA 4.1 - Le forze e i loro effetti Tante azioni che facciamo o vediamo non sono altro che il risultato di una o più forze. Le forze non si vedono e ci accorgiamo della loro presenza
MISURE DI ERATOSTENE E PROVE DEL MOTO DI ROTAZIONE TERRESTRE. Presentazione di Emma Donisi, Elena Perego, Camilla Antonietti, Alessandro D'Archi
 MISURE DI ERATOSTENE E PROVE DEL MOTO DI ROTAZIONE TERRESTRE Presentazione di Emma Donisi, Elena Perego, Camilla Antonietti, Alessandro D'Archi Mappa Eratostene Prima di lui Teoria Pratica Dopo di lui
MISURE DI ERATOSTENE E PROVE DEL MOTO DI ROTAZIONE TERRESTRE Presentazione di Emma Donisi, Elena Perego, Camilla Antonietti, Alessandro D'Archi Mappa Eratostene Prima di lui Teoria Pratica Dopo di lui
LA PROGRAMMAZIONE DI FISICA SUI 5 ANNI IN VISTA DELL ESAME DI STATO
 LA PROGRAMMAZIONE DI FISICA SUI 5 ANNI IN VISTA DELL ESAME DI STATO Marco Bolzon 02/12/2015 La Riforma della scuola - 2010 La programmazione di Fisica sui cinque anni in vista dell'esame di Stato > La
LA PROGRAMMAZIONE DI FISICA SUI 5 ANNI IN VISTA DELL ESAME DI STATO Marco Bolzon 02/12/2015 La Riforma della scuola - 2010 La programmazione di Fisica sui cinque anni in vista dell'esame di Stato > La
Il gatto di Schroedinger: vivo, morto, o...?
 Il gatto di Schroedinger: vivo, morto, o...? Lorenzo Maccone Dip. Fisica, INFN Pavia, Universita' di Pavia www.qubit.it maccone@unipv.it Di cosa parlero? Di cosa parlero? Mostrero' come Stranezza della
Il gatto di Schroedinger: vivo, morto, o...? Lorenzo Maccone Dip. Fisica, INFN Pavia, Universita' di Pavia www.qubit.it maccone@unipv.it Di cosa parlero? Di cosa parlero? Mostrero' come Stranezza della
Il modello cosmologico standard e l enigma dell espansione
 Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio astronomico di Brera Universo in fiore Il modello cosmologico standard e l enigma dell espansione Luigi Guzzo Luigi.guzzo@brera.inaf.it INAF-Osservatorio
Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio astronomico di Brera Universo in fiore Il modello cosmologico standard e l enigma dell espansione Luigi Guzzo Luigi.guzzo@brera.inaf.it INAF-Osservatorio
Introduzione alla Meccanica: Cinematica
 Introduzione alla Meccanica: Cinematica La Cinematica si occupa della descrizione geometrica del moto, senza riferimento alle sue cause. E invece compito della Dinamica mettere in relazione il moto con
Introduzione alla Meccanica: Cinematica La Cinematica si occupa della descrizione geometrica del moto, senza riferimento alle sue cause. E invece compito della Dinamica mettere in relazione il moto con
FISICA. Elaborazione dei dati sperimentali. Autore: prof. Pappalardo Vincenzo docente di Matematica e Fisica
 FISICA Elaborazione dei dati sperimentali Autore: prof. Pappalardo Vincenzo docente di Matematica e Fisica LE GRANDEZZE FISICHE Una grandezza fisica è una quantità che può essere misurata con uno strumento
FISICA Elaborazione dei dati sperimentali Autore: prof. Pappalardo Vincenzo docente di Matematica e Fisica LE GRANDEZZE FISICHE Una grandezza fisica è una quantità che può essere misurata con uno strumento
Ricerca Di Fisica La Teoria della Relatività
 Liceo Scientifico L. Da Vinci. Ricerca Di Fisica La Teoria della Relatività Romeo Marika VH A.S. 2004/2005. La teoria della relatività. Nel 1905, Albert Einstein, allora impiegato all'ufficio Brevetti
Liceo Scientifico L. Da Vinci. Ricerca Di Fisica La Teoria della Relatività Romeo Marika VH A.S. 2004/2005. La teoria della relatività. Nel 1905, Albert Einstein, allora impiegato all'ufficio Brevetti
 DIVINA COMMEDIA Opera elaborata da Dante tra il 1304 (o 1306) e il 1320-1321, la Divina Commedia appartiene al genere letterario dei poemi allegorico-didascalici che si propongono una funzione educativa
DIVINA COMMEDIA Opera elaborata da Dante tra il 1304 (o 1306) e il 1320-1321, la Divina Commedia appartiene al genere letterario dei poemi allegorico-didascalici che si propongono una funzione educativa
Premessa: Si continua a studiare il moto degli oggetti in approssimazione di PUNTO MATERIALE
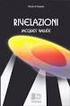 Leggi della Dinamica Premessa: Si continua a studiare il moto degli oggetti in approssimazione di PUNTO MATERIALE Fisica con Elementi di Matematica 1 Leggi della Dinamica Perché i corpi cambiano il loro
Leggi della Dinamica Premessa: Si continua a studiare il moto degli oggetti in approssimazione di PUNTO MATERIALE Fisica con Elementi di Matematica 1 Leggi della Dinamica Perché i corpi cambiano il loro
Corso di Informatica Modulo T1 1 - Il concetto di problema
 Corso di Informatica Modulo T1 1 - Il concetto di problema 1 Prerequisiti Concetti intuitivi di: Proporzione Problema Variabile Numeri interi e reali 2 1 Introduzione Nel risolvere un problema abbiamo
Corso di Informatica Modulo T1 1 - Il concetto di problema 1 Prerequisiti Concetti intuitivi di: Proporzione Problema Variabile Numeri interi e reali 2 1 Introduzione Nel risolvere un problema abbiamo
D I V I S T A S U L L U N I V E R S O
 IL MIGLIOR PUNTO D I V I S T A S U L L U N I V E R S O 13 MILIARDI DI ANNI LUCE: la distanza dell oggetto più lontano osservato da un ricercatore INAF. È un record mondiale. È un lampo di raggi gamma prodotto
IL MIGLIOR PUNTO D I V I S T A S U L L U N I V E R S O 13 MILIARDI DI ANNI LUCE: la distanza dell oggetto più lontano osservato da un ricercatore INAF. È un record mondiale. È un lampo di raggi gamma prodotto
Cantor e l infinito Riccardo Cristoferi
 Cantor e l infinito Riccardo Cristoferi Georg Cantor è il fondatore della teoria degli insiemi. Studia l infinito e gli insiemi ordinati, dimostrando che i numeri reali sono più numerosi dei numeri naturali.
Cantor e l infinito Riccardo Cristoferi Georg Cantor è il fondatore della teoria degli insiemi. Studia l infinito e gli insiemi ordinati, dimostrando che i numeri reali sono più numerosi dei numeri naturali.
Fisica delle cose banali Parte II
 Fisica delle cose banali Parte II Giovanni Organtini Sapienza Università di Roma & INFN-Sez. di Roma Fisica quotidiana la teoria della relatività al lavoro Giovanni Organtini Sapienza Università di Roma
Fisica delle cose banali Parte II Giovanni Organtini Sapienza Università di Roma & INFN-Sez. di Roma Fisica quotidiana la teoria della relatività al lavoro Giovanni Organtini Sapienza Università di Roma
4. I principi della meccanica
 1 Leggi del moto 4. I principi della meccanica Come si è visto la cinematica studia il moto dal punto di vista descrittivo, ma non si sofferma sulle cause di esso. Ciò è compito della dinamica. Alla base
1 Leggi del moto 4. I principi della meccanica Come si è visto la cinematica studia il moto dal punto di vista descrittivo, ma non si sofferma sulle cause di esso. Ciò è compito della dinamica. Alla base
Esame scritto dell Opzione specifica. Filosofia + Pedagogia/Psicologia
 Nome e Cognome:. Gruppo:..Numero:.. Esame scritto dell Opzione specifica Filosofia + Pedagogia/Psicologia Parte interdisciplinare (Tempo a disposizione: 1 ora) Legga attentamente il seguente brano di Immanuel
Nome e Cognome:. Gruppo:..Numero:.. Esame scritto dell Opzione specifica Filosofia + Pedagogia/Psicologia Parte interdisciplinare (Tempo a disposizione: 1 ora) Legga attentamente il seguente brano di Immanuel
Lezioni XII-XIII. Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele
 Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Dinamica. Relazione tra forze e movimento dei corpi Principi della dinamica Conce4 di forza, inerzia, massa
 Dinamica Relazione tra forze e movimento dei corpi Principi della dinamica Conce4 di forza, inerzia, massa Cinematica Moto rettilineo uniforme s=s 0 +v(t-t 0 ) Moto uniformemente accelerato v=v 0 +a(t-t
Dinamica Relazione tra forze e movimento dei corpi Principi della dinamica Conce4 di forza, inerzia, massa Cinematica Moto rettilineo uniforme s=s 0 +v(t-t 0 ) Moto uniformemente accelerato v=v 0 +a(t-t
L illuminazione della Terra
 L illuminazione della Terra I moti della Terra nello spazio Sole Mercurio Venere Terra La Terra e gli altri pianeti orbitano intorno al Sole, che è una stella con un raggio di circa 700 000 km e dista
L illuminazione della Terra I moti della Terra nello spazio Sole Mercurio Venere Terra La Terra e gli altri pianeti orbitano intorno al Sole, che è una stella con un raggio di circa 700 000 km e dista
Relatività e Meccanica Quantistica: concetti e idee. Relativity and Quantum Mechanics: concepts and ideas. Carlo Cosmelli
 Relatività e Meccanica Quantistica: concetti e idee Relativity and Quantum Mechanics: concepts and ideas Settimana 1 - Il punto della situazione Lezione 1.1 Carlo Cosmelli 1 Il XX secolo, nascono due nuove
Relatività e Meccanica Quantistica: concetti e idee Relativity and Quantum Mechanics: concepts and ideas Settimana 1 - Il punto della situazione Lezione 1.1 Carlo Cosmelli 1 Il XX secolo, nascono due nuove
Progetto Laboratori Lauree Scientifiche
 Progetto Laboratori Lauree Scientifiche Laboratorio sulle funzioni trigonometriche Le ore di insolazione giornaliera in funzione della latitudine Bozza di progetto Nel seguito verrà presentata la descrizione
Progetto Laboratori Lauree Scientifiche Laboratorio sulle funzioni trigonometriche Le ore di insolazione giornaliera in funzione della latitudine Bozza di progetto Nel seguito verrà presentata la descrizione
Le rappresentazioni e le proprietà dei numeri reali
 Le rappresentazioni e le proprietà dei numeri reali In generale un numero qualsiasi, con sviluppo decimale finito o infinito, positivo, negativo o nullo, è un numero relativo e appartiene all insieme dei
Le rappresentazioni e le proprietà dei numeri reali In generale un numero qualsiasi, con sviluppo decimale finito o infinito, positivo, negativo o nullo, è un numero relativo e appartiene all insieme dei
PERCORSI INNOVATIVI in Matematica e in Fisica. Conferenze
 PROGETTO DI ECCELLENZA 2014 PERCORSI INNOVATIVI in Matematica e in Fisica Conferenze I Paradossi di Zenone di Elea I Paradossi di Zenone di Elea I Paradossi di Zenone di Elea Alfredo MARZOCCHI I Paradossi
PROGETTO DI ECCELLENZA 2014 PERCORSI INNOVATIVI in Matematica e in Fisica Conferenze I Paradossi di Zenone di Elea I Paradossi di Zenone di Elea I Paradossi di Zenone di Elea Alfredo MARZOCCHI I Paradossi
L essenziale è invisibile agli occhi: la materia oscura
 L essenziale è invisibile agli occhi: la materia oscura Prof. Armando Pisani, M. Peressi e G. Pastore I.S.I.S. (Lic. Classico) D. Alighieri (GO), A.S. 2013-14 Indice Introduzione Di che cosa è fatto l
L essenziale è invisibile agli occhi: la materia oscura Prof. Armando Pisani, M. Peressi e G. Pastore I.S.I.S. (Lic. Classico) D. Alighieri (GO), A.S. 2013-14 Indice Introduzione Di che cosa è fatto l
Matematica e poesia. alla ricerca di un numero misterioso
 Matematica e poesia alla ricerca di un numero misterioso Il sonetto È possibile fare uno studio di tipo matematico su una poesia? C'è un rapporto fra i numeri di cui si serve la matematica e le parole
Matematica e poesia alla ricerca di un numero misterioso Il sonetto È possibile fare uno studio di tipo matematico su una poesia? C'è un rapporto fra i numeri di cui si serve la matematica e le parole
Legatura quadra classica
 Quasi tutti pensano di conoscere bene la legatura quadra e di sapere tutto su di essa però forse qualcosa di nuovo da imparare c è ancora e vedremo qui non delle belle idee, ma il risultato di esperienze
Quasi tutti pensano di conoscere bene la legatura quadra e di sapere tutto su di essa però forse qualcosa di nuovo da imparare c è ancora e vedremo qui non delle belle idee, ma il risultato di esperienze
7. INSIEMI APERTI, INSIEMI CHIUSI, INSIEMI NE APERTI NE CHIUSI
 7. INSIEMI APERTI, INSIEMI CHIUSI, INSIEMI NE APERTI NE CHIUSI Sia E un insieme numerico, sia cioè. Esempi Si dice che E è un insieme APERTO se tutti i suoi punti sono interni. Ogni intervallo aperto (dove
7. INSIEMI APERTI, INSIEMI CHIUSI, INSIEMI NE APERTI NE CHIUSI Sia E un insieme numerico, sia cioè. Esempi Si dice che E è un insieme APERTO se tutti i suoi punti sono interni. Ogni intervallo aperto (dove
10 7 metri Il nostro pianeta, la Terra, vista da una distanza di chilometri dalla sua superficie.
 10 2 metri Qui parte il sentiero che vi porterà dal centro di Bologna, fino ai confini più estremi dell Universo visibile. Il nostro punto di partenza è a 100 metri di altezza su Piazza Maggiore. 10 3
10 2 metri Qui parte il sentiero che vi porterà dal centro di Bologna, fino ai confini più estremi dell Universo visibile. Il nostro punto di partenza è a 100 metri di altezza su Piazza Maggiore. 10 3
L energia potenziale gravitazionale di un oggetto di massa m che si trova ad un altezza h rispetto ad un livello scelto come riferimento è: E PG = mgh
 Lezione 15 - pag.1 Lezione 15: L energia potenziale e l'energia meccanica 15.1. L energia potenziale gravitazionale Consideriamo quello che succede quando solleviamo un oggetto, applicando un forza appena
Lezione 15 - pag.1 Lezione 15: L energia potenziale e l'energia meccanica 15.1. L energia potenziale gravitazionale Consideriamo quello che succede quando solleviamo un oggetto, applicando un forza appena
LEZIONE 6. L Universo al telescopio
 L Universo al telescopio LEZIONE 6 1: La velocità della luce Come abbiamo già accennato, la luce viaggia nel vuoto ad una velocità pari a 300'000 km/s. Per fare un paragone, la luce ci impiega circa 1
L Universo al telescopio LEZIONE 6 1: La velocità della luce Come abbiamo già accennato, la luce viaggia nel vuoto ad una velocità pari a 300'000 km/s. Per fare un paragone, la luce ci impiega circa 1
Il Metodo Scientifico
 Unita Naturali Il Metodo Scientifico La Fisica si occupa di descrivere ed interpretare i fenomeni naturali usando il metodo scientifico. Passi del metodo scientifico: Schematizzazione: modello semplificato
Unita Naturali Il Metodo Scientifico La Fisica si occupa di descrivere ed interpretare i fenomeni naturali usando il metodo scientifico. Passi del metodo scientifico: Schematizzazione: modello semplificato
GAIALAB:INCONTRIAMO L AMBIENTE IN LABORATORIO
 LABORATORIO DI FISICA Le forze che governano la natura La forza ha carattere vettoriale, cioè caratterizzata da un intensità, una direzione e un verso oltre che da un punto di applicazione. Rappresentazione
LABORATORIO DI FISICA Le forze che governano la natura La forza ha carattere vettoriale, cioè caratterizzata da un intensità, una direzione e un verso oltre che da un punto di applicazione. Rappresentazione
Il taccuino dell esploratore
 Il taccuino dell esploratore a cura di ORESTE GALLO (per gli scout: Lupo Tenace) QUINTA CHIACCHIERATA L ORIENTAMENTO (prima parte) Un buon escursionista fra le proprie conoscenze teoriche deve perlomeno
Il taccuino dell esploratore a cura di ORESTE GALLO (per gli scout: Lupo Tenace) QUINTA CHIACCHIERATA L ORIENTAMENTO (prima parte) Un buon escursionista fra le proprie conoscenze teoriche deve perlomeno
LA FORZA...SIA CON TE!
 LA FORZA...SIA CON TE! CHE COS'E' LA FORZA? E' UNA GRANDEZZA FISICA VETTORIALE. L'UNITA' DI MISURA NEL S.I. E' IL "NEWTON" ( N ), DAL CELEBRE SCIENZIATO INGLESE ISAAC NEWTON, CHE NE HA STUDIATO LE LEGGI,
LA FORZA...SIA CON TE! CHE COS'E' LA FORZA? E' UNA GRANDEZZA FISICA VETTORIALE. L'UNITA' DI MISURA NEL S.I. E' IL "NEWTON" ( N ), DAL CELEBRE SCIENZIATO INGLESE ISAAC NEWTON, CHE NE HA STUDIATO LE LEGGI,
FISICA (dal greco physis = natura )
 FISICA (dal greco physis = natura ) scopo della fisica è lo studio dei fenomeni naturali E' una scienza che si propone di osservare e spiegare i fenomeni naturali. Le parti della fisica Nome Argomenti
FISICA (dal greco physis = natura ) scopo della fisica è lo studio dei fenomeni naturali E' una scienza che si propone di osservare e spiegare i fenomeni naturali. Le parti della fisica Nome Argomenti
Unità 2 - L ambiente celeste
 Unità 2 - L ambiente celeste 1 1. La Sfera celeste Stelle in rotazione 2 1. La Sfera celeste Punti di riferimento sulla Sfera celeste 3 1. La Sfera celeste Individuare la Stella polare sulla Sfera celeste
Unità 2 - L ambiente celeste 1 1. La Sfera celeste Stelle in rotazione 2 1. La Sfera celeste Punti di riferimento sulla Sfera celeste 3 1. La Sfera celeste Individuare la Stella polare sulla Sfera celeste
Una prima distinzione nell ambito della teoria dei giochi è quella tra: Giochi cooperativi (si possono fare accordi vincolanti)
 Una prima distinzione nell ambito della teoria dei giochi è quella tra: Giochi cooperativi (si possono fare accordi vincolanti) Giochi non cooperativi (non si possono fare accordi vincolanti) Ci occuperemo
Una prima distinzione nell ambito della teoria dei giochi è quella tra: Giochi cooperativi (si possono fare accordi vincolanti) Giochi non cooperativi (non si possono fare accordi vincolanti) Ci occuperemo
LA STELLA DELLA NOSTRA VITA
 LA STELLA DELLA NOSTRA VITA (di mortola carlo) Il Sole (vero) non è affidabile per la misurazione del tempo perché non percorre, apparentemente, l'equatore celeste, dove si misurano i tempi degli astri,
LA STELLA DELLA NOSTRA VITA (di mortola carlo) Il Sole (vero) non è affidabile per la misurazione del tempo perché non percorre, apparentemente, l'equatore celeste, dove si misurano i tempi degli astri,
Intervista con la professoressa Elisabetta Santoro, docente di Lingua Italiana presso la Facoltà di Lettere dell Università di São Paulo (FFLCH USP).
 Lezione 15 Intervista con la professoressa Elisabetta Santoro, docente di Lingua Italiana presso la Facoltà di Lettere dell Università di São Paulo (FFLCH USP). Tema: Il passato prossimo e l imperfetto
Lezione 15 Intervista con la professoressa Elisabetta Santoro, docente di Lingua Italiana presso la Facoltà di Lettere dell Università di São Paulo (FFLCH USP). Tema: Il passato prossimo e l imperfetto
1 che tende alla perfezione.
 La fisica di Aristotele [384-322 a.c.].] Punti fondamentali Esistenza di nature qualitativamente determinate. Esistenza di un Cosmo: la credenza cioè nell esistenza di principi di ordine, in virtù dei
La fisica di Aristotele [384-322 a.c.].] Punti fondamentali Esistenza di nature qualitativamente determinate. Esistenza di un Cosmo: la credenza cioè nell esistenza di principi di ordine, in virtù dei
Si fuit aliquod tempus antequam faceres caelum et terram
 Si fuit aliquod tempus antequam faceres caelum et terram Alessandro De Angelis Dipartimento di Fisica dell Universita di Udine e INFN Trieste Giornate Scientifiche di Udine e Pordenone, Marzo 2002 Time
Si fuit aliquod tempus antequam faceres caelum et terram Alessandro De Angelis Dipartimento di Fisica dell Universita di Udine e INFN Trieste Giornate Scientifiche di Udine e Pordenone, Marzo 2002 Time
Equazioni lineari con due o più incognite
 Equazioni lineari con due o più incognite Siano date le uguaglianze: k 0; x + y = 6; 3a + b c = 8. La prima ha un termine incognito rappresentato dal simbolo letterale k; la seconda ha due termini incogniti
Equazioni lineari con due o più incognite Siano date le uguaglianze: k 0; x + y = 6; 3a + b c = 8. La prima ha un termine incognito rappresentato dal simbolo letterale k; la seconda ha due termini incogniti
sfera celeste e coordinate astronomiche
 sfera celeste e coordinate astronomiche sfera celeste La sfera celeste appare come una grande sfera che ruota su se stessa, al cui centro sta la Terra immobile, e sulla cui superficie stanno le stelle
sfera celeste e coordinate astronomiche sfera celeste La sfera celeste appare come una grande sfera che ruota su se stessa, al cui centro sta la Terra immobile, e sulla cui superficie stanno le stelle
PRIMI ELEMENTI DI TERMODINAMICA. La termodinamica studia le leggi con cui i sistemi scambiano (cedono e ricevono) energia con l ambiente.
 PRIMI ELEMENTI DI TERMODINAMICA Un sistema è un insieme di corpi che possiamo immaginare avvolti da una superficie chiusa, ma permeabile alla materia e all energia. L ambiente è tutto ciò che si trova
PRIMI ELEMENTI DI TERMODINAMICA Un sistema è un insieme di corpi che possiamo immaginare avvolti da una superficie chiusa, ma permeabile alla materia e all energia. L ambiente è tutto ciò che si trova
MAGNETISMO. Alcuni materiali (calamite o magneti) hanno la proprietà di attirare pezzetti di ferro (o cobalto, nickel e gadolinio).
 MAGNETISMO Alcuni materiali (calamite o magneti) hanno la proprietà di attirare pezzetti di ferro (o cobalto, nickel e gadolinio). Le proprietà magnetiche si manifestano alle estremità del magnete, chiamate
MAGNETISMO Alcuni materiali (calamite o magneti) hanno la proprietà di attirare pezzetti di ferro (o cobalto, nickel e gadolinio). Le proprietà magnetiche si manifestano alle estremità del magnete, chiamate
Esercitazione 1. Invece, essendo il mezzo omogeneo, il vettore sarà espresso come segue
 1.1 Una sfera conduttrice di raggio R 1 = 10 cm ha una carica Q = 10-6 C ed è circondata da uno strato sferico di dielettrico di raggio (esterno) R 2 = 20 cm e costante dielettrica relativa. Determinare
1.1 Una sfera conduttrice di raggio R 1 = 10 cm ha una carica Q = 10-6 C ed è circondata da uno strato sferico di dielettrico di raggio (esterno) R 2 = 20 cm e costante dielettrica relativa. Determinare
Divisibilità per 4. Riprendiamo il nostro numero. se e solo se
 Divisibilità per 4 Riprendiamo il nostro numero N = a n 10 n + a n 1 10 n 1 + + a 2 10 2 + a 1 10 + a 0 Osserviamo che le potenze di dieci sono divisibili per 4 a partire da 10 2 e quindi tutti gli addendi
Divisibilità per 4 Riprendiamo il nostro numero N = a n 10 n + a n 1 10 n 1 + + a 2 10 2 + a 1 10 + a 0 Osserviamo che le potenze di dieci sono divisibili per 4 a partire da 10 2 e quindi tutti gli addendi
Meccanica: Introduzione. Lo Studio del moto degli oggetti
 Meccanica: Introduzione Lo Studio del moto degli oggetti 1 Grandezze fisiche n Scalari : esprimibili mediante singoli numeri (es. massa,temperatura, energia, carica elettrica ecc.) n Vettoriali : per essere
Meccanica: Introduzione Lo Studio del moto degli oggetti 1 Grandezze fisiche n Scalari : esprimibili mediante singoli numeri (es. massa,temperatura, energia, carica elettrica ecc.) n Vettoriali : per essere
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Salvemini - La Pira A.S QUANDO I SENSI CI INGANNANO MA LA GEOMETRIA NO!
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Salvemini - La Pira A.S. 2007-2008 QUANDO I SENSI CI INGANNANO MA LA GEOMETRIA NO! 1 CLASSE IG Insegnante Marta Del Rosso FASE 1: Lezione introduttiva sui concetti di perpendicolarità
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Salvemini - La Pira A.S. 2007-2008 QUANDO I SENSI CI INGANNANO MA LA GEOMETRIA NO! 1 CLASSE IG Insegnante Marta Del Rosso FASE 1: Lezione introduttiva sui concetti di perpendicolarità
Antonino Maria Ferro Esercizi di matematica per giovani e giovanissimi
 Saggistica Aracne Antonino Maria Ferro Esercizi di matematica per giovani e giovanissimi Copyright MMXIV ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A
Saggistica Aracne Antonino Maria Ferro Esercizi di matematica per giovani e giovanissimi Copyright MMXIV ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A
Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici
 Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici Il presente documento individua le conoscenze, abilità e competenze che lo studente dovrà aver acquisito al termine
Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici Il presente documento individua le conoscenze, abilità e competenze che lo studente dovrà aver acquisito al termine
La quarta dimensione del romanzo Lo spazio-tempo relativistico nella letteratura del Novecento
 Francesca Romana Capone - Roma, 3 febbraio 2010 La Lo spazio-tempo relativistico nella letteratura del Novecento 1. Qualche premessa 1.1 Le due culture si parlano? A scuola Nella realtà 2 1 1. Qualche
Francesca Romana Capone - Roma, 3 febbraio 2010 La Lo spazio-tempo relativistico nella letteratura del Novecento 1. Qualche premessa 1.1 Le due culture si parlano? A scuola Nella realtà 2 1 1. Qualche
Fenomeni connessi con il moto ondoso.
 Fenomeni connessi con il moto ondoso 0. Obbiettivo In queste pagine analizzeremo alcuni fenomeni connessi con il moto ondoso: la riflessione, la rifrazione e la diffrazione. Per visualizzare tali fenomeni
Fenomeni connessi con il moto ondoso 0. Obbiettivo In queste pagine analizzeremo alcuni fenomeni connessi con il moto ondoso: la riflessione, la rifrazione e la diffrazione. Per visualizzare tali fenomeni
