Che cosa fanno gli antropologi? Questioni di metodo.
|
|
|
- Renata Leone
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Angela Molinari Che cosa fanno gli antropologi? Questioni di metodo. Il titolo dell incontro di oggi richiama in modo abbastanza evidente una celebre citazione di Clifford Geertz: Se volete capire che cosa è una scienza, non dovete considerare innanzitutto le sue teorie e le sue scoperte (e comunque non quello che dicono i suoi apologeti): dovete guardare che cosa fanno quelli che la praticano. Nell antropologia, o per lo meno nell antropologia sociale, coloro che la praticano fanno dell etnografia. Ed è nel capire che cosa è l etnografia o, più precisamente che cosa è fare etnografia, che si può cominciare ad afferrare in che cosa consista l analisi antropologica come forma di conoscenza. Il passaggio è contenuto in un testo del 1973, dal titolo Verso una teoria interpretativa della cultura, una sorta di manifesto dell antropologia interpretativa. Da un lato viene ribadita la connessione tra scienza e metodo al cuore della visione moderna del sapere. La rivoluzione scientifica è stata principalmente una rivoluzione metodologica. Ha fondato la conoscenza sull esperienza diretta e la verifica sperimentale, ossia su procedure standardizzate, graduali e controllate che orientano la comunità scientifica verso una conoscenza intersoggettivamente condivisa. Da un altro le affermazioni di Geertz sono a loro modo rivoluzionarie. Sovvertono un inveterata consuetudine disciplinare delucidata con chiarezza da Lévi-Strauss in un testo di vent anni precedente, che assegnava alla pratica etnografica (identificata sostanzialmente con la raccolta dei dati ) un ruolo distinto e chiaramente subordinato alla riflessione teorica, condotta da etnologia e antropologia a un crescente livello di generalità (Lévi-Strauss, 1954). Geertz, all opposto, assegna all etnografia un ruolo prioritario. Ne valorizza la natura non strumentale o accessoria non si tratta di tecniche o di procedure convenute ma propriamente conoscitiva, o più esattamente interpretativa. L etnografia viene definita, sulla scorta di Gilbert Ryle, come thik description, una descrizione, cioè, non pura e semplice ma densa, latrice di conoscenza. Fare etnografia è la stessa cosa che produrre antropologia. Riprendendo un costrutto proprio dell ermeneutica, tra le due dimensioni vi è una caratteristica circolarità. Commentare la citazione di Geertz permette di focalizzare il tema di questo incontro. Etnografia è appunto ciò che gli antropologi fanno, il metodo di cui si sostanzia il loro sapere. A onor del vero, il primo titolo che mi era stato proposto era un altro. L abbiamo modificato perché sicuramente quello che è stato scelto è più immediato. Personalmente, però, ne ero entusiasta. Suonava: Metodo, parola da antropologo. Lo trovavo ambizioso e anche provocatorio. Se andate sul sito del Museo a sbirciare i testi degli altri relatori, troverete concetti come identità, patrimonio, dono, minoranze, che quasi istintivamente sembrano parole da antropologo. Ma metodo? Il titolo esprime una tesi forte, rivendica alla disciplina un ruolo
2 significativo entro il dibattito interdisciplinare sul metodo del sapere e sulla scienza in generale. E anche provocatorio, perché l antropologo non è certo il prototipo dello scienziato che staziona nel nostro immaginario. Svilupparlo è accettare una sfida. Tanto per cominciare il termine stesso etnografia è estremamente denso. La sua etimologia racchiude una pluralità di significati e altrettante questioni. Etnografia significa letteralmente scrittura di un popolo (dal greco ethnos, popolo e graphein, scrivere ). A un primo livello indica la descrizione minuziosa e particolareggiata della vita culturale di un gruppo umano, una sorta di ritratto. Almeno a partire dall inizio del Novecento, tuttavia, allude più esattamente al processo di ricerca grazie al quale la descrizione viene compiuta, il cosiddetto lavoro di campo (fieldwork). In apparenza si tratta un attività circoscritta, che corrisponde alla durata effettiva e alla precisa localizzazione fisica e tematica dell indagine. In realtà, implica un attività intellettuale complessa, che inizia molto prima che il ricercatore si metta in viaggio un lavoro di preparazione teorico-pratica di per sé avventuroso e continua per un tempo indefinito anche dopo che il ricercatore è tornato dal campo. E normalmente nel suo contesto di provenienza, infatti, che lo studioso intraprende la complessa e stratificata attività di analisi ed elaborazione dei dati raccolti con l osservazione intensiva e le relazioni che ha saputo instaurare, al fine di produrre un documento, solitamente scritto, che rappresenta il precipitato materiale del suo lavoro e che di fatto lo qualifica come antropologo di fronte alla comunità scientifica. In tal senso l etnografia viene a coincidere con il resoconto della ricerca, cioè con la monografia etnografica, un vero e proprio genere letterario che segue canoni precisi e si differenzia da altri tipi di resoconti. Argonauti del Pacifico Occidentale di Malinowski (1922) ne rappresenta il prototipo. Da ultimo, col termine etnografia ci si riferisce, più in generale, all intero corpus degli studi prodotti su un determinato gruppo umano o area geografica dal punto di vista antropologico. Si parla perciò di etnografia beduina, etnografia balinese, etnografia trobriandese ecc. Riassumendo, la parola etnografia indica contemporaneamente un processo e un prodotto. A partire da Malinowski, la sua importanza per la professionalizzazione del ricercatore è divenuta tale che, intesa soprattutto in quanto esperienza di ricerca, è stata paragonata a un vero e proprio rito di passaggio dal carattere iniziatico. Il parallelismo sottolinea, da un lato, la valenza metodologica della ricerca empirica come base essenziale per l elaborazione teorica. In questo senso, Paul Rabinow riferisce come nel Dipartimento di Antropologia dell Università di Chicago fosse in auge una distinzione tra i veri antropologi (quelli che avevano fatto un esperienza di ricerca sul campo) e quelli che non lo erano, a prescindere dalle loro conoscenze antropologiche o dalla loro capacità di notare le lacune teoriche di alcuni autori classici. Agli studenti veniva detto: Non dimenticate che quegli autori furono dei grandi ricercatori sul campo (Rabinow, 1977). Da un altro, il paragone con l iniziazione enfatizza l incidenza profonda, personale e idiosincratica dell esperienza di ricerca sulla biografia del ricercatore. Volente o nolente rappresenta una cesura nel suo percorso esistenziale, dalla quale è
3 molto difficile che ritorni esattamente com era prima. Forse nessun antropologo ha descritto questi aspetti con pari sensibilità di Lévi-Strauss nel passaggio che segue: Abbandonando il suo paese, il suo focolare, per periodi prolungati; esponendosi alla fame, alla malattia, talvolta al pericolo; esponendo le sue abitudini, le sue credenze, e le sue convinzioni a una profanazione di cui si rende complice, quando assume, senza restrizioni mentali né secondi fini, le forme di vita di una società straniera, l antropologo pratica l osservazione integrale, quella dopo cui non esiste più nulla, se non l assorbimento definitivo ed è un rischio dell osservatore da parte dell oggetto osservato (Lévi- Strauss, 1960). In realtà, tutta l enfasi accordata alla mistica del campo si scontra con un autentico paradosso, che è ancora Rabinow a tratteggiare in modo significativo: Quando eravamo studenti ci veniva detto che l antropologia è esperienza ; che non avreste potuto essere antropologi fino a quando non foste stati in grado di fare quell esperienza. Ma quando si torna dal campo si applica immediatamente il principio opposto: l antropologia non è l esperienza che vi ha iniziato, ma solo i dati oggettivi che avete riportato a casa (Rabinow, 1977). Nella più parte delle monografie cosiddette classiche, i dati oggettivi riportati a casa sono presentati in maniera autoevidente, senza fare alcun riferimento alle reali condizioni che hanno permesso di produrli. Il lavoro di campo sparisce dal testo pur essendone il presupposto necessario, sottraendosi alla verifica. Il processo è occultato nel prodotto, contraddicendo il principio cardine della conoscenza scientifica. Più in generale, sulla pratica etnografica si è scritto molto poco. A parte scarne elaborazioni formali e tecniche su alcuni suoi aspetti, le pubblicazioni e gli insegnamenti accademici sui fondamenti epistemologici, metodologici ed etici dell etnografia hanno fatto decisamente fatica a imporsi. Per lungo tempo il lavoro sul campo è stato ritenuto qualcosa che si impara semplicemente con la pratica, un abilità che si acquisisce attraverso il tirocinio e l immersione totale, più una matita e un quaderno di appunti. Per quasi un secolo di applicazione, il metodo è rimasto poco definito e, per molti versi, personalistico. Paradigmatico, a questo proposito, il resoconto di Evans-Pritchard nell appendice di un opera del 1937, Stregoneria, oracoli e magia tra gli Azande, in cui uno dei più grandi etnografi e fra i primi eredi della rivoluzione etnografica malinowskiana rivela i consigli ottenuti dai principali lavoratori sul campo suoi contemporanei prima di partire per l Africa Centrale: L affascinante e intelligente antropologo austro-americano Paul Radin ha sostenuto che nessuno sa bene come procedere nel lavoro sul campo. Forse dovremmo accontentarci di questo tipo di risposta. Tuttavia, quando ero un giovane e ligio studente a Londra, prima di partire per l Africa centrale, ho pensato di raccogliere qualche consiglio da lavoratori sul campo di grande esperienza. Innanzitutto ho chiesto
4 consigli a Westermarck. Tutto ciò che ottenni fu non conversare con un informatore per più di venti minuti, perché se a quel punto se non sarai stufo tu lo sarà lui. Un consiglio molto valido, anche se insufficiente. Ho cercato istruzioni da Haddon, uno fra gli uomini più importanti nella ricerca sul campo. Mi disse che era tutto piuttosto semplice: bisognava sempre comportarsi come un gentiluomo. Anche questo era un ottimo consiglio. Il mio insegnante, Seligman, mi suggerì di prendere dieci grammi di chinino ogni notte e di stare lontano dalle donne. Il famoso egittologo Sir Flanders Petrie mi disse solo di non preoccuparmi se bevevo acqua sporca, presto mi sarei immunizzato. Infine chiesi a Malinowski e mi sentii rispondere di non fare l idiota. Stando le cose in questi termini, come può l antropologia reclamare a se stessa un ruolo di rilievo sulla questione del metodo? I suoi cultori appaiono ben lontani dal rigore procedurale non solo degli scienziati naturali, ma anche dei loro colleghi che si occupano scientificamente dell uomo e della società. Gli storici menzionano gli archivi, i sociologi mostrano i questionari e le tecniche di campionamento, gli psicologi compilano i protocolli sperimentali. Gli antropologi, invece, per lungo tempo hanno evitato di spiegare come l etnografia sia stata prodotta, di esibire la processualità del loro lavoro e di mostrare le tecniche di raccolta dei dati e di scrittura (Descola,1993). Questa sorta di omertà procedurale è stata stigmatizzata come una congiura del silenzio (Berreman, 1962) mistificatoria ed eticamente sospetta. Precisamente nell interrogare le ragioni di questa ambivalenza il contributo dell antropologia può emergere in tutto il suo spessore. Va detto peraltro che tale apporto non è strettamente metodologico, né può essere colto restando all interno di un discorso sul metodo. Ancora una volta sovvengono le citazioni di due grandi antropologi, Levi-Strauss e Geertz che, malgrado la distanza epistemologica, possono essere accostate nel porre l attenzione su un medesimo aspetto: L antropologia sociale deve il suo carattere distintivo, rispetto ad altri rami della conoscenza, all essere probabilmente la sola a valersi della soggettività più intima come un modo di dimostrazione oggettiva (Lévi-Strauss, 1960). C è qualcosa di stravagante nel costruire dei testi apparentemente scientifici partendo da esperienze ampiamente biografiche (Geertz, 1988). In entrambi i casi la specificità del metodo etnografico viene qualificata non tanto in riferimento a una tecnica o a una metodica particolare, come potrebbe essere per altre scienze umane, quanto all intensità del coinvolgimento personale del ricercatore nel contesto della ricerca, al rapporto di intimità e risonanza che viene a crearsi, nel caso dell antropologia, tra il piano biografico e quello conoscitivo. Per questa disciplina si può dire che il metodo coincida con il soggetto-ricercatore, poiché ciò che l etnografo vive è nel contempo ciò che egli fa per colmare la
5 distanza che istintivamente poniamo tra il piano della massima particolarità (il vissuto biografico) e quello della generalità, oggettività e impersonalità che di norma ascriviamo alla scienza. Tra i due autori esiste comunque una differenza, che emerge con chiarezza nel loro stile di scrittura. Il tono di Lévi-Strauss è affermativo, quasi perentorio. La transizione tra i due livelli, soggettivo e scientifico, è pacifica e data quasi per scontata. Non ha dubbi sul fatto che la ricerca etnografica possa assurgere a dimostrazione oggettiva. Geertz, al contrario, utilizza espressioni avverbiali cautelative chi ha una certa familiarità con questo autore non esiterebbe a trovarle ironiche. Parla di testi apparentemente scientifici e di esperienze ampiamente biografiche. Il confine tra soggettività e scienza si fa incerto. Da un lato la sicurezza di cui la scienza solitamente si ammanta viene offuscata da un apparentemente. Da un altro resta chiaro che l esperienza ampiamente biografica, in quanto esperienza di ricerca, non è né può esserlo esclusivamente. La contraddizione tra l esaltazione della ricerca sul campo, da un lato, e il suo occultamento nel resoconto finale, dall altro, e così pure l artistica indeterminatezza che circonda il metodo etnografico (Olivier de Sardan, 1995, p. 28) diventano comprensibili riconducendole alla genesi della concezione moderna della scienza. In particolare, al trattamento da essa riservato alla soggettività. Proprio nel portare alla luce questo sfondo impensato, l antropologia offre il suo apporto alla questione del metodo, in senso epistemologico più che metodologico perché invita a focalizzare l attenzione, al di là del modo in cui gli scienziati operano, sulle condizioni di possibilità del loro sapere. A prescindere dalla complessità e rilevanza della proposta di Lévi-Strauss, la sua posizione riflette con cristallina trasparenza l ideale moderno di scientificità. Storicamente la scienza nasce come scienza naturale, nell orizzonte dei saperi empirico-razionali dell astronomia e della fisica. Utilizza la matematizzazione e la sperimentazione come cardini di un sapere che ambisce a ottenere validità oggettiva. Tale operazione viene garantita filosoficamente dal dualismo cartesiano tra res cogitans e res extensa e dalla conseguente concezione della conoscenza come rappresentazione mentale del mondo. Da un lato vi è il mondo degli oggetti reali, esterni, sottoposti alle leggi della causalità fisica. Dall altro, ontologicamente separato da quello, si staglia il Soggetto quale polo ideale di un insieme di funzioni razionali, un io astratto e impersonale che, proprio in virtù del suo carattere trascendentale, si erige a legislatore della natura. Un io penso che non a caso fonda la propria evidenza attraverso il dubbio sul corpo. Come rileva Silvana Borutti, alla base di questa concezione del sapere vi è la rimozione cosciente delle radici socioculturali del pensiero, praticata come ideale metodico (Borutti, 1999). Il discorso muove dall assunzione pregiudiziale della neutralità del metodo, sia rispetto all oggetto da conoscere, il dato, sia riguardo a un soggetto conoscente preliminarmente desoggettivato, storicamente e biograficamente.
6 A partire dai suoi esordi evoluzionistici della fine dell Ottocento, l antropologia si rivolge allo studio delle società primitive allo stesso modo in cui Comte andava elaborando una fisica della società occidentale. Nell orizzonte epistemologico del positivismo, in cui l espressione scienza naturale è una tautologia o un pleonasmo, l ipotesi di costruire una scienza della società viene immediatamente risolta con l estensione analogica al nuovo campo di ricerca dei metodi e degli standard già elaborati per lo studio della natura. Nello studio della realtà umana viene riprodotta la separazione fra soggetto e oggetto vigente nell ordine dei fenomeni naturali, nonché l autonomia del livello teorico da quello fattuale. I fatti sociali sono oggetti reali trovati nel mondo, accessibili all osservazione diretta, trascrivibili nel linguaggio denotativo e referenziale della scienza. L osservazione è un atto neutro che in nessun modo influenza il significato dell oggetto o interferisce con le procedure di analisi teorica. La scienza è pensata come un sapere nomotetico che consegue i propri risultati mediante l induzione comparativa generalizzatrice. In questa cornice epistemologica, la pratica etnografica, prosaica e descrittiva, è assunta in modo irriflesso. Ha ragion d essere solo in quanto funzionale allo sforzo teorico. La subordinazione cronologica, metodologica e teorica dell etnografia all antropologia è parte integrante dell identità della disciplina: dalla separazione evoluzionistica fra armchair anthropologists e raccoglitori sul campo, alla distinzione malinowskiana fra raccolta dei dati ed elaborazione teorica, all irrilevanza del caso particolare rispetto all analisi funzionalistica della struttura. A Clifford Geertz spetta l indubbio merito di aver problematizzato etnograficamente l esperienza etnografica, anche a partire dall esame dell opera di Malinowski, il promotore dell osservazione partecipante. La vicenda personale e professionale del prototipo del teoricoricercatore sul campo evidenzia in tutta la sua portata la discrasia tra l assunzione di un ideale metodico standardizzato e derivato dalle scienze naturali e la pratica della ricerca umana. La pubblicazione postuma dei suoi diari segreti ha rivelato i retroscena di un approccio considerato esemplare. Gli sfoghi imbarazzanti, gli epiteti razzisti rivolti ai nativi, il lato umano troppo umano di un personaggio mitizzato in virtù del suo rigore sono sicuramente più rilevanti sul piano epistemologico che su quello etico o deontologico. Ciò che evidenziano, non è tanto la qualità morale di Malinowski, ma il fatto che egli rese pubblica l implausibilità del modo di lavorare degli antropologi com è normalmente presentato (Geertz, 1983, p. 71). Non solo, come è ovvio ritenere, Malinowski sentiva qualcosa nel momento stesso in cui applicava l osservazione imparziale. Soprattutto, questo sentimento ha impedito quell adaequatio all oggetto che invece era data acriticamente per scontata. La pratica della ricerca che emerge dai diari rende, così, manifesta la problematicità del presupposto implicito nella decisione metodologica all origine del progetto della modernità. L esperienza malinowskiana testimonia l oscillazione fra il soggetto e l oggetto, l io puro e l io empirico, la neutralità e il coinvolgimento, disattendendo nella pratica quell intransigenza
7 disgiuntiva che si autoimpone come scienza. Esaminata alla luce degli stessi imperativi del positivismo, l osservazione partecipante, che vuol essere obiettiva ma anche partecipativa, si rivela nella sostanza un mito e un paradosso fondato su un equivoco epistemologico. Il caso Malinowski mostra come l etnografia diventi un problema epistemologico nel momento stesso in cui si afferma come metodologicamente imprescindibile. Rivela, in prima istanza, l artificialità dell operazione di oggettivazione del soggetto in quanto condizione di possibilità delle scienze umane. Da un lato, esso è reificato come soggetto conosciuto, l individuo, la società, la cultura quali correlativi umani della natura. Dall altro lato, viene oggettivato come soggetto conoscente, come io puro, astratto dall esperienza sensibilmente intuitiva e identificato con una funzione logica. Insieme all uomo come oggetto del sapere viene cioè fissata l ideale neutralità del ricercatore. Le soggettività degli interlocutori sul campo, le relazioni intersoggettive fra antropologo e informatori così come le loro affinità e differenze, costitutive dell incontro, sono annullate in quanto ostacoli alla conduzione della ricerca. L analisi del lavoro nelle isole Trobriand invita, in sostanza, a pensare il soggetto come un effetto del metodo, non come suo fondamento. In questo senso l antropologia si colloca in una posizione privilegiata nel dialogo interdisciplinare. Recuperando le indicazioni provenienti dalla propria tradizione di ricerca, offre un contributo forte e una testimonianza diretta dell impossibilità della riduzione del ricercatore a puro soggetto conoscente. Ciò che altre scienze hanno potuto dare per scontato per l antropologia diviene problematico, a motivo del maggior grado di coinvolgimento esistenziale che essa comporta per il ricercatore. Colta in questa luce, l indecisione metodologica dell antropologia appare il riflesso di una domanda sul soggetto conoscente. Quella domanda a cui la scienza psicologica, disattendendo il monito comtiano, si è affrettata a rispondere esasperando la riduzione dell io concreto all astrattezza del soggetto psicologico (oggi neuroscientifico) è rimasta aperta per l antropologia. Eppure questa lacuna è tutt altro che difettiva: la difficoltà nel codificare un metodo coincide con la capacità di decodificare la codifica, ossia di problematizzare il doppio legame tra metodo e soggettività, il presupposto infondato del discorso scientifico. Da questa prospettiva le difficoltà definitorie dell etnografia, in luogo di carenze disciplinari, possono essere ritenute i segni di un ambiguità strutturale che interpella le scienze umane nel loro complesso e l intrinseca progettualità del discorso scientifico sull uomo. Il silenzio dell antropologo sulla processualità della sua ricerca chiama direttamente in causa la connessione tra metodo, episteme e realtà, impedendo che diventi un ovvietà. Oggigiorno, a seguito dei grandi cambiamenti occorsi nello statuto della scienza in generale, ma anche nelle condizioni geopolitiche della pratica antropologica, la questione della soggettività etnografica è divenuta centrale nella disciplina, almeno per quanti si riconoscono nel progetto critico e decostruttivo del postmoderno. L antropologia interpretativa di Clifford Geertz, basata sulla rilevanza epistemologica della scrittura e dell antropologo come autore, ne è
8 un espressione emblematica, e così pure le proposte più recenti fondate sul costrutto dell incorporazione (embodiment), in cui la soggettività del ricercatore è declinata in senso pratico e corporeo (Malighetti, Molinari, 2016). Bibliografia BERREMAN, G.D. (1962), Behind many masks: Ethnography and impression management in a Himalayan hill village. In Society for Applied Anthropology. Monograph, 4. Ithaca, New York. BORUTTI, S. (1999b), Filosofia delle scienze umane. Bruno Mondadori, Milano. DESCOLA, R. (1993), Les lances du crépuscule. Plon, Paris. EVANS-PRITCHARD, E.E. (1937), Stregoneria, oracoli e magia fra gli Azande. Tr. it. Raffaello Cortina, Milano FABIETTI, U. (1999), Antropologia culturale: l esperienza e l interpretazione. Laterza, Roma-Bari. GEERTZ, C. (1973), Interpretazione di culture. Tr. it. il Mulino, Bologna GEERTZ, C. (1983), Antropologia interpretativa. Tr. it. il Mulino, Bologna LÉVI-STRAUSS, C. (1958), Antropologia strutturale. Tr. it. il Saggiatore, Milano LÉVI-STRAUSS, C. (1960), Elogio dell antropologia. Tr. it. in Razza e storia e altri studi di antropologia. Einaudi, Torino 1967, pp MALIGHETTI, R., MOLINARI, A. (2016), Il metodo e l antropologia. Il contributo di una scienza inquieta. Raffaello Cortina, Milano. MALINOWSKI, B. (1922), Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva. Tr. it. Bollati Boringhieri, Torino MALINOWSKI, B. (1967), Giornale di un antropologo. Tr. it. Armando, Roma OLIVIER DE SARDAN, J.P. (1995), La politica del campo. Sulla produzione di dati in antropologia. Tr. it. in Cappelletto, F. (a cura di), Vivere l etnografia. SEID, Firenze 2009, pp RABINOW, P. (1977), Reflections on Fieldwork in Morocco. University of California Press, Oakland, ca.
PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO GRUPPO DISCIPLINARE SCIENZE UMANE A.S. 2015/2016
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE Enrico Mattei ISTITUTO TECNICO ECONOMICO LICEO SCIENTIFICO LICEO delle SCIENZE UMANE Via delle Rimembranze, 26 40068 San Lazzaro di Savena BO Tel. 051 464510 464545 fax
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE Enrico Mattei ISTITUTO TECNICO ECONOMICO LICEO SCIENTIFICO LICEO delle SCIENZE UMANE Via delle Rimembranze, 26 40068 San Lazzaro di Savena BO Tel. 051 464510 464545 fax
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre
La modernità tradotta e tradita: dai fatti alle interpretazioni
 La modernità tradotta e tradita: dai fatti alle interpretazioni dove i territori si sovrappongono e le storie s intrecciano (Edward Said) Cose di questo mondo Il disfacimento della distinzione tra il documentario
La modernità tradotta e tradita: dai fatti alle interpretazioni dove i territori si sovrappongono e le storie s intrecciano (Edward Said) Cose di questo mondo Il disfacimento della distinzione tra il documentario
La filosofia della medicina Lezione n. 1
 Storia e Filosofia della Medicina La filosofia della medicina Lezione n. 1 Contenuti del corso Che cos è la filosofia della medicina Dalla medicina magica alla medicina scientifica La medicina scientifica
Storia e Filosofia della Medicina La filosofia della medicina Lezione n. 1 Contenuti del corso Che cos è la filosofia della medicina Dalla medicina magica alla medicina scientifica La medicina scientifica
La riflessività. Nella società
 La riflessività Nella società Il sapere prodotto dalle scienze sociali diventa fonte di nuovi dati per gli attori e rientra nei contesti che analizza, in quanto sapere generalizzato sul mondo sociale.
La riflessività Nella società Il sapere prodotto dalle scienze sociali diventa fonte di nuovi dati per gli attori e rientra nei contesti che analizza, in quanto sapere generalizzato sul mondo sociale.
Indice. Prefazione all edizione italiana. Gli Autori e i Curatori dell edizione italiana PARTE PRIMA ASPETTI GENERALI
 Indice Prefazione all edizione italiana Gli Autori e i Curatori dell edizione italiana XI XII PARTE PRIMA ASPETTI GENERALI Capitolo 1. Introduzione 1 1.1 La psicologia scientifica 1 1.2 I contesti della
Indice Prefazione all edizione italiana Gli Autori e i Curatori dell edizione italiana XI XII PARTE PRIMA ASPETTI GENERALI Capitolo 1. Introduzione 1 1.1 La psicologia scientifica 1 1.2 I contesti della
FILOSOFIA DEL DIRITTO M - Q
 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOSOFIA DEL DIRITTO M - Q 10 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento ALBERTO ANDRONICO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOSOFIA DEL DIRITTO M - Q 10 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento ALBERTO ANDRONICO
FACOLTÀ DI FILOSOFIA FILOSOFICHE
 FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea MAGISTRALE in SCIENZE FILOSOFICHE PRESENTAZIONE La Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche propone un percorso formativo del tutto innovativo nel panorama universitario
FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea MAGISTRALE in SCIENZE FILOSOFICHE PRESENTAZIONE La Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche propone un percorso formativo del tutto innovativo nel panorama universitario
LOCKE. Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza:
 LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
LE TEORIE DELL ASSISTENZA INFERMIERISTICA
 Università degli Studi di Pavia Corso di Laurea in Infermieristica LE TEORIE DELL ASSISTENZA Piera Bergomi Obiettivi della materia Obiettivo generale Portare lo studente a conoscere, analizzare e saper
Università degli Studi di Pavia Corso di Laurea in Infermieristica LE TEORIE DELL ASSISTENZA Piera Bergomi Obiettivi della materia Obiettivo generale Portare lo studente a conoscere, analizzare e saper
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Anno accademico 2015-2016 Corso di Pedagogia Lezione 05/4/2016 Loredana La Vecchia Dalla prospettiva del soggetto* malattia ü Evento traumatico (che perturba) ü Minaccia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Anno accademico 2015-2016 Corso di Pedagogia Lezione 05/4/2016 Loredana La Vecchia Dalla prospettiva del soggetto* malattia ü Evento traumatico (che perturba) ü Minaccia
Orizzonti della bioetica, diverse prospettive a confronto
 Orizzonti della bioetica, diverse prospettive a confronto 1 PROF. ANDREA PORCARELLI D o c e n t e d i P e d a g o g i a g e n e r a l e e s o c i a l e a l l U n i v e r s i t à d i P a d o v a D o c e
Orizzonti della bioetica, diverse prospettive a confronto 1 PROF. ANDREA PORCARELLI D o c e n t e d i P e d a g o g i a g e n e r a l e e s o c i a l e a l l U n i v e r s i t à d i P a d o v a D o c e
Ufficio Stampa Miur Roma, 29 gennaio 2015 Le Scienze Umane (Antropologia,
 Istruzione e formazione per la cittadinanza attiva, contro le disuguaglianze SEMINARIO DEL GRUPPO DI LAVORO DEI DOCENTI DI SCIENZE UMANE ROMA 16-17 Marzo Trattazione di temi - problemi disciplinari nella
Istruzione e formazione per la cittadinanza attiva, contro le disuguaglianze SEMINARIO DEL GRUPPO DI LAVORO DEI DOCENTI DI SCIENZE UMANE ROMA 16-17 Marzo Trattazione di temi - problemi disciplinari nella
ETNOGRAFIA SOCIALE. La ricerca etnografica = metodo di ricerca qualitativa
 ETNOGRAFIA SOCIALE «descrizione di un particolare mondo sociale in base a una prospettiva non scontata. Fare etnografia non significa semplicemente descrivere realtà sociali (relazioni, mondi, professioni,
ETNOGRAFIA SOCIALE «descrizione di un particolare mondo sociale in base a una prospettiva non scontata. Fare etnografia non significa semplicemente descrivere realtà sociali (relazioni, mondi, professioni,
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE PUL ISTITUTO PASTORALE A.A
 METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE - 60187 PUL ISTITUTO PASTORALE A.A. 2015-2016 MARCO ACCORINTI PRIMA PARTE 2 TEMI E TEMATICHE AFFRONTATE Disegno di una ricerca, Paradigmi di ricerca sociale, Osservazione
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE - 60187 PUL ISTITUTO PASTORALE A.A. 2015-2016 MARCO ACCORINTI PRIMA PARTE 2 TEMI E TEMATICHE AFFRONTATE Disegno di una ricerca, Paradigmi di ricerca sociale, Osservazione
Psicologia della comunicazione Fondamenti. Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1
 Psicologia della comunicazione Fondamenti Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1 Psicologia della comunicazione Settore scientifico-disciplinare: Psicologia generale Campo di ricerca interdisciplinare
Psicologia della comunicazione Fondamenti Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1 Psicologia della comunicazione Settore scientifico-disciplinare: Psicologia generale Campo di ricerca interdisciplinare
La filosofia. Storia della filosofia contemporanea
 La filosofia Storia della filosofia contemporanea Che cos è la filosofia? Concezione tradizionale della filosofia La filosofia è una disciplina scolastica o accademica, che ha per oggetto la storia del
La filosofia Storia della filosofia contemporanea Che cos è la filosofia? Concezione tradizionale della filosofia La filosofia è una disciplina scolastica o accademica, che ha per oggetto la storia del
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI. Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima
 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI
PROGRAMMA PREVENTIVO
 COD. Progr.Prev. PAGINA: 1 PROGRAMMA PREVENTIVO A.S.2013/14 SCUOLA Civico Liceo Linguistico A. Manzoni DOCENTE: prof.ssa P. Vedovati MATERIA: FILOSOFIA Classe 4 Sezione I FINALITÀ DELLA DISCIPLINA Acquisire
COD. Progr.Prev. PAGINA: 1 PROGRAMMA PREVENTIVO A.S.2013/14 SCUOLA Civico Liceo Linguistico A. Manzoni DOCENTE: prof.ssa P. Vedovati MATERIA: FILOSOFIA Classe 4 Sezione I FINALITÀ DELLA DISCIPLINA Acquisire
L identità della pedagogia nelle diverse epoche storiche. Il dibattito sull identità della pedagogia in Italia nella seconda metà del Novecento
 Università degli Studi di Catania Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Laurea in Scienze dell Educazione e della Formazione Cattedra di Educazione degli Adulti Simona Rizzari L identità della pedagogia
Università degli Studi di Catania Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Laurea in Scienze dell Educazione e della Formazione Cattedra di Educazione degli Adulti Simona Rizzari L identità della pedagogia
FACOLTÀ DI FILOSOFIA IN FILOSOFIA
 FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea IN FILOSOFIA PRESENTAZIONE La Facoltà di Filosofia dell Università Vita-Salute San Raffaele si trova in uno dei maggiori centri di ricerca europei, che pone la persona,
FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea IN FILOSOFIA PRESENTAZIONE La Facoltà di Filosofia dell Università Vita-Salute San Raffaele si trova in uno dei maggiori centri di ricerca europei, che pone la persona,
Le competenze infermieristiche: i risultati dei focus-group sull attualità percepita in FVG
 Le competenze infermieristiche: una chiave per il cambiamento del sistema salute Grado, 14 novembre 2013 Le competenze infermieristiche: i risultati dei focus-group sull attualità percepita in FVG A cura
Le competenze infermieristiche: una chiave per il cambiamento del sistema salute Grado, 14 novembre 2013 Le competenze infermieristiche: i risultati dei focus-group sull attualità percepita in FVG A cura
5. Lo sviluppo del processo formativo: metodologia della relazione tra i saperi e tra gli attori..
 5. Lo sviluppo del processo formativo: metodologia della relazione tra i saperi e tra gli attori.. Come passare dalla teoria alla prassi? 5.1.(p. 175) Come intervenire sul territorio? Quale la metodologia
5. Lo sviluppo del processo formativo: metodologia della relazione tra i saperi e tra gli attori.. Come passare dalla teoria alla prassi? 5.1.(p. 175) Come intervenire sul territorio? Quale la metodologia
ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO SANTA MARIA DI LICODIA. Anno Scolastico 2009/2010
 ISTITUTO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE METODOLOGICA IN EDUCAZIONE E FORMAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO SANTA MARIA DI LICODIA Corso di aggiornamento Anno Scolastico 2009/2010 1 LA DIDATTICA
ISTITUTO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE METODOLOGICA IN EDUCAZIONE E FORMAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO SANTA MARIA DI LICODIA Corso di aggiornamento Anno Scolastico 2009/2010 1 LA DIDATTICA
Heidegger e Hölderlin Filosofia e letteratura
 Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Heidegger e Hölderlin Filosofia e letteratura Comprensione del testo 1. Da quale poesia sono tratti i versi che aprono l animazione?
Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Heidegger e Hölderlin Filosofia e letteratura Comprensione del testo 1. Da quale poesia sono tratti i versi che aprono l animazione?
Religione in Aula. Spazi per l IRC
 Religione in Aula. Spazi per l IRC Domenica 28 giugno Eremo di Montecastello Federico Nicoli Istanze: Il testo Religione in Aula. Spazi per l IRC cerca di rispondere a due principali istanze: 1- essere
Religione in Aula. Spazi per l IRC Domenica 28 giugno Eremo di Montecastello Federico Nicoli Istanze: Il testo Religione in Aula. Spazi per l IRC cerca di rispondere a due principali istanze: 1- essere
Geografia dell UE. Simone Bozzato
 Geografia dell UE Simone Bozzato Statuto epistemologico della Geografia Secondo la cultura illuminista un sapere diviene scienza quando acquisisce un proprio statuto epistemologico (Vallega) - Quando sia
Geografia dell UE Simone Bozzato Statuto epistemologico della Geografia Secondo la cultura illuminista un sapere diviene scienza quando acquisisce un proprio statuto epistemologico (Vallega) - Quando sia
La semiotica del progetto
 Salvatore Zingale La semiotica del progetto: il senso delle cose e il senso del progettare D&H Milano 19 maggio 2010 1 / 34 Salvatore Zingale La semiotica del progetto Il senso delle cose e il senso del
Salvatore Zingale La semiotica del progetto: il senso delle cose e il senso del progettare D&H Milano 19 maggio 2010 1 / 34 Salvatore Zingale La semiotica del progetto Il senso delle cose e il senso del
IL CURRICOLO DI SCUOLA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
 IL CURRICOLO DI SCUOLA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA DELL INFANZIA - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) SCUOLA PRIMARIA - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) SCUOLA SECONDARIA I
IL CURRICOLO DI SCUOLA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA DELL INFANZIA - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) SCUOLA PRIMARIA - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) SCUOLA SECONDARIA I
IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L alunno: è aperto alla sincera ricerca della verità; sa interrogarsi
IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L alunno: è aperto alla sincera ricerca della verità; sa interrogarsi
Polisemia della Coscienza. A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia
 Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE QUINTA:
 LICEO DELLE SCIENZE UMANE A.S. 2016/2017 Programmazione Scienze Umane Classe V MATERIA: Scienze Umane CLASSE: 5 A PREMESSA: Durante il percorso liceale lo studente impara a orientarsi con i linguaggi propri
LICEO DELLE SCIENZE UMANE A.S. 2016/2017 Programmazione Scienze Umane Classe V MATERIA: Scienze Umane CLASSE: 5 A PREMESSA: Durante il percorso liceale lo studente impara a orientarsi con i linguaggi propri
GLI INIZI DELL ANTROPOLOGIA: L EVOLUZIONISMO
 GLI INIZI DELL ANTROPOLOGIA: L EVOLUZIONISMO EVOLUZIONISMO (C. Darwin 1809-1882) (H. Spencer 1820-1903) NATURA e SOCIETÀ sono in perenne MOVIMENTO da forme SEMPLICI a forme sempre più COMPLESSE IN ANTROPOLOGIA
GLI INIZI DELL ANTROPOLOGIA: L EVOLUZIONISMO EVOLUZIONISMO (C. Darwin 1809-1882) (H. Spencer 1820-1903) NATURA e SOCIETÀ sono in perenne MOVIMENTO da forme SEMPLICI a forme sempre più COMPLESSE IN ANTROPOLOGIA
Felice Carugati e Patrizia Selleri. Capitolo 1 La psicologia fra storia e cultura
 PSICOLOGIA DELL EDUCAZIONE Felice Carugati e Patrizia Selleri Capitolo 1 La psicologia fra storia e cultura 1 SCOPO della psicologia del XX sec Ricerca di leggi generali in grado di spiegare gli elementi
PSICOLOGIA DELL EDUCAZIONE Felice Carugati e Patrizia Selleri Capitolo 1 La psicologia fra storia e cultura 1 SCOPO della psicologia del XX sec Ricerca di leggi generali in grado di spiegare gli elementi
Jerom Bruner - nasce a New York nel 1915 professore di psicologia alla Harvard University
 Jerom Bruner - nasce a New York nel 1915 - professore di psicologia alla Harvard University centro sulla natura dell attività cognitiva - insegna ad Oxford Le opere Dopo Dewey: il processo di apprendimento
Jerom Bruner - nasce a New York nel 1915 - professore di psicologia alla Harvard University centro sulla natura dell attività cognitiva - insegna ad Oxford Le opere Dopo Dewey: il processo di apprendimento
strumenti e modalità per la rilevazione dei bisogni OSSERVAZIONE E' un imprescindibile strumento
 OSSERVAZIONE strumenti e modalità per la rilevazione dei bisogni OSSERVAZIONE E' un imprescindibile strumento dell'armamentario dell'educatore con il quale può raccogliere ed organizzare informazioni secondo
OSSERVAZIONE strumenti e modalità per la rilevazione dei bisogni OSSERVAZIONE E' un imprescindibile strumento dell'armamentario dell'educatore con il quale può raccogliere ed organizzare informazioni secondo
La ricerca in psicologia di comunità. E la ricerca che fonda una disciplina importanza dei suoi metodi
 Corso di La ricerca in psicologia di comunità E la ricerca che fonda una disciplina importanza dei suoi metodi 1 La ricerca in psicologia di comunità La ricerca in psicologia di comunità ha un ruolo fondamentale
Corso di La ricerca in psicologia di comunità E la ricerca che fonda una disciplina importanza dei suoi metodi 1 La ricerca in psicologia di comunità La ricerca in psicologia di comunità ha un ruolo fondamentale
Insegnante: Prof. Dario Solla Anno Scolastico Materia:
 I ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE E PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE- PIETRO D ABANO PIANO DI LAVORO Insegnante: Prof. Dario Solla Anno Scolastico 2015-2016 Materia: Religione Classe I D Finalità
I ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE E PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE- PIETRO D ABANO PIANO DI LAVORO Insegnante: Prof. Dario Solla Anno Scolastico 2015-2016 Materia: Religione Classe I D Finalità
CLASSE PRIMA MACRO ARGOMENTO CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI COMPETENZE 1 2 3
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL BIENNIO 1. Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2. Potenziare il dialogo interdisciplinare,
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL BIENNIO 1. Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2. Potenziare il dialogo interdisciplinare,
SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE
 SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE Gentilissima Professoressa, Egregio Professore, riteniamo di farle cosa gradita ricordandole che Tra la terra e il cielo ed. verde è un libro a norma secondo i Traguardi
SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE Gentilissima Professoressa, Egregio Professore, riteniamo di farle cosa gradita ricordandole che Tra la terra e il cielo ed. verde è un libro a norma secondo i Traguardi
Attività didattiche finalizzate a sviluppare competenze argomentative riferite alla lezione-conferenza. Percorsi iniziali
 1 Guida all ascolto Il relatore si definisce geografo storico e precisa: «la geografia è utile se può contribuire a risolvere i problemi dei luoghi». 1a Comprensione, interpretazione, riflessione Rifletti
1 Guida all ascolto Il relatore si definisce geografo storico e precisa: «la geografia è utile se può contribuire a risolvere i problemi dei luoghi». 1a Comprensione, interpretazione, riflessione Rifletti
Rudolf Arnheim: un secolo di pensiero visivo
 Rudolf Arnheim: un secolo di pensiero visivo 1904- in vita Ultimo degli allievi della scuola di Berlino. Allievo di K. Lewin e M.Wertheimer. 15/11/06 1 R. Arnheim noto in tutto il mondo per i suoi studi
Rudolf Arnheim: un secolo di pensiero visivo 1904- in vita Ultimo degli allievi della scuola di Berlino. Allievo di K. Lewin e M.Wertheimer. 15/11/06 1 R. Arnheim noto in tutto il mondo per i suoi studi
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
AREA DISCIPLINARE: matematico-scientifico-tecnologica ARGOMENTO: il numero Insegnante referente : Battistina Di Vora
 AREA DISCIPLINARE: matematico-scientifico-tecnologica MATERIA: matematica ARGOMENTO: il numero Insegnante referente : Battistina Di Vora PERIODO DI RIFERIMENTO: classi 4 e 5 scuola primaria - raccordo
AREA DISCIPLINARE: matematico-scientifico-tecnologica MATERIA: matematica ARGOMENTO: il numero Insegnante referente : Battistina Di Vora PERIODO DI RIFERIMENTO: classi 4 e 5 scuola primaria - raccordo
PROGRAMMA PREVENTIVO
 Settore Servizi Scolastici e Educativi PAGINA: 1 PROGRAMMA PREVENTIVO A.S. 2015/16 SCUOLA LICEO LINGUISTICO A. MANZONI DOCENTE: C. FRESCURA MATERIA: MATEMATICA Classe 5 Sezione B FINALITÀ DELLA DISCIPLINA
Settore Servizi Scolastici e Educativi PAGINA: 1 PROGRAMMA PREVENTIVO A.S. 2015/16 SCUOLA LICEO LINGUISTICO A. MANZONI DOCENTE: C. FRESCURA MATERIA: MATEMATICA Classe 5 Sezione B FINALITÀ DELLA DISCIPLINA
La matematica come forma di comunicazione PRIN
 La matematica come forma di comunicazione PRIN 2009-2011 Introduzione Quanto è chiara l idea di comunicazione matematica? Possiamo distinguere il discorso matematico da tutti gli altri concentrandoci soltanto
La matematica come forma di comunicazione PRIN 2009-2011 Introduzione Quanto è chiara l idea di comunicazione matematica? Possiamo distinguere il discorso matematico da tutti gli altri concentrandoci soltanto
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO
 ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA elaborato dai docenti di scuola primaria Coordinatore Ins. Laura Montecchiani Classe I creatore e Padre Scoprire che per la religione
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA elaborato dai docenti di scuola primaria Coordinatore Ins. Laura Montecchiani Classe I creatore e Padre Scoprire che per la religione
John Dewey (1859-1952) La rivoluzione copernicana in pedagogia
 John Dewey (1859-1952) La rivoluzione copernicana in pedagogia Brevi cenni biografici John Dewey nacque il 20 ottobre 1859 a Baltimora, nel Vermont (USA), da una famiglia puritana di modeste condizioni
John Dewey (1859-1952) La rivoluzione copernicana in pedagogia Brevi cenni biografici John Dewey nacque il 20 ottobre 1859 a Baltimora, nel Vermont (USA), da una famiglia puritana di modeste condizioni
L insegnante: un profilo di qualità
 LA FORMAZIONE DEI FORMATORI DEGLI INSEGNANTI Educare lo sguardo. La qualità delle relazioni a scuola (G. Messetti) Rovereto, 11 dicembre 2010 L insegnante: un profilo di qualità Professionista riflessivo
LA FORMAZIONE DEI FORMATORI DEGLI INSEGNANTI Educare lo sguardo. La qualità delle relazioni a scuola (G. Messetti) Rovereto, 11 dicembre 2010 L insegnante: un profilo di qualità Professionista riflessivo
I seminario: Che cos è il tirocinio curricolare?
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea in Scienze dell educazione Seminari metodologici propedeutici al tirocinio A.A. 2009/2010 I seminario: Che cos è il tirocinio
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea in Scienze dell educazione Seminari metodologici propedeutici al tirocinio A.A. 2009/2010 I seminario: Che cos è il tirocinio
Indice. 1 Le fasi della ricerca osservativa Le tecniche e gli strumenti L analisi del comportamento docente...7
 INSEGNAMENTO DI PEDAGOGIA SPERIMENTALE LEZIONE III LA RICERCA EMPIRICA PARTE II PROF. LUCIANO GALLIANI Indice 1 Le fasi della ricerca osservativa...3 2 Le tecniche e gli strumenti...5 3 L analisi del comportamento
INSEGNAMENTO DI PEDAGOGIA SPERIMENTALE LEZIONE III LA RICERCA EMPIRICA PARTE II PROF. LUCIANO GALLIANI Indice 1 Le fasi della ricerca osservativa...3 2 Le tecniche e gli strumenti...5 3 L analisi del comportamento
VERSO LE COMPETENZE: QUALI SFIDE PER LA SCUOLA?
 VERSO LE COMPETENZE: QUALI SFIDE PER LA SCUOLA? VALUTAZIONE COMPETENZA INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO Se si cambiano solo i programmi che figurano nei documenti, senza scalfire quelli che sono nelle teste,
VERSO LE COMPETENZE: QUALI SFIDE PER LA SCUOLA? VALUTAZIONE COMPETENZA INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO Se si cambiano solo i programmi che figurano nei documenti, senza scalfire quelli che sono nelle teste,
NUCLEI FONDANTI COMPETENZE CONTENUTI ABILITA Il. - i segni e le esperienze della presenza di Dio nella natura
 Premessa all insegnamento della religione cattolica (IRC): Le Indicazioni Nazionali s inseriscono pienamente nel percorso formativo, presente nelle singole istituzioni scolastiche e contribuiscono in modo
Premessa all insegnamento della religione cattolica (IRC): Le Indicazioni Nazionali s inseriscono pienamente nel percorso formativo, presente nelle singole istituzioni scolastiche e contribuiscono in modo
ARGOMENTI DELLA LEZIONE
 Università degli Studi di Roma Silvia La Degni Sapienza Facoltà di Psicologia 1 Insegnamento: Storia culturale del XX secolo Docente: Silvia Degni ARGOMENTI DELLA LEZIONE Considerazioni in merito alla
Università degli Studi di Roma Silvia La Degni Sapienza Facoltà di Psicologia 1 Insegnamento: Storia culturale del XX secolo Docente: Silvia Degni ARGOMENTI DELLA LEZIONE Considerazioni in merito alla
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Magistrale Statale A. Cairoli Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Magistrale Statale A. Cairoli Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane Liceo Economico Sociale - Liceo Musicale C.so Mazzini, 7-27100
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Magistrale Statale A. Cairoli Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane Liceo Economico Sociale - Liceo Musicale C.so Mazzini, 7-27100
SCIENZE UMANE PRIMO BIENNIO LINEE GENERALI E COMPETENZE
 SCIENZE UMANE LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l uomo si costituisce
SCIENZE UMANE LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l uomo si costituisce
Lezione n 5 L educatore (1)
 Lezione n 5 L educatore (1) IL complessificarsi della società, la crisi del sistema scolastico, il ritiro della famiglia da molti luoghi del sociale ha contribuito a moltiplicare i luoghi dell educazione,
Lezione n 5 L educatore (1) IL complessificarsi della società, la crisi del sistema scolastico, il ritiro della famiglia da molti luoghi del sociale ha contribuito a moltiplicare i luoghi dell educazione,
Ricerca qualitativa: Focus group
 Corso Metodologia della Ricerca Psicosociale - Prof. Patrizia Romito Ricerca qualitativa: Focus group Dott.ssa Lucia Beltramini Trieste, 22 dicembre 2010 Focus group: definizione Focus group Tecnica di
Corso Metodologia della Ricerca Psicosociale - Prof. Patrizia Romito Ricerca qualitativa: Focus group Dott.ssa Lucia Beltramini Trieste, 22 dicembre 2010 Focus group: definizione Focus group Tecnica di
Didattica generale: sviluppare sensibilità per l insegnamento e per l apprendimento
 Didattica generale: sviluppare sensibilità per l insegnamento e per l apprendimento Walter Gerbino Mestre 15 novembre 2015 una lezione sul fare lezione Effetto notte (François Truffaut 1973) come un film
Didattica generale: sviluppare sensibilità per l insegnamento e per l apprendimento Walter Gerbino Mestre 15 novembre 2015 una lezione sul fare lezione Effetto notte (François Truffaut 1973) come un film
Progetto LA CASA DELLE BUONE RELAZIONI. Un offerta formativa gratuita. rivolta a docenti di ogni ordine e grado. di Milano e provincia
 Progetto LA CASA DELLE BUONE RELAZIONI Un offerta formativa gratuita rivolta a docenti di ogni ordine e grado di Milano e provincia Comunità Nuova Onlus Tel. 02.48303318 Fax 02.48302707 Sede legale e amministrativa:
Progetto LA CASA DELLE BUONE RELAZIONI Un offerta formativa gratuita rivolta a docenti di ogni ordine e grado di Milano e provincia Comunità Nuova Onlus Tel. 02.48303318 Fax 02.48302707 Sede legale e amministrativa:
Freud e Svevo Filosofia e letteratura
 Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Freud e Svevo Filosofia e letteratura Comprensione del testo 1. Qual è la formazione di Sigmund Freud? 2. Quali sono i romanzi
Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Freud e Svevo Filosofia e letteratura Comprensione del testo 1. Qual è la formazione di Sigmund Freud? 2. Quali sono i romanzi
PERCORSO. Colori in contrasto Colori in armonia. Riferimento al testo base: Destinatari: di Elena Ballarin
 PERCORSO 2 Colori in Colori in armonia di Elena Ballarin Riferimento al testo base: E. Tornaghi, A colpo d occhio, volume A, pp. 90-91 Destinatari: Scuola secondaria di Primo grado In classe 1. Osserva
PERCORSO 2 Colori in Colori in armonia di Elena Ballarin Riferimento al testo base: E. Tornaghi, A colpo d occhio, volume A, pp. 90-91 Destinatari: Scuola secondaria di Primo grado In classe 1. Osserva
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA DIDATTICA
 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA DIDATTICA Materia Religione Insegnante Pacchiotti Maria Teresa Classe Prima A L insegnamento della religione cattolica risponde all esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA DIDATTICA Materia Religione Insegnante Pacchiotti Maria Teresa Classe Prima A L insegnamento della religione cattolica risponde all esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici
Analisi dei media. Parte seconda - Come studiare i media: alcune prospettive di analisi. La prospettiva ermeneutica. (Selezione di diapositive)
 Analisi dei media Parte seconda - Come studiare i media: alcune prospettive di analisi. La prospettiva ermeneutica. (Selezione di diapositive) Mezzi di comunicazione e modernità Introduzione: J. Thompson,
Analisi dei media Parte seconda - Come studiare i media: alcune prospettive di analisi. La prospettiva ermeneutica. (Selezione di diapositive) Mezzi di comunicazione e modernità Introduzione: J. Thompson,
Cosa c è alla base? Un esempio
 Cosa c è alla base? Un esempio Competenza Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica Regolamento Obbligo Istruzione (Assi culturali
Cosa c è alla base? Un esempio Competenza Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica Regolamento Obbligo Istruzione (Assi culturali
Programmazione di Storia Classe IV A OTTICA Docente: Anna Maria Sibilia Anno scolastico
 Programmazione di Storia Classe IV A OTTICA Docente: Anna Maria Sibilia Anno scolastico 2013-2014 FINALITA' 1) Favorire la formazione di una cultura storica tesa a recuperare la memoria del passato più
Programmazione di Storia Classe IV A OTTICA Docente: Anna Maria Sibilia Anno scolastico 2013-2014 FINALITA' 1) Favorire la formazione di una cultura storica tesa a recuperare la memoria del passato più
Cristina Davino, Clara Maccari La condizione lavorativa delle donne nella Provincia di Macerata. eum x statistica
 Cristina Davino, Clara Maccari La condizione lavorativa delle donne nella Provincia di Macerata eum x statistica eum x statistica Cristina Davino, Clara Maccari La condizione lavorativa delle donne nella
Cristina Davino, Clara Maccari La condizione lavorativa delle donne nella Provincia di Macerata eum x statistica eum x statistica Cristina Davino, Clara Maccari La condizione lavorativa delle donne nella
Pedagogia sperimentale Prof. Giovanni Arduini
 Pedagogia sperimentale Lezione n. 4 A.A. 2015/16 5. Concettualizzazione e definizione di metodo di conoscenza Etimologicamente il termine italiano "metodo" proviene dai due termini greci "metà" (oltre)
Pedagogia sperimentale Lezione n. 4 A.A. 2015/16 5. Concettualizzazione e definizione di metodo di conoscenza Etimologicamente il termine italiano "metodo" proviene dai due termini greci "metà" (oltre)
Continua la serie di minitesti di avvio al pensiero scientifico.
 info@didatticaperprogetti.it PROGETTO 3.1.4 TITOLO Cerco di capire (2) AREA Scientifica (Pensiero scientifico) SCUOLA Elementare: classi 3-4 - 5 Media: 1-2 - 3 OBIETTIVO Riflettere sul concetto di comprensione
info@didatticaperprogetti.it PROGETTO 3.1.4 TITOLO Cerco di capire (2) AREA Scientifica (Pensiero scientifico) SCUOLA Elementare: classi 3-4 - 5 Media: 1-2 - 3 OBIETTIVO Riflettere sul concetto di comprensione
perché vi sono tante teorie dello sviluppo psicologico?
 perché vi sono tante teorie dello sviluppo psicologico? a cura di laura Aleni Sestito Piaget Con la sperimentazione si cominciano ad affrontare i problemi Vygotskij di esplicazione ed interpretazione delle
perché vi sono tante teorie dello sviluppo psicologico? a cura di laura Aleni Sestito Piaget Con la sperimentazione si cominciano ad affrontare i problemi Vygotskij di esplicazione ed interpretazione delle
JEROME SEYMOUR BRUNER
 TEORIE DELL APPRENDIMENTO E QUALITÀ DEI PROCESSI (PARTE II) PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 JEROME SEYMOUR BRUNER--------------------------------------------------------------------------------------------
TEORIE DELL APPRENDIMENTO E QUALITÀ DEI PROCESSI (PARTE II) PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 JEROME SEYMOUR BRUNER--------------------------------------------------------------------------------------------
PERCORSI DI PARTECIPAZIONE SOCIALE NEL PIANO REGOLATORE SOCIALE DEL COMUNE DI ROMA. Claudia Chiarolanza Sapienza- Università di Roma
 PERCORSI DI PARTECIPAZIONE SOCIALE NEL PIANO REGOLATORE SOCIALE DEL COMUNE DI ROMA Claudia Chiarolanza Sapienza- Università di Roma PARTECIPAZIONE SOCIALE L interesse per la partecipazione sociale deriva
PERCORSI DI PARTECIPAZIONE SOCIALE NEL PIANO REGOLATORE SOCIALE DEL COMUNE DI ROMA Claudia Chiarolanza Sapienza- Università di Roma PARTECIPAZIONE SOCIALE L interesse per la partecipazione sociale deriva
Introduzione alla Statistica con R Lezione 1
 Introduzione alla Statistica con R Lezione 1 Sergio Camiz Chi sono? Laureato in Matematica 1969 (Università di Roma) Professore dal 1975 Dottore di ricerca in Analisi dei Dati dal 2002 (Université Paris
Introduzione alla Statistica con R Lezione 1 Sergio Camiz Chi sono? Laureato in Matematica 1969 (Università di Roma) Professore dal 1975 Dottore di ricerca in Analisi dei Dati dal 2002 (Université Paris
L idea di cultura nella tradizione sociologica
 L idea di cultura nella tradizione sociologica Scemo e più Scemo, 1994 L idea di cultura in due tradizioni sociologiche di ricerca Émile Durkheim (1858 1917) Max Weber (1864 1920) La scuola Francese La
L idea di cultura nella tradizione sociologica Scemo e più Scemo, 1994 L idea di cultura in due tradizioni sociologiche di ricerca Émile Durkheim (1858 1917) Max Weber (1864 1920) La scuola Francese La
RELIGIONE MODULI OPERATIVI:
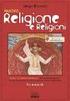 RELIGIONE INDICATORE DISCIPLINARE Avviare alla conoscenza della realtà religiosa del territorio ed degli elementi essenziali del linguaggio religioso per costruire un sapere che evidenzi la dimensione
RELIGIONE INDICATORE DISCIPLINARE Avviare alla conoscenza della realtà religiosa del territorio ed degli elementi essenziali del linguaggio religioso per costruire un sapere che evidenzi la dimensione
Grounded Theory. Patrizia Ascione.
 Grounded Theory Patrizia Ascione patrizia.ascione@gmail.com Trasformazioni del pensiero sociologico Anni 50 del Novecento: diversi ricercatori qualitativi mettono in discussione i modelli di ricerca di
Grounded Theory Patrizia Ascione patrizia.ascione@gmail.com Trasformazioni del pensiero sociologico Anni 50 del Novecento: diversi ricercatori qualitativi mettono in discussione i modelli di ricerca di
Filosofia l origine. A cura di Pietro Gavagnin Pubblicato con Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.
 Filosofia l origine A cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Pubblicato con Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License. Uso Comune del termine Non fare il filosofo! Finché facciamo
Filosofia l origine A cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Pubblicato con Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License. Uso Comune del termine Non fare il filosofo! Finché facciamo
Perché un percorso come DoReMAT?
 Perché un percorso come DoReMAT? Ho capito che ogni insegnante deve costantemente lottare contro la tentazione, che si rinnova continuamente, di essere soddisfatto perché fa lezioni limpide e rigorose,
Perché un percorso come DoReMAT? Ho capito che ogni insegnante deve costantemente lottare contro la tentazione, che si rinnova continuamente, di essere soddisfatto perché fa lezioni limpide e rigorose,
Lezione 1 L impianto del Corso di preparazione alla prova scritta. Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo
 SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DEELL INFANZIA a cura di GIUSEPPE DUMINUCO Lezione 1 L impianto del Corso di preparazione alla prova scritta. Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo Questo Corso di preparazione
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DEELL INFANZIA a cura di GIUSEPPE DUMINUCO Lezione 1 L impianto del Corso di preparazione alla prova scritta. Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo Questo Corso di preparazione
Il Positivismo CARATTERI GENERALI
 Il Positivismo CARATTERI GENERALI Il contesto: la nuova struttura della società industriale e i suoi problemi Solamente a partire dall età della Restaurazione comincia ad affermarsi il significato moderno
Il Positivismo CARATTERI GENERALI Il contesto: la nuova struttura della società industriale e i suoi problemi Solamente a partire dall età della Restaurazione comincia ad affermarsi il significato moderno
CONOSCENZA ED ESPERIENZA
 CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza
CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza
STUDIO CONOSCITIVO TRAPIANTI: UN IMPORTANTE PROSPETTIVA DI VITA
 STUDIO CONOSCITIVO TRAPIANTI: UN IMPORTANTE PROSPETTIVA DI VITA Sintesi dei risultati di ricerca Preparata per O.N.Da. Milano, 22 settembre 2009 SCENARIO E OBIETTIVI DELLA RICERCA L Osservatorio Nazionale
STUDIO CONOSCITIVO TRAPIANTI: UN IMPORTANTE PROSPETTIVA DI VITA Sintesi dei risultati di ricerca Preparata per O.N.Da. Milano, 22 settembre 2009 SCENARIO E OBIETTIVI DELLA RICERCA L Osservatorio Nazionale
Il Registro Nazionale dell ADHD. Il ruolo dei pediatri di famiglia
 Il Registro Nazionale dell ADHD Il ruolo dei pediatri di famiglia Federica Zanetto pediatra di famiglia Associazione Culturale Pediatri ADHD. complesse caratteristiche di multifattorialità lettura complessa
Il Registro Nazionale dell ADHD Il ruolo dei pediatri di famiglia Federica Zanetto pediatra di famiglia Associazione Culturale Pediatri ADHD. complesse caratteristiche di multifattorialità lettura complessa
Oltre a garantire una solida preparazione culturale, queste discipline mirano a promuovere la formazione e la crescita personale.
 Ultimo aggiornamento Domenica 1 Novembre 011 :06 LICEO DELLE SCIENZE UMANE Finalità generali Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati
Ultimo aggiornamento Domenica 1 Novembre 011 :06 LICEO DELLE SCIENZE UMANE Finalità generali Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Prof. Andrea Guarise. PROGETTO DIDATTICO CLASSE 3 a E scientifico
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Sociologia. Corso di Sociologia generale
 Corso di Sociologia La sociologia della conoscenza e il problema della pianificazione democratica: Karl Mannheim (1893-1947). Nasce a Budapest (padre ungherese, madre tedesca, entrambi di origine ebraica);
Corso di Sociologia La sociologia della conoscenza e il problema della pianificazione democratica: Karl Mannheim (1893-1947). Nasce a Budapest (padre ungherese, madre tedesca, entrambi di origine ebraica);
Istruzione e formazione per la cittadinanza attiva, contro le disuguaglianze SEMINARIO DEL GRUPPO DI LAVORO DEI DOCENTI DI SCIENZE UMANE
 Istruzione e formazione per la cittadinanza attiva, contro le disuguaglianze SEMINARIO DEL GRUPPO DI LAVORO DEI DOCENTI DI SCIENZE UMANE ROMA 16-17 Marzo Trattazione di temi - problemi disciplinari nella
Istruzione e formazione per la cittadinanza attiva, contro le disuguaglianze SEMINARIO DEL GRUPPO DI LAVORO DEI DOCENTI DI SCIENZE UMANE ROMA 16-17 Marzo Trattazione di temi - problemi disciplinari nella
3.11. Religione Scuola Primaria
 3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
della porta accanto OSVALDO
 Il GENIO della porta accanto OSVALDO Voglio ringraziare Osvaldo, amico e per anni compagno di viaggio nella formazione in seminario e ora uomo d affari per una multinazionale tedesca che ha voluto donarmi
Il GENIO della porta accanto OSVALDO Voglio ringraziare Osvaldo, amico e per anni compagno di viaggio nella formazione in seminario e ora uomo d affari per una multinazionale tedesca che ha voluto donarmi
E.Nagel: Capitolo 1 Scienza e Senso Comune. Gianluigi Bellin
 E.Nagel: Capitolo 1 Scienza e Senso Comune Gianluigi Bellin October 18, 2011 Che cosa dà di più la conoscenza scientifica di quella del senso comune? Non possiamo dire la scienza ci dà la verità ultima
E.Nagel: Capitolo 1 Scienza e Senso Comune Gianluigi Bellin October 18, 2011 Che cosa dà di più la conoscenza scientifica di quella del senso comune? Non possiamo dire la scienza ci dà la verità ultima
Il mito della caverna
 Il mito della caverna PERCHE USARE IL MITO? Come evocazione: rende più affascinante il concetto filosofico. Come spiegazione là dove la ragione e la filosofia non riescono a rispondere. IL MITO DELLA CAVERNA
Il mito della caverna PERCHE USARE IL MITO? Come evocazione: rende più affascinante il concetto filosofico. Come spiegazione là dove la ragione e la filosofia non riescono a rispondere. IL MITO DELLA CAVERNA
IV NOVEMBRE 35, CLES (TRENTO)
 PROGRAMMAZIONE COMUNE DEL DIPARTIMENTO: SCIENZE UMANE INDIRIZZO: Scienze umane opzione economica Primo BIENNIO: Classi Prime opzione DISCIPLINA: Scienze umane MODULO 1 DI PSICOLOGIA - LA PSICOLOGIA COME
PROGRAMMAZIONE COMUNE DEL DIPARTIMENTO: SCIENZE UMANE INDIRIZZO: Scienze umane opzione economica Primo BIENNIO: Classi Prime opzione DISCIPLINA: Scienze umane MODULO 1 DI PSICOLOGIA - LA PSICOLOGIA COME
LOGICA E PSICOLOGIA DEL PENSIERO. Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva
 titolo LOGICA E PSICOLOGIA DEL PENSIERO Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici logica Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire
titolo LOGICA E PSICOLOGIA DEL PENSIERO Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici logica Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire
Le mani pensanti. Idee, uomini e prodotti di una storia
 Le mani pensanti Idee, uomini e prodotti di una storia industriale diversa Le mani pensanti Fondazione Natale Capellaro Laboratorio Museo Tecnologic@mente associazione culturale Pubblico-08 Che cosa era
Le mani pensanti Idee, uomini e prodotti di una storia industriale diversa Le mani pensanti Fondazione Natale Capellaro Laboratorio Museo Tecnologic@mente associazione culturale Pubblico-08 Che cosa era
Alla base della conoscenza di sé e degli altri la teoria della mente. a cura di laura Aleni Sestito
 Alla base della conoscenza di sé e degli altri la teoria della mente a cura di laura Aleni Sestito LA CONOSCENZA DI SE E DEGLI ALTRI Premack e Woodruff, 1978 TEORIA DELLA MENTE T O M, Theory of Mind ovvero
Alla base della conoscenza di sé e degli altri la teoria della mente a cura di laura Aleni Sestito LA CONOSCENZA DI SE E DEGLI ALTRI Premack e Woodruff, 1978 TEORIA DELLA MENTE T O M, Theory of Mind ovvero
Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa. Corso di Metodi della ricerca qualitativa - a.a [Eugenio De Gregorio]
![Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa. Corso di Metodi della ricerca qualitativa - a.a [Eugenio De Gregorio] Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa. Corso di Metodi della ricerca qualitativa - a.a [Eugenio De Gregorio]](/thumbs/54/33896183.jpg) Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa Come si giunge a una conoscenza del mondo? Superstizione (irrazionale) Intuizione (esperienza soggettiva) Ragionamento (induzione o deduzione) Autorità
Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa Come si giunge a una conoscenza del mondo? Superstizione (irrazionale) Intuizione (esperienza soggettiva) Ragionamento (induzione o deduzione) Autorità
Filosofia o. Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia
 Filosofia o Storia della Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia della Filosofia! Utilità! È un po come per l interesse: della nostra materia non ha molto senso chiedere
Filosofia o Storia della Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia della Filosofia! Utilità! È un po come per l interesse: della nostra materia non ha molto senso chiedere
liceo B. Russell PROGRAMMAZIONE COMUNE DEL DIPARTIMENTO: Scienze Umane INDIRIZZO: Liceo delle Scienze Umane
 PROGRAMMAZIONE COMUNE DEL DIPARTIMENTO: Scienze Umane INDIRIZZO: Liceo delle Scienze Umane Secondo BIENNIO: Classi IV DISCIPLINA: Scienze Umane MODULO di SOCIOLOGIA Ø Saper riflettere sulle evoluzioni
PROGRAMMAZIONE COMUNE DEL DIPARTIMENTO: Scienze Umane INDIRIZZO: Liceo delle Scienze Umane Secondo BIENNIO: Classi IV DISCIPLINA: Scienze Umane MODULO di SOCIOLOGIA Ø Saper riflettere sulle evoluzioni
Dizionario di didattica Concetti e dimensioni operative. Voce: Conoscenze. Pedagogia generale 1 Prof. Giuliana Sandrone
 Dizionario di didattica Concetti e dimensioni operative Voce: Conoscenze Pedagogia generale 1 Prof. Giuliana Sandrone 1 1. Definizione concettuale del termine Il sostantivo «conoscenza» è riconducibile
Dizionario di didattica Concetti e dimensioni operative Voce: Conoscenze Pedagogia generale 1 Prof. Giuliana Sandrone 1 1. Definizione concettuale del termine Il sostantivo «conoscenza» è riconducibile
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Al termine della scuola primaria L alunno: 1.1 Scoprire che la vita, la natura, il. di Gesù: far conoscere il Padre
 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Religione Cattolica - Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Profilo
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Religione Cattolica - Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Profilo
