AIFM La gestione del dato dosimetrico nelle esposizioni mediche Corso formativo, Roma 28 maggio 2015
|
|
|
- Agata Napolitano
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 AIFM La gestione del dato dosimetrico nelle esposizioni mediche Corso formativo, Roma 28 maggio 2015 La dose assorbita: evoluzione dei metodi di misura e di valutazione. Problemi dosimetrici attuali R. F. Laitano Argomenti della relazione La dose assorbita, D Grandezze utili per la determinazione di D Generalità sul calcolo e la misura di D w I protocolli internazionali per la dosimetria di base Necessità di linee guida per la misura di D w in condizioni diverse da quelle degli attuali protocolli (I livelli di accuratezza su D w auspicabili in RT e RD) AIFM Roma
2 La grandezza dose assorbita, D Attuale definizione di D (ICRU Rep. 85, 2011): punto d arrivo di un evoluzione iniziata da circa un secolo: Christen,1914 ( dose ) Gray & Road, 1939 ICRU 1951, 1954, 1957, 1961, 1962, 1971, 1980, Una corretta definizione di D deve consentire di ottenere una correlazione univoca fra l entità, E bio, di un effetto biologico e l energia di una radiazione ionizzante che lo ha indotto: E bio = f(d) AIFM 2015 Roma 2 Basi concettuali della definizione di D D lim m0 m d dm 1 d dv J/kg (Gray), [1 Gy = 1 J/kg] R m(v) in R ex R in R ex Q energia media depositata [R: energia radiante = E (neutre) +T (cariche) (escl. M 0 c 2 )] variaz. energie a riposo Q (<) 0 se ΔM 0 (>) 0 (ε /m): grandezza stocastica (poco utilizzabile) ( /m): valore medio (funzione analitica) /m AIFM 2015 Roma m 3
3 L energia media depositata, Importanza del termine Q in: R in R ex Q Esempio (creazione di coppie): DM > 0 Q < 0 R in = hn 0 V e- T ex e+ T ex R ex = hn0 - (Te- + Te+) 2M0c 2 Q assicura il corretto bilancio fra, R in e R ex La definizione di tiene conto di tutti gli aspetti energetici al fine di correlare univocamente E bio e D AIFM 2015 Roma 4 Non garanzia di univocità, per radiazioni ad alto LET, nella correlazione fra E bio e D Pur tenendo conto di tutti i processi fisici legati alla deposizione di energia della radiazione in un mezzo, il valore di D in alcune situazioni sperimentali - riferite a radiazione densamente ionizzante (alto LET) - non è correlabile univocamente a E bio. E bio rad. alto LET rad. basso LET D 0 D AIFM 2015 Roma 5
4 Dose fisica Dose biologica Radiazione ad alto LET: minor probabilità di riparazione del danno maggiore efficacia della radiazione D bio = D phys RBE (N) 1.1, protoni > 2, LET>200 kev/m D bio SOBP ioni C 290 MeV/u D phys SOBP ioni C 290 MeV/u AIFM 2015 Roma 6 Determinazione di D per radiazione indirettamente ionizzante (fotoni, neutroni) Calcolo di D m (nel mezzo m) in base alla sua definizione Il calcolo di D m (P), nell elemento di volume dv, richiede la conoscenza delle fluenze di energia (Y= FE) entranti in dv e uscenti da dv, relative sia alle particelle neutre (primarie e secondarie) che a quelle cariche (secondarie, terziarie, ecc). F dn da F dl dv AIFM 2015 Roma 7
5 Calcolo di D m (P) in un mezzo m esposto a fotoni Conoscenza di YFE del campo di radiazione primaria, secondaria e terziaria (fotoni ed elettroni) in ingresso e all uscita di V hn Compt S (hn) * V.P T Compt bre R in R ex (Q 0) D 1 d dv T 1 T 2 m R = E + T fotoni ed elettroni AIFM 2015 Roma 8 Utilità di ulteriori grandezze fisiche per agevolare il calcolo di D quando la radiazione primaria è indirettamente ionizzante Il kerma, K, - definito solo per radiazione indir. ioniz. (fotoni, neutroni) - è una grandezza dosimetrica che, in relazione alle grandezze di campo, dipende solo da F(E,P) nel punto P del mezzo m cui K è riferito: energia media trasferita K lim tr m0 m d tr dm 1 d tr dv [J/kg (Gy)] AIFM 2015 Roma 9
6 L energia media trasferita, tr Dato un campo di radiazioni indirettamente ionizzanti che interagiscono con un mezzo, l energia media trasferita a un volume V di quel mezzo è la grandezza: tr E in E * ex Q E in dove è la somma media delle energie delle radiazioni indirettamente ionizzanti entranti in V ed è la somma media delle energie delle radiazioni indirettamente ionizzanti che escono da V, non includendo in questa somma l energia delle radiazioni indirettamente ionizzanti che hanno origine in V a seguito di perdite radiative delle particelle cariche. E ex * AIFM 2015 Roma 10 Il kerma, K m (P), nel punto P di un mezzo m esposto a un fascio di fotoni hn Compt T Compt S (hn) * 2 3.P V bre 1 T 1 T 2 bre K 1 d tr dv tr E in E ex * (Q = 0) solo fotoni bre m dipende solo dalle interazioni che i fotoni hanno all interno di V AIFM 2015 Roma 11
7 Espressione equivalente del kerma, K (definizione operativa di K) K d tr dm dt tr dm dove, l energia trasferita media,, è uguale a, essendo : la somma media delle energie cinetiche iniziali di tutte le particelle cariche liberate nella massa dm a seguito delle interazioni che la radiazione ha avuto in dm. dt tr d tr [J/kg (Gy)] kerma: kinetic energy released in matter dt tr AIFM 2015 Roma 12 Diretta calcolabilità di K m (P),nel punto P di un mezzo m, in funzione della F(E,P) m dei fotoni di energia E incidenti su V hn Compt T Compt S (hn) 3 * 2.P V 1 bre T 1 T 2 bre bre K 1 dt tr dv m tr m att E tr E m K m (P) F(P) E (m tr ) E,m K col K rad AIFM 2015 Roma 13
8 Relazione fra D e K col (a) K col (P) m F(P) E (m en ) E,m, In condizioni di CPE (ST in = ST ex ) * nel volume V(P), si ha: K col (P) m CPE dove: D (P) m E m en m en att E m tr (1 g) e quindi: CPE E max D m (P) F(P) m en ) E F E E,m (P) m en ) E de E,m E min *(l /R molto grande) AIFM 2015 Roma 14 Relazione fra D e K col (b) CPE D m (P) F(P)E m en ) E,m D m D m CPE m m en ) m, TCPE (fotoni) D(P) TCPE K col (P) emx TCPE D m m >1 (K col ) m AIFM 2015 Roma 15
9 La grandezza Terma, T per il calcolo di D (per fotoni) mediante integrali di convoluzione Terma Total energy released to the mass in dv at a point P in a medium T m (P) F(P) E (m att ) E,m Y(P)(m att ) E,m (Gy) F(hn) P dv AIFM 2015 Roma 16 (adapt. from N. Papanikolaou Tex. Univ.) Principali campi d attività in cui è hn richiesta la dosimetria K(r,r ) describes the fraction of energy deposited at r by sec. chrg. part. originating at r Interaction site (dv) where a total en. T(r ) is released by the prim. ph. beam AIFM 2015 Roma 17 AIFM 2015 Roma 17
10 (ref. N. Papanikolaou Tex. Univ.) Scopo della dosimetria in Radioprotezione AIFM 2015 Roma 18 Condizioni per un calcolo semplificato di D (per fotoni) mediante una convoluzione (T X K) 1- CPE or TCPE, full scatter conditions (i.e., within an infinite medium irradiated by an an infinitely broad beam), 2 spatially invariant kernel (i.e., K(r,r ) = K(r r ) ) D Tx) K(x-x ) AIFM 2015 Roma 19
11 Determinazione di D per radiazione direttamente ionizzante (part. cariche): calcolo di D m Il prodotto: F(P) 1 ( (dt ) el ) m m dl [J/kg] potere frenante massico elettronico del mezzo m, (S el /) m fornisce l energia persa, T m = DT/m, da un fascio di particelle cariche in una massa m irradiata uniformemente e -, p. m AIFM 2015 Roma 20 Il calcolo di D m per particelle cariche Se l energia persa, T m, è uguale all energia depositata nella massa m, si ha: T m = D m = F(S el /) m Questa uguaglianza presuppone l assenza dei raggi d, ovvero il ritenere accettabile l approssimazione del rallentamento continuo (CSDA) (perdite di energia locali). In realtà, T m = D m solo se nella massa m si ha equilibrio dei raggi d ( mezzo omogeneo). e -, p. d 1 d 2 d d m AIFM 2015 Roma 21
12 Determinazione di D m in un mezzo m per radiazioni dir. e indir. ionizzanti (fotoni, part. cariche) Misura di D m D w : Per la misura di di D w si può, in linea di principio, usare un qualsiasi rivelatore purchè dotato di suffficiente riproducibilità ( 0,1%) e dell appropriato coefficiente di taratura, N Dw,Q : D w,q M Q N Dw,Q Q qualità della radiazione : tipo ed energia M Q segnale fornito dal rivelatore AIFM 2015 Roma 22 Dipendenza di N Dw,Q dalle condizioni di misura (in part. dall energia della radiazione) N Dw D w M D w kd riv tar m en condizioni ideali: 1)E tar = E RT, 2) disponibilità di un N Dw,Q per ogni Q RT ma non realizzabili! S el w ) riv w ) riv (ind. ion.) (dir. ion.) quindi: N Dw = f (E), tanto più variabile quanto più w riv AIFM 2015 Roma 23
13 Misura di D w,q mediante un dosimetro dotato di un (solo) coefficiente di taratura, N Dw,Qo, ottenuto alla qualità Q 0 D Dw,Q M Q N D w,q0 k Q,Q0, dove k Q,Qo corregge N Dw,Qo se Q Q 0 Il valore del fattore correttivo k Q,Qo dipende da molte variabili relative sia al campo di radiazione, sia alla geometria d irraggiamento, sia alle caratteristiche del dosimetro Il fattore k Q,Qo è determinabile con sufficiente accuratezza solo se il dosimetro è una camera a ionizzazione a cavità ( Teoria della cavità) PROTOCOLLI DI DOSIMETRIA DI BASE AIFM 2015 Roma 24 PROTOCOLLI INTERNAZIONALI PER LA DOSIMETRIA IN RADIOTERAPIA CON FASCI ESTERNI IN CONDIZIONI DI RIFERIMENTO - AAPM s TG-51protocol for clinical reference dosimetry of high-energy photon and electron beams Med. Phys. 26 (9) Addendum to the AAPM s TG- 51protocol for clinical reference dosimetry of highenergy photon beams Med. Phys. 41 (4) ENERGY AGENCY Vienna 2000 AIFM 2015 Roma 25
14 PROTOCOLLI INTERNAZIONALI PER LA DOSIMETRIA IN RADIOTERAPIA CON FASCI ESTERNI IN CONDIZIONI DI RIFERIMENTO - AAPM TG-51: per fasci di fotoni e di elettroni con E > 1 MeV - IAEA TRS 398: per tutti i fasci di radiazione usati in RT (MVRX, kvrx, elettroni, adroni) -Pur se diversi in vari aspetti operativi, i protocolli IAEA e AAPM consentono livelli di accuratezza e risultati sostanzialmente identici. ENERGY AGENCY Vienna Il loro uso, unitamente alla taratura periodica dei dosimetri, sono ESSENZIALI per l affidabilità della dosimetria nei centri di RT! AIFM 2015 Roma 26 LE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO NEI PROTOCOLLI DI DOSIMETRIA - Uso di camere a ionizzazione a cavità (cil. + p-p) per misure di D w e delle PDD in fantoccio; - Vincoli per le distanze, le profondità in fantoccio, le dimensioni dei campi di radiazione ecc.; - Fantocci dosimetrici di materiali e dimensioni specificate; ENERGY AGENCY Vienna 2000 AIFM 2015 Roma 27
15 La dosimetria in condizioni diverse da quelle di riferimento ma compatibili con la dosimetria di base dei Protocolli - Uso di rivelatori diversi dalle camere a cavità, tarati rispetto a quest ultime, e dotati di idonee caratteristiche (linearità, risposta in energia nota, sufficiente riproducibilità, ecc.); - Uso di geometrie d irraggiamento diverse (dimensioni del campo) purchè tali da mantenere coerenza e riferibilità con la dosimetria di base; ENERGY AGENCY Vienna Uso di parametri quali OF (output factor), RDF (relative dose factor), ecc.. per ottenere i dati dosimetrici (riferiti alle condizioni reali) da inserire nei TPS. AIFM 2015 Roma 28 Limiti di validità dell OF rispetto alle dimensioni del campo (Sanchez-Doblado et al, Phys Med, 23, 58, 2007) AIFM 2015 Roma 29
16 Output factors variations for 6 mm and 18 mm sqaure fields (from R. Ulrich BrainLab) AIFM 2015 Roma 30 Condizioni per la validità della dosimetria basata sugli attuali Protocolli (a) D Dw,Q M Q N D w,q0 k Q,Q0 I parametri fisici e i fattori correttivi (W air s w,air p cav p dis p wall p cel ) presenti in k Q,Qo sono determinati (e devono essere usati) in condizioni in cui vi sia CPE o TCPE CPE 10x10 cm 2 TCPE Con campi, A, larghi (A>3x3cm 2 ) e in regioni di TCPE gli spettri di energia, F E, sono noti (alle diverse Q) e sono poco variabili al variare di A. Quindi k Q,Qo non varia con A ENERGY AGENCY Vienna 2000 AIFM 2015 Roma 31
17 Lo scostamento da 1 del rapporto D/K col fornisce una misura del grado di TCPE in funzione della dimensione del campo Li et al. Med. Phys. 22, 1167 (1995) AIFM 2015 Roma 32 Condizioni per la validità della dosimetria basata sugli attuali Protocolli (b) D Dw,Q M Q N D w,q0 k Q,Q0 Il segnale M Q è riferibile a M Qo (ottenuto in condizioni di taratura) se il volume del rivelatore è irraggiato completamente e uniformemente dal campo di radiazione A 1 A2 ENERGY AGENCY Vienna 2000 F Qo km Qo F Q km Q AIFM 2015 Roma 33
18 Cause principali della perdita di validità dei Protocolli nell uso dei comuni rivelatori in campi stretti (statici e dinamici) di fotoni (A < 3x3cm 2 ) 1- Assenza di CPE laterale 2- Irraggiamento non uniforme dei rivelatori (volume averaging effects) 3- Perturbazione della fluenza da parte del rivelatore (quasi mai sufficientemente piccolo) AIFM 2015 Roma 34 Cause principali della perdita di validità dei Protocolli nell uso dei comuni rivelatori in campi stretti (statici e dinamici) di fotoni (A < 3x3cm 2 ) 1- Assenza di CPE laterale 2- Irraggiamento non uniforme dei rivelatori (volume averaging effects) F E F E 1 2 F F F Q k M Q E E k k AIFM 2015 Roma 35
19 Cause principali della perdita di validità dei Protocolli nell uso dei comuni rivelatori in campi stretti di fotoni (A < 3x3cm 2 ) 3- Perturbazione della fluenza Un rivelatore posto in un sottile fascio di radiazione causa una forte perturbazione della fluenza per cui il segnale M non corrisponde più alla D nel mezzo in assenza del rivelatore se la corrispondenza fra M e D è quella ottenuta in fase di taratura con campi larghi. A seguito di ciò possono essere introdotti nella dosimetria errori dell ordine del 10%. m (con il rivelatore) m (in assenza di rivelatore) ENERGY AGENCY Vienna 2000 F E F E AIFM 2015 Roma 36 La qualità Q per fasci sottili Beam quality specification is a problem (in some FFF machines 10x10 collimator setting not available!) (TPR 20/10, 10x10 cm 2 ) Sauer, Med Phys (2009) 36, 4168 Seuntjens, 2014 AAPM Summer School Burlington, VT AIFM 2015 Roma 37
20 Reviews on small field dosimetry R. Alfonso, P. Andreo, R. Capote, M. S. Huq, W. Kilby, P. Kjäll, T. R. Mackie, H. Palmans, K. Rosser, J. Seuntjens, W. Ullrich, and S. Vatnitsky, A new formalism for reference dosimetry of small and nonstandard fields, Med. Phys. 35, (2008). I. J. Das, G. X. Ding, and A. Ahnesjö, Small fields: Nonequilibrium radiation dosimetry, Med. Phys. 35, (2008). H Palmans (2011) CN-182-INV006, Small and composite field dosimetry: the problems and recent progress. IDOS Conference, Vienna. M. Aspradakis, J. Byrne, H. Palmans, J. Conway, K. Rosser, J. Warrington, and S.Duane, Small field MV photon dosimetry, IPEM Report No. 103 (Institute of Physicsand Engineering in Medicine, York, 2010). Large amount of articles - since on the topic of small field dosimetry! AIFM 2015 Roma 38 New formalism for use of cavity chambers in non conventional fields Two related routes for D w : - Small static field dosimetry (ad es. Cyberknife, Tomotherapy, Gammaknife) machine-specific reference field, () - Composite field IMRT dosimetry (ad es. IMRT, fasci scans. ecc.) plan-class specific reference field, pcsr) AIFM 2015 Roma 39
21 New formalism for ion. chambers in small static fields (e.g., CyberKnife, TomoTherapy, GammaKnife) Alfonso el al (2008), Med Phys 35 (11) new CoP: IAEA TECDOC??? D f w,q M f Q N D,w,Q o k Q,Q o k f Q, f,q ref D fclin w,q clin D M M f w,q f Q f Q clin clin f Q D D f clin, clin, Q fclin w,q f w,q clin M M f Q f Q clin clin clin Analogous formalism (with f pcsr in place of f ) in composite-imrt fields (e.g., dynamic, step and shoot, or scanning beam fields) M M f Q f Q AIFM 2015 Roma 40 clin clin k f Q clin clin, f, Q Dose Area Product (DAP) per fasci sottili e a scansione Il prodotto Dose x Area (Gy cm 2 ) si può misurare direttamente con un rivelatore di superficie A irradiato uniformemente. A L uso del DAP (: integrale di D su un area A specificata) in alternativa alla D(P) riduce le variazioni fra le misure con i diversi tipi di rivelatori (*). Il DAP% in profondità (PDDAP) non dipende dalle dimensioni del campo. (*) Djouguela et al, Zeit. Med. Phys. 16 (2006) 217 Underwood et al, Med. Phys. 40 (2013) AIFM 2015 Roma 41
22 Indicatore della qualità: DAPR 20/10 AIFM 2015 Roma 42 Contrary to TPR 20/10, DAPR 20/10 is independent of the field size small field D w = N Dw (DAPR 20/10 ) Σ M i Avendo determinato un k Q corrispondente al DAPR -Problema 1: determinare nuovi k Q,Qo (da parte di NMI o di utenti). -Problema 2: modificare i TPS inserendo valori di DAP anziché di D(P) -Problema 3: acquistare ulteriori rivelatori a superficie estesa. AIFM 2015 Roma 43
23 Accuracy needs in RT dosimetry David Thwaites (2013) Med. Phys. Inst. University of Sydney, Australia Accuracy required and achievable in radiotherapy dosimetry: have modern technology and techniques changed our views? Journal of Physics: Conference Series 444 (2013) IOP Publishing 7thInternational Conference on 3D Radiation Dosimetry + AAPM Rep. 85, 2004 AIFM 2015 Roma 44 Uncertainty, u(d), on absorbed dose, D, as a function of probability of tumor control, P TC, and probability of normal tissue complications, P NTC P TC P NTC P % P % u(d) P UTC D D P UTC = P TC (1 P NTC ), probability of uncomplicated tumor control gsteepness of the dose response (g: from 1 to 6, average 3) g= D (DP NTC /DD) = DP NTC (%) /DD(%) DD(%) = 1% DP NTC = g%)
24 DOMANDE? AIFM 2015 Roma 46
Parte I - LE RADIAZIONI IONIZZANTI E LE GRANDEZZE FISICHE DI INTERESSE IN DOSIMETRIA
 INDICE Parte I - LE RADIAZIONI IONIZZANTI E LE GRANDEZZE FISICHE DI INTERESSE IN DOSIMETRIA Capitolo 1 Le radiazioni ionizzanti 19 1.1 Introduzione 19 1.2 Il fondo naturale di radiazione 21 1.2.1 La radiazione
INDICE Parte I - LE RADIAZIONI IONIZZANTI E LE GRANDEZZE FISICHE DI INTERESSE IN DOSIMETRIA Capitolo 1 Le radiazioni ionizzanti 19 1.1 Introduzione 19 1.2 Il fondo naturale di radiazione 21 1.2.1 La radiazione
Grandezze e unità di misura Dott.ssa Alessandra Bernardini
 Grandezze e unità di misura Dott.ssa Alessandra Bernardini 1 Grandezze radiometriche e coefficienti del mezzo La radiazione ionizzante che attraversa la materia perde la sua energia in processi di eccitazione
Grandezze e unità di misura Dott.ssa Alessandra Bernardini 1 Grandezze radiometriche e coefficienti del mezzo La radiazione ionizzante che attraversa la materia perde la sua energia in processi di eccitazione
DECADIMENTO RADIOATTIVO
 DECADIMENTO RADIOATTIVO Emissione di una o più particelle da parte di un nucleo. Tutti i decadimenti (tranne il decad. γ) cambiano Z e/o N del nucleo. Radionuclidi = Nuclidi radioattivi presenti in natura:
DECADIMENTO RADIOATTIVO Emissione di una o più particelle da parte di un nucleo. Tutti i decadimenti (tranne il decad. γ) cambiano Z e/o N del nucleo. Radionuclidi = Nuclidi radioattivi presenti in natura:
Linear No-Threshold Hypothesis (LNT)
 Il concetto di dose La Dosimetria Una delle discipline scientifiche che supporta la legge è la dosimetria, cioè la misura delle grandezze che consentono di calcolare il danno biologico dovuto all esposizione
Il concetto di dose La Dosimetria Una delle discipline scientifiche che supporta la legge è la dosimetria, cioè la misura delle grandezze che consentono di calcolare il danno biologico dovuto all esposizione
SORVEGLIANZA DOSIMETRICA INDIVIDUALE. dr. Marco Serafini
 SORVEGLIANZA DOSIMETRICA INDIVIDUALE dr. Marco Serafini m.serafini@ausl.mo.it Grandezze dosimetriche in uso in Radioprotezione Quantità fisiche Grandezze limite Grandezze operative ICRP International Commission
SORVEGLIANZA DOSIMETRICA INDIVIDUALE dr. Marco Serafini m.serafini@ausl.mo.it Grandezze dosimetriche in uso in Radioprotezione Quantità fisiche Grandezze limite Grandezze operative ICRP International Commission
CAPACITA DI PENETRAZIONE DELLA RADIAZIONE PERCORSO MASSIMO (RANGE) PER PARTICELLE CARICHE E SPESSORE EMIVALENTE PER FOTONI E NEUTRONI
 CAPACITA DI PENETRAZIONE DELLA RADIAZIONE NELLA MATERIA: PERCORSO MASSIMO (RANGE) PER PARTICELLE CARICHE E SPESSORE EMIVALENTE PER FOTONI E NEUTRONI Polvani pp 50-57 Particelle cariche Tessuti molli considerati
CAPACITA DI PENETRAZIONE DELLA RADIAZIONE NELLA MATERIA: PERCORSO MASSIMO (RANGE) PER PARTICELLE CARICHE E SPESSORE EMIVALENTE PER FOTONI E NEUTRONI Polvani pp 50-57 Particelle cariche Tessuti molli considerati
Acceleratori lineari Flattening Filter Free
 Acceleratori lineari Flattening Filter Free Dott. Marco D Andrea Laboratorio di Fisica Medica e Sistemi Esperti Istituto Nazionale Tumori Regina Elena Roma Fino a poco tempo fa 102 52 2-20 -10 0 10 20-48
Acceleratori lineari Flattening Filter Free Dott. Marco D Andrea Laboratorio di Fisica Medica e Sistemi Esperti Istituto Nazionale Tumori Regina Elena Roma Fino a poco tempo fa 102 52 2-20 -10 0 10 20-48
Grandezze dosimetriche in radiologia convenzionale ed interventistica
 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi GRUPPO REGIONALE OSCANO Grandezze dosimetriche Per misurare l irradiazione di un paziente conosciamo diverse quantità generali Grandezze dosimetriche in radiologia
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi GRUPPO REGIONALE OSCANO Grandezze dosimetriche Per misurare l irradiazione di un paziente conosciamo diverse quantità generali Grandezze dosimetriche in radiologia
Campi piccoli: la camera a ionizzazione Pinpoint
 GR Liguria Campi piccoli: la camera a ionizzazione Pinpoint Dott. Stefano Agostinelli S.C. Fisica Medica Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro Seminari di Fisica in Radioterapia Genova, 1 aprile
GR Liguria Campi piccoli: la camera a ionizzazione Pinpoint Dott. Stefano Agostinelli S.C. Fisica Medica Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro Seminari di Fisica in Radioterapia Genova, 1 aprile
INTERAZIONE DELLA RADIAZIONE CON CON LA LA MATERIA. Dal punto di vista dell interazione con la materia le radiazioni IONIZZANTI si classificano in:
 INTERAZIONE DELLA RADIAZIONE CON CON LA LA MATERIA Dal punto di vista dell interazione con la materia le radiazioni IONIZZANTI si classificano in: DIRETTAMENTE IONIZZANTI INDIRETTAMENTE IONIZZANTI Le radiazioni
INTERAZIONE DELLA RADIAZIONE CON CON LA LA MATERIA Dal punto di vista dell interazione con la materia le radiazioni IONIZZANTI si classificano in: DIRETTAMENTE IONIZZANTI INDIRETTAMENTE IONIZZANTI Le radiazioni
L impiego della simulazione Monte Carlo nell ambito della radioterapia
 L impiego della simulazione Monte Carlo nell ambito della radioterapia Lidia Strigari e Annelisa d Angelo Lab Fisica Medica e Sistemi Esperti Perché si usa / non si usa Consente la corretta determinazione
L impiego della simulazione Monte Carlo nell ambito della radioterapia Lidia Strigari e Annelisa d Angelo Lab Fisica Medica e Sistemi Esperti Perché si usa / non si usa Consente la corretta determinazione
DOSE DI RADIAZIONE IONIZZANTE PERICOLO DA RADIAZIONI IONIZZANTI DOSE ASSORBITA D =!E AREA CONTROLLATA. energia assorbita nell'unità di massa
 DOSE DI RADIAZIONE IONIZZANTE PERICOLO DA RADIAZIONI IONIZZANTI DOSE ASSORBITA AREA CONTROLLATA D =!E!m energia assorbita nell'unità di massa 2 UNITA' DI MISURA dose assorbita D =!E!m dimensioni [D] =
DOSE DI RADIAZIONE IONIZZANTE PERICOLO DA RADIAZIONI IONIZZANTI DOSE ASSORBITA AREA CONTROLLATA D =!E!m energia assorbita nell'unità di massa 2 UNITA' DI MISURA dose assorbita D =!E!m dimensioni [D] =
RADIOBIOLOGIA CELLULE, RADIAZIONI E STUDI DEGLI EFFETTI BIOLOGICI INDOTTI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
 RADIOBIOLOGIA CELLULE, RADIAZIONI E STUDI DEGLI EFFETTI BIOLOGICI INDOTTI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI Maria Pachera Andrea Reffo Eugenio Saletta Kawarpreet Singh Tutor: R. Cherubini, V. De Nadal LNL 26
RADIOBIOLOGIA CELLULE, RADIAZIONI E STUDI DEGLI EFFETTI BIOLOGICI INDOTTI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI Maria Pachera Andrea Reffo Eugenio Saletta Kawarpreet Singh Tutor: R. Cherubini, V. De Nadal LNL 26
Aspetti Fisici dell Adroterapia al CNAO
 Incontro di Orietamento per la Laurea Magistrale in Scienze Fisiche Martedì 19 Maggio 2015, Aula 102 Aspetti Fisici dell Adroterapia al CNAO Aurora Tamborini Assegnista di ricerca INFN Sezione di Pavia
Incontro di Orietamento per la Laurea Magistrale in Scienze Fisiche Martedì 19 Maggio 2015, Aula 102 Aspetti Fisici dell Adroterapia al CNAO Aurora Tamborini Assegnista di ricerca INFN Sezione di Pavia
INTERAZIONI DELLE RADIAZIONI CON LA MATERIA
 M. Marengo INTERAZIONI DELLE RADIAZIONI CON LA MATERIA Servizio di Fisica Sanitaria Ospedale Policlinico S.Orsola - Malpighi, Bologna mario.marengo@unibo.it Si definiscono radiazioni ionizzanti tutte le
M. Marengo INTERAZIONI DELLE RADIAZIONI CON LA MATERIA Servizio di Fisica Sanitaria Ospedale Policlinico S.Orsola - Malpighi, Bologna mario.marengo@unibo.it Si definiscono radiazioni ionizzanti tutte le
Sorgente Nucletron 3.6 0.65
 26 Sorgente Nucletron 3.6 0.65 27 TPS per Brachiterapia Hanno avuto uno sviluppo tardivo rispetto a quelli per fasci esterni La pianificazione BT è basata storicamente sull utilizzo di regole fisse per
26 Sorgente Nucletron 3.6 0.65 27 TPS per Brachiterapia Hanno avuto uno sviluppo tardivo rispetto a quelli per fasci esterni La pianificazione BT è basata storicamente sull utilizzo di regole fisse per
FOGGIA, 14 maggio 2010
 FOGGIA, 14 maggio 2010 Qualità: il grado dell eccellenza, la misura con la quale un organizzazione soddisfa i bisogni del cliente e le sue attese. L insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un
FOGGIA, 14 maggio 2010 Qualità: il grado dell eccellenza, la misura con la quale un organizzazione soddisfa i bisogni del cliente e le sue attese. L insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA
 Fisica Sanitaria Interazione di raggi X con la materia (diffusione, effetto compton, fotoelettrico, produzione di coppie, fotodisintegrazione). Spessore emivalente, decivalente. Interazione delle particelle
Fisica Sanitaria Interazione di raggi X con la materia (diffusione, effetto compton, fotoelettrico, produzione di coppie, fotodisintegrazione). Spessore emivalente, decivalente. Interazione delle particelle
Esercizio8: il lavoro di estrazione per il tungsteno é 4.49 ev. Calcolare la lunghezza d onda massima per ottenere effetto fotoelettrico [275.6 nm].
![Esercizio8: il lavoro di estrazione per il tungsteno é 4.49 ev. Calcolare la lunghezza d onda massima per ottenere effetto fotoelettrico [275.6 nm]. Esercizio8: il lavoro di estrazione per il tungsteno é 4.49 ev. Calcolare la lunghezza d onda massima per ottenere effetto fotoelettrico [275.6 nm].](/thumbs/62/47096832.jpg) Esercizio8: il lavoro di estrazione per il tungsteno é 4.49 ev. Calcolare la lunghezza d onda massima per ottenere effetto fotoelettrico [275.6 nm]. Esercizio9: un fotone gamma sparisce formando una coppia
Esercizio8: il lavoro di estrazione per il tungsteno é 4.49 ev. Calcolare la lunghezza d onda massima per ottenere effetto fotoelettrico [275.6 nm]. Esercizio9: un fotone gamma sparisce formando una coppia
CIED e Radioterapia. Mara Severgnini, Fisica Medica A.O.U. Ospedali Riuniti di Trieste
 CIED e Radioterapia Mara Severgnini, Fisica Medica A.O.U. Ospedali Riuniti di Trieste Dispositivi Cardiaci Impiantabili e radioterapia Pacemaker Defibrillatori Le radiazioni provocano danni: distruzione
CIED e Radioterapia Mara Severgnini, Fisica Medica A.O.U. Ospedali Riuniti di Trieste Dispositivi Cardiaci Impiantabili e radioterapia Pacemaker Defibrillatori Le radiazioni provocano danni: distruzione
Misura del coefficiente di assorbimento di vari materiali in funzione dell'energia del fascio dei fotoni incidenti
 materiali in funzione dell'energia del fascio dei fotoni Esperto Qualificato LNF - INFN Interazioni delle particelle indirettamente ionizzanti con la materia Le particelle indirettamente ionizzanti, principalmente
materiali in funzione dell'energia del fascio dei fotoni Esperto Qualificato LNF - INFN Interazioni delle particelle indirettamente ionizzanti con la materia Le particelle indirettamente ionizzanti, principalmente
L unità di misura della dose nel S.I. è il Gray
 LA LA DOSE DOSE DA DA RADIAZIONE Le radiazioni (particelle, raggi gamma ) quando interagiscono con un mezzo cedono (tutta o parte) della loro energia al mezzo stesso. Si definisce allora la dose assorbita
LA LA DOSE DOSE DA DA RADIAZIONE Le radiazioni (particelle, raggi gamma ) quando interagiscono con un mezzo cedono (tutta o parte) della loro energia al mezzo stesso. Si definisce allora la dose assorbita
LA SICUREZZA NEI CANTIERI NASCE A SCUOLA
 LA SICUREZZA NEI CANTIERI NASCE A SCUOLA Da Studente a RSPP Progetto sperimentale per gli Istituti superiori per Geometri della Provincia di Modena Il rischio da radiazioni ionizzanti Modulo A Lezione
LA SICUREZZA NEI CANTIERI NASCE A SCUOLA Da Studente a RSPP Progetto sperimentale per gli Istituti superiori per Geometri della Provincia di Modena Il rischio da radiazioni ionizzanti Modulo A Lezione
RADIAZIONI IONIZZANTI
 RADIAZIONI IONIZZANTI PREMESSA Le radiazioni ionizzanti sono quelle radiazioni dotate di sufficiente energia da poter ionizzare gli atomi (o le molecole) con i quali vengono a contatto. La caratteristica
RADIAZIONI IONIZZANTI PREMESSA Le radiazioni ionizzanti sono quelle radiazioni dotate di sufficiente energia da poter ionizzare gli atomi (o le molecole) con i quali vengono a contatto. La caratteristica
Esercizio8: il lavoro di estrazione per il tungsteno é 4.49 ev. Calcolare la lunghezza d onda massima per ottenere effetto fotoelettrico [275.6 nm].
![Esercizio8: il lavoro di estrazione per il tungsteno é 4.49 ev. Calcolare la lunghezza d onda massima per ottenere effetto fotoelettrico [275.6 nm]. Esercizio8: il lavoro di estrazione per il tungsteno é 4.49 ev. Calcolare la lunghezza d onda massima per ottenere effetto fotoelettrico [275.6 nm].](/thumbs/62/47096834.jpg) Esercizio8: il lavoro di estrazione per il tungsteno é 4.49 ev. Calcolare la lunghezza d onda massima per ottenere effetto fotoelettrico [275.6 nm]. Esercizio9: un fotone gamma sparisce formando una coppia
Esercizio8: il lavoro di estrazione per il tungsteno é 4.49 ev. Calcolare la lunghezza d onda massima per ottenere effetto fotoelettrico [275.6 nm]. Esercizio9: un fotone gamma sparisce formando una coppia
LE GRANDEZZE DOSIMETRICHE
 LE GRANDEZZE DOSIMETRICHE Introduzione Per la valutazione dell esposizione a radiazioni ionizzanti sono state sviluppate delle grandezze speciali, dette grandezze dosimetriche: queste si possono schematicamente
LE GRANDEZZE DOSIMETRICHE Introduzione Per la valutazione dell esposizione a radiazioni ionizzanti sono state sviluppate delle grandezze speciali, dette grandezze dosimetriche: queste si possono schematicamente
Rivelatori a gas. In situazione di equilibrio il gas si comporta come isolante e non c è passaggio di corrente elettrica
 STRUMENTI Rivelatori a gas I rivelatori a gas sono costituiti da due elettrodi immersi in un gas tra i quali è applicata un campo elettrico uniforme (differenza di potenziale) In situazione di equilibrio
STRUMENTI Rivelatori a gas I rivelatori a gas sono costituiti da due elettrodi immersi in un gas tra i quali è applicata un campo elettrico uniforme (differenza di potenziale) In situazione di equilibrio
TECNICHE RADIOCHIMICHE
 TECNICHE RADIOCHIMICHE L ATOMO - Un atomo e costituito da un nucleo carico positivamente, circondato da una nuvola di elettroni carichi negativamente. - I nuclei atomici sono costituiti da due particelle:
TECNICHE RADIOCHIMICHE L ATOMO - Un atomo e costituito da un nucleo carico positivamente, circondato da una nuvola di elettroni carichi negativamente. - I nuclei atomici sono costituiti da due particelle:
Cenni di fisica moderna
 Cenni di fisica moderna 1 fisica e salute la fisica delle radiazioni è molto utilizzata in campo medico esistono applicazioni delle radiazioni non ionizzanti nella terapia e nella diagnosi (laser per applicazioni
Cenni di fisica moderna 1 fisica e salute la fisica delle radiazioni è molto utilizzata in campo medico esistono applicazioni delle radiazioni non ionizzanti nella terapia e nella diagnosi (laser per applicazioni
Lezione 24 Radiazioni Ionizzanti
 Generalità Lezione 24 Radiazioni Ionizzanti Con il termine radiazione si descrivono fenomeni molto diversi fra loro: Emissione di luce da una lampada Emissione di calore da una fiamma Particelle elementari
Generalità Lezione 24 Radiazioni Ionizzanti Con il termine radiazione si descrivono fenomeni molto diversi fra loro: Emissione di luce da una lampada Emissione di calore da una fiamma Particelle elementari
Distaccamento Volontari Caselle Torinese 5) RADIOATTIVITA. Testi, immagini ed argomenti trattati a cura del Comando Provinciale di Torino
 5) RADIOATTIVITA 5.1 Radioattività Parlando di radioattività bisogna partire dai concetti introduttivi di fisica nucleare. 5.1.1 L atomo L atomo può essere definito la più piccola parte di un elemento
5) RADIOATTIVITA 5.1 Radioattività Parlando di radioattività bisogna partire dai concetti introduttivi di fisica nucleare. 5.1.1 L atomo L atomo può essere definito la più piccola parte di un elemento
Tecniche innovative modulate con LINAC
 XVII Convegno Regionale AIRO Piemonte Valle D Aosta Asti 18-Ott- 2008 Tecniche innovative modulate con LINAC Riccardo Ragona Radioterapia - Università di Torino Collimatori Multileaf (1995) Collimatori
XVII Convegno Regionale AIRO Piemonte Valle D Aosta Asti 18-Ott- 2008 Tecniche innovative modulate con LINAC Riccardo Ragona Radioterapia - Università di Torino Collimatori Multileaf (1995) Collimatori
Preparazione di radiofarmaci PET e per terapia radionuclidica: aree critiche per l operatore
 Preparazione di radiofarmaci PET e per terapia radionuclidica: aree critiche per l operatore Marco Chianelli, MD, PhD Unità Operativa di Endocrinologia Ospedale Regina Apostolorum, Albano Roma II WORKSHOP
Preparazione di radiofarmaci PET e per terapia radionuclidica: aree critiche per l operatore Marco Chianelli, MD, PhD Unità Operativa di Endocrinologia Ospedale Regina Apostolorum, Albano Roma II WORKSHOP
Fisica delle Apparecchiature per Radioterapia, lez. III RADIOTERAPIA M. Ruspa 1
 RADIOTERAPIA 14.01.11 M. Ruspa 1 Con il termine RADIOTERAPIA si intende l uso di radiazioni ionizzanti altamente energetiche (fotoni X o gamma, elettroni, protoni) nel trattamento dei tumori. La radiazione
RADIOTERAPIA 14.01.11 M. Ruspa 1 Con il termine RADIOTERAPIA si intende l uso di radiazioni ionizzanti altamente energetiche (fotoni X o gamma, elettroni, protoni) nel trattamento dei tumori. La radiazione
Introduzione ai Plasmi Relativistici
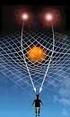 Introduzione ai Plasmi Relativistici Andrea Macchi CNR/INO, Pisa Dipartimento di Fisica Enrico Fermi, Università di Pisa www.df.unipi.it/~macchi/ A.A. 2010/11 Definizione e contesto PLASMA: sistema a molti
Introduzione ai Plasmi Relativistici Andrea Macchi CNR/INO, Pisa Dipartimento di Fisica Enrico Fermi, Università di Pisa www.df.unipi.it/~macchi/ A.A. 2010/11 Definizione e contesto PLASMA: sistema a molti
Chimica Nucleare. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.
 Chimica Nucleare Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. 1 Riassunto Numero Atomico (Z) = numero di protoni nel nucleo Numero di Massa (A) = numero di
Chimica Nucleare Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. 1 Riassunto Numero Atomico (Z) = numero di protoni nel nucleo Numero di Massa (A) = numero di
Interazione radiazione materia Dott.ssa Alessandra Bernardini
 Interazione radiazione materia Dott.ssa Alessandra Bernardini 1 Un po di storia Lo studio delle radiazioni ionizzanti come materia di interesse nasce nel novembre del 1895 ad opera del fisico tedesco Wilhelm
Interazione radiazione materia Dott.ssa Alessandra Bernardini 1 Un po di storia Lo studio delle radiazioni ionizzanti come materia di interesse nasce nel novembre del 1895 ad opera del fisico tedesco Wilhelm
MISURA LA DOSE ASSORBITA Gy = J Kg -1 (UNITA S.I.) MISURA DEL DANNO Sv = J Kg -1 (UNITA S.I.)
 LE UNITA DI MISURA DELLA RADIOATTIVITA Gray Sievert Röntgen Bequerel Curie Rutherford Rad Rem MISURA LA DOSE ASSORBITA Gy = J Kg -1 (UNITA S.I.) MISURA DEL DANNO Sv = J Kg -1 (UNITA S.I.) MISURA RADIAZIONE
LE UNITA DI MISURA DELLA RADIOATTIVITA Gray Sievert Röntgen Bequerel Curie Rutherford Rad Rem MISURA LA DOSE ASSORBITA Gy = J Kg -1 (UNITA S.I.) MISURA DEL DANNO Sv = J Kg -1 (UNITA S.I.) MISURA RADIAZIONE
Problematiche fisico dosimetriche della SBRT
 SIMPOSIO AIRO-AIFM SBRT: Aggiornamenti clinici e dosimetrici Problematiche fisico dosimetriche della SBRT pietro.mancosu@humanitas.it ! DICHIARAZIONE Relatore: Pietro Mancosu Come da nuova regolamentazione
SIMPOSIO AIRO-AIFM SBRT: Aggiornamenti clinici e dosimetrici Problematiche fisico dosimetriche della SBRT pietro.mancosu@humanitas.it ! DICHIARAZIONE Relatore: Pietro Mancosu Come da nuova regolamentazione
SPETTROMETRIA GAMMA SPETTROMETRIA GAMMA
 La spettrometria gamma è un metodo di analisi che consente la determinazione qualitativa e quantitativa dei radionuclidi gamma-emettitori presenti in un campione di interesse. Il successo di questo metodo
La spettrometria gamma è un metodo di analisi che consente la determinazione qualitativa e quantitativa dei radionuclidi gamma-emettitori presenti in un campione di interesse. Il successo di questo metodo
Capitolo 12. Moto oscillatorio
 Moto oscillatorio INTRODUZIONE Quando la forza che agisce su un corpo è proporzionale al suo spostamento dalla posizione di equilibrio ne risulta un particolare tipo di moto. Se la forza agisce sempre
Moto oscillatorio INTRODUZIONE Quando la forza che agisce su un corpo è proporzionale al suo spostamento dalla posizione di equilibrio ne risulta un particolare tipo di moto. Se la forza agisce sempre
La radioterapia nel trattamento integrato del cancro al polmone non microcitoma
 La radioterapia nel trattamento integrato del cancro al polmone non microcitoma Taranto 21-1- TECNICHE NON COPLANARI E SCELTA DELL ENERGIA ENERGIA NEL PLANNING 3D Dr. Domenico Mola - Fisico Medico - S.C.
La radioterapia nel trattamento integrato del cancro al polmone non microcitoma Taranto 21-1- TECNICHE NON COPLANARI E SCELTA DELL ENERGIA ENERGIA NEL PLANNING 3D Dr. Domenico Mola - Fisico Medico - S.C.
L importanza delle misure di dose assorbita in radioprotezione e nelle applicazioni mediche delle radiazioni ionizzanti
 L importanza delle misure di dose assorbita in radioprotezione e nelle applicazioni mediche delle radiazioni ionizzanti R. F. Laitano Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti ENEA,
L importanza delle misure di dose assorbita in radioprotezione e nelle applicazioni mediche delle radiazioni ionizzanti R. F. Laitano Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti ENEA,
PIANO DIDATTICO. Elementi di Anatomia, fisiologia umana e biofisica. Fondamenti di Biochimica e Biologia Applicata. Informatica I e II
 PIANO DIDATTICO I ANNO Insegnamento Ambito disciplinare Elementi di Anatomia, fisiologia umana e biofisica Fondamenti di Biochimica e Biologia Applicata BIO/16 BIO/09 BIO/13 BIO/10 TC 1 -- -- -- TC 1 --
PIANO DIDATTICO I ANNO Insegnamento Ambito disciplinare Elementi di Anatomia, fisiologia umana e biofisica Fondamenti di Biochimica e Biologia Applicata BIO/16 BIO/09 BIO/13 BIO/10 TC 1 -- -- -- TC 1 --
CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE DISO. Il software DISO è una procedura che permette la ricostruzione della dose nel punto di
 CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE DISO Il software DISO è una procedura che permette la ricostruzione della dose nel punto di isocentro del trattamento con fasci 3D-CRT statici di raggi x erogati dai linac
CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE DISO Il software DISO è una procedura che permette la ricostruzione della dose nel punto di isocentro del trattamento con fasci 3D-CRT statici di raggi x erogati dai linac
Produzione di un fascio di raggi x
 Produzione di un fascio di raggi x WWW.SLIDETUBE.IT Un fascio di elettroni penetra nella materia, dando origine a: produzione di elettroni secondari (raggi delta) emissione X caratteristica bremsstrahlung
Produzione di un fascio di raggi x WWW.SLIDETUBE.IT Un fascio di elettroni penetra nella materia, dando origine a: produzione di elettroni secondari (raggi delta) emissione X caratteristica bremsstrahlung
L utilizzo del codice Monte Carlo EGSnrc/BEAMnrc nella radioterapia : supporto alla clinica
 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ Corso per l'utilizzo del codice MonteCarlo in campo medico L utilizzo del codice Monte Carlo EGSnrc/BEAMnrc nella radioterapia : supporto alla clinica Rauco R * -AragnoD *
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ Corso per l'utilizzo del codice MonteCarlo in campo medico L utilizzo del codice Monte Carlo EGSnrc/BEAMnrc nella radioterapia : supporto alla clinica Rauco R * -AragnoD *
Corso di laboratorio di fisica della materia Prof. Mario Rocca AA Il progresso delle conoscenze in Fisica è indissolubilmente legato al
 Corso di laboratorio di fisica della materia Prof. Mario Rocca AA 2012-2013 Il progresso delle conoscenze in Fisica è indissolubilmente legato al progresso nei metodi di indagine sperimentale. Il corso
Corso di laboratorio di fisica della materia Prof. Mario Rocca AA 2012-2013 Il progresso delle conoscenze in Fisica è indissolubilmente legato al progresso nei metodi di indagine sperimentale. Il corso
Decadimento a. E tipico dei radioisotopi con Z > 82 (Pb), nei quali il rapporto tra il numero dei neutroni e quello dei protoni è troppo basso.
 Decadimento a Nel decadimento vengono emesse particelle formate da 2 protoni e 2 neutroni ( = nuclei di 4He) aventi velocità molto elevate (5-7% della velocità della luce) E tipico dei radioisotopi con
Decadimento a Nel decadimento vengono emesse particelle formate da 2 protoni e 2 neutroni ( = nuclei di 4He) aventi velocità molto elevate (5-7% della velocità della luce) E tipico dei radioisotopi con
Sicurezza nel Laboratorio: Radiazioni ionizzanti
 Sicurezza nel Laboratorio: Radiazioni ionizzanti Per questo corso non si consiglia nessun libro di testo t pertanto t il file contiene sia pagine didattiche sia pagine di approfondimento messe a punto
Sicurezza nel Laboratorio: Radiazioni ionizzanti Per questo corso non si consiglia nessun libro di testo t pertanto t il file contiene sia pagine didattiche sia pagine di approfondimento messe a punto
APPENDICE 1 Fondamenti di Dosimetria e Radioprotezione
 APPENDICE 1 Fondamenti di Dosimetria e adioprotezione I processi di ionizzazione e di eccitazione degli atomi e delle molecole associati al passaggio delle radiazioni ionizzanti nella materia, sono all
APPENDICE 1 Fondamenti di Dosimetria e adioprotezione I processi di ionizzazione e di eccitazione degli atomi e delle molecole associati al passaggio delle radiazioni ionizzanti nella materia, sono all
CELLULE E RADIAZIONI
 Stage H CELLULE E RADIAZIONI Tutor: Roberto Cherubini, Viviana De Nadal Relatori: Giulia Bonello, Luca Calciolari, Linda Giora, Marco Pinamonti 1 Scopo dell esperienza Studiare la sopravvivenza delle cellule
Stage H CELLULE E RADIAZIONI Tutor: Roberto Cherubini, Viviana De Nadal Relatori: Giulia Bonello, Luca Calciolari, Linda Giora, Marco Pinamonti 1 Scopo dell esperienza Studiare la sopravvivenza delle cellule
Effetti biologici NIR
 Effetti biologici NIR NIR Origine Lunghezza d onda Frequenza Effetti Biologici UVC Lampade UV germicide 100 nm - 280 nm 1075 THz - 3000 THz Eritema cutaneo, iperpigmentazione; Fotocheratite UVB Lampade
Effetti biologici NIR NIR Origine Lunghezza d onda Frequenza Effetti Biologici UVC Lampade UV germicide 100 nm - 280 nm 1075 THz - 3000 THz Eritema cutaneo, iperpigmentazione; Fotocheratite UVB Lampade
Approfondita discussione sull interazione radiazione materia vivente (radiobiologia) Funzionamento dettagliato di un acceleratore per radioterapia
 Cenni di Radioterapia Argomenti che NON verranno affrontati: Approfondita discussione sull interazione radiazione materia vivente (radiobiologia) Funzionamento dettagliato di un acceleratore per radioterapia
Cenni di Radioterapia Argomenti che NON verranno affrontati: Approfondita discussione sull interazione radiazione materia vivente (radiobiologia) Funzionamento dettagliato di un acceleratore per radioterapia
Radiazione di betatrone in plasmi prodotti da LASER
 Radiazione di betatrone in plasmi prodotti da LASER Alessandro Curcio a, Danilo Giulietti a a Physics Department of the University and INFN, Pisa, Italy 100 o Congresso SIF 23 Settembre 2014, Pisa Regime
Radiazione di betatrone in plasmi prodotti da LASER Alessandro Curcio a, Danilo Giulietti a a Physics Department of the University and INFN, Pisa, Italy 100 o Congresso SIF 23 Settembre 2014, Pisa Regime
Lezione 7 Effetto Cerenkov
 Per una trattazione classica dell effetto Cerenkov consultare Jackson : Classical Electrodynamics cap 13 e paragrafi 13.4 e 13.5 Rivelatori di Particelle 1 La radiazione Cerenkov e emessa ogniqualvolta
Per una trattazione classica dell effetto Cerenkov consultare Jackson : Classical Electrodynamics cap 13 e paragrafi 13.4 e 13.5 Rivelatori di Particelle 1 La radiazione Cerenkov e emessa ogniqualvolta
Se la funzione è analiticamente invertibile, estratto q, si può ricavare x = x(q).
 La tecnica Monte Carlo Il metodo Monte Carlo è basato sulla scelta di eventi fisici con una probabilità di accadimento nota a priori. sia p(x) la distribuzione di probabilità con la quale si manifesta
La tecnica Monte Carlo Il metodo Monte Carlo è basato sulla scelta di eventi fisici con una probabilità di accadimento nota a priori. sia p(x) la distribuzione di probabilità con la quale si manifesta
Tipologie di controlli di qualità dedicate a linac mediante rivelatore 4D a diodi
 Tipologie di controlli di qualità dedicate a linac mediante rivelatore 4D a diodi Anna Sardo SD Fisica Sanitaria ScandiDos Delta 4 169 diodi p-type Area:.78 mm 2 Altezza:.5 mm in qualsiasi direzione di
Tipologie di controlli di qualità dedicate a linac mediante rivelatore 4D a diodi Anna Sardo SD Fisica Sanitaria ScandiDos Delta 4 169 diodi p-type Area:.78 mm 2 Altezza:.5 mm in qualsiasi direzione di
Radiazione: propagazione di energia senza che vi sia né. Radiazioni ionizzanti radiazioni che hanno energia sufficiente per produrre la ionizzazione.
 Radiazioni Radiazione: propagazione di energia senza che vi sia né trasporto di quantità macroscopiche di materia, né necessità di un substrato materiale per la propagazione. L energia viene ceduta quando
Radiazioni Radiazione: propagazione di energia senza che vi sia né trasporto di quantità macroscopiche di materia, né necessità di un substrato materiale per la propagazione. L energia viene ceduta quando
Indici di dose in MSCT. (dr. Francesca Pietrobon U.O. Fisica Sanitaria Ospedale San Martino Belluno U.L.S.S. n. 1)
 Indici di dose in MSCT (dr. Francesca Pietrobon U.O. Fisica Sanitaria Ospedale San Martino Belluno U.L.S.S. n. 1) L introduzione delle MSCT ha riportato l attenzione sul settore della tomografia computerizzata
Indici di dose in MSCT (dr. Francesca Pietrobon U.O. Fisica Sanitaria Ospedale San Martino Belluno U.L.S.S. n. 1) L introduzione delle MSCT ha riportato l attenzione sul settore della tomografia computerizzata
Fisica dei piccoli campi
 Fisica dei piccoli campi Serenella Russo S.C. Fisica Sanitaria Azienda Sanitaria di Firenze serenella.russo@asf.toscana.it Sommario Introduzione Definizione di piccoli campi Caratteristiche dei piccoli
Fisica dei piccoli campi Serenella Russo S.C. Fisica Sanitaria Azienda Sanitaria di Firenze serenella.russo@asf.toscana.it Sommario Introduzione Definizione di piccoli campi Caratteristiche dei piccoli
Fisica delle Radiazioni Ionizzanti. Dott. Mirco Amici Esperto Qualificato U.O.C Medicina Legale e Gestione del Rischio
 Fisica delle Radiazioni Ionizzanti Dott. Mirco Amici Esperto Qualificato U.O.C Medicina Legale e Gestione del Rischio 1 Fisica delle Radiazioni Ionizzanti Cosa sono le radiazioni ionizzanti Tipi di radiazioni
Fisica delle Radiazioni Ionizzanti Dott. Mirco Amici Esperto Qualificato U.O.C Medicina Legale e Gestione del Rischio 1 Fisica delle Radiazioni Ionizzanti Cosa sono le radiazioni ionizzanti Tipi di radiazioni
Adroterapia a CNAO (Centro Nazionale di Adroterpia Oncologica)
 XXII GIORNATE DI STUDIO sui RIVELATORI Adroterapia a CNAO (Centro Nazionale di Adroterpia Oncologica) Simona Giordanengo - INFN Torino Torino 12 Giugno 2012 Sommario PARTE I Adroterapia Principi base (Elevata
XXII GIORNATE DI STUDIO sui RIVELATORI Adroterapia a CNAO (Centro Nazionale di Adroterpia Oncologica) Simona Giordanengo - INFN Torino Torino 12 Giugno 2012 Sommario PARTE I Adroterapia Principi base (Elevata
la forma esplicita delle correzioni
 la forma esplicita delle correzioni al leading order (ma nei programmi di fit le correzioni si spingono, a seconda dei casi, ad ordini superiori) e per m H >m W le correzioni dipendenti dal flavour sono
la forma esplicita delle correzioni al leading order (ma nei programmi di fit le correzioni si spingono, a seconda dei casi, ad ordini superiori) e per m H >m W le correzioni dipendenti dal flavour sono
SICUREZZA DEL PAZIENTE E RISCHIO CLINICO IN RADIOTERAPIA
 SICUREZZA DEL PAZIENTE E RISCHIO CLINICO IN RADIOTERAPIA Treviso, 10 dicembre 2014 Appunti tratti da: 1 Rischio per il paziente in radioterapia sottodosaggio del PTV sovradosaggio di organi sani rischi
SICUREZZA DEL PAZIENTE E RISCHIO CLINICO IN RADIOTERAPIA Treviso, 10 dicembre 2014 Appunti tratti da: 1 Rischio per il paziente in radioterapia sottodosaggio del PTV sovradosaggio di organi sani rischi
LA PRODUZIONE DEI RAGGI X
 UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia LA PRODUZIONE DEI RAGGI X A.A. 2015-2016 Tecniche di Radiodiagnostica
UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia LA PRODUZIONE DEI RAGGI X A.A. 2015-2016 Tecniche di Radiodiagnostica
SVILUPPO DEI MODELLI
 SVILUPPO DEI MODELLI definizione del problema struttura del modello banca dati taratura/ calibrazione (messa a punto) NO validazione (collaudo) SI implementazione e utilizzo modelli descrittivi: simulazione
SVILUPPO DEI MODELLI definizione del problema struttura del modello banca dati taratura/ calibrazione (messa a punto) NO validazione (collaudo) SI implementazione e utilizzo modelli descrittivi: simulazione
APPLICAZIONI Popolazioni residenti in alta quota Dosimetria sui voli aerei Dosimetria nei voli spaziali
 USO DEL FANTOCCIO ANTROPOMORFO PER DOSIMETRIA INTERNA IN ATMOSFERA APPLICAZIONI Popolazioni residenti in alta quota Dosimetria sui voli aerei Dosimetria nei voli spaziali Obiettivo della tesi Estensione
USO DEL FANTOCCIO ANTROPOMORFO PER DOSIMETRIA INTERNA IN ATMOSFERA APPLICAZIONI Popolazioni residenti in alta quota Dosimetria sui voli aerei Dosimetria nei voli spaziali Obiettivo della tesi Estensione
CORSO DI RADIOPROTEZIONE FISICA
 CORSO DI RADIOPROTEZIONE FISICA Gli studenti sono pregati di considerare queste slides come indice dettagliato degli argomenti svolti a lezione e non come un libro di testo. Lo studio dei testi consigliati
CORSO DI RADIOPROTEZIONE FISICA Gli studenti sono pregati di considerare queste slides come indice dettagliato degli argomenti svolti a lezione e non come un libro di testo. Lo studio dei testi consigliati
Gli acceleratori e i rivelatori di particelle
 Gli acceleratori e i rivelatori di particelle Come studiare le proprietà dei NUCLEI? Facendoli collidere tra loro!!!! Informazioni: Dimensioni e struttura del nucleo Forze nucleari Meccanismi di reazione
Gli acceleratori e i rivelatori di particelle Come studiare le proprietà dei NUCLEI? Facendoli collidere tra loro!!!! Informazioni: Dimensioni e struttura del nucleo Forze nucleari Meccanismi di reazione
Theory Italiano (Italy)
 Q3-1 Large Hadron Collider (10 punti) Prima di iniziare questo problema, leggi le istruzioni generali nella busta a parte. In questo problema è discussa la fisica dell acceleratore di particelle del CERN
Q3-1 Large Hadron Collider (10 punti) Prima di iniziare questo problema, leggi le istruzioni generali nella busta a parte. In questo problema è discussa la fisica dell acceleratore di particelle del CERN
La struttura elettronica degli atomi
 1 In unità atomiche: a 0 me 0,59A unità di lunghezza e H 7, ev a H=Hartree unità di energia L energia dell atomo di idrogeno nello stato fondamentale espresso in unità atomiche è: 4 0 me 1 e 1 E H 13,
1 In unità atomiche: a 0 me 0,59A unità di lunghezza e H 7, ev a H=Hartree unità di energia L energia dell atomo di idrogeno nello stato fondamentale espresso in unità atomiche è: 4 0 me 1 e 1 E H 13,
Radiazioni ionizzanti
 Radiazioni ionizzanti Radiazioni ionizzanti interagiscono con la materia determinando fenomeni di ionizzazione sia direttamente (elettroni, protoni, particelle alfa) che indirettamente (neutroni) cedendo
Radiazioni ionizzanti Radiazioni ionizzanti interagiscono con la materia determinando fenomeni di ionizzazione sia direttamente (elettroni, protoni, particelle alfa) che indirettamente (neutroni) cedendo
Elettricità e Fisica Moderna
 Esercizi di fisica per Medicina C.Patrignani, Univ. Genova (rev: 9 Ottobre 2003) 1 Elettricità e Fisica Moderna 1) Una candela emette una potenza di circa 1 W ad una lunghezza d onda media di 5500 Å a)
Esercizi di fisica per Medicina C.Patrignani, Univ. Genova (rev: 9 Ottobre 2003) 1 Elettricità e Fisica Moderna 1) Una candela emette una potenza di circa 1 W ad una lunghezza d onda media di 5500 Å a)
INTERAZIONE RADIAZIONE MATERIA
 INTERAZIONE RADIAZIONE MATERIA Grandezze pertinenti e relative unità di misura (S.I. o pratiche) E fotone = energia di un fotone X N = numero di fotoni X Ex = N E fotone = energia trasportata da N fotoni
INTERAZIONE RADIAZIONE MATERIA Grandezze pertinenti e relative unità di misura (S.I. o pratiche) E fotone = energia di un fotone X N = numero di fotoni X Ex = N E fotone = energia trasportata da N fotoni
Generalità delle onde elettromagnetiche
 Generalità delle onde elettromagnetiche Ampiezza massima: E max (B max ) Lunghezza d onda: (m) E max (B max ) Periodo: (s) Frequenza: = 1 (s-1 ) Numero d onda: = 1 (m-1 ) = v Velocità della luce nel vuoto
Generalità delle onde elettromagnetiche Ampiezza massima: E max (B max ) Lunghezza d onda: (m) E max (B max ) Periodo: (s) Frequenza: = 1 (s-1 ) Numero d onda: = 1 (m-1 ) = v Velocità della luce nel vuoto
Caratterizzazione di rivelatori di radiazione a semiconduttore. Monica Scaringella
 Caratterizzazione di rivelatori di radiazione a semiconduttore Monica Scaringella SOMMARIO Principio di funzionamento di un rivelatore Applicazioni e ambiente di lavoro: Rivelatori di particelle a silicio
Caratterizzazione di rivelatori di radiazione a semiconduttore Monica Scaringella SOMMARIO Principio di funzionamento di un rivelatore Applicazioni e ambiente di lavoro: Rivelatori di particelle a silicio
SPECT (Gamma Camera)
 SPECT-PET Nella tomografia a raggi-x si usa la misura del coefficiente di attenuazione del tessuti per dedurre informazioni diagnostiche sul paziente. La tomografia ad emissione d altra parte utilizza
SPECT-PET Nella tomografia a raggi-x si usa la misura del coefficiente di attenuazione del tessuti per dedurre informazioni diagnostiche sul paziente. La tomografia ad emissione d altra parte utilizza
Simulazione di apparati. Programmi di simulazione. Design. Analisi dati in Fisica Subnucleare. Simulazione di processi fisici
 Analisi dati in Fisica Subnucleare Simulazione di processi fisici Simulazione di apparati In un moderno esperimento di Fisica Subnucleare, la simulazione dei complessi sistemi di rivelatori che costituiscono
Analisi dati in Fisica Subnucleare Simulazione di processi fisici Simulazione di apparati In un moderno esperimento di Fisica Subnucleare, la simulazione dei complessi sistemi di rivelatori che costituiscono
LE RADIAZIONI IONIZZANTI
 LE RADIAZIONI IONIZZANTI Generalità Le radiazioni ionizzanti sono, per definizione, onde elettromagnetiche e particelle capaci di causare, direttamente o indirettamente, la ionizzazione degli atomi e delle
LE RADIAZIONI IONIZZANTI Generalità Le radiazioni ionizzanti sono, per definizione, onde elettromagnetiche e particelle capaci di causare, direttamente o indirettamente, la ionizzazione degli atomi e delle
Elenco aggiornato a Febbraio 2016 delle norme CEI in corso di validità.
 Elenco aggiornato a Febbraio 2016 delle norme CEI in corso di validità. Di seguito trovate l elenco delle norme CEI in corso di validità emesse dai due sottocomitati di maggiore interesse per i Fisici
Elenco aggiornato a Febbraio 2016 delle norme CEI in corso di validità. Di seguito trovate l elenco delle norme CEI in corso di validità emesse dai due sottocomitati di maggiore interesse per i Fisici
DATAZIONI PER PER LUMINESCENZA
 Stima della dose annua: La dose annua è dovuta alle particelle alfa, beta, ai raggi gamma e ai raggi cosmici. Mentre il contributo delle particelle alfa è interamente dovuto ai radionuclidi delle serie
Stima della dose annua: La dose annua è dovuta alle particelle alfa, beta, ai raggi gamma e ai raggi cosmici. Mentre il contributo delle particelle alfa è interamente dovuto ai radionuclidi delle serie
ANALISI PER IMMAGINI ED ELEMENTI DI DOSIMETRIA
 DIPARTIMENTO DI FISICA ED ASTRONOMIA Corso di laurea magistrale in Fisica Anno accademico 2015/2016-1 anno - Curriculum FISICA APPLICATA ANALISI PER IMMAGINI ED ELEMENTI DI DOSIMETRIA 6 CFU - 2 semestre
DIPARTIMENTO DI FISICA ED ASTRONOMIA Corso di laurea magistrale in Fisica Anno accademico 2015/2016-1 anno - Curriculum FISICA APPLICATA ANALISI PER IMMAGINI ED ELEMENTI DI DOSIMETRIA 6 CFU - 2 semestre
IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 159/ 19 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI
 30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 159/ 19 ALLEGATO VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere
30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 159/ 19 ALLEGATO VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere
Nel referto di ogni esame radiologico è prevista la presenza di informazioni relative all esposizione del paziente (art.58 b).
 Documento di consenso intersocietario Registrazione e informazione dei dati di esposizione radiologica alla luce della Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013. Premessa Il presente documento si rivolge
Documento di consenso intersocietario Registrazione e informazione dei dati di esposizione radiologica alla luce della Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013. Premessa Il presente documento si rivolge
ESERCIZI W X Y Z. Numero di massa Neutroni nel nucleo Soluzione
 ESERCIZI 1) La massa di un elettrone, rispetto a quella di un protone, è: a. uguale b. 1850 volte più piccola c. 100 volte più piccola d. 18,5 volte più piccola 2) I raggi catodici sono: a. radiazioni
ESERCIZI 1) La massa di un elettrone, rispetto a quella di un protone, è: a. uguale b. 1850 volte più piccola c. 100 volte più piccola d. 18,5 volte più piccola 2) I raggi catodici sono: a. radiazioni
Linee guida per il planning nel carcinoma del polmone. Radiotherapy and Oncology 71 (2004)
 Linee guida per il planning nel carcinoma del polmone Radiotherapy and Oncology 71 (2004) 139-146 Linee guida per il planning nel carcinoma del polmone Posizionamento del paziente Acquisizione delle immagini
Linee guida per il planning nel carcinoma del polmone Radiotherapy and Oncology 71 (2004) 139-146 Linee guida per il planning nel carcinoma del polmone Posizionamento del paziente Acquisizione delle immagini
Per ognuno di questi effetti si definisce una sezione d urto microscopica σ ph, σ C, σ pp.
 Interazione dei fotoni con la materia I fotoni interagiscono con la materia attraverso tre effetti : fotoelettrico (ph); compton (C); produzione di coppie (pp). Per ognuno di questi effetti si definisce
Interazione dei fotoni con la materia I fotoni interagiscono con la materia attraverso tre effetti : fotoelettrico (ph); compton (C); produzione di coppie (pp). Per ognuno di questi effetti si definisce
I livelli diagnostici di riferimento. Valutazione strumentale dei LDR
 Ospedale di Circolo Fondazione Macchi I livelli diagnostici di riferimento. Valutazione strumentale dei LDR Dr.ssa Carla Bianchi Servizio di Fisica Sanitaria - Ospedale di Circolo RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE
Ospedale di Circolo Fondazione Macchi I livelli diagnostici di riferimento. Valutazione strumentale dei LDR Dr.ssa Carla Bianchi Servizio di Fisica Sanitaria - Ospedale di Circolo RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE
Il nucleare non è il diavolo. Il problema:
 2005 Anno Mondiale della Fisica Il nucleare non è il diavolo Progetto di monitoraggio della radioattività ambientale nelle scuole Sezione di Torino dell INFN e Dipartimenti di Fisica dell Università di
2005 Anno Mondiale della Fisica Il nucleare non è il diavolo Progetto di monitoraggio della radioattività ambientale nelle scuole Sezione di Torino dell INFN e Dipartimenti di Fisica dell Università di
Unità didattica 10. Decima unità didattica (Fisica) 1. Corso integrato di Matematica e Fisica per il Corso di Farmacia
 Unità didattica 10 Radioattività... 2 L atomo... 3 Emissione di raggi x... 4 Decadimenti nucleari. 6 Il decadimento alfa.... 7 Il decadimento beta... 8 Il decadimento gamma...... 9 Interazione dei fotoni
Unità didattica 10 Radioattività... 2 L atomo... 3 Emissione di raggi x... 4 Decadimenti nucleari. 6 Il decadimento alfa.... 7 Il decadimento beta... 8 Il decadimento gamma...... 9 Interazione dei fotoni
Teoria Atomica Moderna. Chimica generale ed Inorganica: Chimica Generale. sorgenti di emissione di luce. E = hν. νλ = c. E = mc 2
 sorgenti di emissione di luce E = hν νλ = c E = mc 2 FIGURA 9-9 Spettro atomico, o a righe, dell elio Spettri Atomici: emissione, assorbimento FIGURA 9-10 La serie di Balmer per gli atomi di idrogeno
sorgenti di emissione di luce E = hν νλ = c E = mc 2 FIGURA 9-9 Spettro atomico, o a righe, dell elio Spettri Atomici: emissione, assorbimento FIGURA 9-10 La serie di Balmer per gli atomi di idrogeno
Radioattivita (radiazioni ionizzanti) e salute. 1a parte
 Radioattivita (radiazioni ionizzanti) e salute Cristiana Peroni Dipartimento di Fisica Sperimentale dell Universita di Torine e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 1a parte 4/11/2005 C.Peroni 1 Che cosa
Radioattivita (radiazioni ionizzanti) e salute Cristiana Peroni Dipartimento di Fisica Sperimentale dell Universita di Torine e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 1a parte 4/11/2005 C.Peroni 1 Che cosa
Il carcinoma della mammella in gravidanza e allattamento: un problema emergente. La Radioterapia
 Il carcinoma della mammella in gravidanza e allattamento: un problema emergente. La Radioterapia 23 maggio 2013 A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Varese Dott.sa Daniela Doino Dirigente medico
Il carcinoma della mammella in gravidanza e allattamento: un problema emergente. La Radioterapia 23 maggio 2013 A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Varese Dott.sa Daniela Doino Dirigente medico
Radiazioni ionizzanti
 Radiazioni ionizzanti Qualunque radiazione in grado di provocare fenomeni di ionizzazione. Radiazione: trasferimento di energia attraverso lo spazio. Ionizzazione: fenomeno per il quale, da un atomo stabile
Radiazioni ionizzanti Qualunque radiazione in grado di provocare fenomeni di ionizzazione. Radiazione: trasferimento di energia attraverso lo spazio. Ionizzazione: fenomeno per il quale, da un atomo stabile
DEIS ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
 ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Campi a basse e alte frequenze per la valutazione dei livelli di esposizione Vengono considerati in modo del tutto distinto i campi elettrici e magnetici a bassa frequenza
ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Campi a basse e alte frequenze per la valutazione dei livelli di esposizione Vengono considerati in modo del tutto distinto i campi elettrici e magnetici a bassa frequenza
Il rischio di effetti stocastici in Diagnostica per Immagini
 Il rischio di effetti stocastici in Diagnostica per Immagini Francesco Coppolino Rimini, 9 Novembre 2015! Introduzione Esiste consapevolezza del problema dose nella popolazione? Introduzione Esiste consapevolezza
Il rischio di effetti stocastici in Diagnostica per Immagini Francesco Coppolino Rimini, 9 Novembre 2015! Introduzione Esiste consapevolezza del problema dose nella popolazione? Introduzione Esiste consapevolezza
Corso di Master Universitario di I livello in VERIFICHE DI QUALITA IN RADIODIAGNOSTICA, MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA
 Corso di Master Universitario di I livello in VERIFICHE DI QUALITA IN RADIODIAGNOSTICA, MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA Esame relativo al corso Principi alla base della formazione dell'immagine diagnostica
Corso di Master Universitario di I livello in VERIFICHE DI QUALITA IN RADIODIAGNOSTICA, MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA Esame relativo al corso Principi alla base della formazione dell'immagine diagnostica
Verso una teoria del tutto: La teoria delle stringhe
 Verso una teoria del tutto: La teoria delle stringhe S. Penati Università di Milano Bicocca ed INFN Napoli, 10/03/08 S. Penati 1 Fisica e ordini di grandezza Napoli, 10/03/08 S. Penati 2 Teorie diverse
Verso una teoria del tutto: La teoria delle stringhe S. Penati Università di Milano Bicocca ed INFN Napoli, 10/03/08 S. Penati 1 Fisica e ordini di grandezza Napoli, 10/03/08 S. Penati 2 Teorie diverse
