INTRODUZIONE I Cenni preliminari
|
|
|
- Miranda Gioia
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 INTRODUZIONE I Cenni preliminari Il presente lavoro si propone di effettuare un analisi linguistico-stilistica dei Contes di Charles Perrault, al fine di mettere in evidenza il rispetto o l infrazione delle norme secentesche. Ho ritenuto innanzitutto di dare alcuni cenni sulla lingua francese del XVII secolo, sia considerando le opere dei maggiori teorici e grammatici, sia presentandone alcune tra le principali caratteristiche. Ho inoltre messo in evidenza la lenta imposizione del francese come lingua nazionale. Ho tenuto presente che Perrault ha composto racconti sia in prosa (la raccolta Histoires ou Contes du temps passé) sia in versi, e che dunque ha dovuto rispettare le diverse esigenze di tali produzioni; così ho trattato in maniera distinta le due categorie, usando diversi criteri di analisi. Per i racconti in prosa ho valutato, tra le altre, le caratteristiche sintattiche ed il rispetto per la natura orale dei racconti, elementi molto più elastici nella produzione poetica per le particolari esigenze della versificazione; al contrario, i racconti in versi sono stati oggetto di analisi delle tecniche retoriche caratteristiche dello stile prezioso, che vanno da accumulatio a iperboli, paragoni, perifrasi e metafore. 3
2 Ho considerato infine il complesso dei racconti di Perrault per alcune osservazioni di carattere soprattutto lessicale. I tre dizionari del XVII secolo (di Richelet, Furetière e dell Académie française) 1 hanno rappresentato un ausilio fondamentale per le mie riflessioni, così come le Remarques sur la langue françoise di Vaugelas 2. È risultato interessante anche il confronto fra le diverse edizioni dei racconti 3, tra le quali esistono discordanze grafiche e lessicali significative, utili per comprendere l instabilità della lingua francese del XVII secolo. Tutte le citazioni di brani dei racconti sono tratte dall edizione curata da Collinet. Si è ritenuto opportuno presentare in breve le questioni che hanno caratterizzato lo studio dell evoluzione del racconto; inoltre, si è voluto illustrare l analisi morfologica di Propp 4, fornendo una sua applicazione ai racconti di Perrault, al fine di dimostrare l universalità del genere e degli studi che lo accompagnano. 1 P. Richelet, Dictionnaire françois, fac similé de l édition originale de 1680, 2 tomi, Genève, Slatkine Reprints, 1970; A. Furetière, Dictionnaire Universel, fac similé de l édition originale de 1690, 3 tomi, Genève, Slatkine Reprints, 1970; Dictionnaire de l Académie Française, fac similé de l édition originale de 1695, 2 tomi, Genève, Slatkine Reprints, C. F. de Vaugelas, Remarques sur la langue françoise, fac similé de l édition originale de 1647, Genève, Slatkine Reprints, Contes de Perrault, fac similé de l édition originale de , Genève, Slatkine Reprints, 1980; Ch. Perrault, Contes, édition de J. P. Collinet, Paris, Gallimard, collection Folio, 1981; Ch. Perrault, Contes, édition de G. Rouger, Paris, Garnier, 1967; Ch. Perrault/M.me d Aulnoy, Contes, Paris, Flammarion, Testo di riferimento: V. Propp, Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi,
3 II Le origini del conte de fée L interesse scientifico che si è mostrato nel nostro secolo nei confronti dei Contes di Charles Perrault è piuttosto modesto in confronto alla fama degli stessi nell ambito della letteratura per bambini; il motivo è che il conte de fée è oggi considerato un genere minore, pertanto pochissime opere critiche sono dedicate al suo studio 5. Tutti conoscono i racconti di Perrault, ma pochi ne conoscono l autore, cosa che invece non è accaduta ai fratelli Grimm. Tuttavia egli è il più noto degli autori di contes de fées del XVII secolo, definito addirittura da Calvino inventore del genere 6, e gli studi dedicati all evoluzione del racconto non hanno ignorato il suo ruolo fondamentale. Tra i critici che si sono occupati di letteratura per l infanzia, Marc Soriano è stato l unico a dedicare diversi studi esclusivamente ai racconti di Perrault, analizzandoli sia da un punto di vista linguistico che psicologico e filosofico, tenendo presente anche l influsso della precedente produzione dello scrittore e della sua vita privata 7. Va segnalato anche l interesse mostrato da Jacques Barchilon nella sua opera Le conte merveilleux français de 1690 à , nella quale ha dedicato un capitolo ai racconti di Perrault. Delarue e Tenèze hanno 5 J. Barchilon, Le conte merveilleux français de 1690 à Cent ans de féerie et de poésie ignorées de l histoire littéraire, Paris, Librairie Honoré Champion, 1975, p. XVI. 6 I. Calvino, Fiabe italiane, Milano, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 1993, p. XII. 7 Di Soriano sono state consultate le seguenti opere dedicate a Charles Perrault: Les contes de Perrault. Culture savante et traditions populaires, édition revue et corrigée, s. l., Gallimard, 1968, préface del 1977; La langue plurielle de Charles Perrault, in AAVV, Quaderni del Seicento francese, n. 9, Bari/Paris, Adriatica/Nizet, J. Barchilon, op. cit., pp
4 invece condotto un analisi filologica, individuando le origini e i temi ricorrenti dei racconti popolari francesi 9, e ampio spazio vi trovano i Contes, che hanno prodotto o riprodotto elementi divenuti immortali nell universo favolistico internazionale. Ogni popolo, ogni provincia, ogni villaggio possiede un tesoro di tradizioni popolari, e non esiste che un piccolissimo numero di leggende, canzoni, proverbi, racconti che appartengano solo ad una determinata tradizione; al contrario, si nota che ognuna di queste tradizioni possiede una forza meravigliosa di sopravvivenza nel tempo e di diffusione nello spazio 10. Per dirlo con Propp: il racconto di fate è internazionale e [...], fino a un certo punto, anche i suoi motivi sono internazionali 11 Infatti, i racconti di Perrault si diffusero rapidamente anche all estero, e i racconti popolari tedeschi cui attinsero i fratelli Grimm per la composizione della loro raccolta erano traduzioni di tali racconti, importati da governanti francesi residenti in Germania; ecco perché sono spesso molto simili a quelli del nostro autore P. Delarue e M.-L. Tenèze, Le conte populaire français, 3 tomi, Paris, Editions G. P. Maisonneuve et Larose, J. Bédier, L origine et la propagation des contes populaires, in Les Fabliaux. Etudes de littérature populaire et d histoire littéraire du Moyen Âge, Paris, Librairie Honoré Champion, 1964, p V. Propp, Le radici storiche dei racconti di fate, Torino, Editore Boringhieri, 1972, p J. Barchilon, op. cit., p
5 La moda dei contes de fées è esplosa nell ultimo decennio del Seicento, quando i romanzi cortesi, la tradizione orale e quella del Rinascimento italiano, iniziarono a fornire spunti e temi per una produzione di racconti vasta ma di breve durata; spesso le radici dei racconti si fissano profondamente nel passato, fino alle origini dei pensieri e delle credenze primitive 13. La raccolta del materiale parte dal Medioevo, perché è a questo periodo storico che risalgono le prime attestazioni di tradizioni popolari 14. Il conte de fée è una categoria particolare della fiaba 15, ed è nato dall esigenza di evocare un passato florido (reale o fittizio) in un epoca di disagio economico per evadere dal presente 16 ; per tale ragione questi racconti sono ambientati in un periodo passato, introdotto dalla celeberrima formula Il était une fois. La caratteristica peculiare dei racconti è il meraviglioso, che in essi gioca un ruolo fondamentale; tuttavia, i conteurs francesi, al contrario degli altri autori stranieri, tendevano a calmare la fantasia ricorrendo a realismo e verosimiglianza, senza tuttavia trascurare l aspetto soprannaturale delle avventure dei loro eroi 17. Perrault ha avvertito questa esigenza, e ha modificato diversi elementi della tradizione orale per rendere verosimili 13 J. Bédier, op. cit., pp Ibid., p V. Propp, Le radici storiche dei racconti di fate, p J. Barchilon, op. cit., p. XIII. 17 Ibid., p. XV. 7
6 i racconti; inoltre, ha inserito commenti al loro interno per spiegare situazioni che potrebbero sembrare irrazionali 18. Secondo la teoria antropologica illustrata da Bédier, streghe, animali parlanti, orchi, fate e, in generale, ogni contatto dell uomo con una natura fantastica, non è opera dell immaginario dei popoli civili, ma sono resti di modi di pensare e di credenze aboliti, che in passato rappresentavano dei tabù; pertanto, per spiegare queste meraviglie, bisognerebbe fare riferimento a culture selvagge 19. Diverse teorie hanno cercato di identificare il luogo di nascita dei racconti; fra queste prevale la teoria orientalista (confutata da Propp) 20, secondo la quale la fonte comune da cui i racconti popolari si sarebbero sparsi in tutto il mondo è l India 21. Seguendo tale teoria, la trasmissione dei racconti nel mondo occidentale coinciderebbe sia con l inizio di relazioni più strette tra i popoli occidentali e quelli orientali, sia con la comparsa di traduzioni di raccolte orientali; il periodo cruciale di tale trasmissione sarebbe stato quello delle crociate, che ha portato gli occidentali in Terra Santa. Tuttavia è stata provata l esistenza di racconti simili a quelli indiani nell età greco-latina, la cui civiltà è di gran lunga più antica 22 ; già in un antichissimo racconto egiziano, si ritrova il tema della scarpetta di Cenerentola, mentre quello del sonno della Bella addormentata si trova, 18 Cfr. cap. 2, 2. 7, p J. Bédier, op. cit., p V. Propp, Morfologia della fiaba, p J. Bédier, op. cit., p Ibid., p
7 prima ancora che nel lai Eliduc di Marie de France, in una miriade di racconti greci, tra cui alcuni di Eschilo; ed anche il tema dell animale che soccorre l uomo in difficoltà, come in Le Chat botté, si riscontra in un racconto greco 23. Il fatto è che le componenti fondamentali dei racconti sono in numero molto limitato, ed è dalla loro diversa combinazione che nascono i racconti; ciò conferisce loro le caratteristiche di ambiguità, eterogeneità, uniformità e ripetibilità analizzate da Propp 24. Le analogie con diverse fiabe raccolte da Italo Calvino nell opera Fiabe italiane confermano tutto ciò; ecco, per esempio, che in una fiaba del Monferrato intitolata La biscia 25 si intrecciano i motivi dei racconti Les Fées e Cendrillon: qui, infatti, protagonista è una ragazza che, in seguito ad un incantesimo, piange chicchi d oro, è vittima dell invidia delle sorelle e supera una prova che le permette di sposare il principe. Il palazzo dell Omo morto, invece, rievoca il tema della principessa addormentata 26, anche se in questo caso si tratta di un re; e il racconto La Belle au bois dormant è ancora evocato da Il figlio del Re di Danimarca 27, dove la figlia tanto attesa da una regina è al centro delle predizioni di dodici astrologhi, di cui l ultimo, avendo avuto un telescopio d argento e non di oro come gli altri, si vendica con un incantesimo. 23 Cfr. ibid., pp , 110, V. Propp, Morfologia della fiaba, pp I. Calvino, op. cit., p Ibid., p Ibid., p
8 Infine, lo stesso titolo del racconto Pelle di vecchia 28 annuncia l analogia con Peau d Ane. Tuttavia Francia e Italia sono Paesi confinanti senza grosse differenze culturali, pertanto è comprensibile la trasmissione dei racconti; risulta piuttosto interessante che gli stessi temi si ritrovano in culture radicalmente diverse da quella europea, per effetto della diffusione dei racconti e a conferma delle suddette caratteristiche enunciate da Propp. 28 Ibid., p
9 III Applicazione dell analisi morfologica di Propp ai Contes di Perrault Propp definisce così la favola: Da un punto di vista morfologico possiamo definire favola qualsiasi sviluppo da un danneggiamento [...] o da una mancanza [...] attraverso funzioni intermedie fino al matrimonio [...] o ad altre funzioni impiegate a mo di scioglimento 29. La sua analisi di tipo morfologico ha come scopo la definizione della struttura generale comune a tutti i racconti; infatti, pur considerando solo racconti russi, le funzioni individuate si riscontrano anche nei racconti di Perrault, dove sussiste una situazione iniziale, nella quale si presenta l eroe riportandone il nome o la condizione (come in Le Petit Chaperon rouge e La Barbe bleue), oppure si enumerano i membri della sua famiglia (come in La Belle au bois dormant, Le Chat botté, Les Fées, Cendrillon, Riquet à la houppe, Le Petit Poucet) 30. A questo punto subentrano le varie funzioni; qui si rilevano solo quelle che interessano i racconti di Perrault: 29 V. Propp, Morfologia della fiaba, p Ibid., p
10 I. Uno dei membri della famiglia si allontana da casa 31 : anche se Propp la pone come prima funzione, nel racconto La Belle au bois dormant essa figura dopo un altra serie di funzioni che si vedranno in seguito; si tratta dell allontanamento dei genitori della principessa, che favorirà l inizio dell incantesimo. Lo stesso avviene nel racconto La Barbe bleue, dove è lo stesso protagonista ad allontanarsi, e in Le Petit Poucet; anche nel racconto Le Petit Chaperon rouge è l eroina ad allontanarsi, e questa figura come prima funzione. II. All eroe è imposto un divieto 32 : in La Belle au bois dormant il divieto c è (non usare il telaio per evitare che si realizzi l incantesimo), ma non è rivolto all eroina; invece in Le Petit Chaperon rouge il divieto di non parlare col lupo non è espressamente imposto alla bambina, ma presentato come una regola morale: la pauvre enfant, qui ne savait pas qu il est dangereux de s arrêter à écouter un Loup L imposizione del divieto è invece netta in La Barbe bleue, anche se è lo stesso protagonista a farla; in questo caso si verifica una forma di contaminazione tra due rubriche 34 : Barbablù è il protagonista del racconto, ma è anche l antagonista di sua moglie, cui egli impone il divieto. 31 Ibid., p Ibid. 33 Ch. Perrault, Contes, ed. a cura di J. P. Collinet, p V. Propp, Morfologia della fiaba, p
11 Il gatto del racconto Le Chat botté impone il suo divieto agli agricoltori sotto forma di minaccia: Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au Roi que le pré que vous fauchez appartient à Monsieur le Marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté 35. Un divieto è imposto anche a Cenerentola, che non può rientrare dopo mezzanotte. III. Il divieto è infranto 36 : non è una conseguenza che si realizza in tutti i racconti citati; si verifica infrazione in La Belle au bois dormant, dove l uso del telaio fa scattare l incantesimo sulla principessa, in Le Petit Chaperon rouge, nel momento in cui la bambina si ferma a parlare col lupo, e in La Barbe bleue con l apertura della porta proibita, infrazione che era auspicata dal protagonista per ingannare la moglie. Invece nei racconti Le Chat botté e Cendrillon il divieto è rispettato. Anche nel racconto Le Petit Poucet si riscontra una forma, anche se anomala, di infrazione di un divieto che in effetti non c è mai stato: ritrovando la strada di casa, infatti, il piccolo contravviene alla volontà dei genitori. 35 Ch. Perrault, op. cit., ed. a cura di J. P. Collinet, p V. Propp, Morfologia della fiaba, p
12 In seguito a queste infrazioni, nel racconto compare l antagonista, che ha il ruolo di turbare la pace della famiglia felice, provocare qualche sciagura 37 : IV. L antagonista tenta una ricognizione 38, cioè il suo obiettivo è individuare la sua vittima; in La Belle au bois dormant ciò non avviene, in quanto la fata antagonista ha già agito all inizio del racconto enunciando l incantesimo. Nel racconto Le Petit Chaperon rouge il lupo è l antagonista, che approfitta subito della situazione; c è poi il caso di La Barbe bleue, dove il protagonista è anche antagonista. V. L antagonista riceve informazioni sulla sua vittima 39 ; è una funzione che si trova nei racconti Le Petit Chaperon rouge e La Barbe bleue: nel primo il lupo riesce a sapere dove si dirige la bambina, mentre nel secondo, grazie alla chiave fatata, Barbablù apprende il tradimento di sua moglie. VI. L antagonista tenta di ingannare la vittima per impadronirsi di lei 40 : è una funzione esclusiva del racconto Le Petit Chaperon rouge, dove il lupo cambia aspetto (si traveste da nonna), secondo i canoni previsti da Propp; dopodiché subentra la persuasione ed il ricorso alla violenza. La Barbe bleue rispetta uno di tali canoni, e precisamente il ricorso, da parte dell antagonista, a mezzi magici (si tratta della chiave, che permetterà a Barbablù di incastrare la moglie). 37 Ibid., p Ibid. 39 Ibid., p Ibid. 14
13 VII. La vittima cade nell inganno e con ciò favorisce involontariamente il nemico 41 : la Bella addormentata si punge al telaio, permettendo l inizio dell incantesimo (casi 2-3 illustrati da Propp: reazione meccanica al mezzo magico) 42 ; Cappuccetto rosso indica precisamente al lupo la casa della nonna, e la moglie di Barbablù fa cadere la chiave macchiandola irrimediabilmente di sangue (ancora casi 2-3, dato che la chiave était Fée 43 ). VIII. L antagonista arreca danno o menomazione a uno dei membri della famiglia 44 : da questo punto comincia la vera azione narrativa; questa funzione apre una nuova sequenza nel racconto La Belle au bois dormant: la suocera/orchessa della principessa approfitta della partenza del figlio (funzione I: allontanamento) per mangiare nuora e nipoti. Il compito è affidato al maggiordomo, che però nasconde i piccoli; tuttavia la principessa subisce una menomazione, dovuta alla scomparsa dei suoi bambini. In Le Petit Chaperon rouge il lupo uccide la nonna e poi la bambina, mentre in La Barbe bleue il protagonista minaccia di morte la moglie. Tutte le funzioni successive non sono caratteristiche dei racconti di Perrault, in quanto riguardano l arrivo di eroi e mezzi magici tipici dei racconti cavallereschi; si può dunque passare direttamente alla funzione XIV (L antagonista è vinto) 45, che coinvolge due dei tre racconti superstiti in 41 Ibid., p Ibid. 43 Ch. Perrault, op. cit., ed. a cura di J. P. Collinet, p V. Propp, Morfologia della fiaba, p Ibid., p
14 questo excursus: si tratta di La Barbe bleue e della nuova sequenza di La Belle au bois dormant; nel primo è l arrivo dei fratelli della vittima a salvare la stessa e a determinare la morte del protagonista/antagonista del racconto; nel secondo è l arrivo del principe che strappa alla morte moglie e figli e fa uccidere la madre vendicativa. XIX. È rimossa la sciagura o mancanza iniziale 46 : la vedova di Barbablù ritrova la pace con la morte del marito e la principessa dormiente può vivere finalmente felice con la sua famiglia. Seguono altre funzioni che però sono irrilevanti. Generalmente nel racconto la situazione iniziale è florida, per dare un risalto maggiore alla sventura che è al centro della narrazione; nei racconti di Perrault si realizza anche il contrario, ed il povero mugnaio cui in eredità è spettato solo un gatto, alla fine del racconto diventa un principe; stessa sorte tocca alla protagonista del racconto Les Fées e a Cenerentola, dopo un passato di schiavitù. Pollicino invece non ottiene un titolo nobiliare, ma salva la famiglia dal disagio economico presentato all inizio del racconto. Come si è potuto vedere, i racconti non contengono necessariamente tutte le funzioni illustrate, e la mancanza di alcune non influisce sulla loro struttura Ibid., p Ibid., p
15 L analisi di Propp prosegue fornendo tabelle dettagliate delle funzioni, nelle quali trovano spazio tutte le possibili varianti delle stesse 48, e ciò rende possibile un analisi più approfondita dei racconti di Perrault; per esempio, tra le situazioni iniziali, viene introdotto il caso della sterilità, e dunque dell impossibilità di avere figli 49, presente in La Belle au bois dormant, con conseguenti preghiere e gravidanza. Compaiono, inoltre, le profezie, che interesseranno ancora la protagonista del suddetto racconto e il protagonista di Riquet à la houppe. Comincia poi la parte preparatoria 50, dove le funzioni che vanno dal divieto alla sciagura sono descritte nei dettagli; così, nel divieto sono indicati gli esecutori dello stesso, il suo contenuto e la motivazione che lo accompagna 51. In tal modo, considerando il racconto La Barbe bleue, diremo che l esecutore del divieto è il protagonista del racconto, che tale divieto, rivolto alla moglie, consiste nel non aprire la porta di uno stanzino, ma nessuna motivazione è fornita. L allontanamento viene introdotto a questo punto (contrariamente allo schema iniziale), e interessa l esecutore del divieto, con l indicazione della sua forma e la motivazione 52 ; sempre nello stesso racconto, Barbablù parte per affari, funzione che provoca quella successiva, cioè l infrazione del divieto, sempre con l indicazione dell esecutore, della sua forma e del motivo 53 : la moglie di 48 Cfr. ibid., pp Ibid., p Ibid., pp Ibid., p Ibid. 53 Ibid. 17
Benvenuti nel magico Mondo delle Fiabe
 Benvenuti nel magico Mondo delle Fiabe Che cosa e una fiaba? La fiaba è un genere letterario simile a quello della favola; anch essa ha origini molto antiche, si basa su elementi fantastici ed un linguaggio
Benvenuti nel magico Mondo delle Fiabe Che cosa e una fiaba? La fiaba è un genere letterario simile a quello della favola; anch essa ha origini molto antiche, si basa su elementi fantastici ed un linguaggio
Benvenuti nel. Mondo delle Fiabe! Cliccate Esplorate E buon divertimento!
 Benvenuti nel Mondo delle Fiabe! Cliccate Esplorate E buon divertimento! Dovete sapere che esistono tanti tipi di testo che raccontano fantastiche avventure di personaggi straordinari, o storie quasi reali
Benvenuti nel Mondo delle Fiabe! Cliccate Esplorate E buon divertimento! Dovete sapere che esistono tanti tipi di testo che raccontano fantastiche avventure di personaggi straordinari, o storie quasi reali
La fiaba Parzialmente tratto dal sito «lefavole.org»
 La fiaba Parzialmente tratto dal sito «lefavole.org» 1 Gli elementi, i personaggi della fiaba La caratteristica fondamentale di ogni fiaba è la presenza di elementi magici e fantastici; fatti irreali o
La fiaba Parzialmente tratto dal sito «lefavole.org» 1 Gli elementi, i personaggi della fiaba La caratteristica fondamentale di ogni fiaba è la presenza di elementi magici e fantastici; fatti irreali o
I RUOLI DEI PERSONAGGI E LE FUNZIONI DI PROPP
 I RUOLI DEI PERSONAGGI E LE FUNZIONI DI PROPP VLADIMIR PROPP Studioso russo Ha scoperto che nelle fiabe PERSONAGGI SITUAZIONI AZIONI Si RIPETONO quasi sempre Ha trovato quindi Per i personaggi Per le situazioni
I RUOLI DEI PERSONAGGI E LE FUNZIONI DI PROPP VLADIMIR PROPP Studioso russo Ha scoperto che nelle fiabe PERSONAGGI SITUAZIONI AZIONI Si RIPETONO quasi sempre Ha trovato quindi Per i personaggi Per le situazioni
La bella addormentata nel bosco Rosaspina
 La bella addormentata nel bosco Rosaspina A.S. 2013\2014 1^C Dell Avvocato Martina, Di Terlizzi Francesca, He Federico, Hu Giulia 1 Indice Riassunto fiaba di Charles Perrault e dei Fratelli Grimm Somiglianze
La bella addormentata nel bosco Rosaspina A.S. 2013\2014 1^C Dell Avvocato Martina, Di Terlizzi Francesca, He Federico, Hu Giulia 1 Indice Riassunto fiaba di Charles Perrault e dei Fratelli Grimm Somiglianze
Lezione 6 La semiotica narrativa di Greimas (1): lo schema narrativo canonico
 Corso di laurea in Pubblicità, marketing e comunicazione aziendale Corso di Semiotica per la Comunicazione prof. Piero Polidoro Lezione 6 La semiotica narrativa di Greimas (1): lo schema narrativo canonico
Corso di laurea in Pubblicità, marketing e comunicazione aziendale Corso di Semiotica per la Comunicazione prof. Piero Polidoro Lezione 6 La semiotica narrativa di Greimas (1): lo schema narrativo canonico
PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE ANNUALE
 INSEGNANTE: Maggi Francesca ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 CLASSE: III Scientifico MATERIA: Italiano Scienze Applicate PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE ANNUALE UDA 1: Ripasso: la letteratura delle origini Ripasso
INSEGNANTE: Maggi Francesca ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 CLASSE: III Scientifico MATERIA: Italiano Scienze Applicate PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE ANNUALE UDA 1: Ripasso: la letteratura delle origini Ripasso
Protocollo dei saperi imprescindibili. Ordine di scuola: liceo artistico a.s
 Ordine di scuola: liceo artistico a.s. 2016-2017 CLASSE PRIMA L alunno deve essere in grado di analizzare qualsiasi testo di tipo letterario: racconto, brano, novella abbastanza semplice. Saper fare riassunti
Ordine di scuola: liceo artistico a.s. 2016-2017 CLASSE PRIMA L alunno deve essere in grado di analizzare qualsiasi testo di tipo letterario: racconto, brano, novella abbastanza semplice. Saper fare riassunti
Paolo Jedlowski. (2002) Il mondo in questione. Introduzione alla storia del pensiero sociologico. Carocci. capitolo 4.
 Paolo Jedlowski (2002) Il mondo in questione. Introduzione alla storia del pensiero sociologico Carocci capitolo 4 su Emile Durkheim Emile Durkheim (1858-1917) Quali domande si faceva Durkheim ci sono
Paolo Jedlowski (2002) Il mondo in questione. Introduzione alla storia del pensiero sociologico Carocci capitolo 4 su Emile Durkheim Emile Durkheim (1858-1917) Quali domande si faceva Durkheim ci sono
PIANO DI LAVORO DI LINGUA ITALIANA - SCUOLA MEDIA -
 PIANO DI LAVORO DI LINGUA ITALIANA - SCUOLA MEDIA - AREE DA SVILUPPARE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI, ATTIVITÁ COMPETENZE IN USCITA Riflettere sulla lingua Prima e seconda Media Classe
PIANO DI LAVORO DI LINGUA ITALIANA - SCUOLA MEDIA - AREE DA SVILUPPARE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI, ATTIVITÁ COMPETENZE IN USCITA Riflettere sulla lingua Prima e seconda Media Classe
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
 MATERIA: I T A L I A N O PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2016-2017 CLASSE: QUARTA AAT LIBRO DI TESTO: AUTORE: A.RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A.DENDI, E.SADA. O.TRIBULATO TITOLO: IL ROSSO E IL BLU 2. DAL SEICENTO
MATERIA: I T A L I A N O PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2016-2017 CLASSE: QUARTA AAT LIBRO DI TESTO: AUTORE: A.RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A.DENDI, E.SADA. O.TRIBULATO TITOLO: IL ROSSO E IL BLU 2. DAL SEICENTO
La bella addormentata nel bosco Rosaspina. A.S. 2013\2014 1^C Dell Avvocato Martina, Di Terlizzi Francesca, He Federico, Hu Giulia
 La bella addormentata nel bosco Rosaspina A.S. 2013\2014 1^C Dell Avvocato Martina, Di Terlizzi Francesca, He Federico, Hu Giulia 1 Indice Riassunto fiaba di Charles Perrault e dei Fratelli Grimm Somiglianze
La bella addormentata nel bosco Rosaspina A.S. 2013\2014 1^C Dell Avvocato Martina, Di Terlizzi Francesca, He Federico, Hu Giulia 1 Indice Riassunto fiaba di Charles Perrault e dei Fratelli Grimm Somiglianze
LA FIABA E UN RACCONTO FANTASTICO RICCO DI ELEMENTI MAGICI, MERAVIGLIOSI : VI SI INCONTRANO FATE, STREGHE, DIAVOLI, ORCHI, MAGHI, NANI, ESSERI BUONI
 LA FIABA E UN RACCONTO FANTASTICO RICCO DI ELEMENTI MAGICI, MERAVIGLIOSI : VI SI INCONTRANO FATE, STREGHE, DIAVOLI, ORCHI, MAGHI, NANI, ESSERI BUONI O CATTIVI, DTATI DI POTERI STRAORDINARI, SOPRANNATURALI.
LA FIABA E UN RACCONTO FANTASTICO RICCO DI ELEMENTI MAGICI, MERAVIGLIOSI : VI SI INCONTRANO FATE, STREGHE, DIAVOLI, ORCHI, MAGHI, NANI, ESSERI BUONI O CATTIVI, DTATI DI POTERI STRAORDINARI, SOPRANNATURALI.
Le fiabe: un patrimonio fantastico inesauribile. Cecilia brugnoli
 Le fiabe: un patrimonio fantastico inesauribile Cecilia brugnoli Laboratorio n. 1/a: Quali sono le nostre fiabe preferite e perché? Laboratorio n. 1/b: CHE COSA SONO LE FIABE? Dopo aver letto un numero
Le fiabe: un patrimonio fantastico inesauribile Cecilia brugnoli Laboratorio n. 1/a: Quali sono le nostre fiabe preferite e perché? Laboratorio n. 1/b: CHE COSA SONO LE FIABE? Dopo aver letto un numero
Prova orale: Prova orale: Prova scritta:
 A037 - FILOSOFIA E STORIA La prova scritta invece, consisterà nell'analisi e contestualizzazione di tre testi filosofici e di due documenti storici. A061 STORIA DELL ARTE La prova verterà sui contenuti
A037 - FILOSOFIA E STORIA La prova scritta invece, consisterà nell'analisi e contestualizzazione di tre testi filosofici e di due documenti storici. A061 STORIA DELL ARTE La prova verterà sui contenuti
PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME ITALIANO STORIA GEOGRAFIA
 PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME ITALIANO STORIA GEOGRAFIA Anno Scolastico 2013-2014 ITALIANO Obiettivi minimi ASCOLTARE E PARLARE Prestare attenzione ad un messaggio per un breve periodo di tempo Cogliere
PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME ITALIANO STORIA GEOGRAFIA Anno Scolastico 2013-2014 ITALIANO Obiettivi minimi ASCOLTARE E PARLARE Prestare attenzione ad un messaggio per un breve periodo di tempo Cogliere
Università degli Studi di Salerno
 Università degli Studi di Salerno FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE TESI DI LAUREA IN LETTERATURA NORD-AMERICANA LA FAVOLA E IL MITO DELL EROE. Analisi
Università degli Studi di Salerno FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE TESI DI LAUREA IN LETTERATURA NORD-AMERICANA LA FAVOLA E IL MITO DELL EROE. Analisi
LICEO SCIENTIFICO STATALE FEDERICO II DI SVEVIA - MELFI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA LATINO CLASSE III AC. Prof. LOREDANA LEONARDI. a.s.
 LICEO SCIENTIFICO STATALE FEDERICO II DI SVEVIA - MELFI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA LATINO CLASSE III AC Prof. LOREDANA LEONARDI a.s. 2016-17 SITUAZIONE DI PARTENZA La classe III AC è composta da 11 alunni.
LICEO SCIENTIFICO STATALE FEDERICO II DI SVEVIA - MELFI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA LATINO CLASSE III AC Prof. LOREDANA LEONARDI a.s. 2016-17 SITUAZIONE DI PARTENZA La classe III AC è composta da 11 alunni.
TESTO/I ADOTTATO/I: B.Panebianco A.Varani, METODI E FANTASIA, Narrativa e Poesia e Teatro, Zanichelli ed COMPETENZE
 Anno scolastico 2013/2014 PRIMO BIENNIO Corso Diurno Classe :2 As RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di: ITALIANO PROF./SSA CAIOLO RITA TESTO/I ADOTTATO/I: B.Panebianco A.Varani, METODI E FANTASIA, Narrativa
Anno scolastico 2013/2014 PRIMO BIENNIO Corso Diurno Classe :2 As RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di: ITALIANO PROF./SSA CAIOLO RITA TESTO/I ADOTTATO/I: B.Panebianco A.Varani, METODI E FANTASIA, Narrativa
Elementi che caratterizzano i racconti di AVVENTURA
 Elementi che caratterizzano i racconti di AVVENTURA LUOGHI lontani Nel tempo nello spazio PERSONAGGI reali o verosimili EROE Forte ANTAGONISTA aiutante Coraggioso aiutante Astuto Avventuroso Curioso Riesce
Elementi che caratterizzano i racconti di AVVENTURA LUOGHI lontani Nel tempo nello spazio PERSONAGGI reali o verosimili EROE Forte ANTAGONISTA aiutante Coraggioso aiutante Astuto Avventuroso Curioso Riesce
UDA n.1 STUDIARE LA GRAMMATICA C1_01: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l interazione
 CPIA PALERMO 2 PROGETTAZIONE PER UNITA DI APPRENDIMENTO PERCORSO DI ISTRUZIONE DI I LIVELLO - SECONDO PERIODO DIDATTICO a.s. 2016/2017 ASSE DEI LINGUAGGI (ITALIANO) UDA n.1 STUDIARE LA GRAMMATICA C1_01:
CPIA PALERMO 2 PROGETTAZIONE PER UNITA DI APPRENDIMENTO PERCORSO DI ISTRUZIONE DI I LIVELLO - SECONDO PERIODO DIDATTICO a.s. 2016/2017 ASSE DEI LINGUAGGI (ITALIANO) UDA n.1 STUDIARE LA GRAMMATICA C1_01:
L ANELLO DELLA STREGA
 L ANELLO DELLA STREGA PRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI PRINCIPESSA STREGA CAVALIERE FATA TESTO SEMPLICE AMBIENTAZIONE C era una volta una principessa che viveva in un grande castello. Era molto triste perché
L ANELLO DELLA STREGA PRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI PRINCIPESSA STREGA CAVALIERE FATA TESTO SEMPLICE AMBIENTAZIONE C era una volta una principessa che viveva in un grande castello. Era molto triste perché
Le caratteristiche della fiaba
 Le caratteristiche della fiaba Gli studi sulla fiaba La pubblicazione della raccolta dei fratelli Grimm segna l inizio di quell attività di indagine sull origine e la diffusione delle fiabe, a cui si dedicarono
Le caratteristiche della fiaba Gli studi sulla fiaba La pubblicazione della raccolta dei fratelli Grimm segna l inizio di quell attività di indagine sull origine e la diffusione delle fiabe, a cui si dedicarono
Maria Ricciolini SAMUEL BECKETT E LA MIGRAZIONE DELLA PAROLA
 A10 672 Maria Ricciolini SAMUEL BECKETT E LA MIGRAZIONE DELLA PAROLA Copyright MMX ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A B 00173 Roma (06) 93781065
A10 672 Maria Ricciolini SAMUEL BECKETT E LA MIGRAZIONE DELLA PAROLA Copyright MMX ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A B 00173 Roma (06) 93781065
LIVELLO A2 LIVELLO B1
 PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE Test informatizzato (durata 45 min): LIVELLO A2 2 cloze test (esercizi gap-fill di grammatica e lessico) livello A2 al fine di individuare i termini o la tipologia
PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE Test informatizzato (durata 45 min): LIVELLO A2 2 cloze test (esercizi gap-fill di grammatica e lessico) livello A2 al fine di individuare i termini o la tipologia
Progetto In Vitro sussidi didattici La produzione editoriale 0-6. La Fiaba Maria Natascia Ciullo. progettazione e produzione a cura di
 Progetto In Vitro sussidi didattici La produzione editoriale 0-6. La Fiaba Maria Natascia Ciullo progettazione e produzione a cura di La fiaba Dott.ssa CIULLO Maria Natascia Marianatascia.ciullo@gmail.com
Progetto In Vitro sussidi didattici La produzione editoriale 0-6. La Fiaba Maria Natascia Ciullo progettazione e produzione a cura di La fiaba Dott.ssa CIULLO Maria Natascia Marianatascia.ciullo@gmail.com
Istituto Comprensivo Campagnola-Galilei. Area Didattica
 Sezione Competenze Contenuti/attività Scuola dell Infanzia Sezione 3 anni 1. Essere in grado di esprimersi in modo comprensibile. 2. Essere in grado di ascoltare. Narrazioni orali Letture Comprensioni
Sezione Competenze Contenuti/attività Scuola dell Infanzia Sezione 3 anni 1. Essere in grado di esprimersi in modo comprensibile. 2. Essere in grado di ascoltare. Narrazioni orali Letture Comprensioni
Prova orale: Prova orale: Prova scritta:
 A037 - FILOSOFIA E STORIA La prova verterà sui contenuti dei vigenti programmi di storia e filosofia per la classe A037 A061 STORIA DELL ARTE La prova scritta invece, consisterà nell'analisi e contestualizzazione
A037 - FILOSOFIA E STORIA La prova verterà sui contenuti dei vigenti programmi di storia e filosofia per la classe A037 A061 STORIA DELL ARTE La prova scritta invece, consisterà nell'analisi e contestualizzazione
SOMMARIO RINGRAZIAMENTI...XIII
 SOMMARIO RINGRAZIAMENTI...XIII CAPITOLO I PROFILI TEORICI DELLA MOTIVAZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI: TRA LOGICA E LINGUAGGIO...1 1. La motivazione nel linguaggio comune e nella realtà giuridica, con specifico
SOMMARIO RINGRAZIAMENTI...XIII CAPITOLO I PROFILI TEORICI DELLA MOTIVAZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI: TRA LOGICA E LINGUAGGIO...1 1. La motivazione nel linguaggio comune e nella realtà giuridica, con specifico
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE 201-2017 MATERIA: CLASSE: I T A L I A N O QUARTA LIBRO DI TESTO: AUTORE: A.RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A.DENDI, E.SADA. O.TRIBULATO TITOLO: IL ROSSO E IL BLU 2. DAL SEICENTO ALL
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 201-2017 MATERIA: CLASSE: I T A L I A N O QUARTA LIBRO DI TESTO: AUTORE: A.RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A.DENDI, E.SADA. O.TRIBULATO TITOLO: IL ROSSO E IL BLU 2. DAL SEICENTO ALL
ITALIANO NOVEMBRE Traguardi per lo sviluppo delle competenze. Raccordi interdisciplinari
 ITALIANO NOVEMBRE Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività Raccordi interdisciplinari ASCOLTARE E PARLARE Comprende e rielabora testi ascoltati, intervenendo
ITALIANO NOVEMBRE Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività Raccordi interdisciplinari ASCOLTARE E PARLARE Comprende e rielabora testi ascoltati, intervenendo
EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO PROGRAMMA SVOLTO
 EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2016/2017 Materia insegnata : Italiano-Antologia Classe : 1 a sez.: B Docente: GIORGETTA ANTONELLA N 1 La favola, la fiaba, la narrativa
EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2016/2017 Materia insegnata : Italiano-Antologia Classe : 1 a sez.: B Docente: GIORGETTA ANTONELLA N 1 La favola, la fiaba, la narrativa
PIANO DI LAVORO. Gruppo Disciplinare LETTERE TRIENNIO. Anno Scolastico
 PIANO DI LAVORO Gruppo Disciplinare LETTERE TRIENNIO Anno Scolastico 2016-2017 Classe III Disciplina LATINO Il piano di lavoro tiene conto del drastico ridimensionamento delle ore di latino. La lettura
PIANO DI LAVORO Gruppo Disciplinare LETTERE TRIENNIO Anno Scolastico 2016-2017 Classe III Disciplina LATINO Il piano di lavoro tiene conto del drastico ridimensionamento delle ore di latino. La lettura
DIDATTICA DELL ITALIANO L2) PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL INFANZIA. Dott.ssa Fallea Floriana
 DIDATTICA DELL ITALIANO (L1-L2) L2) PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL INFANZIA IL TESTO NARRATIVO LETTERARIO Un testo narrativo è, un testo nel quale la storia narrata ha in se stessa la sua ragione d'essere,
DIDATTICA DELL ITALIANO (L1-L2) L2) PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL INFANZIA IL TESTO NARRATIVO LETTERARIO Un testo narrativo è, un testo nel quale la storia narrata ha in se stessa la sua ragione d'essere,
Carlo Magno, il Sacro romano impero e il feudalesimo
 la nostra proposta didattica del mese Unità di apprendimento semplificata con glossario, schemi ed esercizi che facilitano l apprendimento A cura di Emma Mapelli Carlo Magno, il Sacro romano impero e il
la nostra proposta didattica del mese Unità di apprendimento semplificata con glossario, schemi ed esercizi che facilitano l apprendimento A cura di Emma Mapelli Carlo Magno, il Sacro romano impero e il
La prova scritta consisterà nell'analisi e contestualizzazione di tre testi filosofici e di due documenti storici.
 A037 - FILOSOFIA E STORIA A061 STORIA DELL ARTE A445, A446 Lingua straniera (spagnolo) e lingua e civiltà straniera (spagnolo) La prova scritta consisterà nell'analisi e contestualizzazione di tre testi
A037 - FILOSOFIA E STORIA A061 STORIA DELL ARTE A445, A446 Lingua straniera (spagnolo) e lingua e civiltà straniera (spagnolo) La prova scritta consisterà nell'analisi e contestualizzazione di tre testi
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA. PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 2015
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 201 Materia d insegnamento: ITALIANO Classe 3^ sezione G Prof.ssa Linda Billi LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 201 Materia d insegnamento: ITALIANO Classe 3^ sezione G Prof.ssa Linda Billi LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
Claude Lévi-Strauss Formazione filosofica Scuola etnologica francese durkheimiana Scuola di Boas Linguistica strutturale (Jakobson)
 Claude Lévi-Strauss 1908-2009 Formazione filosofica Scuola etnologica francese durkheimiana Scuola di Boas Linguistica strutturale (Jakobson) Bricolage teorico Ricerca scientifica e ricerca esistenziale
Claude Lévi-Strauss 1908-2009 Formazione filosofica Scuola etnologica francese durkheimiana Scuola di Boas Linguistica strutturale (Jakobson) Bricolage teorico Ricerca scientifica e ricerca esistenziale
Guido Gustavo Gozzano [Nel centenario della morte] 16 dicembre 2016 Maurizia Cotti
![Guido Gustavo Gozzano [Nel centenario della morte] 16 dicembre 2016 Maurizia Cotti Guido Gustavo Gozzano [Nel centenario della morte] 16 dicembre 2016 Maurizia Cotti](/thumbs/75/72105724.jpg) Guido Gustavo Gozzano [Nel centenario della morte] 16 dicembre 2016 Maurizia Cotti Crepuscolarismo Poeta simbolista francese Francis Jammes Tournay 2 dicembre 1968 Hasparren 1 novembre 1938 Metafora del
Guido Gustavo Gozzano [Nel centenario della morte] 16 dicembre 2016 Maurizia Cotti Crepuscolarismo Poeta simbolista francese Francis Jammes Tournay 2 dicembre 1968 Hasparren 1 novembre 1938 Metafora del
A.S. 2016/2017 PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI PER IL RECUPERO ESTIVO. Della prof.ssa LUCIA URBINATI. docente di ITALIANO.
 A.S. 2016/2017 PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI PER IL RECUPERO ESTIVO Della prof.ssa LUCIA URBINATI docente di ITALIANO Classe II L Moduli I Educazione linguistica La frase: La frase semplice e complessa
A.S. 2016/2017 PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI PER IL RECUPERO ESTIVO Della prof.ssa LUCIA URBINATI docente di ITALIANO Classe II L Moduli I Educazione linguistica La frase: La frase semplice e complessa
Esami di Idoneità/Integrativi. Liceo delle Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico
 Esami di Idoneità/Integrativi Liceo delle Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico Materia: Italiano Alla Classe seconda Contenuti essenziali La riflessione sulla lingua: la fonologia le regole
Esami di Idoneità/Integrativi Liceo delle Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico Materia: Italiano Alla Classe seconda Contenuti essenziali La riflessione sulla lingua: la fonologia le regole
secondaria di I grado. poesie, filastrocche, scioglilingua, fiabe, storie della tradizione e storie inventate da mio
 Sono Sonia Selvaggi, ho 40 anni e vivo a S. Marco Argentano (CS) con mio marito e i 2 nostri due figli: Lucrezia e Riccardo. Sono una docente di Lettere e insegno nella scuola secondaria di I grado. Ho
Sono Sonia Selvaggi, ho 40 anni e vivo a S. Marco Argentano (CS) con mio marito e i 2 nostri due figli: Lucrezia e Riccardo. Sono una docente di Lettere e insegno nella scuola secondaria di I grado. Ho
Lo spazio linguistico italiano. Elena Nuzzo Trento, 20/12/2010
 Lo spazio linguistico italiano Elena Nuzzo Trento, 20/12/2010 La mobilità nello spazio linguistico Una conoscenza della lingua materna sicura e ricca, che non si limiti ai bisogni comunicativi primari,
Lo spazio linguistico italiano Elena Nuzzo Trento, 20/12/2010 La mobilità nello spazio linguistico Una conoscenza della lingua materna sicura e ricca, che non si limiti ai bisogni comunicativi primari,
DIAGRAMMA RELATIVO ALLA CATALOGAZIONE SEMANTICA DEI MATERIALI DIDATTICI ELABORATI DAGLI ISTRUTTORI S.P.I.Di.S. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
 DIAGRAMMA RELATIVO ALLA CATALOGAZIONE SEMANTICA DEI MATERIALI DIDATTICI ELABORATI DAGLI ISTRUTTORI S.P.I.Di.S. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO MATERIALE ELABORATO DAGLI ISTRUTTORI AREA LINGUISTICA LINGUA STRANIERA
DIAGRAMMA RELATIVO ALLA CATALOGAZIONE SEMANTICA DEI MATERIALI DIDATTICI ELABORATI DAGLI ISTRUTTORI S.P.I.Di.S. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO MATERIALE ELABORATO DAGLI ISTRUTTORI AREA LINGUISTICA LINGUA STRANIERA
Programmazione annuale a. s
 Programmazione annuale a. s. 2016-2017 MATERIA: CLASSE: ITALIANO SECONDA LIBRO/I DI TESTO: AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI L ITALIANO DA SAPERE IN TEORIA E IN PRATICA
Programmazione annuale a. s. 2016-2017 MATERIA: CLASSE: ITALIANO SECONDA LIBRO/I DI TESTO: AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI L ITALIANO DA SAPERE IN TEORIA E IN PRATICA
Freud e Svevo Filosofia e letteratura
 Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Freud e Svevo Filosofia e letteratura Comprensione del testo 1. Qual è la formazione di Sigmund Freud? 2. Quali sono i romanzi
Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Freud e Svevo Filosofia e letteratura Comprensione del testo 1. Qual è la formazione di Sigmund Freud? 2. Quali sono i romanzi
Programma di italiano
 ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. S.BANDINI SIENA Programma di italiano Antologia: TITOLO = SCRITTORI e SCRITTURE Poesia e Teatro AUTORE = A. De Simone C. Gusmini EDIZIONE = Le Monnier La poesia: Gli strumenti
ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. S.BANDINI SIENA Programma di italiano Antologia: TITOLO = SCRITTORI e SCRITTURE Poesia e Teatro AUTORE = A. De Simone C. Gusmini EDIZIONE = Le Monnier La poesia: Gli strumenti
ITALIANO CLASSE II ANNO SCOLASTICO TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE U.A. I LA LETTERATURA
 U.A. I LA LETTERATURA Tempi: anno scolastico l attenzione. Lettura e commento di testi, esercizi di analisi e individuale di testi. Strumenti strumenti multimediali Link interdisciplinari storia, storia
U.A. I LA LETTERATURA Tempi: anno scolastico l attenzione. Lettura e commento di testi, esercizi di analisi e individuale di testi. Strumenti strumenti multimediali Link interdisciplinari storia, storia
Pierino e il lupo A volte il lupo perde il vizio
 Ragno magico 11 Germana Bruno Pierino e il lupo A volte il lupo perde il vizio e non il pelo Copyright MMXIV ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it www.narrativaracne.it info@aracneeditrice.it via
Ragno magico 11 Germana Bruno Pierino e il lupo A volte il lupo perde il vizio e non il pelo Copyright MMXIV ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it www.narrativaracne.it info@aracneeditrice.it via
LA VITA QUOTIDIANA AI TEMPI DEI CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA
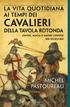 MICHEL PASTOUREAU LA VITA QUOTIDIANA AI TEMPI DEI CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA VITE QUOTIDIANE Proprietà letteraria riservata 1991 Hachette Littératures 1991 RCS Rizzoli Libri S.p.A., Milano 1998 RCS
MICHEL PASTOUREAU LA VITA QUOTIDIANA AI TEMPI DEI CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA VITE QUOTIDIANE Proprietà letteraria riservata 1991 Hachette Littératures 1991 RCS Rizzoli Libri S.p.A., Milano 1998 RCS
LABORATORIO POPOTUS. Scuole partecipanti: >Scuola Elementare Fontanelle 2 Circolo Riccione. >Scuola Elementare Alba Adriatica (Cd 3 RN)
 LABORATORIO POPOTUS Scuole partecipanti: >Scuola Elementare Fontanelle 2 Circolo Riccione >Scuola Elementare Alba Adriatica (Cd 3 RN) >Scuola Elementare Galliano (Cd 2 Riccione ) >Scuola Elementare Repubblica
LABORATORIO POPOTUS Scuole partecipanti: >Scuola Elementare Fontanelle 2 Circolo Riccione >Scuola Elementare Alba Adriatica (Cd 3 RN) >Scuola Elementare Galliano (Cd 2 Riccione ) >Scuola Elementare Repubblica
23 marzo 2017 Lezione 8 strutture semio-narrative superficiali 1 il modello attanziale
 Semiotica per la comunicazione d impresa Lumsa a.a. 2016/2017 Piero Polidoro 23 marzo 2017 Lezione 8 strutture semio-narrative superficiali 1 il modello attanziale MODELLO ATTANZIALE / ENUNCIATI E PN Premessa
Semiotica per la comunicazione d impresa Lumsa a.a. 2016/2017 Piero Polidoro 23 marzo 2017 Lezione 8 strutture semio-narrative superficiali 1 il modello attanziale MODELLO ATTANZIALE / ENUNCIATI E PN Premessa
Italo Calvino
 Italo Calvino 1923-1985 pensiero e poetica sperimentalismo e coerenza temi e forme narrative differenti coe siste l intento realistico e il gusto per il fantastico, cr i t ic a sociale e i n te re s se
Italo Calvino 1923-1985 pensiero e poetica sperimentalismo e coerenza temi e forme narrative differenti coe siste l intento realistico e il gusto per il fantastico, cr i t ic a sociale e i n te re s se
III Circolo di Rho. Programmazione annuale. Lingua Italiana. Classe III
 III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe III ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende le informazioni principali di un messaggio Interviene nel dialogo e nella conversazione in modo
III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe III ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende le informazioni principali di un messaggio Interviene nel dialogo e nella conversazione in modo
Università degli Studi di Bari. Dipartimento di Lingue, Lettere, Arti. Italianistica e Letterature comparate. Corso di Laurea di I livello
 1 Università degli Studi di Bari Dipartimento di Lingue, Lettere, Arti. Italianistica e Letterature comparate Corso di Laurea di I livello A) Culture delle Lingue moderne e del Turismo (L11) Curriculum:
1 Università degli Studi di Bari Dipartimento di Lingue, Lettere, Arti. Italianistica e Letterature comparate Corso di Laurea di I livello A) Culture delle Lingue moderne e del Turismo (L11) Curriculum:
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE
 ITALIANO Classe Prima SECONDARIA COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE Ascolta e si esprime oralmente Comprendere un testo ascoltato Esprimersi oralmente in modo corretto e chiaro Acquisire ed espandere
ITALIANO Classe Prima SECONDARIA COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE Ascolta e si esprime oralmente Comprendere un testo ascoltato Esprimersi oralmente in modo corretto e chiaro Acquisire ed espandere
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO a. s. 2015/ 2016
 PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO a. s. 2015/ 2016 DOCENTE TARSITANO ADELE CLASSE 1MA DISCIPLINA ITALIANO TESTO IN USO: Sciogliere i nodi 2.0 C. Savigliano Garzanti Scuola 1) RIFLESSIONE SULLA LINGUA I fonemi,
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO a. s. 2015/ 2016 DOCENTE TARSITANO ADELE CLASSE 1MA DISCIPLINA ITALIANO TESTO IN USO: Sciogliere i nodi 2.0 C. Savigliano Garzanti Scuola 1) RIFLESSIONE SULLA LINGUA I fonemi,
Istituto San Luigi di Chieri PIANO DI LAVORO ANNUALE a.s. 2013/2014. MATERIA: Italiano CLASSE: II SEZIONE: A e B SUDDIVISIONE DEI MODULI SETTIMANALI:
 Istituto San Luigi di Chieri PIANO DI LAVORO ANNUALE a.s. 2013/2014 MATERIA: Italiano CLASSE: II SEZIONE: A e B SUDDIVISIONE DEI MODULI SETTIMANALI: nr. 3 moduli di grammatica nr. 2 moduli di antologia
Istituto San Luigi di Chieri PIANO DI LAVORO ANNUALE a.s. 2013/2014 MATERIA: Italiano CLASSE: II SEZIONE: A e B SUDDIVISIONE DEI MODULI SETTIMANALI: nr. 3 moduli di grammatica nr. 2 moduli di antologia
APRENDO APPRENDO LAPBOOK FIABA, FAVOLA, MITO E LEGGENDA
 BLOG: laboratoriointerattivomanuale.com CANALE: http://www.youtube.com/user/labintmanuale/featured?view_as=public GRUPPO SUI LAPBOOK: https://www.facebook.com/groups/344721115699457/ APRENDO APPRENDO LAPBOOK
BLOG: laboratoriointerattivomanuale.com CANALE: http://www.youtube.com/user/labintmanuale/featured?view_as=public GRUPPO SUI LAPBOOK: https://www.facebook.com/groups/344721115699457/ APRENDO APPRENDO LAPBOOK
DALLA MIA STORIA ALLA STORIA
 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO A. M. RICCI Via XXIII Settembre,16-02100 RIETI 0746/203129-251330 fax 0746/489300
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO A. M. RICCI Via XXIII Settembre,16-02100 RIETI 0746/203129-251330 fax 0746/489300
CENERENTOLA OSSIA LA BONTÀ IN TRIONFO A CURA DI DILETTA D EREDITÀ
 CENERENTOLA OSSIA LA BONTÀ IN TRIONFO A CURA DI DILETTA D EREDITÀ INDICE Presentazione dell opera Cenerentola ossia La bontà in trionfo Fonti Successo Trama Struttura dei personaggi secondo Propp Cambiamenti
CENERENTOLA OSSIA LA BONTÀ IN TRIONFO A CURA DI DILETTA D EREDITÀ INDICE Presentazione dell opera Cenerentola ossia La bontà in trionfo Fonti Successo Trama Struttura dei personaggi secondo Propp Cambiamenti
Introduzione alla storia lezione n. 2. Prof. Marco Bartoli
 Introduzione alla storia lezione n. 2 Prof. Marco Bartoli una domanda che il passato pone al presente L incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall ignoranza del passato. Ma non è forse meno
Introduzione alla storia lezione n. 2 Prof. Marco Bartoli una domanda che il passato pone al presente L incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall ignoranza del passato. Ma non è forse meno
DIPARTIMENTO LETTERE CLASSICO LINGUISTICO DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico)
 Educazione linguistica: Educazione letteraria: Produzione scritta: DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico) morfologia: il verbo. Sintassi: gli elementi fondamentali di analisi della proposizione.
Educazione linguistica: Educazione letteraria: Produzione scritta: DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico) morfologia: il verbo. Sintassi: gli elementi fondamentali di analisi della proposizione.
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO MATERIA: ITALIANO Prof.ssa Santomauro Teresa ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Classe I^ AS ELENCO DELLE UNITA DIDATTICHE/MODULI Num Titolo delle UNITA
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO MATERIA: ITALIANO Prof.ssa Santomauro Teresa ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Classe I^ AS ELENCO DELLE UNITA DIDATTICHE/MODULI Num Titolo delle UNITA
ITALIANO CLASSE I ANNO SCOLASTICO
 ITALIANO CLASSE I ANNO SCOLASTICO 2017-2018 U.A.I IL TESTO NARRATIVO Tempi: anno scolastico alternanza di momenti di lezione frontale e momenti di lezione partecipata per favorire e guidare gli interventi
ITALIANO CLASSE I ANNO SCOLASTICO 2017-2018 U.A.I IL TESTO NARRATIVO Tempi: anno scolastico alternanza di momenti di lezione frontale e momenti di lezione partecipata per favorire e guidare gli interventi
Galileo e Bellarmino Filosofia e scienza
 Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Galileo e Bellarmino Filosofia e scienza Comprensione del testo 1. Il sistema aristotelico-tolemaico e il sistema copernicano
Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Galileo e Bellarmino Filosofia e scienza Comprensione del testo 1. Il sistema aristotelico-tolemaico e il sistema copernicano
Il poema epico. I poemi epici
 Il poema epico I poemi epici I poemi epici e le storie popolari risalgono a tempi antichi e rivelano molto della psicologia e dell identità culturale dei popoli che le hanno tramandate L epica, ovvero
Il poema epico I poemi epici I poemi epici e le storie popolari risalgono a tempi antichi e rivelano molto della psicologia e dell identità culturale dei popoli che le hanno tramandate L epica, ovvero
PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE I F sc.og Anno Scolastico 2016/2017
 Docente: Gabriella Greco MODULO 1: Riflessione sulla lingua PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE I F sc.og Anno Scolastico 2016/2017 Conoscere ed applicare lo schema della comunicazione Conoscere ed applicare
Docente: Gabriella Greco MODULO 1: Riflessione sulla lingua PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE I F sc.og Anno Scolastico 2016/2017 Conoscere ed applicare lo schema della comunicazione Conoscere ed applicare
Educazione Linguistica (lingua come codice) ortografia e punteggiatura morfologia sintassi della frase semplice e complessa
 Liceo B. Russell VIA IV NOVEMBRE 35, 38023 CLES Tutti gli indirizzi Anno scolastico Disciplina: Lingua e letteratura italiana CLASSE 1 1. comunicare e interagire verbalmente in contesti di varia natura
Liceo B. Russell VIA IV NOVEMBRE 35, 38023 CLES Tutti gli indirizzi Anno scolastico Disciplina: Lingua e letteratura italiana CLASSE 1 1. comunicare e interagire verbalmente in contesti di varia natura
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Secondaria di Primo Grado - ITALIANO - COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA Classe Prima Profilo dello studente al termine
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Secondaria di Primo Grado - ITALIANO - COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA Classe Prima Profilo dello studente al termine
Le altre Antigoni nella letteratura greca
 Le altre Antigoni nella letteratura greca La prima attestazione del personaggio di Antigone si ha nel mitografo Ferecide di Atene (prima metà V sec. a. C.), citato negli scoli alle Fenicie di Euripide,
Le altre Antigoni nella letteratura greca La prima attestazione del personaggio di Antigone si ha nel mitografo Ferecide di Atene (prima metà V sec. a. C.), citato negli scoli alle Fenicie di Euripide,
Modulo I: Fiaba in musica e sonorizzazione Discipline: Musica e Italiano Competenze
 Curricolo indirizzo musicale classe prima Modulo I: Fiaba in musica e sonorizzazione Discipline: Musica e Italiano Conoscere la vita dell autore Conoscere attraverso la musica le caratteristiche descrittive
Curricolo indirizzo musicale classe prima Modulo I: Fiaba in musica e sonorizzazione Discipline: Musica e Italiano Conoscere la vita dell autore Conoscere attraverso la musica le caratteristiche descrittive
Giuseppe Parini e il neoclassicismo. XVIII secolo
 Giuseppe Parini e il neoclassicismo XVIII secolo classico Scrittore esemplare, superiore alla media, le cui opere servono da modello di riferimento relativo alla cultura greca e romana, intesa come modello
Giuseppe Parini e il neoclassicismo XVIII secolo classico Scrittore esemplare, superiore alla media, le cui opere servono da modello di riferimento relativo alla cultura greca e romana, intesa come modello
1. Discussioni su argomenti di diverso tipo. 2. Uso di registri diversi per comunicare.
 Traguardi di competenza ASCOLTO E PARLATO Partecipa a conversazioni e discussioni con messaggi chiari e pertinenti, usando un registro adeguato al contesto. Comprende e utilizza in maniera appropriata
Traguardi di competenza ASCOLTO E PARLATO Partecipa a conversazioni e discussioni con messaggi chiari e pertinenti, usando un registro adeguato al contesto. Comprende e utilizza in maniera appropriata
Il Neorealismo movimento culturale Italia fine Seconda Guerra Mondiale problemi bisogni rappresentazione realtà Verismo
 Il Neorealismo Questo movimento culturale si sviluppa in Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tra il 1945 e il 1955. Nasce dal bisogno di interpretare i problemi e i bisogni reali della società,
Il Neorealismo Questo movimento culturale si sviluppa in Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tra il 1945 e il 1955. Nasce dal bisogno di interpretare i problemi e i bisogni reali della società,
Grammatica : morfologia Le parti del discorso: nome, articolo, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, preposizioni, congiunzioni, interiezione.
 Programma Lingua e letteratura italiana classe prima Le tecniche narrative: fabula e intreccio, ruolo e funzione dei personaggi, spazio e tempo, sequenze, narratore e punto di vista, lingua e stile I generi
Programma Lingua e letteratura italiana classe prima Le tecniche narrative: fabula e intreccio, ruolo e funzione dei personaggi, spazio e tempo, sequenze, narratore e punto di vista, lingua e stile I generi
CANTO di NATALE. A Christmas Carol di Charles Dickens. Laboratorio di Lettura Svolto dalla classe 1 F a.s.2014/2015
 CANTO di NATALE A Christmas Carol di Charles Dickens Laboratorio di Lettura Svolto dalla classe 1 F a.s.2014/2015 Presentazione Charles Dickens nacque nel 1812 a Portsmouth, in Inghilterra. La sua infanzia
CANTO di NATALE A Christmas Carol di Charles Dickens Laboratorio di Lettura Svolto dalla classe 1 F a.s.2014/2015 Presentazione Charles Dickens nacque nel 1812 a Portsmouth, in Inghilterra. La sua infanzia
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 ISTITUTO DI ISTRUZI SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI - Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: X LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate LICEO TECNICO ISTITUTO TECNICO
ISTITUTO DI ISTRUZI SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI - Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: X LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate LICEO TECNICO ISTITUTO TECNICO
Prof. Margherita Botto
 LINGUA FRANCESE LINGUA FRANCESE I (primo e secondo periodo) Prof. Margherita Botto Codice: 3001 Il corso è destinato agli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere
LINGUA FRANCESE LINGUA FRANCESE I (primo e secondo periodo) Prof. Margherita Botto Codice: 3001 Il corso è destinato agli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere
CURRICOLO DI LETTERE
 Triennio scuola media TRAGUARDI DI COMPETENZA: ascoltare Classe 1ª media Ascolto funzionale a se stesso 1. Acquisire il piacere dell ascolto fine a se stesso Ascolto funzionale alle conoscenze 1. Ascolta
Triennio scuola media TRAGUARDI DI COMPETENZA: ascoltare Classe 1ª media Ascolto funzionale a se stesso 1. Acquisire il piacere dell ascolto fine a se stesso Ascolto funzionale alle conoscenze 1. Ascolta
PREZZEMOLINA PRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI
 PREZZEMOLINA PRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI MAMMA DI PREZZEMOLINA PREZZEMOLINA STREGA PRINCIPE AMBIENTAZIONE TESTO SEMPLICE C'era una volta una donna che abitava in una bella casetta. Da una finestra si
PREZZEMOLINA PRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI MAMMA DI PREZZEMOLINA PREZZEMOLINA STREGA PRINCIPE AMBIENTAZIONE TESTO SEMPLICE C'era una volta una donna che abitava in una bella casetta. Da una finestra si
LICEO SCIENTIFICO STATALE
 LICEO STATALE SCIENTIFICO - LINGUISTICO - CLASSICO GALILEO GALILEI - LEGNANO PdQ - 7.06 Ediz.: 1 Rev.: 0 Data 02/09/05 Alleg.: D01 PROG. M2 PROCEDURA della QUALITA' Programma Didattico Annuale Anno Scolastico
LICEO STATALE SCIENTIFICO - LINGUISTICO - CLASSICO GALILEO GALILEI - LEGNANO PdQ - 7.06 Ediz.: 1 Rev.: 0 Data 02/09/05 Alleg.: D01 PROG. M2 PROCEDURA della QUALITA' Programma Didattico Annuale Anno Scolastico
ideologia sessista, in quanto prodotti di una cultura
 U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i T r e n t o F a coltà di L e ttere e F i losofia Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere SINTESI TESI DI LAUREA FIABE RILETTE E RISCRITTE: ANGELA CARTER
U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i T r e n t o F a coltà di L e ttere e F i losofia Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere SINTESI TESI DI LAUREA FIABE RILETTE E RISCRITTE: ANGELA CARTER
Programmazione didattico-educativa di Latino 3 anno (Liceo Classico)
 Liceo Classico Altavilla Palermo Anno Scolastico 2010/2011 Prof. Paolo Monella Programmazione didattico-educativa di Latino 3 anno (Liceo Classico) Modulo 1: Lingua La conoscenza della lingua latina è
Liceo Classico Altavilla Palermo Anno Scolastico 2010/2011 Prof. Paolo Monella Programmazione didattico-educativa di Latino 3 anno (Liceo Classico) Modulo 1: Lingua La conoscenza della lingua latina è
LICEO GINNASIO STATALE G. B. BROCCHI Bassano del Grappa -VI. Progettazione didattico educativa di dipartimento CLASSE INDIRIZZO
 Pagina 1 di 5 DIPARTIMENTO CLASSE INDIRIZZO FRANCESE PRIMO BIENNIO LINGUISTICO SCIENZE UMANE (OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE) OBIETTIVI IN TERMINI DI: COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE E ATTIVITÀ COMPETENZA ABILITÀ
Pagina 1 di 5 DIPARTIMENTO CLASSE INDIRIZZO FRANCESE PRIMO BIENNIO LINGUISTICO SCIENZE UMANE (OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE) OBIETTIVI IN TERMINI DI: COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE E ATTIVITÀ COMPETENZA ABILITÀ
III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO
 III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO 2016/17 CLASSI PRIME Percepire la dimensione del sé, dell altro e della condivisione nello stare insieme Scoprire
III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO 2016/17 CLASSI PRIME Percepire la dimensione del sé, dell altro e della condivisione nello stare insieme Scoprire
STORIA DELLA PEDAGOGIA:
 STORIA DELLA PEDAGOGIA STORIA DELLA PEDAGOGIA: A cura di : Lanciotti Giulia e Marcucci Martina 3Alsu Indice: Capitolo 1: UNITA 1 L EDUCAZIONE DAI COMUNI ALLA SCOLASTICA L educazione laica nel Basso Medioevo
STORIA DELLA PEDAGOGIA STORIA DELLA PEDAGOGIA: A cura di : Lanciotti Giulia e Marcucci Martina 3Alsu Indice: Capitolo 1: UNITA 1 L EDUCAZIONE DAI COMUNI ALLA SCOLASTICA L educazione laica nel Basso Medioevo
ATTIVITA POTENZIAMENTO COMPETENZE NARRATIVE. Dott.ssa Barbara Cerri Logopedista Fondazione IRCCS Stella Maris Calambrone - Pisa
 ATTIVITA POTENZIAMENTO COMPETENZE NARRATIVE Dott.ssa Barbara Cerri Logopedista Fondazione IRCCS Stella Maris Calambrone - Pisa La narrazione è una competenza che viene trasmessa precocemente ai bambini
ATTIVITA POTENZIAMENTO COMPETENZE NARRATIVE Dott.ssa Barbara Cerri Logopedista Fondazione IRCCS Stella Maris Calambrone - Pisa La narrazione è una competenza che viene trasmessa precocemente ai bambini
La storia della Fantascienza
 La Fantascienza I racconti di fantascienza prendono spunto da dati scientifici per narrare eventi fantastici al limite dell incredibile ma non necessariamente impossibili La storia della Fantascienza La
La Fantascienza I racconti di fantascienza prendono spunto da dati scientifici per narrare eventi fantastici al limite dell incredibile ma non necessariamente impossibili La storia della Fantascienza La
COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
 COMPETENZA ITALIANO COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Definizione: è la capacità di esprimere e interpretare pensieri,sentimenti e fatti in forma sia in forma orale che scritta (comprensione
COMPETENZA ITALIANO COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Definizione: è la capacità di esprimere e interpretare pensieri,sentimenti e fatti in forma sia in forma orale che scritta (comprensione
LETTURA SCRITTURA ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
 Classe Seconda ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL USO DELLA LINGUA Settembre Prove d ingresso
Classe Seconda ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL USO DELLA LINGUA Settembre Prove d ingresso
SCHEDA MATERIA INDIRIZZO TECNICO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA. COMPETENZE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO Allegato A Linee guida DPR 88/2010
 SCHEDA MATERIA INDIRIZZO TECNICO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (Materia) COMPETENZE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO Allegato A Linee guida DPR 88/2010 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione
SCHEDA MATERIA INDIRIZZO TECNICO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (Materia) COMPETENZE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO Allegato A Linee guida DPR 88/2010 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione
CLASSE I SEZ. H Indirizzo alberghiero : PROGRAMMA DI ITALIANO. DOCENTE : Domenica Di Donato
 CLASSE I SEZ. H Indirizzo alberghiero : PROGRAMMA DI ITALIANO DOCENTE : Domenica Di Donato Anno scolastico 2015-2016 Strumenti: Pagine aperte, di M.A.Chiocchio e M. Napoli, Ed.La Nuova Italia UNITA O :
CLASSE I SEZ. H Indirizzo alberghiero : PROGRAMMA DI ITALIANO DOCENTE : Domenica Di Donato Anno scolastico 2015-2016 Strumenti: Pagine aperte, di M.A.Chiocchio e M. Napoli, Ed.La Nuova Italia UNITA O :
ELENCO LIBRI DI TESTO DA DISMETTERE
 ELENCO LIBRI DI TESTO DA DISMETTERE MATERIA TITOLO N. COPIE DISPONIBILI DISMETTERE SI/NO Diritto ed Economia Diritto ed economia insieme 5 Diritto ed Economia Diritto commerciale 5 Diritto ed Economia
ELENCO LIBRI DI TESTO DA DISMETTERE MATERIA TITOLO N. COPIE DISPONIBILI DISMETTERE SI/NO Diritto ed Economia Diritto ed economia insieme 5 Diritto ed Economia Diritto commerciale 5 Diritto ed Economia
Italiano Lingua Seconda IV classe scuola primaria
 Italiano Lingua Seconda IV classe scuola primaria Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria L alunno, l alunna sa (1) comprendere dialoghi che si riferiscono alla vita di
Italiano Lingua Seconda IV classe scuola primaria Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria L alunno, l alunna sa (1) comprendere dialoghi che si riferiscono alla vita di
Testo narrativo in prosa di una certa ampiezza che narra vicende reali o fantastiche
 Il romanzo Testo narrativo in prosa di una certa ampiezza che narra vicende reali o fantastiche ORIGINI STRUTTURA Genere antico, nato dalle letterature orientali; nel medioevo furono creati romanzi in
Il romanzo Testo narrativo in prosa di una certa ampiezza che narra vicende reali o fantastiche ORIGINI STRUTTURA Genere antico, nato dalle letterature orientali; nel medioevo furono creati romanzi in
CAPITOLO 1 Dall accogliente buio all accecante luce: dalla fecondazione al parto
 1 CAPITOLO 1 Dall accogliente buio all accecante luce: dalla fecondazione al parto 1.3 Sempre più stretti 1.4 Finalmente fuori Videografia National Geographic, Nove mesi, il viaggio meraviglioso dal concepimento
1 CAPITOLO 1 Dall accogliente buio all accecante luce: dalla fecondazione al parto 1.3 Sempre più stretti 1.4 Finalmente fuori Videografia National Geographic, Nove mesi, il viaggio meraviglioso dal concepimento
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 ISTITUTO DI ISTRUZI SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI - Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: X LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate LICEO TECNICO ISTITUTO TECNICO
ISTITUTO DI ISTRUZI SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI - Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: X LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate LICEO TECNICO ISTITUTO TECNICO
PROGETTO LETTURA. Spazi: la biblioteca della scuola. Tempi: il progetto ha una durata annuale e prevede orari alternati fra le 5 sezioni.
 PROGETTO LETTURA Destinatari: l uso della biblioteca è garantito a tutti i bambini della scuola dell infanzia; il progetto lettura è finalizzato prevalentemente ai bambini di 5 anni. Spazi: la biblioteca
PROGETTO LETTURA Destinatari: l uso della biblioteca è garantito a tutti i bambini della scuola dell infanzia; il progetto lettura è finalizzato prevalentemente ai bambini di 5 anni. Spazi: la biblioteca
