PROSODIA. 4 - La a finale è breve al Nom. Sing. di I Decl. ed al Nom., Acc., Voc. Plur. Neutro di II, III e IV Decl.; è lunga in altri casi
|
|
|
- Beniamino Testa
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PROSODIA Le principali leggi 1 - I dittonghi (ae, au, oe,...) sono lunghi 2 - Vocale davanti ad altra vocale è breve 3 - Vocale seguita da due o più consonanti o da x e z è lunga (per posizione) 4 - La a finale è breve al Nom. Sing. di I Decl. ed al Nom., Acc., Voc. Plur. Neutro di II, III e IV Decl.; è lunga in altri casi 5 - i / o / u finali sono lunghe 6 - e finale è lunga all'abl. di V Decl. ed all'imper. di II Con.; è breve in altri casi 7 - Ogni sillaba finale in consonante, che non sia s, è breve 8 - as / es / os finali sono lunghe 9 - is / us finali sono brevi (ma is è lunga al Dat. ed Abl. Plur. di I e II Decl.) 10 - Vocale seguita da muta (b, c, t,...) + liquida (r,...) è ancipite (cioè può essere o breve o lunga) 11 - La penultima sillaba di una parola almeno trisillabica è lunga, se accentata; breve nell'altro caso 12 - Elisione: una sillaba finale in vocale od in m cade se la parola che segue inizia per vocale o per h (es.: regere imperio -> regerimperio ) METRICA La metrica studia: a) i piedi (insieme di sillabe brevi e lunghe) b) i versi (insieme di più piedi) c) le strofi (insieme di più versi) Il Piede La sua unità di misura è la mora, che indica la durata musicale della vocale breve. I piedi possono essere di due o più more: pirrichio...due more v v trìbraco...tre more v v v giambo... " v - trocheo / coréo... " v dàttilo...quattro more v v anapèsto... " v v -
2 anfìbraco... " v - v proceleusmàtico... " v v v v spondèo... " crètico...cinque more v - bacchìaco... " v - - ionico a minore...sei more v v - - ionico a maiore... " v v molòsso... " antispasto... " v - - v coriambo... " v v - apìtrito...sette more v Il Verso La sua unità di misura è il metro, formato da uno o più piedi (in genere, però, solo due). Una serie di metri forma il verso. I versi possono essere: in base al numero dei piedi -> dipodìe...2 piedi tripodìe...3 tetrapodìe...4 pentapodìe...5 esapodìe...6 in base al numero dei metri -> dìmetri...2 metri trìmetri...3 tetràmetri....4 pentàmetri....5 esàmetri...6 in base ai piedi che li formano -> dattìlico...da dattilo (unità di m.) giàmbico...da giambo (unità di m.) trocàico...da trocheo (unità di m.) alcàico...da Alceo
3 asclepiadèo......da Asclepìade archilochèo....da Archìloco sàffico...da Saffo ecc. quindi tripodìa trocàica = verso formato da 3 trochèi trìmetro giàmbico = verso formato da 3 metri giambici esàmetro dattìlico = verso formato da 6 dàttili ecc. La Strofa Risulta formata da più versi di struttura ed estensione varia raggruppatisi in modo da presentare un periodo ritmico maggiore di un distico. Si ricordi che due versi disuguali accoppiati insieme formano un distico (quello elegiaco è composto di un esametro più un pentametro); formano un epòdo, se i due versi non sono nè un esametro, nè un pentametro. L'ESAMETRO Questo verso, "chiamato" da Ennio a sostituire l'antico saturnio, prende il nome di "esametro" da "ex = sei" + "mètron = misura/piede", anche se lo si conosce pure come "epico" o "pizio", perchè adoperato dagli oracoli nel secondo caso, nei poemi epici nel primo. Formato da sei dattili, presenta, quindi, uno schema originario... - v v, - v v, - v v, - v v, - v v, - v v 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^...sede...che, presentando l'ultimo dattilo catalettico, cioè mancante di una o più sillabe nella parte finale (- v [v]), con la possibilità di alternare (per dare ad esso un carattere di musicalità) al trocheo (- v) lo spondeo (- -) e di considerare, quindi, ancipite (X) l'ultima sillaba, facilmente vediamo trasformato in... - v v, - v v, - v v, - v v, - v v, - X...e, spesso, per la possibilità di poter sostituire al dattilo uno spondeo nelle prime quattro sedi, nello schema definitivo... - v v (- -), - v v (- -), - v v (- -), - v v (- -), - v v, - - (- v) Solo raramente si incontra lo spondeo (- -) in quinta sede ed il dattilo (- v v ) in quarta, ma, quando succede, l'esametro assume il nome di "spondaico"; rarissimo il caso di esametri formati solo da spondei. Al ritmo ed all'armonia dei versi concorrono anche le "cesure", quasi sempre a fine parola e
4 spesso dopo un segno di interpunzione. Quelle proprie dell'esametro sono: - la semiquinària: cesura principale, dopo due piedi e mezzo, molto frequente - la semisettenària: cesura principale, dopo tre piedi e mezzo - la trocaica del terzo piede: cesura principale, dopo il terzo trocheo, rara - la semiternaria: cesura secondaria, dopo il terzo mezzo piede - la trocaica del secondo piede: cesura secondaria, dopo il secondo trocheo - la bucolica: dopo il quarto piede dattilico, coincide spesso con la fine di un piede IL SENARIO GIAMBICO -> Esso è l'evoluzione latina del trìmetro giambico greco di cui conserva lo stesso numero di piedi [la cui unità di misura è la "mora" che indica la durata musicale della vocale breve; i piedi possono essere di due o più "more" e vanno dal "pirrìchio", "v v" cioè due "more", all'"epìtrito", "- - - v" cioè sette "more"] ma non lo stesso numero di "metra" [che è l'unità di misura del verso ed in genere è formato da due o più piedi]: nel trìmetro ci sono tre "metra" (cioè tre dipodìe [di cui ognuna formata da due piedi]), mentre nel senario i "metra" sono sei perchè i singoli piedi costituiscono un "metrum". -> E' formato da sei piedi giambici: v -, v -, v -, v -, v -, v X 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ -> Tutti gli elementi dei primi cinque piedi possono subire sostituzioni e dar luogo a: trìbrachi...v v v [tre more] spondéi [quattro more] dattili...- v v [quattro more] anapesti...v v - [quattro more] proceleusmàtici...v v v v [quattro more] Queste sostituzioni si realizzano secondo precise norme: ad esempio il "proceleusmàtico" è usato quasi esclusivamente nella prima sede. Per questo è difficile trovare consecutivi "dàttilo" (- v v) ed "anapésto" (v v -), perchè formerebbero una successione di quattro brevi. -> Il metro giambico è impiegato nei versi del dialogo, ma va tenuto presente che la difficoltà di scansione dei versi giambici deriva dalla diversa prosodia [che regola l'alternanza di brevi e lunghe] dei testi arcaici (Plauto) rispetto a quelli più recenti (Fedro, Seneca): questi ultimi sono decisamente più regolari e di facile scansione. -> Il senario giambico ha cesure pentemìmere ([dette anche "semiquinarie"];cesure principali, che troviamo dopo il quinto elemento, cioè dopo due piedi e mezzo o, meglio, dopo la breve del terzo piede) e cesure eftemìmere ([dette anche "semisettenarie"]; cesure principali che troviamo dopo il settimo elemento, cioè dopo tre piedi e mezzo).
5 Erat ìmperàtor sùmmus. Nèptunì nepòs IL SETTENARIO TROCAICO -> E' il verso delle parti recitate, ma compare anche nei "càntica". -> Esso è formato da sette trochéi [o "coréi"; v -, cioè di tre "more"] più un elemento, cioè da due tetrapodìe trocaiche [vale a dire, da due versi di quattro piedi ciascuno] di cui la seconda "cataléttica" [con l'ultimo piede, cioè, privo del secondo elemento] ed ha tutte le sostituzioni possibili nei senari giambici. -> Il penultimo piede è sempre puro; la cesura ricorre generalmente dopo l'ottavo elemento che è "anceps" [cioè "breve" o "lunga"]. -> Schema: - v, - v, - v, - X, - v, - v, - v, X 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ dùlci[a] àtqu[e] amàr[a] apùd te sù[m] elocùtus òmnia IL SETTENARIO GIAMBICO -> Detto anche comicus quadratus, presenta le stesse sostituzioni del senario giambico (ognuno dei primi cinque piedi può essere v - / - - / v v v / - v v / v v -) e le stesse risoluzioni metriche. male mètuòne Philùmenàe magis mòrbus àdgravèscat L OTTONARIO GIAMBICO -> I primi sette piedi ammettono tutte le sostituzioni già viste per il senario; l ottavo piede è puro. ag[e] inèpte! quàsi nunc nòn norìmus nos intèr nos, Ctèsiphò! LE PRINCIPALI FIGURE RETORICHE Elisione: fusione di una sillaba finale (in vocale, dittongo od in m) con la prima sillaba (in vocale, dittongo od in m) della parola seguente Es.: Conticuer(e) omnes intentiqu(e) ora tenebant Sinizèsi (o sinèresi): unione di due sillabe di una stessa parola in modo da formare una sola sillaba lunga
6 Es.: Tristis Aristaeus Penei genitoris ad undam Diéresi: separazione di due sillabe, in genere formanti un suono unico, in due sillabe aventi suono distinto Es.: Stamina non ulli dissoluenda deo Sìstole: uso, per necessità metriche, si una sillaba lunga come breve Es.: Occiderunt magnis qui gentibus imperitarunt Diàstole: uso di una sillaba breve come lunga Es.: Accepisse simul vitam dederitis in undis Afèresi: caduta di sillaba iniziale di parola Es.: Altera signata (e)st, altera forma biceps Sìncope: caduta di vocale all'interno di una parola Es.: Sed mihi tarda gelu saeclisqu(e) effeta senectus Apòcope: caduta di lettera o sillaba a fine parola Es.: Pauperis et tuguri (=ii) congestum caespite culmen Pròtesi: aggiunta di lettera o sillaba ad inizio parola Es.: Eduramque pir(um) et spina iam pruna ferentes Epèntesi: aggiunta di lettera o sillaba dentro una parola Es.: Quantos ille virum magnam Mavortis ad Urbem Paragòge: aggiunta di lettera o sillaba a fine parla Es.: Dulce caput magicas invit(am) accingier artis
Latinitas CENNI DI METRICA CATULLIANA E ORAZIANA. Materiali didattici VERTENDO
 Latinitas Materiali didattici CENNI DI METRICA CATULLIANA E ORAZIANA DISCO VERTENDO 1 L esametro Con la svolta operata in sede metrica da Ennio, l esametro -sperimentato in tutte le sue possibilitàdiventa
Latinitas Materiali didattici CENNI DI METRICA CATULLIANA E ORAZIANA DISCO VERTENDO 1 L esametro Con la svolta operata in sede metrica da Ennio, l esametro -sperimentato in tutte le sue possibilitàdiventa
NOZIONI FONDAMENTALI DI METRICA. elementum biceps: può essere realizzato da due sillabi brevi o da una sillaba lunga;
 1. Terminologia e simboli metrici NOZIONI FONDAMENTALI DI METRICA elementum longum: è realizzato da sillaba lunga; ᴗ elementum breve: è realizzato da sillaba breve; elementum biceps: può essere realizzato
1. Terminologia e simboli metrici NOZIONI FONDAMENTALI DI METRICA elementum longum: è realizzato da sillaba lunga; ᴗ elementum breve: è realizzato da sillaba breve; elementum biceps: può essere realizzato
Scheda metrica: il trimetro giambico della tragedia
 Scheda metrica: il trimetro giambico della tragedia Il tessuto di una tragedia è caratterizzato dall'alternanza di dialoghi recitati e di canto con accompagnamento di musica e danza e pertanto contiene
Scheda metrica: il trimetro giambico della tragedia Il tessuto di una tragedia è caratterizzato dall'alternanza di dialoghi recitati e di canto con accompagnamento di musica e danza e pertanto contiene
LA SCANSIONE DEL VERSO LATINO. Prosodia e metrica latina
 LA SCANSIONE DEL VERSO LATINO Prosodia e metrica latina Poesia italiana metrica accentuativa (posizione di accenti, alternanza regolare di sillabe toniche/atone) Nel mèzzo del cammìn di nostra vìta Poesia
LA SCANSIONE DEL VERSO LATINO Prosodia e metrica latina Poesia italiana metrica accentuativa (posizione di accenti, alternanza regolare di sillabe toniche/atone) Nel mèzzo del cammìn di nostra vìta Poesia
LA METRICA ANTICA QUALCHE NOZIONE DI METRICA GRECA.
 LA METRICA ANTICA Per quanto riguarda i VARI METRI usati dai poeti Lirici, possiamo soltanto fare delle illazioni al riguardo. Possiamo cioè ricostruire, attraverso la struttura delle opere, la divisione
LA METRICA ANTICA Per quanto riguarda i VARI METRI usati dai poeti Lirici, possiamo soltanto fare delle illazioni al riguardo. Possiamo cioè ricostruire, attraverso la struttura delle opere, la divisione
Corso di Latino. Terza parte
 F. D'ALESSI Corso di Latino Terza parte F. Dalessi 1 Glossario delle figure retoriche e stilistiche alliterazione L'alliterazione consiste nella ripetizione non casuale di uno stesso suono o di un gruppo
F. D'ALESSI Corso di Latino Terza parte F. Dalessi 1 Glossario delle figure retoriche e stilistiche alliterazione L'alliterazione consiste nella ripetizione non casuale di uno stesso suono o di un gruppo
La fonetica latina. Ipertesto della prof.ssa Maria Grazia Desogus
 La fonetica latina Ipertesto della prof.ssa Maria Grazia Desogus 2.1 L alfabeto latino A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v x y z Tre di questi caratteri
La fonetica latina Ipertesto della prof.ssa Maria Grazia Desogus 2.1 L alfabeto latino A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v x y z Tre di questi caratteri
TEORIA. 7 Figure ritmiche
 TEORIA. 7 Figure ritmiche Ritmi iniziali Le categorie di ritmo tetico, anacrusico e acefalo si riferiscono all inizio del fraseggio in rapporto al metro. Ritmo tetico (o in battere) Inizia sul primo movimento
TEORIA. 7 Figure ritmiche Ritmi iniziali Le categorie di ritmo tetico, anacrusico e acefalo si riferiscono all inizio del fraseggio in rapporto al metro. Ritmo tetico (o in battere) Inizia sul primo movimento
Nozioni essenziali di Metrica METRICA ITALIANA 1
 METRICA ITALIANA 1 La METRICA è l insieme delle norme che regolano la composizione del VERSO 2. La metrica italiana, a differenza di quella greca e latina 3, è accentuativa, cioè basata sull alternanza
METRICA ITALIANA 1 La METRICA è l insieme delle norme che regolano la composizione del VERSO 2. La metrica italiana, a differenza di quella greca e latina 3, è accentuativa, cioè basata sull alternanza
Elementi di prosodia e metrica latina A.A
 Elementi di prosodia e metrica latina A.A. 2014-2015 Prosodia: Disciplina che studia l accentazione e la quantità delle vocali e delle sillabe. Προσῳδία < πρός + ᾠδή = ad + cantus accentus VERSO ITALIANO
Elementi di prosodia e metrica latina A.A. 2014-2015 Prosodia: Disciplina che studia l accentazione e la quantità delle vocali e delle sillabe. Προσῳδία < πρός + ᾠδή = ad + cantus accentus VERSO ITALIANO
POESIA. filastrocche per iniziare
 POESIA filastrocche per iniziare Filastrocche in rima baciata (ABBA) e alternata (ABAB) (a cura della cl. 1 B) PRIMO ESEMPIO di due strofe, la prima formata da quattro versi, la seconda da uno. La filastrocca
POESIA filastrocche per iniziare Filastrocche in rima baciata (ABBA) e alternata (ABAB) (a cura della cl. 1 B) PRIMO ESEMPIO di due strofe, la prima formata da quattro versi, la seconda da uno. La filastrocca
VERSIFICAZIONE Il verso
 VERSIFICAZIONE Il verso Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall ospizio ov erano stati a visitarlo.
VERSIFICAZIONE Il verso Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall ospizio ov erano stati a visitarlo.
Percorso formativo disciplinare Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA CLASSE4AM LICEO CLASSICO Anno scolastico Prof.
 INTRODUZIONE ALLA LIRICA GRECA Percorso formativo disciplinare Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA CLASSE4AM LICEO CLASSICO Anno scolastico 2015-2016 Prof.ssa MURA GLORIA La lirica L esecuzione e la fruizione
INTRODUZIONE ALLA LIRICA GRECA Percorso formativo disciplinare Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA CLASSE4AM LICEO CLASSICO Anno scolastico 2015-2016 Prof.ssa MURA GLORIA La lirica L esecuzione e la fruizione
Perché studiare la metrica?
 Perché studiare la metrica? Premessa Assumiamo come appartenente all ambito della poesia (forma-poesia), e dunque passibile di studio metrico, qualsiasi testo prodotto e recepito come letterario il quale
Perché studiare la metrica? Premessa Assumiamo come appartenente all ambito della poesia (forma-poesia), e dunque passibile di studio metrico, qualsiasi testo prodotto e recepito come letterario il quale
LA METRICA. Norma di Ritschel Un elemento bisillabico non può essere formato da una parola che cominci prima di esso e finisca all'interno di esso.
 P LAUTO P OENULUS LA METRICA Norma di Ritschel Un elemento bisillabico non può essere formato da una parola che cominci prima di esso e finisca all'interno di esso. Si vieta. La norma non vale se il primo
P LAUTO P OENULUS LA METRICA Norma di Ritschel Un elemento bisillabico non può essere formato da una parola che cominci prima di esso e finisca all'interno di esso. Si vieta. La norma non vale se il primo
La III declinazione o declinazione atematica
 La III declinazione o declinazione atematica La III declinazione comprende: sostantivi (maschili, femminili e neutri), aggettivi (II classe), participi presenti. I sostantivi presentano i seguenti temi:
La III declinazione o declinazione atematica La III declinazione comprende: sostantivi (maschili, femminili e neutri), aggettivi (II classe), participi presenti. I sostantivi presentano i seguenti temi:
La rima ha funzione demarcativa: favorisce la percezione della divisione in versi. L anisosillabismo è possibile perché la scansione in versi è
 La rima Identità di suono della parte finale di parole a partire dalla vocale tonica compresa Il termine rima deriva attraverso il fr. ant. risme, rime e il prov. rim / rima dal lat. rhythmus Rhythmus:
La rima Identità di suono della parte finale di parole a partire dalla vocale tonica compresa Il termine rima deriva attraverso il fr. ant. risme, rime e il prov. rim / rima dal lat. rhythmus Rhythmus:
Nozioni fondamentali di Metrica greca
 Nozioni fondamentali di Metrica greca Poesia quantitativa e accentuativa Le lingue classiche, sia il Greco che il Latino, si differenziano dall italiano, oltre che per molti altri aspetti, in particolare
Nozioni fondamentali di Metrica greca Poesia quantitativa e accentuativa Le lingue classiche, sia il Greco che il Latino, si differenziano dall italiano, oltre che per molti altri aspetti, in particolare
Le forme della poesia (istruzioni per l uso)
 Le forme della poesia (istruzioni per l uso) Il verso è il singolo rigo di una poesia. il verso Il verso italiano si basa su due elementi fondamentali: - il numero delle sillabe metriche (attenzione: sillabe
Le forme della poesia (istruzioni per l uso) Il verso è il singolo rigo di una poesia. il verso Il verso italiano si basa su due elementi fondamentali: - il numero delle sillabe metriche (attenzione: sillabe
Caratteri generali di metrica
 Caratteri generali di metrica metrica insieme delle regole e delle convenzioni che, in una tradizione letteraria, presiedono alla strutturazione formale del prodotto poetico, fornendo agli autori una serie
Caratteri generali di metrica metrica insieme delle regole e delle convenzioni che, in una tradizione letteraria, presiedono alla strutturazione formale del prodotto poetico, fornendo agli autori una serie
La poesia Che differenza c'è tra poesia e prosa? La poesia dice troppo in pochissimo tempo, la prosa dice poco e ci mette un bel po'.
 La poesia Che differenza c'è tra poesia e prosa? La poesia dice troppo in pochissimo tempo, la prosa dice poco e ci mette un bel po'. (Charles Bukowski) San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per
La poesia Che differenza c'è tra poesia e prosa? La poesia dice troppo in pochissimo tempo, la prosa dice poco e ci mette un bel po'. (Charles Bukowski) San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per
L'incisione mediana del pentametro greco ammette molto raramente brevis in longo
 Durante tutto il periodo preclassico e classico la Grecia antica non conobbe la poesia «letta» nel significato nostro della parola. Le composizioni poetiche venivano: a) recitate senza accompagnamento
Durante tutto il periodo preclassico e classico la Grecia antica non conobbe la poesia «letta» nel significato nostro della parola. Le composizioni poetiche venivano: a) recitate senza accompagnamento
POESIA schede riassuntive 2010
 POESIA La poesia è costituita da versi, ossia una fila di parole che ad un tratto vengono interrotti e che vanno a capo prima della fine della riga. VERSO: dal latino versus, che significa volto all indietro
POESIA La poesia è costituita da versi, ossia una fila di parole che ad un tratto vengono interrotti e che vanno a capo prima della fine della riga. VERSO: dal latino versus, che significa volto all indietro
ORIGINE E FORMAZIONE DELL'ESAMETRO. Premessa
 SBORNIK PRACI FILOZOFICK.É FAKULTY BRNÉNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS N6-7, 2001-2002 CARLO ODO PAVESE ORIGINE E FORMAZIONE DELL'ESAMETRO Premessa L'origine
SBORNIK PRACI FILOZOFICK.É FAKULTY BRNÉNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS N6-7, 2001-2002 CARLO ODO PAVESE ORIGINE E FORMAZIONE DELL'ESAMETRO Premessa L'origine
AGGETTIVI DI SECONDA CLASSE A DUE E A UNA SOLA USCITA. AGGETTIVI IRREGOLARI AGGETTIVI A DUE USCITE
 ETTII I SECO CLSSE UE E U SOL USCIT. ETTII IRREOLRI ETTII UE USCITE 1 Hanno il tema in preceduta da (Quelli in preceduta da e in preceduta da sono, sempre di seconda classe, ma a 3 uscite; vedi nero e
ETTII I SECO CLSSE UE E U SOL USCIT. ETTII IRREOLRI ETTII UE USCITE 1 Hanno il tema in preceduta da (Quelli in preceduta da e in preceduta da sono, sempre di seconda classe, ma a 3 uscite; vedi nero e
Lo dedico soprattutto a chi ancora crede nella poesia, e soprattutto in quella italiana; nonché a chiunque continuerà a provare a tenerla viva.
 93 Dedico questo libretto alle persone che mi hanno chiesto di scriverlo, nonché a quelle che, cercando uno strumento per iniziare, ne hanno tratto qualche spunto utile per cominciare ad avvicinarsi alla
93 Dedico questo libretto alle persone che mi hanno chiesto di scriverlo, nonché a quelle che, cercando uno strumento per iniziare, ne hanno tratto qualche spunto utile per cominciare ad avvicinarsi alla
1. Terminazione dei versi e computo sillabico
 ABC La metrica italiana si fonda su un sistema sillabico accentuativo: in un verso sono importanti il numero delle sillabe e il ritmo, che regola la successione e l alternanza delle sillabe toniche (o
ABC La metrica italiana si fonda su un sistema sillabico accentuativo: in un verso sono importanti il numero delle sillabe e il ritmo, che regola la successione e l alternanza delle sillabe toniche (o
PROGRAMMA FINALE LETTERATURA
 Disciplina: Lingua e cultura greca Docente: Prof. Gaetano Gallo Anno scolastico: 2017/2018 Classe III sez. E PROGRAMMA FINALE LETTERATURA Introduzione allo studio della letteratura greca I. Forme e periodi
Disciplina: Lingua e cultura greca Docente: Prof. Gaetano Gallo Anno scolastico: 2017/2018 Classe III sez. E PROGRAMMA FINALE LETTERATURA Introduzione allo studio della letteratura greca I. Forme e periodi
Vita nova. Lezione quarta
 Vita nova Lezione quarta Calendario 21 settembre 19 ottobre: Lezioni introduttive. Esempio: Tanto gentile e tanto onesta pare. presentazioni 26 ottobre: A ciascun alma presa e gentil core 9 novembre: Piangete,
Vita nova Lezione quarta Calendario 21 settembre 19 ottobre: Lezioni introduttive. Esempio: Tanto gentile e tanto onesta pare. presentazioni 26 ottobre: A ciascun alma presa e gentil core 9 novembre: Piangete,
LE REGOLE DEL CONTRAPPUNTO DI DUBOIS
 LE REGOLE DEL CONTRAPPUNTO DI DUBOIS 1 ACCORDI USATI: Oltre agli accordi perfetti maggiore, minore e al loro 1 rivolto, è possibile usare l accordo di 5 diminuita nel suo 1 rivolto: Nel suo stato fondamentale,
LE REGOLE DEL CONTRAPPUNTO DI DUBOIS 1 ACCORDI USATI: Oltre agli accordi perfetti maggiore, minore e al loro 1 rivolto, è possibile usare l accordo di 5 diminuita nel suo 1 rivolto: Nel suo stato fondamentale,
Percorso formativo disciplinare Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA CLASSE4AM LICEO CLASSICO Anno scolastico
 Percorso formativo disciplinare Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA CLASSE4AM LICEO CLASSICO Anno scolastico 2015-2016 LA SATIRA I caratteri del genere LUCILIO LA TARDA REPUBBLICA Il contesto storico-culturale
Percorso formativo disciplinare Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA CLASSE4AM LICEO CLASSICO Anno scolastico 2015-2016 LA SATIRA I caratteri del genere LUCILIO LA TARDA REPUBBLICA Il contesto storico-culturale
4 Capitolo Il Ritmo La Ritmica
 4 Capitolo Le regole grammaticali della musica Le parole (in corsivo celeste) vanno ricercate nel Glossario musicale anche nel nostro sito. Per ogni ulteriore chiarimento o spiegazione Non esitare a contattarci.
4 Capitolo Le regole grammaticali della musica Le parole (in corsivo celeste) vanno ricercate nel Glossario musicale anche nel nostro sito. Per ogni ulteriore chiarimento o spiegazione Non esitare a contattarci.
Claudio Bini
 INDAGINE SPERIMENTALE SULL INDICE DI GRADIMENTO DI ALCUNE UNITA RITMICHE DI BASE DELLA METRICA CLASSICA QUANTITATIVA GRECA. ESISTENZA E CONFERMA DI ETHOS RITMICO. QUANTIFICAZIONE STATISTICA. Claudio Bini
INDAGINE SPERIMENTALE SULL INDICE DI GRADIMENTO DI ALCUNE UNITA RITMICHE DI BASE DELLA METRICA CLASSICA QUANTITATIVA GRECA. ESISTENZA E CONFERMA DI ETHOS RITMICO. QUANTIFICAZIONE STATISTICA. Claudio Bini
LINGUA E CULTURA GRECA PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV B ANNO SCOLASTICO
 LINGUA E CULTURA GRECA PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV B ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Libro di testo: P. Agazzi, M. Villardo Ellenistì, Corso di lingua e cultura greca, Manuale ed Esercizi vol.1, Zanichelli 2014,
LINGUA E CULTURA GRECA PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV B ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Libro di testo: P. Agazzi, M. Villardo Ellenistì, Corso di lingua e cultura greca, Manuale ed Esercizi vol.1, Zanichelli 2014,
CURRICOLO VERTICALE LICEO CLASSICO: Secondo biennio
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G. PEANO C/da Fontanelle 85052 ISTITUTO MARSICONUOVO D ISTRUZIONE (PZ) SUPERIORE Tel.0975342102 - Fax 0975344109 C. F. 80006310769 - C. M. PZIS01900C www.liceomarsico.it
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G. PEANO C/da Fontanelle 85052 ISTITUTO MARSICONUOVO D ISTRUZIONE (PZ) SUPERIORE Tel.0975342102 - Fax 0975344109 C. F. 80006310769 - C. M. PZIS01900C www.liceomarsico.it
Negli esercizi indicherò la corda da utilizzare attraverso il numero romano sopra la nota: I = SOL II = RE III = LA IV = MI
 INDICE Crediti... 4 Prefazione... 5 Le basi...7 Glossario teorico... 8 Primi Bassi... 11 Uso delle ottave... 15 Uso delle quinte... 17 Triadi maggiori... 22 Triadi minori... 24 Uso delle triadi... 26 Triadi
INDICE Crediti... 4 Prefazione... 5 Le basi...7 Glossario teorico... 8 Primi Bassi... 11 Uso delle ottave... 15 Uso delle quinte... 17 Triadi maggiori... 22 Triadi minori... 24 Uso delle triadi... 26 Triadi
Franco_Sanna_lettura_metrica-Hyperlatino_3 29/02/ :36:00 LA LETTURA METRICA DELLA POESIA LATINA
 LA LETTURA METRICA DELLA POESIA LATINA In ordine i problemi posti dalla lettura metrica dei testi latini sono i seguenti: la pronuncia; le caratteristiche della metrica latina; l'ictus metrico; le elisioni;
LA LETTURA METRICA DELLA POESIA LATINA In ordine i problemi posti dalla lettura metrica dei testi latini sono i seguenti: la pronuncia; le caratteristiche della metrica latina; l'ictus metrico; le elisioni;
Breve introduzione alla metrica italiana. 1. La poesia
 Breve introduzione alla metrica italiana 1. La poesia Caratteristiche generali Il testo poetico, come la prosa, è costituito da proposizioni. Rispetto alla prosa però presenta una differenza essenziale.
Breve introduzione alla metrica italiana 1. La poesia Caratteristiche generali Il testo poetico, come la prosa, è costituito da proposizioni. Rispetto alla prosa però presenta una differenza essenziale.
Gli strumenti della poetica
 Gli strumenti della poetica Il verso Il testo poetico è scritto in versi, una riga di una poesia, di lunghezza variabile, in un continuo andare a capo. L'utilizzo dei versi consente al poeta di trasmettere
Gli strumenti della poetica Il verso Il testo poetico è scritto in versi, una riga di una poesia, di lunghezza variabile, in un continuo andare a capo. L'utilizzo dei versi consente al poeta di trasmettere
SINOSSI DEL CURRICOLO VERTICALE PER GLI ASSI LINGUISTICO (L) E STORICO-SOCIALE (S) 1
 PERIODO Primo biennio COMPETENZE/ABILITÀ IN USCITA PER L ASSE LINGUISTICO L1. Riconoscere, distinguere e analizzare le parole della lingua italiana, della lingua latina e della lingua greca ai livelli
PERIODO Primo biennio COMPETENZE/ABILITÀ IN USCITA PER L ASSE LINGUISTICO L1. Riconoscere, distinguere e analizzare le parole della lingua italiana, della lingua latina e della lingua greca ai livelli
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE LICEO TRIENNIO. Anno scolastico Materia Classi Greco I, II, III liceo classico
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE LICEO TRIENNIO Anno scolastico Materia Classi 2012-13 Greco I, II, III liceo classico 15 GRECO Prerequisiti - Comprensione complessiva di un semplice testo di autore
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE LICEO TRIENNIO Anno scolastico Materia Classi 2012-13 Greco I, II, III liceo classico 15 GRECO Prerequisiti - Comprensione complessiva di un semplice testo di autore
Eventi sonori. o comunque percettivi. o comunque percettivi.
 CLASSE PRIMA Discriminare la sonorità di ambienti e oggetto naturali e artificiali. Eventi sonori. Attribuzione di significati a segnali sonori musicali Sperimentare tipologie di espressioni vocali (parlato,
CLASSE PRIMA Discriminare la sonorità di ambienti e oggetto naturali e artificiali. Eventi sonori. Attribuzione di significati a segnali sonori musicali Sperimentare tipologie di espressioni vocali (parlato,
SEZIONE A: LINGUA LATINA
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI SANTERAMO IN COLLE LICEO SCIENTIFICO PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERE LATINE SVOLTO DALLA CLASSE IV SEZIONE A ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - PROF. ANDREA CAVALIERE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI SANTERAMO IN COLLE LICEO SCIENTIFICO PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERE LATINE SVOLTO DALLA CLASSE IV SEZIONE A ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - PROF. ANDREA CAVALIERE
376 Introduzione alla lingua di Roma nel Duecento
 INDICE Introduzione Preliminare» 3 Riferimenti testuali e bibliografici» 4 I. La lingua di Roma nel Duecento» 5 II. La trascrizione dei testi e le abbreviazioni» 7 III. Correzioni alle trascrizioni dei
INDICE Introduzione Preliminare» 3 Riferimenti testuali e bibliografici» 4 I. La lingua di Roma nel Duecento» 5 II. La trascrizione dei testi e le abbreviazioni» 7 III. Correzioni alle trascrizioni dei
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE R. DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO. Liceo Classico. Orbetello RELAZIONE FINALE
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE R. DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO Liceo Classico Orbetello CLASSE: I RELAZIONE FINALE DISCIPLINA: Lingua e letteratura Greca DOCENTE: Mariateresa Canessa Obiettivi
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE R. DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO Liceo Classico Orbetello CLASSE: I RELAZIONE FINALE DISCIPLINA: Lingua e letteratura Greca DOCENTE: Mariateresa Canessa Obiettivi
MARCO BEGHELLI Guida alla identificazione metrica dei versi italiani
 MARCO BEGHELLI Guida alla identificazione metrica dei versi italiani Individuazione delle sillabe metriche Consideriamo questo testo poetico, inizio di una celebre aria d opera di Giuseppe Verdi (da Rigoletto,
MARCO BEGHELLI Guida alla identificazione metrica dei versi italiani Individuazione delle sillabe metriche Consideriamo questo testo poetico, inizio di una celebre aria d opera di Giuseppe Verdi (da Rigoletto,
ROSARIO PINTAUDI & MARIA CANNATÀ FERA PINDARO, NEM. I 15-18, IN UN PAPIRO LAURENZIANO (PL III/310 C)
 ROSARIO PINTAUDI & MARIA CANNATÀ FERA PINDARO, NEM. I 15-18, 35-42 IN UN PAPIRO LAURENZIANO (PL III/310 C) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 117 (1997) 197 199 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn
ROSARIO PINTAUDI & MARIA CANNATÀ FERA PINDARO, NEM. I 15-18, 35-42 IN UN PAPIRO LAURENZIANO (PL III/310 C) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 117 (1997) 197 199 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn
IV LICEO CLASSICO Letteratura latina Riassunto del programma L'ETA' DI CESARE
 IV LICEO CLASSICO Letteratura latina Riassunto del programma L'ETA' DI CESARE LUCREZIO Tito Lucrezio Caro fu un poeta ma anche un filosofo, forse di origine campana, sostenitore della dottrina materialista_e
IV LICEO CLASSICO Letteratura latina Riassunto del programma L'ETA' DI CESARE LUCREZIO Tito Lucrezio Caro fu un poeta ma anche un filosofo, forse di origine campana, sostenitore della dottrina materialista_e
4) Con la fine dell Impero romano (476 d.c.) il latino fu sostituito dalle lingue romanze negli atti ufficiali e nel parlato.
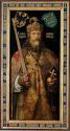 1) La differenza tra documento e monumento sta nel fatto che: a) i documenti sono cartacei, i monumenti lapidei b) il documento è una scrittura non fatta per durare, il monumento sì c) il documento è personale,
1) La differenza tra documento e monumento sta nel fatto che: a) i documenti sono cartacei, i monumenti lapidei b) il documento è una scrittura non fatta per durare, il monumento sì c) il documento è personale,
Le note musicali come tutti sanno sono sette: qui possiamo vedere per ogni nota la sua corrispondente altezza in un pentagramma in chiave di Sol.
 Le note musicali Le note musicali come tutti sanno sono sette: qui possiamo vedere per ogni nota la sua corrispondente altezza in un pentagramma in chiave di Sol. Il Do della figura è anche chiamato Do
Le note musicali Le note musicali come tutti sanno sono sette: qui possiamo vedere per ogni nota la sua corrispondente altezza in un pentagramma in chiave di Sol. Il Do della figura è anche chiamato Do
I II II III III IV IV V SINGOLARE CASI M / F M / F N M / F N M / F N F (M)
 PROSPETTO RIASSUNTIVO DECLINAZIONI LATINE I II II III III IV IV V CASI M / F M / F N M / F N M / F N F (M) NOM us, er, ir um vario vario s u es GEN ae i i is is s s ei DAT ae o o i i i u ei ACC am um um
PROSPETTO RIASSUNTIVO DECLINAZIONI LATINE I II II III III IV IV V CASI M / F M / F N M / F N M / F N F (M) NOM us, er, ir um vario vario s u es GEN ae i i is is s s ei DAT ae o o i i i u ei ACC am um um
ESERCIZI RITMICI FONDAMENTALI
 1/9 ESERCIZI RITMICI FONDAMENTALI ESERCIZI RITMICI FONDAMENTALI ESERCIZIO 1 Questo esercizio sull accordo di Mim su un tempo di 2/4 deve essere eseguito in modo che la successione delle battute sia chiaramente
1/9 ESERCIZI RITMICI FONDAMENTALI ESERCIZI RITMICI FONDAMENTALI ESERCIZIO 1 Questo esercizio sull accordo di Mim su un tempo di 2/4 deve essere eseguito in modo che la successione delle battute sia chiaramente
Programmazione di Dipartimento (Area 1) Lettere. Programmazione di Lingua e Cultura Latina. Liceo Delle Scienze Umane II Biennio I e II anno
 Programmazione di Dipartimento (Area 1) Lettere Programmazione di Lingua e Cultura Latina Liceo Delle Scienze Umane II Biennio I e II anno Civiltà Latina V anno Liceo socio- psico pedagogico e Liceo Linguistico
Programmazione di Dipartimento (Area 1) Lettere Programmazione di Lingua e Cultura Latina Liceo Delle Scienze Umane II Biennio I e II anno Civiltà Latina V anno Liceo socio- psico pedagogico e Liceo Linguistico
MORFOLOGIA ARTICOLO. Nell'antico volgare esisteva un solo articolo maschile:
 MORFOLOGIA ARTICOLO L'articolo non esisteva in latino. Nel latino tardo i dimostrativi ILLE/ILLA cominciano a essere adoperati con la funzione ora ricoperta dall'articolo determinativo, l'indefinito UNUS/UNA
MORFOLOGIA ARTICOLO L'articolo non esisteva in latino. Nel latino tardo i dimostrativi ILLE/ILLA cominciano a essere adoperati con la funzione ora ricoperta dall'articolo determinativo, l'indefinito UNUS/UNA
Quaderni Urbinati Di cultura classica
 Quaderni Urbinati Di cultura classica Direttore responsabile: Bruno Gentili. Redazione: Condirettori: Paola Bernardini, Maurizio Bettini, Giovanni Cerri, Franca Perusino. Segretaria: Maria Colantonio.
Quaderni Urbinati Di cultura classica Direttore responsabile: Bruno Gentili. Redazione: Condirettori: Paola Bernardini, Maurizio Bettini, Giovanni Cerri, Franca Perusino. Segretaria: Maria Colantonio.
Il mimo. ed Eroda. Prof.ssa F. Carta. Liceo Classico G.M. Dettori Cagliari
 Il mimo ed Eroda Prof.ssa F. Carta Liceo Classico G.M. Dettori Cagliari Sofrone Le fonti antiche sono concordi nell affermare che il mimo nacque in Sicilia e che il primo a conferirgli dignità letteraria
Il mimo ed Eroda Prof.ssa F. Carta Liceo Classico G.M. Dettori Cagliari Sofrone Le fonti antiche sono concordi nell affermare che il mimo nacque in Sicilia e che il primo a conferirgli dignità letteraria
LICEO GINNASIO JACOPO STELLINI
 LICEO GINNASIO JACOPO STELLINI Piazza I Maggio, 26-33100 Udine Tel. 0432 504577 Fax. 0432 511490 Codice fiscale 80023240304 e-mail: info@liceostellini.it - Indirizzo Internet: www.stelliniudine.gov.it
LICEO GINNASIO JACOPO STELLINI Piazza I Maggio, 26-33100 Udine Tel. 0432 504577 Fax. 0432 511490 Codice fiscale 80023240304 e-mail: info@liceostellini.it - Indirizzo Internet: www.stelliniudine.gov.it
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIPARTIMENTO GRECO-LATINO A.S. 2012-2013 Tale programmazione viene elaborata dal Dipartimento di Greco-Latino, tenuti presenti il DM 139 del 22 agosto 2007, il D.P.R. del 15 marzo
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIPARTIMENTO GRECO-LATINO A.S. 2012-2013 Tale programmazione viene elaborata dal Dipartimento di Greco-Latino, tenuti presenti il DM 139 del 22 agosto 2007, il D.P.R. del 15 marzo
LATINO E GRECO II BIENNIO e V ANNO LATINO
 LATINO E GRECO II BIENNIO e V ANNO LATINO Finalità generali La consapevolezza della propria identità culturale attraverso il recupero di radici e archetipi che trovano nel mondo greco e romano le loro
LATINO E GRECO II BIENNIO e V ANNO LATINO Finalità generali La consapevolezza della propria identità culturale attraverso il recupero di radici e archetipi che trovano nel mondo greco e romano le loro
Breve dizionario di metrica italiana
 Breve dizionario di metrica italiana di Giorgio Bertone Edizione di riferimento: Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 1999 Sommario acatalessi, vedi catalessi/acatalessi 1 accentuativa/quantitativa, metrica
Breve dizionario di metrica italiana di Giorgio Bertone Edizione di riferimento: Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 1999 Sommario acatalessi, vedi catalessi/acatalessi 1 accentuativa/quantitativa, metrica
LICEO GINNASIO STATALE G. B. BROCCHI Bassano del Grappa -VI. Progettazione didattico educativa di dipartimento CLASSICO
 Pagina 1 di 13 DIPARTIMENTO DISCIPLINA CLASSI INDIRIZZO LETTERE GRECO 1 A E 2 A LICEO CLASSICO OBIETTIVI IN TERMINI DI: COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE E ATTIVITÀ N.B. La tabella evidenzia i contributi
Pagina 1 di 13 DIPARTIMENTO DISCIPLINA CLASSI INDIRIZZO LETTERE GRECO 1 A E 2 A LICEO CLASSICO OBIETTIVI IN TERMINI DI: COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE E ATTIVITÀ N.B. La tabella evidenzia i contributi
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO G. UGDULENA SEZIONE: LICEO CLASSICO - TERMINI IMERESE
 Libri di testo: LATINO Diotti, Dossi, Signoracci - Narrant letteratura, antologia, cultura latina- vol.1- SEI Flocchini, Bacci, Moscio, Sampietro, Lamagna-Sermo et humanitas- corso di lingua e cultura
Libri di testo: LATINO Diotti, Dossi, Signoracci - Narrant letteratura, antologia, cultura latina- vol.1- SEI Flocchini, Bacci, Moscio, Sampietro, Lamagna-Sermo et humanitas- corso di lingua e cultura
Elementi di analisi di un testo poetico
 Elementi di analisi di un testo poetico Livelli di analisi di un testo poetico 1. I temi e la struttura 2. Livello semantico 3. Livello metrico-ritmico 4. Livello fonico 5. Livello retorico 6. Livello
Elementi di analisi di un testo poetico Livelli di analisi di un testo poetico 1. I temi e la struttura 2. Livello semantico 3. Livello metrico-ritmico 4. Livello fonico 5. Livello retorico 6. Livello
LICEO CLASSICO PITAGORA CROTONE
 LICEO CLASSICO PITAGORA CROTONE A.S. 2016-2017 PROGRAMMA SVOLTO CLASSE: III SEZ. E MATERIA: LATINO PROF. LOPEZ FRANCESCO CONTENUTI I contenuti hanno compreso lo studio della Letteratura latina, dalle origini
LICEO CLASSICO PITAGORA CROTONE A.S. 2016-2017 PROGRAMMA SVOLTO CLASSE: III SEZ. E MATERIA: LATINO PROF. LOPEZ FRANCESCO CONTENUTI I contenuti hanno compreso lo studio della Letteratura latina, dalle origini
Materia: LATINO. Classe I sez. A. Liceo Scientifico. Docente: Prof.ssa Carla Bonfitto
 Materia: LATINO Classe I sez. A Liceo Scientifico Docente: Prof.ssa Carla Bonfitto a.s. 2015/2016 UNITÀ 1 L alfabeto latino e la pronuncia Vocali e dittonghi Consonanti Divisione in sillabe Quantità delle
Materia: LATINO Classe I sez. A Liceo Scientifico Docente: Prof.ssa Carla Bonfitto a.s. 2015/2016 UNITÀ 1 L alfabeto latino e la pronuncia Vocali e dittonghi Consonanti Divisione in sillabe Quantità delle
L EVOLUZIONE DEL DISTICO ELEGIACO FRA CATULLO E OVIDIO
 LUCIO CECCARELLI L EVOLUZIONE DEL DISTICO ELEGIACO FRA CATULLO E OVIDIO 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 1.1 Un esame dell evoluzione del distico elegiaco richiede prima di tutto un lavoro di selezione; un
LUCIO CECCARELLI L EVOLUZIONE DEL DISTICO ELEGIACO FRA CATULLO E OVIDIO 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 1.1 Un esame dell evoluzione del distico elegiaco richiede prima di tutto un lavoro di selezione; un
PROVA ORALE CLASSE DI CONCORSO A 11 Discipline Letterarie e Latino
 Concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e per posti di sostegno nelle scuole dell infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado della
Concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e per posti di sostegno nelle scuole dell infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado della
Per colpa di un accento un tale di Santhià credeva di essere alla meta ed era appena a metà. Gianni Rodari Il libro degli errori
 Per colpa di un accento un tale di Santhià credeva di essere alla meta ed era appena a metà. Gianni Rodari Il libro degli errori ORTOGRAFIA E PUNTEGGIATURA 1. Che cosa sono l ortografia e la punteggiatura
Per colpa di un accento un tale di Santhià credeva di essere alla meta ed era appena a metà. Gianni Rodari Il libro degli errori ORTOGRAFIA E PUNTEGGIATURA 1. Che cosa sono l ortografia e la punteggiatura
Brevi Cenni di Teoria Musicale
 Corso di Antropologia della Musica A. A. 2007-2008 2008 Lezione Introduttiva Brevi Cenni di Teoria Musicale 23 Novembre 2007 Docente: Dott.ssa Laura Ruzza L'ottava Un'ottava può essere definita come la
Corso di Antropologia della Musica A. A. 2007-2008 2008 Lezione Introduttiva Brevi Cenni di Teoria Musicale 23 Novembre 2007 Docente: Dott.ssa Laura Ruzza L'ottava Un'ottava può essere definita come la
numeri quantici orbitale spin
 La funzione d onda ψ definisce i diversi stati in cui può trovarsi l elettrone nell atomo. Nella sua espressione matematica, essa contiene tre numeri interi, chiamati numeri quantici, indicati con le lettere
La funzione d onda ψ definisce i diversi stati in cui può trovarsi l elettrone nell atomo. Nella sua espressione matematica, essa contiene tre numeri interi, chiamati numeri quantici, indicati con le lettere
MARCO BEGHELLI Guida alla identificazione metrica dei versi italiani
 MARCO BEGHELLI Guida alla identificazione metrica dei versi italiani Individuazione delle sillabe metriche Consideriamo questo testo poetico, inizio di una celebre aria d opera di Giuseppe Verdi (da Rigoletto,
MARCO BEGHELLI Guida alla identificazione metrica dei versi italiani Individuazione delle sillabe metriche Consideriamo questo testo poetico, inizio di una celebre aria d opera di Giuseppe Verdi (da Rigoletto,
Rhythmic Music Theory
 Rhythmic Music Theory il solfeggio "sovrano" Menolascina Simone INDICE 1. Prima di cominciare...qualche piccola nozione p. 2 2. Le figure e le pause musicali + esercizi p. 3 3. Prospetto comparativo delle
Rhythmic Music Theory il solfeggio "sovrano" Menolascina Simone INDICE 1. Prima di cominciare...qualche piccola nozione p. 2 2. Le figure e le pause musicali + esercizi p. 3 3. Prospetto comparativo delle
LICEO GINNASIO JACOPO STELLINI
 LICEO GINNASIO JACOPO STELLINI Piazza I Maggio, 26-33100 Udine Tel. 0432 504577 Fax 0432 511490 Codice fiscale 80023240304 e-mail: info@liceostellini.it - Indirizzo Internet: www.stelliniudine.gov.it -
LICEO GINNASIO JACOPO STELLINI Piazza I Maggio, 26-33100 Udine Tel. 0432 504577 Fax 0432 511490 Codice fiscale 80023240304 e-mail: info@liceostellini.it - Indirizzo Internet: www.stelliniudine.gov.it -
Indice del volume MORFOLOGIA. unità 1 Alfabeto e fonetica. unità 2 Nozioni preliminari di morfologia
 Indice del volume Notizia storica MORFOLOGIA unità 1 Alfabeto e fonetica XV 1 I fonemi 2 2 L alfabeto 2 3 I fonemi del latino 3 Vocali 3 Dittonghi 4 Consonanti 4 Semivocali (o semiconsonanti) 5 4 La pronuncia
Indice del volume Notizia storica MORFOLOGIA unità 1 Alfabeto e fonetica XV 1 I fonemi 2 2 L alfabeto 2 3 I fonemi del latino 3 Vocali 3 Dittonghi 4 Consonanti 4 Semivocali (o semiconsonanti) 5 4 La pronuncia
SENECIO. Direttore Andrea Piccolo e Lorenzo Fort. Recensioni, Note Critiche, Extravaganze
 SENECIO Direttore Andrea Piccolo e Lorenzo Fort Recensioni, Note Critiche, Extravaganze Senecio www.senecio.it direzione@senecio.it Napoli, 2015 La manipolazione e/o la riproduzione (totale o parziale)
SENECIO Direttore Andrea Piccolo e Lorenzo Fort Recensioni, Note Critiche, Extravaganze Senecio www.senecio.it direzione@senecio.it Napoli, 2015 La manipolazione e/o la riproduzione (totale o parziale)
l con0etto di sillaba può essere appreso inizialmente attraverso l eser0izio orale.
 3. l con0etto di sillaba può essere appreso inizialmente attraverso l eser0izio orale. insegnante prima pronuncia separatamente i due suoni alfabetici con il loro suono naturale, cioè duro e gutturale,
3. l con0etto di sillaba può essere appreso inizialmente attraverso l eser0izio orale. insegnante prima pronuncia separatamente i due suoni alfabetici con il loro suono naturale, cioè duro e gutturale,
STUDIAMO INSIEME LA MUSICA
 ESTRATTI dal PRO MEMORIA DELLA TEORIA MUSICALE PAGINE DIMOSTRATIVE Dal Metodo STUDIAMO INSIEME LA MUSICA di ENNIO CAMEDDA Proprietà dell Autore www..bbrruunnooccaameeddddaa..ccoom Corso di Ammissione Lezione
ESTRATTI dal PRO MEMORIA DELLA TEORIA MUSICALE PAGINE DIMOSTRATIVE Dal Metodo STUDIAMO INSIEME LA MUSICA di ENNIO CAMEDDA Proprietà dell Autore www..bbrruunnooccaameeddddaa..ccoom Corso di Ammissione Lezione
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO LUCA SIGNORELLI - CORTONA GRECO BIENNIO
 GRECO BIENNIO Il Liceo Classico promuove lo studio delle lingue classiche per fornire agli studenti validi strumenti di comprensione e riflessione diretta sulla storia e l evoluzione delle civiltà greca
GRECO BIENNIO Il Liceo Classico promuove lo studio delle lingue classiche per fornire agli studenti validi strumenti di comprensione e riflessione diretta sulla storia e l evoluzione delle civiltà greca
MUSICHE E CANTI DELL ANTICA GRECIA
 MUSICHE E CANTI DELL ANTICA GRECIA Ricerche ed Osservazioni Allievo : Andrea Balzani Conservatorio A.Casella (L Aquila) Corso : Ear Training /Approfondimenti Teorici LA MUSICA GRECA La storia e l evoluzione
MUSICHE E CANTI DELL ANTICA GRECIA Ricerche ed Osservazioni Allievo : Andrea Balzani Conservatorio A.Casella (L Aquila) Corso : Ear Training /Approfondimenti Teorici LA MUSICA GRECA La storia e l evoluzione
Lezione 3 - Beati i miti
 Oggi vediamo una vocale che è molto, molto frequente in inglese, ma della cui esistenza è possibile che tu non sia consapevole. Com'è possibile che (forse) tu non conosca una vocale che è così importante?
Oggi vediamo una vocale che è molto, molto frequente in inglese, ma della cui esistenza è possibile che tu non sia consapevole. Com'è possibile che (forse) tu non conosca una vocale che è così importante?
FORME / tonalità e accordi
 Published on MUSIC-BOX (http://www.music-box.it) HOME > tonalità e accordi FORME / tonalità e accordi Parafrasando il titolo di un celebre libro, No man is an island" (nessun uomo è un isola), possiamo
Published on MUSIC-BOX (http://www.music-box.it) HOME > tonalità e accordi FORME / tonalità e accordi Parafrasando il titolo di un celebre libro, No man is an island" (nessun uomo è un isola), possiamo
Programmazione comune triennio LATINO E GRECO a.s
 Programmazione comune triennio LATINO E GRECO a.s. 2016-2017 Tale programmazione viene elaborata dal Dipartimento di Greco-Latino, tenuti presenti il DM 139 del 22 agosto 2007, il D.P.R. del 15 marzo 2010
Programmazione comune triennio LATINO E GRECO a.s. 2016-2017 Tale programmazione viene elaborata dal Dipartimento di Greco-Latino, tenuti presenti il DM 139 del 22 agosto 2007, il D.P.R. del 15 marzo 2010
LICEO GINNASIO LUCREZIO CARO. Programma di Latino
 LICEO GINNASIO LUCREZIO CARO ROMA Programma di Latino a.s. 2008/2009 Classe 2 Sez. E prof. Vulcano Ortenzi STORIA DELLA LETTERATURA LATINA Libro di testo: AA.VV., Genius loci, Loescher, Voll. I e II AA.VV.,
LICEO GINNASIO LUCREZIO CARO ROMA Programma di Latino a.s. 2008/2009 Classe 2 Sez. E prof. Vulcano Ortenzi STORIA DELLA LETTERATURA LATINA Libro di testo: AA.VV., Genius loci, Loescher, Voll. I e II AA.VV.,
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE prof.ssa ANTONELLA PERESSINI A.S. 2015/2016 CLASSE 1 ALL MATERIA: LINGUA LATINA
 PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE prof.ssa ANTONELLA PERESSINI A.S. 2015/2016 CLASSE 1 ALL MATERIA: LINGUA LATINA Modulo n. 1 INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL LATINO Collocazione temporale: settembre e ottobre riconoscere
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE prof.ssa ANTONELLA PERESSINI A.S. 2015/2016 CLASSE 1 ALL MATERIA: LINGUA LATINA Modulo n. 1 INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL LATINO Collocazione temporale: settembre e ottobre riconoscere
Strumenti dell analisi del testo poetico. Prof.ssa A. C. Napolitano
 Strumenti dell analisi del testo poetico. Prof.ssa A. C. Napolitano Aspetto formale Per una completa analisi del testo poetico occorrerà prestare attenzione a diversi livelli d indagine: - Livello fonico
Strumenti dell analisi del testo poetico. Prof.ssa A. C. Napolitano Aspetto formale Per una completa analisi del testo poetico occorrerà prestare attenzione a diversi livelli d indagine: - Livello fonico
LATINO E GRECO Programmazione comune per il secondo biennio e l anno conclusivo del liceo classico a.s
 LATINO E GRECO Programmazione comune per il secondo biennio e l anno conclusivo del liceo classico a.s. 2018-2019 Tale programmazione viene elaborata dal Dipartimento di Lettere, tenuti presenti il DM
LATINO E GRECO Programmazione comune per il secondo biennio e l anno conclusivo del liceo classico a.s. 2018-2019 Tale programmazione viene elaborata dal Dipartimento di Lettere, tenuti presenti il DM
Complementi: limitazione, qualità, agente, causa efficiente, fine
 LATINO CLASSE PRIMA Il concetto di declinazione, di caso, di coniugazione Complementi diretti: soggetto, parte nominale, complemento oggetto Attributo e apposizione L'alfabeto latino e la pronuncia Complementi:
LATINO CLASSE PRIMA Il concetto di declinazione, di caso, di coniugazione Complementi diretti: soggetto, parte nominale, complemento oggetto Attributo e apposizione L'alfabeto latino e la pronuncia Complementi:
INDICE. digitalisiert durch: IDS Basel Bern
 AVVERTENZA pag. VII Capitolo I - L'ORIGINALE DEL CANZONIERE» 1 1. L'originale dallo scrittoio di Petrarca a oggi» 1 2. Descrizione sintetica» 3 3. La scrittura di Petrarca e quella di Malpaghini» 6 4.
AVVERTENZA pag. VII Capitolo I - L'ORIGINALE DEL CANZONIERE» 1 1. L'originale dallo scrittoio di Petrarca a oggi» 1 2. Descrizione sintetica» 3 3. La scrittura di Petrarca e quella di Malpaghini» 6 4.
PARTE PRIMA - FONETICA
 Sommario PARTE PRIMA - FONETICA 1. Scrittura e pronuncia 3 1.1. Introduzione 3 1.2. L alfabeto: i segni grafici 6 1.2.1. La pronuncia del greco e la fonetica 7 1.2.2. Spiriti 10 1.2.3. Segni d interpunzione
Sommario PARTE PRIMA - FONETICA 1. Scrittura e pronuncia 3 1.1. Introduzione 3 1.2. L alfabeto: i segni grafici 6 1.2.1. La pronuncia del greco e la fonetica 7 1.2.2. Spiriti 10 1.2.3. Segni d interpunzione
Annotazioni metriche a Vento a Tìndari di Salvatore Quasimodo
 maggi-impaginato 21-12-2006 14:18 Pagina 1 DANIELE MAGGI Annotazioni metriche a Vento a Tìndari di Salvatore Quasimodo Tìndari, mite ti so fra larghi colli pensile sull acque dell isole dolci del dio,
maggi-impaginato 21-12-2006 14:18 Pagina 1 DANIELE MAGGI Annotazioni metriche a Vento a Tìndari di Salvatore Quasimodo Tìndari, mite ti so fra larghi colli pensile sull acque dell isole dolci del dio,
PIANO DI LAVORO. a.s. 2016/2017
 LICEO CLASSICO PITAGORA CROTONE PIANO DI LAVORO a.s. 2016/2017 Insegnante: Prof. FRANCESCO LOPEZ Materia: GRECO Classe: III Sez. E Indirizzo: «Non si impara il latino e il greco per parlare queste lingue
LICEO CLASSICO PITAGORA CROTONE PIANO DI LAVORO a.s. 2016/2017 Insegnante: Prof. FRANCESCO LOPEZ Materia: GRECO Classe: III Sez. E Indirizzo: «Non si impara il latino e il greco per parlare queste lingue
Nella musica il ritmo riguarda: la melodia, vale a dire la durata delle note (suoni) e delle pause (silenzi); la pulsazione, ovvero il battito
 IL RITMO NELLA DANZA Avere una conoscenza di base della musica, e in particolare del ritmo, ci aiuta a ballare in armonia con lo stile e il carattere di un brano, a memorizzare la coreografia, a coordinarci
IL RITMO NELLA DANZA Avere una conoscenza di base della musica, e in particolare del ritmo, ci aiuta a ballare in armonia con lo stile e il carattere di un brano, a memorizzare la coreografia, a coordinarci
DIZIONARIO DI METRICA E RETORICA
 DIZIONARIO DI METRICA E RETORICA aprile 26, 2009 Poesia religiosa Autori Canettieri Paolo Paolo Canettieri Indice dei lemmi Accento, accumulazione, acròstico, actio, acutezza, adynaton, aferesi, aforisma,
DIZIONARIO DI METRICA E RETORICA aprile 26, 2009 Poesia religiosa Autori Canettieri Paolo Paolo Canettieri Indice dei lemmi Accento, accumulazione, acròstico, actio, acutezza, adynaton, aferesi, aforisma,
TONALITÀ E ALTERAZIONI. Unità didattica di Educazione musicale
 TONALITÀ E ALTERAZIONI Unità didattica di Educazione musicale Partiamo dalla scala Tutti voi (almeno spero) avete presente la scala, cioè la successione di otto suoni (otto e non sette) che parte da Do.
TONALITÀ E ALTERAZIONI Unità didattica di Educazione musicale Partiamo dalla scala Tutti voi (almeno spero) avete presente la scala, cioè la successione di otto suoni (otto e non sette) che parte da Do.
PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO CLASSE N2GL ITALIANO
 PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO CLASSE N2GL Docente NANOCCHIO ANGELA Disciplina ITALIANO Materiali didattici: Viberti, Parliamoci chiaro Grammatica e scrittura, S.E.I., Torino 2014 De Costanzo- Bergomi
PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO CLASSE N2GL Docente NANOCCHIO ANGELA Disciplina ITALIANO Materiali didattici: Viberti, Parliamoci chiaro Grammatica e scrittura, S.E.I., Torino 2014 De Costanzo- Bergomi
IIS Via SILVESTRI 301 SEZIONE Liceo Scientifico M:MALPIGHI
 PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE IV SEZ. A IIS Via SILVESTRI 301 SEZIONE Liceo Scientifico M:MALPIGHI Docente: prof.ssa Gloria Galloni Anno scolastico: 2018-2019 Letteratura Italiana IL RINASCIMENTO: Il genere
PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE IV SEZ. A IIS Via SILVESTRI 301 SEZIONE Liceo Scientifico M:MALPIGHI Docente: prof.ssa Gloria Galloni Anno scolastico: 2018-2019 Letteratura Italiana IL RINASCIMENTO: Il genere
