Uva Rara. Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.
|
|
|
- Bartolommeo Piccinini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI Nome: N. Codice: 248 Sinonimi ufficiali: Data di ammissione: 25/05/1970, decreto pubblicato sulla G.U. 149 del 17/06/ INFORMAZIONI GENERALI Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: G. Dalmasso, M. Cacciatore ed A. Corte - "Uva rara", in Principali vitigni da vino coltivati in Italia - Volume II, Sinonimi (ed eventuali errati) Anche per l'"" (come per la "Vespolina" o "Uvetta") possiamo dire che è uno dei vitigni che hanno una sinonimia più complicata e discutibile. Se il nome di "" è comune in provincia di Pavia (specialmente nell'oltrepò pavese), in provincia di Novara (dove oggi è, insieme con la "Creatina", uno dei due vitigni più diffusi e coltivati nella parte collinare) lo si chiama più comunemente "Bonarda" e lo stesso dicasi per la zona collinare della prov. di Vercelli (che, come è noto, fino a non molti anni fa era tutt'uno con la prov. di Novara). Ora, già il di Rovasenda nel suo aureo Saggio annotava: ""Uva rara" - Voghera - identica alla "Bonarda" di Gattinara e Cavaglià. Non la direi "Bonarda"; preferisco il nome di "Uva rara", com'è realmente il suo grappolo". Già qualche anno prima (1873) lo stesso di Rovasenda, in un'ampia, interessante monografia su la "Bonarda nera", poneva bene in evidenza le sostanziali differenze fra questo vitigno e quello che noi consideriamo la vera "Bonarda", diffusa da tempo fra i colli di Torino e quelli dell'astigiano e del Monferrato. Egli però propendeva allora per chiamare quella novarese col nome di "Balsamea", sotto il quale egli l'aveva ricevuta da varie fonti (fra cui dall'odart!). Aggiungeva che riteneva che ad essa si dovessero riferire le descrizioni della "Bonarda" fatte dal Prof. Milano per le uve biellesi, e dal Dott. Gatta per quelle di Ivrea. Oggi, noi non possiamo che sottoscrivere pienamente alla opinione espressa dal grande ampelografo dell'ottocento circa l'identità dell'"uva rara" con questa pseudo "Bonarda". Un altro insigne ampelografo, il Molon, nella sua Ampelografia, preferì invece descrivere questo vitigno sotto il nome di "Bonarda di Gattinara", pur citando, come primo dei suoi vari sinonimi, quello di "Uva rara" (Voghera). Fra gli altri sinonimi (o nomi errati) egli ricorda i seguenti: "Rairon" (Casteggio) e "Rairone" (Groppello), che evidentemente sono varianti di "Uva rara"; "Martellana" (Stradella), "Oriola", tuttora usato nella zona di Borgomanero (con le varianti di "Oriana" e "Orianella"), "Foglia lucente" (sul Lago di Como); "Balsamina nera" o "Balsamea": nomi talora erroneamente attribuitile nel Novarese e altrove; "Raplum" (grappolone), talora usato ad Oleggio. Quest'ultimo nome è però anche attribuito alla "Durasa di Mezzomerico", che è tutt'altra cosa. L'erronea sinonimia di "Balsamina nera", che è ricordata anche da Mas et Pulliat nel loro Vignoble, è forse dovuta ad una supposizione dell'incisa, che, nominando la "Balsamina nera del Piemonte", aveva detto che "potrebbe essere la "Bonarda di Gattinara"". Però più tardi lo stesso Pulliat, nelle sue "Mille variétés de vignes" descrisse i due vitigni ("Balsamina" e "Uva rara") come indipendenti fra loro. Comunque, il Molon adottò il nome di "Bonarda di Gattinara", aggiungendo che potrebbe anche accettarsi quello di "Bonarda novarese". Sotto il nome di "Bonarda" senz'altre aggiunte, questo vitigno è stato accuratamente descritto fra i vitigni novaresi (e tale descrizione è stata letteralmente riportata dal Molon) nel Bollettino Ampelografico del 1879 in un'ampia relazione, presentata dallo stesso di Rovasenda, sui lavori della Commissione ampelografica della prov. di Novara; mentre in un Elenco dei vitigni della prov. di Pavia (comune per comune), pubblicato nello stesso Bollettino Ampelografico del 1881 figura talora sotto il nome di "Bonarda", tal'altra sotto quello di "Rara" o "Rairone". In un Catalogo ragionato di una Mostra d'uve tenuta in Como nell'ottobre 1890 per cura di quella Commissione Ampelografica provinciale esso figura come "Uva rara" (con sinon. di "Bonarda") nel Circondario di Varese, "Bonarda di Gattinara, Orianella, Balsamina" in alcuni paesi del Novarese. E potremmo continuare nelle citazioni per dimostrare quanto questi due nomi d'"uva rara" e di "Bonarda" siano stati e vengano tuttora largamente usati per indicare lo stesso vitigno. Ma poiché il nome di "Bonarda" è già attribuito a svariati vitigni, più o meno analoghi fra loro, non sembra giustificato adottarlo anche per questo, che dalla vera Bonarda si differenzia nettamente. Concludendo: noi riteniamo che il nome legittimo di questo vitigno debba essere quello di "Uva rara", che se si volesse conservare il Pagina 1 di 5 documento generato il , 17:20
2 sinonimo di "Bonarda" (Novarese o di Gattinara o di Cavaglià) bisognerebbe però, a scanso di equivoci, aggiungere l'aggettivo "falsa"... (il che probabilmente non suonerebbe gradito a coloro che l'hanno usato finora) Descrizione Ampelografica Per la descrizione che segue furono utilizzati tre cloni, due dei quali (situati l'uno in provincia di Novara, nel comune di Boca, e l'altro in provincia di Pavia, nel comune di Casteggio) vennero descritti contemporaneamente nel 1959, mentre il terzo (situato pur esso in provincia di Novara, nel comune di Ghemme) era stato descritto in precedenza per cura dell'ispettorato agrario provinciale di Novara. Inoltre, specialmente nel periodo che intercorre tra lo sviluppo completo delle foglie e la maturazione dell'uva, vennero stabiliti dei confronti tra i caratteri dei predetti cloni e quelli di altri ceppi dello stesso vitigno posti nelle località considerate. La presente descrizione ampelografica ha potuto essere agevolmente concordata in un testo unico, perché fra i caratteri dei tre cloni non si notarono differenze di qualche importanza. Le poche e lievi differenze riscontrate (riguardanti essenzialmente le foglie ed i tralci erbacei) vengono segnalate nel corso della descrizione stessa. Germoglio di cm Apice: espanso, cotonoso, bianco, con orlo carminato leggero. Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a): a coppa o a gronda, cotonose: di più sulla pagina inferiore; sulla pagina superiore talvolta la tomentosità diminuisce rapidamente dalla prima alla terza fogliolina. Color bianco (per il tomento) con bordi carminati; sulla terza fogliolina (pagina superiore) appare il color verde chiaro con riflessi bronzei. Foglioline basali (dalla 4a in poi): a coppa o a gronda nei cloni novaresi, a coppa nel clone pavese. Cotonose sulla pagina inferiore, quasi glabre sulla pagina superiore. Color verde con riflessi rameici sulla pagina superiore, bianco (per il tomento) sulla pagina inferiore. Asse del germoglio: leggermente ricurvo. Germoglio alla fioritura Apice: espanso (a volte medio nei cloni novaresi), cotonoso; bianco con orli carminati. Foglioline apicali: spiegate o quasi (le prime due leggermente a coppa o a gronda nel clone pavese); cotonose. Colore: con riflessi fulvi o rameici, visibili attraverso il biancore del tomento, prevalente nella pagina inferiore. Foglioline basali: piegate leggermente a coppa o a gronda, con bordi che tendono per lo più a volgersi in basso. Glabre sulla pagina superiore, leggermente feltrate sulla pagina inferiore. Colore: sulla pagina superiore verde chiaro (volgente al fulvo nei cloni novaresi); sulla pagina inferiore bianchiccio (per il tomento) su sfondo verde chiaro. Asse del germoglio: ricurvo a pastorale. Tralcio erbaceo: a sezione trasversale circolare; contorno liscio (o quasi liscio nel clone pavese); praticamente glabro (qualche raro pelo lungo, specialmente notato nel clone di Ghemme); color verde, rosso vinoso dalla parte soleggiata, uniformemente diffuso; internodi medio-corti. Viticci: intermittenti. Formula: (primo viticcio sul 6 nodo dall'inserzione). Bifidi o trifidi, medi, di color verde chiaro con sfumature rosse verso la base. Infiorescenza: piuttosto grande, conica, alata. Fiore: bottone fiorale piriforme-cilindroide, mezzano. Ermafrodita. Corolla a cappuccio, verde bronzata; apertura normale. Foglia adulta: grandezza media; forma pentagonale; quinquelobata. Seno peziolare a lira; seni laterali superiori per lo più a lira chiusa, spesso con bordi sovrapposti, più raramente ad U; seni laterali inferiori ad U od a lira, talvolta a V. Pagina superiore praticamente glabra (qualche raro pelo lungo); pagina inferiore cotonosa anche sulle nervature di ordine. Lembo generalmente piano (talvolta piegato a gronda nei cloni novaresi). Lobi piani, spesso con bordi un po' revoluti; angolo della sommità dei lobi terminali acuto. Superficie del lembo per lo più liscia (talvolta un po' vescicolosa nei cloni novaresi). Colore delle nervature principali: sulla pagina superiore, verde; sulla pagina inferiore, verde chiaro (con qualche lieve sfumatura rosea nel clone pavese). Denti laterali di media grandezza, irregolari, a base larga, con margini rettilinei. Lamina fogliare di colore verde più o meno carico sulla pagina superiore, verde chiaro sulla pagina inferiore; opaca; nervature di grado sporgenti, piane le altre. Picciolo: medio-corto (poco più corto della nervatura mediana): di media grossezza; con tomento aracnoideo; a sezione trasversale con canale poco evidente; di color verde chiaro con sfumature rosso vinose. Colorazione autunnale delle foglie: verde con macchie e striature gialle. Acino erbaceo: sferoide, ma abbastanza frequentemente discoide. Grappolo a maturità industriale: grandezza media (il volume dei grappoli è, in questo vitigno, piuttosto variabile). Mediamente compatto o sciolto (anche questo carattere è mutevole, per quanto la tendenza alla scioltezza sia evidente). Allungato, conico, alato (a volte conico senza ali, o talora anche piuttosto corto e tozzo). Peduncolo visibile, verde o semilegnoso, piuttosto grosso, di lunghezza pari a circa 1/4 quella del grappolo, che può mediamente ritenersi di cm Acino: medio o medio-grosso; tondeggiante o subellittico, regolare; ombelico prominente, non persistente; sezione trasversale circolare, regolare; buccia pruinosa, abbastanza consistente, ma non coriacea; Pagina 2 di 5 documento generato il , 17:20
3 color turchino carico, quasi nero, regolarmente diffuso; succo incolore; polpa succosa a sapore semplice; pedicello medio-lungo di colore rosso chiaro; cercine evidente di color rosso ruggine; pennello corto e rosso; separazione del pedicello dall'acino non facile. Vinaccioli: generalmente due per ogni acino, raramente tre, medi, con becco non lungo e non appuntito. Nessun acino è senza vinaccioli. Tralcio legnoso: lunghezza e robustezza medie; poco ramificato. Corteccia resistente, bene aderente. Sezione trasversale circolare o tendente all'ellittico. Superficie striata con striature non molto rilevate; parzialmente pruinosa. Nodi un po' appiattiti; meritalli medio-corti (però abbastanza variabili: in media di 10 cm.); gemme arrotondate, sporgenti, biancastre per tomentosità. Colore dei meritalli: su di uno sfondo nocciola chiaro, qua e là rossiccio (appena un po' più carico sui nodi) si ha quasi una patina grigio cinerea irregolarmente distribuita, con punteggiature brune non fitte. Cercine peziolare largo, sinuoso, sporgente. Diaframma convesso, spesso; midollo scuro, occupante circa metà del diametro del tralcio. Tronco: robusto (o mediamente robusto) Fenologia Condizioni d'osservazione: il primo clone (A) si trova nel comune di Casteggio, in località Mairano (prov. di Pavia), in un vigneto dei signori Venco Fratelli, il secondo (B) nel comune di Boca (prov. di Novara), in località Castello, in un vigneto del Comm. Minazzoli Pierino, il terzo (C) si trova nel comune di Ghemme (prov. di Novara) in località Fornace Baragioli, in un vigneto del signor Magistrini Carlo. Ubicazione Longitudine: (A) 9 07' merid. di Roma, (B) 4 03' ad ovest del merid. di Roma (M.te Mario), (C) 4 01' ad ovest del merid. di Roma (M.te Mario). Latitudine : (A) 45 N, (B) 45 42' N, (C) 54 36' N. Altitudine: (A) m. 115 s.l.m., (B) m. 400 circa s.l.m, (C) m. 280 circa s.l.m. Esposizione: (A) Nord-Est, (B) Sud-sud-ovest, (C) Ovest-sud-ovest. Portinnesto: (A) 3309, (B) Rip x Rup. 101/14, (C) Berl. x Rip. 420/A. Età delle viti: (A) 40 anni circa, (B) Anni 35, (C) anni 18. Sistema di allevamento: (A) a filari piuttosto alti, con branche laterali a guisa di cordoni (senza regola fissa), a circa m. 2 da terra, (B) quello detto localmente "Maggiorino" (dal comune di Maggiora) o "a quadretti". Le viti sono piantate a gruppi di due, alla distanza di m. 4 in quadrato fra i singoli gruppi, e sono allevate a piramide quadrangolare capovolta (ricavando due branche principali da ciascuna vite) fino all'altezza di metri 1,50-1,60 da terra, (C) come nel caso precedente. Forma di potatura: (A) lunga e ricca (una specie di Guyot multiplo, con capi a frutto in generale lunghi e numerosi), (B) lunga e ricca. Schematicamente: da ciascuna branca principale ascendente si fanno derivare (dirigendole orizzontalmente ed in sensi opposti) due branche secondarie, che porteranno i tralci annuali a frutto. Questi variano assai di numero e di sviluppo (secondo la robustezza della branca che li alimenta) e le branche - sia le primarie che le secondarie - hanno durata non definita, dipendente dalla frequenza colla quale il potatore ritiene di dover allevare tralci di sostituzione, (C) come nel caso precedente. Terreno: (A) di medio impasto, (B) collinare, a lieve pendio. Di natura argillosa (derivante da roccia feldspatica con ossidi di ferro) che non si impasta se bagnato; sciolto, profondo, fresco, di facile sgrondo, (C) Situato in bassa collina. Prevalentemente argilloso, derivante da remota bonifica di brughiera, profondo, poverissimo di calcare, a reazione subacida. Fenomeni vegetativi Germogliamento: verso il 20 aprile. Fioritura: giugno. Invaiatura: verso il 15 agosto. Arresto dell'accrescimento dei tralci: 5-10 agosto. Maturazione: tra la III e la IV epoca (5-10 ottobre). Caduta delle foglie: dalla fine di ottobre alla metà di novembre Caratteristiche ed Attitudini colturali Vigoria: notevole, senza però carattere di eccezionalità. Richiede potatura lunga ed abbastanza ricca. E' adatta per sistemi di allevamento espansi quali vengono tradizionalmente praticati nelle zone viticole considerate; sistemi che, per altro, sono suscettibili di perfezionamenti o di radicali sostituzioni. Produzione: nelle zone viticole delle provincie di Novara e Vercelli, i pratici fanno distinzione tra due sottovarietà di questo vitigno: l'una a gemme bene sviluppate e sporgenti, l'altra con caratteri opposti (detta localmente "a gemme corte"); ed eliminano accuratamente la seconda, come meno produttiva. Probabilmente per effetto di tale continua selezione, oltre che per condizioni d'ambiente particolarmente favorevoli, nelle suddette provincie la produttività dell' "Uva rara" è regolare e discretamente abbondante. In provincia di Pavia si lamenta invece una produzione di solito meno che normale, a causa della colatura, che è così frequente ed accentuata da rendere i grappoli eccessivamente spargoli. Nell'Oltrepò pavese, pertanto, converrebbe - poiché il vitigno è pregevole - impostare una accurata selezione, anche eventualmente con importazione di marze dalla provincia di Novara. Posizione del primo germoglio fruttifero: sul secondo o terzo Pagina 3 di 5 documento generato il , 17:20
4 nodo (anche sul primo, nel clone pavese). Numero medio di infiorescenze per germoglio: per lo più due; abbastanza sovente anche tre. Fertilità delle femminelle: saltuaria, ma senza importanza pratica. Resistenza alle avversità: ha resistenza normale alla peronospora, scarsa all'oidio. Va soggetta (specialmente nelle primavere piovose e fredde) alla colatura dei fiori; inconveniente, però, che - come s'è detto - è assai più lamentato nella zona viticola pavese che non in quella novarese-vercellese. Resiste abbastanza bene alle percosse della grandine (rimargina senza marcire) ed al marciume dell'uva, anche in fruttaio. Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: l'attecchimento per innesto e l'affinità coi portinnesti americani appaiono in generale buoni, non ottimi. I portinnesti più usati sono attualmente il Kober 5 BB ed il 420/A. Nel Novarese si ricorre ancora al 3309 ed al 101/14, mentre la Rupestris du Lot (già assai usata per questo ed altri vitigni) è in abbandono Utilizzazione L'"Uva rara", vinificata da sola, dà un vino da pasto discretamente alcoolico, di poco colore e di relativamente scarsa acidità, con profumo caratteristico gradevole. Praticamente, tuttavia, nel Novarese-Vercellese questo vino viene preparato solo in piccoli quantitativi per uso familiare, e nell'oltrepò pavese, dopo aver tentato - con l'"uva rara" - la confezione di vini rosati, vi si rinunciò, avendo ottenuto prodotti troppo scialbi, per scarsezza di acidità e di tannino. Normalmente la vinificazione di quest'uva viene fatta in mescolanze, con quelle di altri vitigni e in proporzioni solo di rado preventivamente stabilite. 3. COLTIVAZIONE 3.1 Classificazione Consigliata In tutta la regione: Piemonte Idonea In tutta la regione: Lombardia 3.2 DOP ed IGP La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche DOC Boca, Bonarda dell'oltrepo' Pavese, Bramaterra, Buttafuoco dell'oltrepo' Pavese o Buttafuoco, Canavese, Casteggio, Colline Novaresi, Fara, Oltrepo' Pavese, San Colombano al Lambro o san Colombano, Sangue di Giuda dell'oltrepo' Pavese o Sangue di Giuda, Sizzano IGT Alto Mincio, Bergamasca*, Collina del Milanese*, Provincia di Mantova, Provincia di Pavia*, Quistello*, Ronchi Varesini, Sabbioneta, Sebino, Alpi Retiche*, Terre Lariane * è ammessa la menzione di questa varietà in etichetta 4. CLONI ISCRITTI AL REGISTRO Codice Nome Data emanazione Codice proponente G.U. del 001 I - MI-UR G.U I - 6-RA /33 G.U I - CVT G.U I - CVT G.U I - UR /92 G.U Legenda codici proponenti 7 ) - Università degli Studi di Milano, Istituto di Patologia Vegetale 33 ) - Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale (Di.Pro.Ve.) - Sez. di Coltivazioni Arboree 12 ) - CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità Staccata di Grugliasco 92 ) - ERSAF Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all'agricoltura e alle Foreste 16 ) - Università Cattolica del "Sacro Cuore" - Facoltà di agraria di Piacenza Istituto di Fruttiviticoltura Pagina 4 di 5 documento generato il , 17:20
5 5. SUPERFICIE VITATA Evoluzione della superfice vitata dal 1970 ad oggi, rilevata dai censimenti ISTAT (dati espressi in ettari) PRODUZIONE VIVAISTICA Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2009 all'ultimo dato disponibile. Anno Standard Certificato Base Iniziale * * : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005 Pagina 5 di 5 documento generato il , 17:20
Registro Nazionale delle Varietà di Vite. Sinonimi (ed eventuali errati)
 Pagina 1 di 6 Home > Catalogo istituzionale > Informazioni sulla varietà > Scheda ampelografica Scarica la versione solo testo della scheda in formato.pdf Chardonnay di U. Benetti, A. Cersosimo ed I. Roncador
Pagina 1 di 6 Home > Catalogo istituzionale > Informazioni sulla varietà > Scheda ampelografica Scarica la versione solo testo della scheda in formato.pdf Chardonnay di U. Benetti, A. Cersosimo ed I. Roncador
MOSCATO BIANCO CN 4. Vitigni del Piemonte Varietà e Cloni
 MOSCATO BIANCO CN 4 Origine: Castiglione Tinella (CN). Anno di omologazione: 1980. Nucleo di premoltiplicazione: CE.PRE.MA.VI.-Regione Piemonte. Vigneto di riferimento: Canelli (AT); collinare, terreno
MOSCATO BIANCO CN 4 Origine: Castiglione Tinella (CN). Anno di omologazione: 1980. Nucleo di premoltiplicazione: CE.PRE.MA.VI.-Regione Piemonte. Vigneto di riferimento: Canelli (AT); collinare, terreno
DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA, BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Pasquarella C., Scaglione G.
 GERMOPLASMA CAMPANO 241 DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA, BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Pasquarella C., Scaglione G. SAN ANTONINO I - SINONIMI (ED EVENTUALI NOMI
GERMOPLASMA CAMPANO 241 DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA, BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Pasquarella C., Scaglione G. SAN ANTONINO I - SINONIMI (ED EVENTUALI NOMI
DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA, BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO Il" Pasquarella C., Vallefuoco S.B.
 GERMOPLASMA CAMPANO 139 DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA, BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO Il" Pasquarella C., Vallefuoco S.B., GELSO I - SINONIMI ED EVENTUALI NOMI
GERMOPLASMA CAMPANO 139 DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA, BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO Il" Pasquarella C., Vallefuoco S.B., GELSO I - SINONIMI ED EVENTUALI NOMI
VERNACCIA NERA GROSSA (CERRETANA) CENNI STORICI ED AREA DI DIFFUSIONE
 VERNACCIA NERA GROSSA (CERRETANA) CENNI STORICI ED AREA DI DIFFUSIONE La citazione più antica attualmente disponibile su questo vitigno è presente nel bollettino ampelografico numero X del 1877 (4) dove
VERNACCIA NERA GROSSA (CERRETANA) CENNI STORICI ED AREA DI DIFFUSIONE La citazione più antica attualmente disponibile su questo vitigno è presente nel bollettino ampelografico numero X del 1877 (4) dove
La tecnica colturale per il ciliegio ad alta densità in Germania
 La tecnica colturale per il ciliegio ad alta densità in Germania Martin Balmer DLR - Rheinpfalz Kompetenzzentrum Gartenbau Walporzheimer Str. 48 D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Mail: martin.balmer@dlr.rlp.de
La tecnica colturale per il ciliegio ad alta densità in Germania Martin Balmer DLR - Rheinpfalz Kompetenzzentrum Gartenbau Walporzheimer Str. 48 D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Mail: martin.balmer@dlr.rlp.de
vino e qualità in Lombardia
 vino e qualità in Lombardia L Unione Nazionale Consumatori della Lombardia con il presente opuscolo intende dare informazioni al consumatore sui marchi di qualità dei vini, sui vini di qualità della Lombardia
vino e qualità in Lombardia L Unione Nazionale Consumatori della Lombardia con il presente opuscolo intende dare informazioni al consumatore sui marchi di qualità dei vini, sui vini di qualità della Lombardia
Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Art. 1 Art. 2 Art. 3
 Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Decreto 19/5/1998 G.U. n 133 del 10/6/1998 Art. 1 La denominazione di origine controllata e
Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Decreto 19/5/1998 G.U. n 133 del 10/6/1998 Art. 1 La denominazione di origine controllata e
Febbraio Classe terza A: L ARANCIA
 Febbraio Classe terza A: L ARANCIA L arancia è il frutto dell albero dell arancio. Com'è la pianta L arancio è un albero sempreverde dalla bella chioma rotonda, che può arrivare fino a 10 metri. I rami
Febbraio Classe terza A: L ARANCIA L arancia è il frutto dell albero dell arancio. Com'è la pianta L arancio è un albero sempreverde dalla bella chioma rotonda, che può arrivare fino a 10 metri. I rami
La Signora Ines Tondini & Uva del Tundé. Azienda Agrituristica L Azdora. Via Vangaticcio 14 (RA); 0544/497669 335/6683087
 La Signora Ines Tondini & Uva del Tundé Azienda Agrituristica L Azdora Via Vangaticcio 14 (RA); 0544/497669 335/6683087 Vitigno Uva del Tundè Genere/specie: vite da uva rossa per vinificazione, appartenente
La Signora Ines Tondini & Uva del Tundé Azienda Agrituristica L Azdora Via Vangaticcio 14 (RA); 0544/497669 335/6683087 Vitigno Uva del Tundè Genere/specie: vite da uva rossa per vinificazione, appartenente
LAMBRUSCO. Pjaföc Provincia di Mantova Lambrusco IGT
 M A N T O V A M A N T O V A E stata fondata agli inizi del 1900 da Angelo Virgili, discendente di Luigi, che vide nella vigna una valida alternativa alla zootecnica radicata sul territorio. Fu così che
M A N T O V A M A N T O V A E stata fondata agli inizi del 1900 da Angelo Virgili, discendente di Luigi, che vide nella vigna una valida alternativa alla zootecnica radicata sul territorio. Fu così che
autocertificazione e prezzo sorgente il vino
 autocertificazione e prezzo sorgente il vino IL PRODUTTORE Nome produttore/azienda e ragione sociale: CANTINE DI Mezzaluna Azienda Vitivinicola Doria Elisabetta Elena Indirizzo: Loc. Casa Tacconi 1-27040
autocertificazione e prezzo sorgente il vino IL PRODUTTORE Nome produttore/azienda e ragione sociale: CANTINE DI Mezzaluna Azienda Vitivinicola Doria Elisabetta Elena Indirizzo: Loc. Casa Tacconi 1-27040
Evoluzione della disciplina europea nel settore del vino: dall'italia all'europa e ritorno
 Seminario VINO, PATRIMONIO E TERRITORIO Ordine degli Avvocati di Milano Milano, venerdì 8 maggio 2015 Evoluzione della disciplina europea nel settore del vino: dall'italia all'europa e ritorno Prof. Avv.
Seminario VINO, PATRIMONIO E TERRITORIO Ordine degli Avvocati di Milano Milano, venerdì 8 maggio 2015 Evoluzione della disciplina europea nel settore del vino: dall'italia all'europa e ritorno Prof. Avv.
UVA DA VINO STIMA DEI DANNI DA GRANDINE ED AVVERSITA ATMOSFERICHE
 Corso di formazione di avvio alla professione: Perito estimatore danni da avversità atmosferiche - Perito Grandine UVA DA VINO STIMA DEI DANNI DA GRANDINE ED AVVERSITA ATMOSFERICHE La garanzia assicurativa
Corso di formazione di avvio alla professione: Perito estimatore danni da avversità atmosferiche - Perito Grandine UVA DA VINO STIMA DEI DANNI DA GRANDINE ED AVVERSITA ATMOSFERICHE La garanzia assicurativa
Il pero è una specie assurgente; produce molti succhioni e rami verticali. Le forme che meglio si addicono sono: 3 Palmetta 3 Fusetto 3 Doppio asse
 PERO Il pero è una specie assurgente; produce molti succhioni e rami verticali. Le forme che meglio si addicono sono: 3 Palmetta 3 Fusetto 3 Doppio asse PALMETTA Nella forma moderna di palmetta (Fig.1),
PERO Il pero è una specie assurgente; produce molti succhioni e rami verticali. Le forme che meglio si addicono sono: 3 Palmetta 3 Fusetto 3 Doppio asse PALMETTA Nella forma moderna di palmetta (Fig.1),
IASMA ECO 4. Origine: Incrocio Moscato Ottonel x Malvasia di Candia
 IASMA ECO 4 Origine: Incrocio Moscato Ottonel x Malvasia di Candia CARATTERISTICHE ED ATTITUDINI COLTURALI IASMA ECO 4 Vitigno di buona vigoria con epoca di germogliamento media, acino medio ellittico
IASMA ECO 4 Origine: Incrocio Moscato Ottonel x Malvasia di Candia CARATTERISTICHE ED ATTITUDINI COLTURALI IASMA ECO 4 Vitigno di buona vigoria con epoca di germogliamento media, acino medio ellittico
Scheda tecnica di prodotto
 Albicocca Ninfa Bulida Tiryntos Bella d Italia Colore: giallo con sfumature di rosso Colore: arancio/giallo Colore: arancio/giallo Colore: giallo aranciato soffuso di rosso Forma: sferica Sapore: dolce,
Albicocca Ninfa Bulida Tiryntos Bella d Italia Colore: giallo con sfumature di rosso Colore: arancio/giallo Colore: arancio/giallo Colore: giallo aranciato soffuso di rosso Forma: sferica Sapore: dolce,
Carta Vini. Datemi libri, frutta, vino, un buon clima e un pò di musica fuori dalla porta, suonata da qualcuno che non conosco.
 Carta Vini Datemi libri, frutta, vino, un buon clima e un pò di musica fuori dalla porta, suonata da qualcuno che non conosco. John Keats CASTORE Cincinnato Bellone Lazio IGT Bianco Uva: Bellone 100% VIGNETI:
Carta Vini Datemi libri, frutta, vino, un buon clima e un pò di musica fuori dalla porta, suonata da qualcuno che non conosco. John Keats CASTORE Cincinnato Bellone Lazio IGT Bianco Uva: Bellone 100% VIGNETI:
Prodotti tipici lombardi
 Regione: Lombardia Prodotti tipici lombardi Oltre che nei campi artistico e letterario, influenzati da una storia millenaria che ha generato una terra dal patrimonio inestimabile, anche a tavola la Lombardia
Regione: Lombardia Prodotti tipici lombardi Oltre che nei campi artistico e letterario, influenzati da una storia millenaria che ha generato una terra dal patrimonio inestimabile, anche a tavola la Lombardia
Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI. Articolo 1 Denominazione e vini
 Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Grance Senesi» è riservata ai vini che
Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Grance Senesi» è riservata ai vini che
La vite e il vino in Toscana
 La vite e il vino in Toscana Campagna viticola 2014/2015 DATI STRUTTURALI E PRODUTTIVI Tabella n. 1: potenziale viticolo regionale, superficie vitata, aziende con vite e superficie media di vigneto per
La vite e il vino in Toscana Campagna viticola 2014/2015 DATI STRUTTURALI E PRODUTTIVI Tabella n. 1: potenziale viticolo regionale, superficie vitata, aziende con vite e superficie media di vigneto per
REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale Le Batteriosi dell Actinidia
 REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale Le Batteriosi dell Actinidia Il cancro batterico dell actinidia è stato segnalato per
REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale Le Batteriosi dell Actinidia Il cancro batterico dell actinidia è stato segnalato per
ALLEGATO L1 - Caratteristiche tecniche dei LED 1,8-3 - 4,8-5 mm (Ledz).
 ALLEGATO L1 - Caratteristiche tecniche dei LED 1,8-3 - 4,8-5 mm (Ledz). Tipo Colore (K) Caratteristiche elettriche e ottiche (*) Vf (V) If Intensità Angolo Tipica Max (ma) luminosa (cd) proiezione ( )
ALLEGATO L1 - Caratteristiche tecniche dei LED 1,8-3 - 4,8-5 mm (Ledz). Tipo Colore (K) Caratteristiche elettriche e ottiche (*) Vf (V) If Intensità Angolo Tipica Max (ma) luminosa (cd) proiezione ( )
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA CHIANTI PROPOSTA DI MODIFICA REDATTA SECONDO LO SCHEMA INDICATO DAL COMITATO NAZIONALE VINI Articolo 1 (denominazione
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA CHIANTI PROPOSTA DI MODIFICA REDATTA SECONDO LO SCHEMA INDICATO DAL COMITATO NAZIONALE VINI Articolo 1 (denominazione
DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA, BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO Il" Pallagrello Bianco
 DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA, BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO Il" Pasquarella C.,* Lauro P.,** D Auria G.*** Pallagrello Bianco Ecco primier già spillo Il dolce
DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA, BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO Il" Pasquarella C.,* Lauro P.,** D Auria G.*** Pallagrello Bianco Ecco primier già spillo Il dolce
POTATURA. Obiettivo principale:
 POTATURA Obiettivo principale: REGOLARE L'ATTIVITÀ VEGETATIVA E DI FRUTTIFICAZIONE PER CONSEGUIRE IL PIÙ RAPIDAMENTE POSSIBILE UNA PRODUZIONE ELEVATA, COSTANTE E DELLA MIGLIORE QUALITÀ POTATURA fattori
POTATURA Obiettivo principale: REGOLARE L'ATTIVITÀ VEGETATIVA E DI FRUTTIFICAZIONE PER CONSEGUIRE IL PIÙ RAPIDAMENTE POSSIBILE UNA PRODUZIONE ELEVATA, COSTANTE E DELLA MIGLIORE QUALITÀ POTATURA fattori
La Vinicola Broni SpA P.Iva 00794080150 Via Circonvallazione 93, 27043 Broni (Pavia) - Italy T. +39 0385 51528 F. +39 0385 54396 www.vinicolabroni.
 BARBERA La Barbera è uno dei vitigni piú coltivati nel comprensorio dell Oltrepò. Ha un tenore zuccherino che varia dal 16 al 20-22% in peso a seconda delle UVE BASE: Barbera 100% GRADAZIONE ALCOOLICA:
BARBERA La Barbera è uno dei vitigni piú coltivati nel comprensorio dell Oltrepò. Ha un tenore zuccherino che varia dal 16 al 20-22% in peso a seconda delle UVE BASE: Barbera 100% GRADAZIONE ALCOOLICA:
SINTESI DI ALCUNI DATI STATISTICI SULLA VITICOLTURA DEL PIEMONTE
 ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA SINTESI DI ALCUNI DATI STATISTICI SULLA VITICOLTURA DEL PIEMONTE * * * * * ANNATA AGRARIA 2014/2015 E CONFRONTI CON LA PRECEDENTE TORINO, NOVEMBRE 2015 C.so Stati
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA SINTESI DI ALCUNI DATI STATISTICI SULLA VITICOLTURA DEL PIEMONTE * * * * * ANNATA AGRARIA 2014/2015 E CONFRONTI CON LA PRECEDENTE TORINO, NOVEMBRE 2015 C.so Stati
5. MANUALE D USO DEL TERRITORIO
 5. MANUALE D USO DEL TERRITORIO 81 5. MANUALE D USO DEL TERRITORIO Clima, morfologia della superficie e suolo sono i tre fattori naturali che maggiormente caratterizzano un ambiente viticolo. Da un lontano
5. MANUALE D USO DEL TERRITORIO 81 5. MANUALE D USO DEL TERRITORIO Clima, morfologia della superficie e suolo sono i tre fattori naturali che maggiormente caratterizzano un ambiente viticolo. Da un lontano
LA MONTAGNA FONTE DI BENESSERE E DI VITA
 LA MONTAGNA FONTE DI BENESSERE E DI VITA Quando parlo della montagna intendo quella zona che parte dall altezza di 700 metri, ove situo il limite superiore del clima di collina e giunge fino a 1600 metri,
LA MONTAGNA FONTE DI BENESSERE E DI VITA Quando parlo della montagna intendo quella zona che parte dall altezza di 700 metri, ove situo il limite superiore del clima di collina e giunge fino a 1600 metri,
PROTEZIONE INTEGRATA CONTRO LA MUFFA GRIGIA
 Una crittogama devastante della qualità dell uva e del vino PROTEZIONE INTEGRATA CONTRO LA MUFFA GRIGIA La botrite o muffa grigia della vite è causata da un fungo che nella sua forma assessuata prende
Una crittogama devastante della qualità dell uva e del vino PROTEZIONE INTEGRATA CONTRO LA MUFFA GRIGIA La botrite o muffa grigia della vite è causata da un fungo che nella sua forma assessuata prende
Densità di impianto: distanza tra le piante sul filare e tra i filari (da Fregoni 1984 e Calò 1987)
 Densità di impianto: distanza tra le piante sul filare e tra i filari (da Fregoni 1984 e Calò 1987) Prima regola: oltre un certo carico produttivo per ceppo la qualità diminuisce ( ) Fittezza in relazione
Densità di impianto: distanza tra le piante sul filare e tra i filari (da Fregoni 1984 e Calò 1987) Prima regola: oltre un certo carico produttivo per ceppo la qualità diminuisce ( ) Fittezza in relazione
GUTTURNIO DOC VIGNA COSTONE
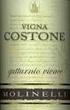 GUTTURNIO DOC VIGNA COSTONE UVE DI PRODUZIONE: DI SERVIZIO: GUTTURNIO DOC COLLI PIACENTINI VIVACE 60% Barbera 40% Bonarda Vigneti di proprietà dell'azienda Agricola Molinelli siti nel comune di Ziano P.no.
GUTTURNIO DOC VIGNA COSTONE UVE DI PRODUZIONE: DI SERVIZIO: GUTTURNIO DOC COLLI PIACENTINI VIVACE 60% Barbera 40% Bonarda Vigneti di proprietà dell'azienda Agricola Molinelli siti nel comune di Ziano P.no.
Schede tecniche LA SOURCE
 Schede tecniche LA SOURCE s.a.s di Celi Stefano & C. Società Agricola - C.F. e P. IVA 01054500077 Loc. Bussan Dessous, 1-11010 Saint-Pierre (AO) - Cell: 335.6613179 - info@lasource.it Documento scaricato
Schede tecniche LA SOURCE s.a.s di Celi Stefano & C. Società Agricola - C.F. e P. IVA 01054500077 Loc. Bussan Dessous, 1-11010 Saint-Pierre (AO) - Cell: 335.6613179 - info@lasource.it Documento scaricato
Rosso Piceno D.o.c. Abbinamenti consigliati: ideale per carni saporite, affettati, formaggi stagionati, paste ripiene. Tenore alcolico: 12,50 vol.
 Rosso Piceno D.o.c. Uvaggio: Montepulciano (60%) Sangiovese (25%) Merlot (15%) Sistema di allevamento: cordone speronato Resa per ettaro : 70-80 q.li di uva Epoca vendemmia: Fine settembre/primi di ottobre
Rosso Piceno D.o.c. Uvaggio: Montepulciano (60%) Sangiovese (25%) Merlot (15%) Sistema di allevamento: cordone speronato Resa per ettaro : 70-80 q.li di uva Epoca vendemmia: Fine settembre/primi di ottobre
a suo piacimento, è il punto durante l annata con conseguente sviluppo di gemme latenti e
 Lo 5 Diffusione : 12000 Pagina 20 : RIPENSARELA POTATURA perseguire le esigenze e gli equilibri della vite Inun mondo in continua evoluzione molto spesso le risposte a problematiche attuali s? ottengono
Lo 5 Diffusione : 12000 Pagina 20 : RIPENSARELA POTATURA perseguire le esigenze e gli equilibri della vite Inun mondo in continua evoluzione molto spesso le risposte a problematiche attuali s? ottengono
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE
 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE Approvato con DM 09.10.1995 G.U. 250-25.10.1995 Modificato con DM 22.11.1995 G.U. 300-27.12.1995 Modificato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE Approvato con DM 09.10.1995 G.U. 250-25.10.1995 Modificato con DM 22.11.1995 G.U. 300-27.12.1995 Modificato
Provincia della Spezia
 Provincia della Spezia La Provincia della Spezia è la più orientale delle province liguri. Ha circa 220.000 abitanti, di cui 90.000 nella città capoluogo. Confina con la provincia di Genova ad est, con
Provincia della Spezia La Provincia della Spezia è la più orientale delle province liguri. Ha circa 220.000 abitanti, di cui 90.000 nella città capoluogo. Confina con la provincia di Genova ad est, con
RAINOLDI CHIURO SONDRIO
 GRUMELLO D.O.C.G. Vino proveniente dalla sottozona della Valtellina Superiore che prende il nome dall omonimo castello risalente al XI secolo. Rosso di alta personalità con buone caratteristiche di corpo
GRUMELLO D.O.C.G. Vino proveniente dalla sottozona della Valtellina Superiore che prende il nome dall omonimo castello risalente al XI secolo. Rosso di alta personalità con buone caratteristiche di corpo
N. piante presenti. Anno d impianto. Accessioni valutate
 VITE Famiglia: Vitaceae Genere: Vitis Specie: Vitis vinifera L. Nome comune: Canina nera Codice iscrizione Registro nazionale: 50 Sinonimi accertati: Canina, Canèna, Cannina Sinonimie errate: Cagnina,
VITE Famiglia: Vitaceae Genere: Vitis Specie: Vitis vinifera L. Nome comune: Canina nera Codice iscrizione Registro nazionale: 50 Sinonimi accertati: Canina, Canèna, Cannina Sinonimie errate: Cagnina,
del Taurasi 32 Aglianico Caratteristiche colturali ed attitudini produttive
 32 Aglianico del Taurasi Viene coltivato in Campania in particolare nelle provincie di Benevento, Caserta e Avellino. Fa parte della "famiglia" degli Aglianici che ha dato origine ad un'ampia variabilità
32 Aglianico del Taurasi Viene coltivato in Campania in particolare nelle provincie di Benevento, Caserta e Avellino. Fa parte della "famiglia" degli Aglianici che ha dato origine ad un'ampia variabilità
LUGANA D.O.P. Linea Pergola
 scheda aggiornata il 11/3/2015 LUGANA D.O.P. Linea Pergola Colline moreniche della Lugana nei pressi di Sirmione, lungo la sponda sud del Lago di Garda. Trebbiano di Lugana (noto anche come Turbiana) in
scheda aggiornata il 11/3/2015 LUGANA D.O.P. Linea Pergola Colline moreniche della Lugana nei pressi di Sirmione, lungo la sponda sud del Lago di Garda. Trebbiano di Lugana (noto anche come Turbiana) in
C A G N U L A R I - I S O L A D E I N U R A G H I I. G. T.
 C A G N U L A R I - I S O L A D E I N U R A G H I I. G. T. Zona di produzione: Vigneti siti nelle colline calcaree del comune di Usini con viti allevate ad alberello. Tecnica di Produzione: Vinificazione
C A G N U L A R I - I S O L A D E I N U R A G H I I. G. T. Zona di produzione: Vigneti siti nelle colline calcaree del comune di Usini con viti allevate ad alberello. Tecnica di Produzione: Vinificazione
Viola Enoteca LA CANTINA DEL MESE
 Viola Enoteca LA CANTINA DEL MESE Ogni mese VIOLA, presenterà una cantina, della sua selezione, al suo pubblico di appassionati per farne apprezzare e condividere le qualità. Ci piace l idea di coinvolgere
Viola Enoteca LA CANTINA DEL MESE Ogni mese VIOLA, presenterà una cantina, della sua selezione, al suo pubblico di appassionati per farne apprezzare e condividere le qualità. Ci piace l idea di coinvolgere
- Contatti 36. - Presentazione 4. - Attività svolta 8
 - Presentazione 4 - Attività svolta 8 - Schede Cloni Vitis Vinifera Catarratto bianco comune CS1 12 Carricante CR7 14 Damaschino DF1 16 Frappato FC26 18 Frappato FC32 20 Malvasia bianca MC1 22 Moscato
- Presentazione 4 - Attività svolta 8 - Schede Cloni Vitis Vinifera Catarratto bianco comune CS1 12 Carricante CR7 14 Damaschino DF1 16 Frappato FC26 18 Frappato FC32 20 Malvasia bianca MC1 22 Moscato
Vivaio Biologico Carlo Lonsi. Cenaia (PI) 2012
 Effetti sull innesto di vite europea su americana in rapporto ai diversi impulsi planetari e lunari: 4 diversi giorni Vivaio Biologico Carlo Lonsi. Cenaia (PI) 2012 Il vivaio Biologico di Carlo Lonsi -
Effetti sull innesto di vite europea su americana in rapporto ai diversi impulsi planetari e lunari: 4 diversi giorni Vivaio Biologico Carlo Lonsi. Cenaia (PI) 2012 Il vivaio Biologico di Carlo Lonsi -
ETOILEPEDIA ARANCIA CONSERVAZIONE CARATTERISTICHE
 ARANCIA STORIA E ORIGINE Originario di Cina, Indocina ed altri paesi del Sud Est asiatico, dove è coltivato da molti secoli, l'arancio (Citrus Sinensis) si diffuse nel bacino del Mediterraneo in tempi
ARANCIA STORIA E ORIGINE Originario di Cina, Indocina ed altri paesi del Sud Est asiatico, dove è coltivato da molti secoli, l'arancio (Citrus Sinensis) si diffuse nel bacino del Mediterraneo in tempi
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «STREVI»
 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «STREVI» Approvato con DM 06.07.2005 GU 163-15.07.2005 Modificato con DM 30.11.2011 GU 295-20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «STREVI» Approvato con DM 06.07.2005 GU 163-15.07.2005 Modificato con DM 30.11.2011 GU 295-20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale
VINI DOP E IGP DATI ECONOMICI E STRUTTURA DEL SISTEMA DELLA VITICOLTURA DI QUALITÀ IN ITALIA
 VINI DOP E IGP DATI ECONOMICI E STRUTTURA DEL SISTEMA DELLA VITICOLTURA DI QUALITÀ IN ITALIA www.ismea.it www.ismeaservizi.it L UNIVERSO DI RIFERIMENTO DELL ANALISI IL NUMERO DEI RICONOSCIMENTI TOTALI:
VINI DOP E IGP DATI ECONOMICI E STRUTTURA DEL SISTEMA DELLA VITICOLTURA DI QUALITÀ IN ITALIA www.ismea.it www.ismeaservizi.it L UNIVERSO DI RIFERIMENTO DELL ANALISI IL NUMERO DEI RICONOSCIMENTI TOTALI:
Le piante. Sulla terra esistono vari tipi di piante: legnose ed erbacee a seconda delle dimensioni e della forma del fusto.
 di Gaia Brancati Le piante Sulla terra esistono vari tipi di piante: legnose ed erbacee a seconda delle dimensioni e della forma del fusto. Il fusto Il fusto tende a crescere verso l alto. Quando esso
di Gaia Brancati Le piante Sulla terra esistono vari tipi di piante: legnose ed erbacee a seconda delle dimensioni e della forma del fusto. Il fusto Il fusto tende a crescere verso l alto. Quando esso
Vino (categoria di prodotto)
 DESIGNAZIONE VINI (ex tavola) NON A DOP/IGT SCHEMI DI ETICHETTE Vino (categoria di prodotto) imbottigliato da Bianchi Mario, Casteggio, stabilimento di Voghera Italia o Prodotto d Italia o Vino d Italia
DESIGNAZIONE VINI (ex tavola) NON A DOP/IGT SCHEMI DI ETICHETTE Vino (categoria di prodotto) imbottigliato da Bianchi Mario, Casteggio, stabilimento di Voghera Italia o Prodotto d Italia o Vino d Italia
39 37024 045 6000728 F
 Note di Vino Stralci dialle Vitae Teniamo nostre terre oggi la nostra azienda è di sedici ettari di cui dieci coltivati a vigneto divisi in due corpi distanti tra loro, da negrar a sant ambrogio nella
Note di Vino Stralci dialle Vitae Teniamo nostre terre oggi la nostra azienda è di sedici ettari di cui dieci coltivati a vigneto divisi in due corpi distanti tra loro, da negrar a sant ambrogio nella
VIVAI COOPERATIVI di PADERGNONE Abbiamo radici antiche e forti
 VIVAI COOPERATIVI di PADERGNONE Abbiamo radici antiche e forti Il vivaismo trentino nasce con l avvento della filossera, ennesimo riproporsi di calamità naturali che risveglia l ingegno e la capacità degli
VIVAI COOPERATIVI di PADERGNONE Abbiamo radici antiche e forti Il vivaismo trentino nasce con l avvento della filossera, ennesimo riproporsi di calamità naturali che risveglia l ingegno e la capacità degli
La Corsa Società Agricola S.r.l.
 I Nostri Vini MANDRIONE 2009 DENOMINAZIONE: IGT Maremma Sangiovese 2009 VARIETA : Sangiovese 100% SUPERFICIE VITATA: 15 ha ANNO DI IMPIANTO VIGNETI: 2004 MATURAZIONE ED AFFINAMENTO: in barriques di legni
I Nostri Vini MANDRIONE 2009 DENOMINAZIONE: IGT Maremma Sangiovese 2009 VARIETA : Sangiovese 100% SUPERFICIE VITATA: 15 ha ANNO DI IMPIANTO VIGNETI: 2004 MATURAZIONE ED AFFINAMENTO: in barriques di legni
Grillo. Il GRILLO è principalmente diffuso nel territorio di Trapani, dove costituisce il vitigno base per produrre i migliori vini DOC Marsala.
 Vivai Ampola S.R.L. Catalogo Generale Patrimonio ampelografico siciliano: Vitigni autoctoni siciliani di interesse Regionali (Catarratto, Frappato, Greganico, Grillo, Insolia, Nero d Avola, Nerello mascalese).
Vivai Ampola S.R.L. Catalogo Generale Patrimonio ampelografico siciliano: Vitigni autoctoni siciliani di interesse Regionali (Catarratto, Frappato, Greganico, Grillo, Insolia, Nero d Avola, Nerello mascalese).
Venerdì 5 Febbraio 2016 Padiglione 4, area Unione Italiana Vini (ore 11.00) GESTIONE DELLA CHIOMA: POTATURA E SANITA DELLE PIANTE
 Venerdì 5 Febbraio 2016 Padiglione 4, area Unione Italiana Vini (ore 11.00) STEFANO PONI STEFANO.PONI@UNICATT.IT UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE I BISOGNI D INNOVAZIONE In tema di rapporti tra potatura
Venerdì 5 Febbraio 2016 Padiglione 4, area Unione Italiana Vini (ore 11.00) STEFANO PONI STEFANO.PONI@UNICATT.IT UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE I BISOGNI D INNOVAZIONE In tema di rapporti tra potatura
LA SITUAZIONE DELL ACTINIDICOLTURA MONDIALE AL 2010/2011
 LA SITUAZIONE DELL ACTINIDICOLTURA MONDIALE AL 2010/2011 Ottavio Cacioppo La situazione dell actinidicoltura mondiale, salvo una leggera flessione della superficie, dovuta alla batteriosi, è stazionaria,
LA SITUAZIONE DELL ACTINIDICOLTURA MONDIALE AL 2010/2011 Ottavio Cacioppo La situazione dell actinidicoltura mondiale, salvo una leggera flessione della superficie, dovuta alla batteriosi, è stazionaria,
DOLCETTO D ACQUI PIEMONTE GRIGNOLINO BARBERA MONFERRATO. Denominazione di Origine Controllata. Denominazione di Origine Controllata
 Piemonte Piemonte Piemonte DOLCETTO D ACQUI PIEMONTE GRIGNOLINO BARBERA MONFERRATO ZONA DI PRODUZIONE Colline del Monferrato, province di Alessandria e Asti ZONA DI PRODUZIONE Colline del Monferrato, nelle
Piemonte Piemonte Piemonte DOLCETTO D ACQUI PIEMONTE GRIGNOLINO BARBERA MONFERRATO ZONA DI PRODUZIONE Colline del Monferrato, province di Alessandria e Asti ZONA DI PRODUZIONE Colline del Monferrato, nelle
Piante certificate: necessità e vantaggi
 Département fédéral de l'économie DFE Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW Piante certificate: necessità e vantaggi 30 novembre 2012 Certificazione Basi legali 1. Ordinanza federale (RS
Département fédéral de l'économie DFE Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW Piante certificate: necessità e vantaggi 30 novembre 2012 Certificazione Basi legali 1. Ordinanza federale (RS
Le origini. Storia del Sagrantino. Morfologia del terreno
 Il Sagrantino è un vitigno autoctono che cresce da secoli solo nella zona di Montefalco e che non ha alcuna parentela con altre uve rosse tipiche del centro Italia. Le origini Diverse sono le testimonianze
Il Sagrantino è un vitigno autoctono che cresce da secoli solo nella zona di Montefalco e che non ha alcuna parentela con altre uve rosse tipiche del centro Italia. Le origini Diverse sono le testimonianze
Il settore agro-alimentare in Italia. Focus sul lattiero caseario. Direzione Studi e Ricerche
 Il settore agro-alimentare in Italia. Focus sul lattiero caseario Direzione Studi e Ricerche Milano, 30 Marzo 2016 Agenda 1 Importanza e specificità dell agroalimentare italiano 2 Il lattiero caseario
Il settore agro-alimentare in Italia. Focus sul lattiero caseario Direzione Studi e Ricerche Milano, 30 Marzo 2016 Agenda 1 Importanza e specificità dell agroalimentare italiano 2 Il lattiero caseario
 SORRETTOLE TIPOLOGIA: Chianti d.o.c.g. SUPERFICE VIGNETO: ettari 4,5 ESPOSIZIONE E PENDENZA: Sud, 25-30 %(3,5 ha) NordEst 25% (1 ha). ANNO D IMPIANTO: 1999 e 2003. UVAGGIO: Sangiovese 80 % Colorino 10
SORRETTOLE TIPOLOGIA: Chianti d.o.c.g. SUPERFICE VIGNETO: ettari 4,5 ESPOSIZIONE E PENDENZA: Sud, 25-30 %(3,5 ha) NordEst 25% (1 ha). ANNO D IMPIANTO: 1999 e 2003. UVAGGIO: Sangiovese 80 % Colorino 10
si comporta come perenne grazie alla sua propagazione attraverso i tuberi
 LA PATATA Famiglia delle solanacee Genere solanum Pianta erbacea coltivata come annuale ma che in natura si comporta come perenne grazie alla sua propagazione attraverso i tuberi I fiori sono riuniti a
LA PATATA Famiglia delle solanacee Genere solanum Pianta erbacea coltivata come annuale ma che in natura si comporta come perenne grazie alla sua propagazione attraverso i tuberi I fiori sono riuniti a
IL DECRETO LEGISLATIVO 61/2010: LE NUOVE NORME PER I VINI DI QUALITA
 1 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IL DECRETO LEGISLATIVO 61/2010: LE NUOVE NORME PER I VINI DI QUALITA SOMMARIO Premessa Quadro normativo europeo Quadro normativo nazionale
1 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IL DECRETO LEGISLATIVO 61/2010: LE NUOVE NORME PER I VINI DI QUALITA SOMMARIO Premessa Quadro normativo europeo Quadro normativo nazionale
Abies, Abete (Pinaceae)
 , Abete (Pinaceae) Conifera dalla forma elegante e imponente, quasi sempre conica, molto diffusa come pianta ornamentale nei giardini e nei parchi pubblici e privati, in particolare per il colore degli
, Abete (Pinaceae) Conifera dalla forma elegante e imponente, quasi sempre conica, molto diffusa come pianta ornamentale nei giardini e nei parchi pubblici e privati, in particolare per il colore degli
RIDUZIONE-CONTENIMENTO DELLE DIMENSIONI Serve a contenere la pianta entro certe dimensioni compatibili col contesto circostante (edifici, linee
 RIDUZIONE-CONTENIMENTO DELLE DIMENSIONI Serve a contenere la pianta entro certe dimensioni compatibili col contesto circostante (edifici, linee elettriche, ecc ) RIDUZIONE-CONTENIMENTO DELLE DIMENSIONI
RIDUZIONE-CONTENIMENTO DELLE DIMENSIONI Serve a contenere la pianta entro certe dimensioni compatibili col contesto circostante (edifici, linee elettriche, ecc ) RIDUZIONE-CONTENIMENTO DELLE DIMENSIONI
VINI & VITIGNI: DEGUSTAZIONE VERTICALE DI BRAMATERRA AZIENDA LA PALAZZINA DI ROASIO
 VINI & VITIGNI Il Bramaterra è vino di territorio collinare, prodotto da uve di vigneti circondati dai boschi, su rocce di quarzo e porfido, in terreni acidi e poveri, che possono bene esaltare le caratteristiche
VINI & VITIGNI Il Bramaterra è vino di territorio collinare, prodotto da uve di vigneti circondati dai boschi, su rocce di quarzo e porfido, in terreni acidi e poveri, che possono bene esaltare le caratteristiche
ROSSO DI MONTALCINO COLLELCETO ROSSO
 DI MONTALCINO COLLELCETO DI MONTALCINO DOC MONTALCINO SANGIOVESE 100% MONTALCINO BOTTE GRANDE BOTTIGLIA 13,5 RUBINO CARICO Note aromatiche di frutta rossa, tannino morbido 18 BRUNELLO DI MONTALCINO COLLELCETO
DI MONTALCINO COLLELCETO DI MONTALCINO DOC MONTALCINO SANGIOVESE 100% MONTALCINO BOTTE GRANDE BOTTIGLIA 13,5 RUBINO CARICO Note aromatiche di frutta rossa, tannino morbido 18 BRUNELLO DI MONTALCINO COLLELCETO
VIVERE LA TERRA: ESPLORO, CONOSCO ED ASSAGGIO
 I.I.S. L.Des Ambrois Oulx (To) PROGETTO VIVERE LA TERRA: ESPLORO, CONOSCO ED ASSAGGIO Scuola Media - Classi Prime a.s. 2012-13 13 PROGETTO FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI TORINO Programma L educazione alimentare
I.I.S. L.Des Ambrois Oulx (To) PROGETTO VIVERE LA TERRA: ESPLORO, CONOSCO ED ASSAGGIO Scuola Media - Classi Prime a.s. 2012-13 13 PROGETTO FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI TORINO Programma L educazione alimentare
POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2014
 C.E.C.A.T. Castelfranco V.to COMUNICATO TECNICO n 1/2014 (9-01-2014) PROGETTO VITE POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2014 Per ottenere dal vigneto il risultato migliore intermini di qualità
C.E.C.A.T. Castelfranco V.to COMUNICATO TECNICO n 1/2014 (9-01-2014) PROGETTO VITE POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2014 Per ottenere dal vigneto il risultato migliore intermini di qualità
Giovanni Nigro Responsabile della Filiera Vitivinicola ed Olivo-Oleicola. E-mail: gnigro@crpv.it
 Giovanni Nigro Responsabile della Filiera Vitivinicola ed Olivo-Oleicola E-mail: gnigro@crpv.it Progetto vitigni minori Valutazione di vecchie varietà di vite locali in funzione della diversificazione
Giovanni Nigro Responsabile della Filiera Vitivinicola ed Olivo-Oleicola E-mail: gnigro@crpv.it Progetto vitigni minori Valutazione di vecchie varietà di vite locali in funzione della diversificazione
Scelta varietale. standard produttivo innovazioni varietali miglioramento genetico
 Scelta varietale standard produttivo innovazioni varietali miglioramento genetico Problematiche varietali del susino europeo in Italia Le cultivar valide sono poche e perlopiù a maturazione tardiva Poche
Scelta varietale standard produttivo innovazioni varietali miglioramento genetico Problematiche varietali del susino europeo in Italia Le cultivar valide sono poche e perlopiù a maturazione tardiva Poche
Oltrepo Pavese Azienda vinicola con cantina e casali in vendita Lombardia vendita aziende vinicole
 Ville@Casali Real Estate s.r.l. Telefono: 800 984 481 Email: info@villeecasalinetwork.com Oltrepo Pavese Azienda vinicola con cantina e casali in vendita Lombardia vendita aziende vinicole Oltrepò Pavese,
Ville@Casali Real Estate s.r.l. Telefono: 800 984 481 Email: info@villeecasalinetwork.com Oltrepo Pavese Azienda vinicola con cantina e casali in vendita Lombardia vendita aziende vinicole Oltrepò Pavese,
La terra parla, noi l ascoltiamo. www.valdamonte.it
 La terra parla, noi l ascoltiamo 347 M.S.L.M Media fascia collinare della Valle Versa, nel comune di Santa Maria con esposizione ad ovest. ALTITUDINE: 340-350 mslm ETA DEI VIGNETI: 10 anni UVAGGIO: barbera
La terra parla, noi l ascoltiamo 347 M.S.L.M Media fascia collinare della Valle Versa, nel comune di Santa Maria con esposizione ad ovest. ALTITUDINE: 340-350 mslm ETA DEI VIGNETI: 10 anni UVAGGIO: barbera
LA SELEZIONE CLONALE DELLA VITE IN ITALIA
 LA SELEZIONE CLONALE DELLA VITE IN ITALIA Mannini Franco - Istituto Virologia Vegetale, Unità Staccata Viticoltura, CNR, Grugliasco (TO) 1. Introduzione Negli ultimi decenni in tutti i Paesi in cui il
LA SELEZIONE CLONALE DELLA VITE IN ITALIA Mannini Franco - Istituto Virologia Vegetale, Unità Staccata Viticoltura, CNR, Grugliasco (TO) 1. Introduzione Negli ultimi decenni in tutti i Paesi in cui il
Giornate tecniche 2011
 Giornate tecniche 2011 Seminario: Aspetti teorici e applicativi della potatura delle piante da frutto Relatore: dott. agr. Salvatore Gaudio Data: 12 febbraio 2011 Aspetti teorici ed applicativi della potatura
Giornate tecniche 2011 Seminario: Aspetti teorici e applicativi della potatura delle piante da frutto Relatore: dott. agr. Salvatore Gaudio Data: 12 febbraio 2011 Aspetti teorici ed applicativi della potatura
BURACO MARCHE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA ROSSO
 BURACO MARCHE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA ROSSO Vino dal colore rosso rubino intenso con sfumature violacee, dal profumo persistente, complesso, ampio leggermente speziato ricorda la ciliegia matura
BURACO MARCHE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA ROSSO Vino dal colore rosso rubino intenso con sfumature violacee, dal profumo persistente, complesso, ampio leggermente speziato ricorda la ciliegia matura
Accessioni valutate presenti d impianto 1) Azienda Venturelli Vincenzo Modena 100 innestate 1990 circa. 200 circa 2000
 SCHEDA TECNICA PER L ISCRIZIONE AL REPERTORIO VITE Famiglia: Vitaceae Genere: Vitis Specie: Vitis vinifera L. Nome comune: Trebbianina Codice iscrizione Registro nazionale: 434 Sinonimi accertati: Trebbiano
SCHEDA TECNICA PER L ISCRIZIONE AL REPERTORIO VITE Famiglia: Vitaceae Genere: Vitis Specie: Vitis vinifera L. Nome comune: Trebbianina Codice iscrizione Registro nazionale: 434 Sinonimi accertati: Trebbiano
Vini Rossi. ABBINAMENTI Si accompagna a qualsiasi tipo di salume, formaggi giovani e carni lessate.
 Vini Rossi ARDENTE LINEA TENUTA MARIA ROSA VINO ROSSO FRIZZANTE DA TAVOLA Questo vino è ottenuto dalla vinificazione congiunta di uve Croatina e Barbera. Il colore è rosso rubino ed il sapore è secco e
Vini Rossi ARDENTE LINEA TENUTA MARIA ROSA VINO ROSSO FRIZZANTE DA TAVOLA Questo vino è ottenuto dalla vinificazione congiunta di uve Croatina e Barbera. Il colore è rosso rubino ed il sapore è secco e
Borgo Conventi. Collio. Isonzo. Un trinomio inscindibile fatto di qualità, tradizione e passione.
 Fondata nel 1975 a Farra d Isonzo, in provincia di Gorizia, Borgo Conventi deve il suo nome ai numerosi conventi che si trovavano nella zona fin da tempi antichissimi. Da subito, Borgo Conventi, con vigneti
Fondata nel 1975 a Farra d Isonzo, in provincia di Gorizia, Borgo Conventi deve il suo nome ai numerosi conventi che si trovavano nella zona fin da tempi antichissimi. Da subito, Borgo Conventi, con vigneti
Corso di potatura base
 Corso di potatura base Fattoria La Quercia 16 gennaio 2016 Punto Uva Cenni storici 9.000 a.c : addomesticamento di Vitis vinifera silvestris in Asia centrale 3.000 a.c. : in un testo sumerico si parla
Corso di potatura base Fattoria La Quercia 16 gennaio 2016 Punto Uva Cenni storici 9.000 a.c : addomesticamento di Vitis vinifera silvestris in Asia centrale 3.000 a.c. : in un testo sumerico si parla
...un angolo di paradiso alle pendici del Monte San Vicino, il fascino di un paesaggio che conquista chi lo scopre, il piacere unico di vini che
 ...un angolo di paradiso alle pendici del Monte San Vicino, il fascino di un paesaggio che conquista chi lo scopre, il piacere unico di vini che sorprendono chi li incontra... Le Marche, si sa, sono l
...un angolo di paradiso alle pendici del Monte San Vicino, il fascino di un paesaggio che conquista chi lo scopre, il piacere unico di vini che sorprendono chi li incontra... Le Marche, si sa, sono l
LA BIODIVERSITA FRUTTICOLA NEL PARMENSE: un patrimonio da conservare e valorizzare
 ITAS F. Bocchialini Parma, 20 Ottobre 2005 LA BIODIVERSITA FRUTTICOLA NEL PARMENSE: un patrimonio da conservare e valorizzare Dott. Mauro Carboni Prof. Enzo Melegari Biodiversità BIO + DIVERSITA Vita Nel
ITAS F. Bocchialini Parma, 20 Ottobre 2005 LA BIODIVERSITA FRUTTICOLA NEL PARMENSE: un patrimonio da conservare e valorizzare Dott. Mauro Carboni Prof. Enzo Melegari Biodiversità BIO + DIVERSITA Vita Nel
La Potatura della vite
 La Potatura della vite Lezione 2/3 Relatore: Dott. Agronomo Marco Tonni Si ringraziano per i materiali didattici e per la collaborazione i Dott. Agr. Luigi Reghenzi, Fabio Sorgiacomo, Pierluigi Donna 19/12/2012
La Potatura della vite Lezione 2/3 Relatore: Dott. Agronomo Marco Tonni Si ringraziano per i materiali didattici e per la collaborazione i Dott. Agr. Luigi Reghenzi, Fabio Sorgiacomo, Pierluigi Donna 19/12/2012
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
ESAME DI STATO. SIMULAZIONE PROVA NAZIONALE Scuola Secondaria di I grado Classe Terza. Prova 3. Anno Scolastico 20. - 20. Classe:... Data:...
 Prova Nazionale di Matematica: Simulazioni - a cura di M. Zarattini Prova ESAME DI STATO Anno Scolastico 0. - 0. SIMULAZIONE PROVA NAZIONALE Scuola Secondaria di I grado Classe Terza Classe:... Data:...
Prova Nazionale di Matematica: Simulazioni - a cura di M. Zarattini Prova ESAME DI STATO Anno Scolastico 0. - 0. SIMULAZIONE PROVA NAZIONALE Scuola Secondaria di I grado Classe Terza Classe:... Data:...
VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 DECRETO 20 maggio 2009. Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reno». IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE VISTA la legge
DECRETO 20 maggio 2009. Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reno». IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE VISTA la legge
Donato, capostipite della famiglia Nigro, dopo aver appreso, dalla tradizione maestria degli agricoltori provenienti da Turi(Ba), il prezioso e poco
 Donato, capostipite della famiglia Nigro, dopo aver appreso, dalla tradizione maestria degli agricoltori provenienti da Turi(Ba), il prezioso e poco diffuso mestiere di innestino, decise nel 1934, di fondare
Donato, capostipite della famiglia Nigro, dopo aver appreso, dalla tradizione maestria degli agricoltori provenienti da Turi(Ba), il prezioso e poco diffuso mestiere di innestino, decise nel 1934, di fondare
UNA STORIA DI FAMIGLIA, UN IMPRESA DI SUCCESSO, UN LAVORO FATTO DI PASSIONE, FATICA ED ESPERIENZA.
 UNA STORIA DI FAMIGLIA, UN IMPRESA DI SUCCESSO, UN LAVORO FATTO DI PASSIONE, FATICA ED ESPERIENZA. Un azienda giovane con radici antiche. L Azienda Agricola CAVEN CAMUNA è stata fondata nel 1982 dai fratelli
UNA STORIA DI FAMIGLIA, UN IMPRESA DI SUCCESSO, UN LAVORO FATTO DI PASSIONE, FATICA ED ESPERIENZA. Un azienda giovane con radici antiche. L Azienda Agricola CAVEN CAMUNA è stata fondata nel 1982 dai fratelli
SEPARAZIONI E DIVORZI IN ITALIA ED IN EMILIA- ROMAGNA DAL 2000 AL 2012
 SEPARAZIONI E DIVORZI IN ITALIA ED IN EMILIA- ROMAGNA DAL 0 AL 2012 L Istat ha recentemente pubblicato i dati relativi alla rilevazione delle separazioni e dei divorzi condotta nel 2012 presso le cancellerie
SEPARAZIONI E DIVORZI IN ITALIA ED IN EMILIA- ROMAGNA DAL 0 AL 2012 L Istat ha recentemente pubblicato i dati relativi alla rilevazione delle separazioni e dei divorzi condotta nel 2012 presso le cancellerie
VIAGGIO IN VALLE D AOSTA. IL PRIE BLANC: VITIGNO AUTOCTONO DI ALTA MONTAGNA
 VIAGGIO IN VALLE D AOSTA. IL PRIE BLANC: VITIGNO AUTOCTONO DI ALTA MONTAGNA La Valle d Aosta è un piccola regione italiana molto ricca dal punto di vista enologico. Possono essere individuate tre zone
VIAGGIO IN VALLE D AOSTA. IL PRIE BLANC: VITIGNO AUTOCTONO DI ALTA MONTAGNA La Valle d Aosta è un piccola regione italiana molto ricca dal punto di vista enologico. Possono essere individuate tre zone
Le attività della Regione Lombardia
 Le attività della Regione Lombardia Mauro Fasano Dirigente UO Energia e Reti Tecnologiche DG Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile- REGIONE LOMBARDIA La distribuzione del Gas: gli ATEM e le gare per
Le attività della Regione Lombardia Mauro Fasano Dirigente UO Energia e Reti Tecnologiche DG Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile- REGIONE LOMBARDIA La distribuzione del Gas: gli ATEM e le gare per
Vitigni resistenti alle malattie crittogamiche: prove ed esperienze in Ticino. Rapporto Marzo 2010
 Rapporto Marzo 2010 Vitigni resistenti alle malattie crittogamiche: prove ed esperienze in Ticino Autori Mirto Ferretti, Stazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil ACW Centro di Cadenazzo, Ala Mota
Rapporto Marzo 2010 Vitigni resistenti alle malattie crittogamiche: prove ed esperienze in Ticino Autori Mirto Ferretti, Stazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil ACW Centro di Cadenazzo, Ala Mota
Franco Fronteddu Agenzia LAORE
 La coltivazione dell agrume POMPIA nel comprensorio delle Baronie Franco Fronteddu Agenzia LAORE Convegno Sa Pompia coltivazione, tradizione, innovazione e prospettive di sviluppo Siniscola, 20 marzo 2010
La coltivazione dell agrume POMPIA nel comprensorio delle Baronie Franco Fronteddu Agenzia LAORE Convegno Sa Pompia coltivazione, tradizione, innovazione e prospettive di sviluppo Siniscola, 20 marzo 2010
www.regione.lombardia.com Groppello, l autoctono della Valtènesi
 www.regione.lombardia.com Groppello, l autoctono della Valtènesi INQUADRAMENTO GENETICO Indagini territoriali e caratteristiche varietali Risposte a diversi metodi di vinificazione Quaderni della Ricerca
www.regione.lombardia.com Groppello, l autoctono della Valtènesi INQUADRAMENTO GENETICO Indagini territoriali e caratteristiche varietali Risposte a diversi metodi di vinificazione Quaderni della Ricerca
Si accompagna a: pasta ripiena di carne, arrosti di selvaggina, brasati di carne rossa, formaggi stagionati.
 Barbaresco Asili Denominazione: Barbaresco d.o.c.g. Provenienza: sottozona ASILI, comune di Barbaresco. Vinificazione: macerazione in rosso tradizionale di 12-15 giorni, con fermentazione a temperatura
Barbaresco Asili Denominazione: Barbaresco d.o.c.g. Provenienza: sottozona ASILI, comune di Barbaresco. Vinificazione: macerazione in rosso tradizionale di 12-15 giorni, con fermentazione a temperatura
I RISULTATI DEL 4 CONCORSO ENOLOGICO CALICE D'ORO DELL'ALTO PIEMONTE"
 I RISULTATI DEL 4 CONCORSO ENOLOGICO CALICE D'ORO DELL'ALTO PIEMONTE" Ente organizzatore Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Novara Controlli Ministeriali Sig. Andrea Squarcia - Ministero
I RISULTATI DEL 4 CONCORSO ENOLOGICO CALICE D'ORO DELL'ALTO PIEMONTE" Ente organizzatore Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Novara Controlli Ministeriali Sig. Andrea Squarcia - Ministero
Vini. Bianchi. Nazionali
 Vini Bianchi Nazionali Alto Adige S. MICHELE APPIANO Sauvignon LAHN 1999 35,00 TERLAN LUNARE Gewurztraminer 2010 40,00 CANTINA DI TERMENO Pinot Grigio Unterebner 2002 32,00 CANTINA DI TERMENO Gewurtz.
Vini Bianchi Nazionali Alto Adige S. MICHELE APPIANO Sauvignon LAHN 1999 35,00 TERLAN LUNARE Gewurztraminer 2010 40,00 CANTINA DI TERMENO Pinot Grigio Unterebner 2002 32,00 CANTINA DI TERMENO Gewurtz.
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 1
 SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DISEGNO INDUSTRIALE CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 1 a.a. 2013 / 2014 PROF. ARCH. CHERUBINO
SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DISEGNO INDUSTRIALE CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 1 a.a. 2013 / 2014 PROF. ARCH. CHERUBINO
Viticoltori Migliozzi Casale di Carinola, Caserta
 Viticoltori Migliozzi Casale di Carinola, Caserta Marco Valerio Marziale - Xenia, Falernum CXI Viticoltori Migliozzi, ogni storia ha un inizio. L azienda agricola Migliozzi ha una lunga storia nella produzione
Viticoltori Migliozzi Casale di Carinola, Caserta Marco Valerio Marziale - Xenia, Falernum CXI Viticoltori Migliozzi, ogni storia ha un inizio. L azienda agricola Migliozzi ha una lunga storia nella produzione
