Confronto tra stima di parametri di posizione e velocità ottenuti da serie temporali continue o a blocchi
|
|
|
- Gloria Alfieri
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Confronto tra stima di parametri di posizione e velocità ottenuti da serie temporali continue o a blocchi Maurizio Barbarella, Stefano Gandolfi (*) DICAM-ARCES, Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna, Viale Risorgimento 2, 40136, Bologna Tel , Fax , nome.congome@unibo.it Riassunto La posizione delle stazioni che realizzano il Frame di un Sistema Geodetico è ottenuta da centri di calcolo che in continuo (con cadenza giornaliera o settimanale) acquisiscono dati grezzi e calcolano soluzioni. Questo è quanto realizzato da IGS e EUREF per la gestione dei sistemi ITRS e ETRS89. L Italia ha recentemente adottato il Sistema Geodetico Europeo ETRS89 e ha realizzato il Frame di riferimento nazionale denominato RDN (Rete Dinamica Nazionale). Per la definizione del sistema l IGM e diversi centri di calcolo (tra cui l Università di Bologna) hanno calcolato autonomamente la soluzione utilizzando quattro settimane di dati ogni sei mesi circa. Successivamente l IGM ha acquisito dati dalle stazioni di RDN non in modo continuo ma per dataset della durata di 4 settimane a sei mesi di distanza l uno dall altro. La ricerca in oggetto, basandosi su un campione di circa 8 anni di dati di una rete di 13 Stazioni Permanenti della rete IGS-EPN (quella utilizzata per l inquadramento della rete RDN), intende analizzare le differenze tra risultati medi di posizione e velocità ottenuti da una soluzione a blocchi rispetto ad una soluzione continua sia in termini di stima dei parametri sia in termina di accuratezza associata. Viene inoltre valutata la affidabilità della stima delle velocità in relazione alla durata del dataset. Abstract The position of the stations that realize the Frame of a Geodetic System is obtained by Computing Centers that continuously (every day) acquire raw data from the Stations and compute solutions. This task is carried out by IGS and EUREF which realize and manage the Geodetic Systems ITRS and ETRS89 and periodically update the System s frames Italy has recently adopted the European Geodetic System ETRS89 and has created the national densification frame, called RDN (Rete Dinamica Nazionale). For the definition of the RDN frame, various computing centers (including the University of Bologna) have independently calculated the solution using four weeks of data, in agreement with IGM. Then IGM has acquired data from RDN stations not continuously but through data samples of four weeks about every 6 months. This paper intends to analyze the differences between the results obtained from a discontinuous dataset (like that considered by IGM) with respect a continous and seamless data sample. The research in question is based on a sample of about 8 years of data from a network of 13 permanent stations network EPN-IGS (the one used for the classification of the network RDN). The same dataset is used to assess the influence of the duration of the of time series on the reliability of the estimate of the velocity of points. 1. Il problema affrontato Nell elaborazione delle osservazioni acquisite da Stazioni Permanenti una fase molto impegnativa riguarda la organizzazione dei dati in un archivio ben organizzato che costituisce il dato di input al o ai software scelti per il calcolo. Nel caso di una rete articolata composta di numerose stazioni anche la semplice acquisizione dei dati grezzi completi può risultare un problema complesso, 257
2 soprattutto se i ricevitori sono di marche diverse, se le stazioni appartengono a diversi soggetti, se non è possibile organizzare il flusso regolare e automatizzato dei file giornalieri registrati dalla Stazione verso il centro di calcolo. Problemi di questo tipo sono stati incontrati dall IGM quando ha selezionato una novantina di Stazioni Permanenti (SP) italiane per costituire una Rete che fungesse da frame del nuovo Sistema Geodetico Italiano, la R.D.N. [Relazione RDN ]: le stazioni sono state scelte in modo da avere una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale, da essere sufficientemente affidabili sia strutturalmente che per la strumentazione istallata che per affidabilità della gestione. Tuttavia non è stato possibile almeno nei primi anni organizzare un flusso continuo e automatico dei dati, per cui l IGM ha concentrato gli sforzi per acquisire uno spezzone di registrazioni della durata di 28 giorni, tramite i quali ha calcolato la posizione d impianto dei vertici della rete, inquadrata su circa una dozzina di S.P. delle reti IGS e EUREF. Successivamente all impianto, il monitoraggio delle posizioni e delle caratteristiche specifiche delle singole stazioni è stato effettuato ripetendo i calcoli a distanza di sei mesi, sempre su uno spezzone continuo di 4 settimane; questa procedura è stata seguita dal 2008 fino ad ora pur continuando il processo di automazione del flusso dati che sembra potersi considerare ormai completato. E interessante capire se l elaborazione di spezzoni temporali di durata Δt acquisti a distanza di tempo T equivalga sostanzialmente alla elaborazione dei dati completi senza soluzione di continuità, e questo sia in termini di posizione che di velocità; infatti il calcolo ripetuto nel tempo della posizione dei punti di una rete, oltre a tenere sotto controllo le caratteristiche di stabilità delle singole stazioni, ha il vantaggio di fornire indicazioni sulla loro velocità nel sistema adottato per il calcolo. E importante sottolineare che per la definizione di un frame geodetico pienamente operativo occorre conoscere la posizione dei vertici a una certa data (epoca) ma anche la velocità (dati corredati da matrice di varianza covarianza), in modo da attualizzare la posizione della stazione ad un tempo successivo ipotizzando un movimento uniforme. In questo lavoro gli autori si pongono due obiettivi. Uno riguarda il confronto dei risultati ottenuti col passare del tempo tra elaborazione eseguite per spezzoni temporali discontinui regolarmente intervallati (com è avvenuto per RDN) e quelli ottenuti con dati senza soluzione di continuità. Un secondo problema riguarda il tempo necessario ad ottenere stime attendibili per le velocità delle stazioni: per quanto riscontrabile in letteratura, tre anni di funzionamento (in continuo) vengono generalmente considerati indispensabili allo scopo; sembra utile svolgere una analisi in questa direzione anche nel contesto nazionale. Per approfondire i due punti si analizza una rete i cui dati sono disponibili per un lungo periodo di tempo e che danno garanzie di accurati controlli effettuati ad alto livello tecnico scientifico; la scelta è caduta su Stazioni Permanenti delle reti IGS o EUREF.[ Boucher, Altamimi., 2007]. 2. Formazione del campione dati usato nelle elaborazioni Per l analisi si è scelto una rete campione costituita da Stazioni Permanenti delle Reti internazionali IGS e EUREF ben documentate da anni e quindi tali da consentire una agevole acquisizione di dati affidabili. Per quanto attiene la collocazione geografica della rete, sono state scelte le stesse 13 Stazioni usate per effettuare l inquadramento di RDN perché lo studio del loro comportamento consente di prefigurare quello (ovviamente medio) delle stazioni di RDN, al di là del comportamento specifico di ciascuna di esse. Per quanto concerne la collocazione temporale, l archivio è stato creato con i dati disponibili a partire dal 2002; le valutazioni sono state concentrate negli stessi periodi per i quali sono state effettuate le elaborazioni per RDN (dalle ultime due settimane del 2007 ad oggi) [Barbarella., Gandolfi, 2010.]. Questo significa che per studiare le differenze introdotte dall uso di spezzoni temporali disgiunti rispetto alla elaborazione sull intero intervallo senza soluzione di continuità, sono stati considerati gli intervalli temporali riportati in tabella 1. Per epoca s intende il riferimento temporale dello spezzone, collocato a circa la sua metà : 258
3 N Epoca da a n n / / / / / / / / / / Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Spezzoni temporali di dati acquisiti per RDN. Per la realizzazione del dataset in oggetto, sono state messe a punto procedure batch in ambiente linux sia per il download dei dati delle stazioni permanente sia per il download delle orbite precise. L archivio è stato suddiviso in anni e giorni seguendo le architetture standard di archiviazione dei dati nei principali repository mondiali. Una volta organizzato l archivio dati è stata anche realizzata una procedura automatizzata per la esecuzione dei calcoli della posizione dei punti. 3. Modalità di elaborazione dei dati Per l analisi che si intendeva effettuare, il calcolo della posizione dei punti della rete è stato utilizzato il software Gipsy [Zumberge,1997] in modalità Precise Point Positioning e senza risoluzione delle ambiguità iniziali di fase che risulta particolarmente efficiente soprattutto in termini di velocità di esecuzione e produce risultati equivalenti ad altri software di tipo scientifico, quali Bernese e Gamit soprattutto per quanto attiene la stima dei parametri di posizione e velocità media dei siti [Kierulf, 2008]. Il calcolo ha fornito soluzioni giornaliere per le 13 Stazioni analizzate su tutto il periodo, soluzioni consistenti nelle stime della posizione del punto e della relativa matrice di varianza 3x3: avendo con Gipsy seguito l approccio indifferenziato, ciascun punto della rete è calcolato indipendentemente dagli altri e quindi non sono calcolate le covarianze tra le stazioni. Avendo quindi a disposizione le soluzioni giornaliere su tutto il periodo è possibile analizzare campioni parziali relativi a determinati intervalli temporali, in relazione a ciascuno dei quali è stata effettuata una analisi standard, separatamente per ciascuna coordinata, basata su un protocollo e su codici ampiamente testati e consistente essenzialmente in : Stima dei parametri di regressione lineare dei dati (coordinate stimate giornalmente) ricompresi nel campione, mediante minimi quadrati pesati tramite l inverso della varianza ottenuta per la coordinata stimata da Gipsy, eliminazione iterativa di singole soluzioni giornaliere che sono considerate outliers alla luce di parametri statistici predefiniti, stima definitiva del fit per ciascuna coordinata separatamente e ottenimento dei coefficienti della regressione lineare finale e dei parametri statistici associati alla loro stima. La procedura accennata è stata applicata a tutti i campioni (nel seguito indicati con A, B,..E) sia che fossero costituiti da spezzoni discontinui che contenessero dati senza soluzione di continuità nel periodo considerato. Per l intervallo temporale più breve considerato (spezzone di quattro settimane) si è stimata la media pesata anziché il trend lineare. Si osserva che il coefficiente angolare della regressione lineare ottenuto per la serie temporale delle coordinate è interpretabile come velocità media del punto stimata per il periodo analizzato (nel seguito espressa in mm/anno), per la quale è calcolato anche lo s.q.m.. Tramite i valori stimati dei coefficienti di regressione è possibile estrapolare il valore previsto per ciascuna coordinata ad un epoca successiva con associata la corrispondente indeterminazione. 259
4 4. Analisi dei campioni costituiti da spezzoni disgiunti Per analizzare le differenze risultanti dall uso di spezzoni disgiunti di dati rispetto alla serie completa che ricopre il medesimo intervallo, sono stati elaborati cinque campioni di dati costituiti rispettivamente da 1,2,3,4,5 spezzoni (ciascuno di 28 giorni, corrispondenti ai tempi di acquisizione di RDN) e i cinque campioni corrispondenti costituiti da tutti i dati compresi dell inizio del primo spezzone alla fine dell ultimo considerato; la tabella illustra i campioni paralleli considerati e posti a confronti, e la relativa consistenza. Campione Per Spezzoni In Continuo DATI contiene gg da A gg A / / B 1 e / / C 1,2, / / D 1,2,3, / / E 1,2,3,4, / / Tabella 1 Campioni analizzati e loro consistenza. Per valutare le differenze introdotte dall uso di spezzoni discreti intervallati di circa sei mesi rispetto alla serie temporale che copre con continuità lo stesso intervallo, si è scelto di confrontare il dato che si ottiene proiettando le stime delle corrispondenti regressioni, a una data corrispondente a sei mesi dopo il termine del campione, secondo quanto illustrato in tabella 2; si vuole cioè rispondere alla domanda: le previsioni a sei mesi (quando inizierà il prossimo spezzone), di quanto differiscono nei due casi? Campioni B C D E Termine dati, gg. 194/ / / /2010 Proiezione Tabella 3 Ultimo dato presente nel campione e data di proiezione della stima di posizione. La differenza delle coordinate geocentriche (ΔX, ΔY, ΔZ) che si ottengono dalla elaborazione dei due campioni corrispondenti allo stesso periodo può essere sinteticamente riassunta dai grafici della sottostante figura 1, nei quali sono riportati gli istogrammi del modulo dello spostamento globale per ciascun punto, Δ = Δ X + Δ Y + ΔZ in mm ottenuti per i quattro casi B,C,D,E considerati Per ciascuna coordinata il comportamento è indicato dai parametri statistici in Tabella 4. ( mm ) ΔX ΔY ΔZ Spostamento Δ Caso media s.q.m. Media s.q.m. media s.q.m. media s.q.m. B C D E Tabella 4 Parametri statistici della differenza di coordinate stimate, in X,Y,Z e totale. 260
5 Caso B. 2 spezzoni Caso C : 3 spezzoni Caso D : 4 spezzoni Caso E : 5 spezzoni Figura 1 Istogramma della differenza di posizione per il punto stimata per i vari campioni. Con 2-3 spezzoni si assiste ad un comportamento abbastanza differenziato tra i vari punti, con una stazione che presenta una differenza di posizione di 1 cm, decisamente importante. Nei casi D ed E ovvero con 4 e 5 spezzoni che coprono (in modo continuo e no) rispettivamente 2 e 2.5 anni, le differenze dovute all uso di spezzoni di un mese sono limitate in media ma soprattutto il comportamento è più omogeneo tra i punti, anche se esistono stazioni che presentano ancora differenze di 5-6 mm nella posizione prevista. L uso di spezzoni introduce variazioni modeste ma apprezzabili, che si riducono col passare del tempo; quello che però si perde definitivamente è la possibilità di apprezzare variazioni annuali della serie temporale e quindi la possibilità di una modellizzazione più fine. 5. Stima delle velocità L altro problema affrontato riguarda l attendibilità della stima della velocità dei punti stimata in relazione alla lunghezza della serie temporale. A questo scopo sono state calcolate le differenze tra le stime delle velocità di ciascuna coordinata delle stazioni ottenute con gli spezzoni parziali e il corrispondente valore relativo all intero campione di dati, ottenendo i risultati sintetizzati nelle figure seguenti. Considerata la media dei valori sulle stazioni si osserva sopratutto per le componenti Est e Nord (sistemi geodetici locali con origini nei punti di stazione) una rapida 261
6 convergenza a zero: in ordinata la media della differenza di velocità rispetto al campione completo in mm/anno, in ascissa la durata del campione, in mesi. Figura 2 Media delle differenze di velocità in relazione alla lunghezza del campione analizzato. Ovviamente non tutte le stazioni si comportano allo stesso modo: negli istogrammi succevi si riporta la dispersione del difetto di troncamento per alcune durate del campione dati usato. 262
7 Figura 3 Differenze di velocità di ciascuna stazione in relazione alla lunghezza del campione analizzato. 263
8 Figura 4 Valore dello s.q.m. della stima di velocità delle stazioni per i campioni analizzati. Si osserva che l indeterminazione associata alla stima delle velocità del campione completo, soprattutto per le componenti planimetriche, risulta assai piccola, inferiore al decimo di millimetro. Anche prendendo come limite di significatività il triplo dello s.q.m. della velocità finale, la differenza tra stima del campione ridotto e quello finale rimane superiore a quel limite anche per spezzoni lunghi una ottantina di mesi e quasi in un terzo dei casi non diviene mai inferiore. Col tempo la stima si raffina sempre più, dal punto di vista dei parametri formali e il campione utilizzato non ha durata ancora sufficiente a capire se un intervallo più ridotto è equivalente. 6. Conclusioni Il comportamento d assieme della Rete RDN, al di là delle caratteristiche specifiche locali di ogni singola stazione, è ben descritto da quello delle 13 Stazioni Permanenti di IGS e EUREF che sono 264
9 usate per inquadrare RDN nel contesto mondiale dei sistemi ITRS e ETRS89. Analizzando il comportamento di tali stazioni si ritiene di non allontanarsi troppo da quelli che sono i comportamenti di RDN. Otto anni di dati delle 13 stazioni sono stati usati per capire quanto una soluzione ottenuta su due spezzoni di 28 giorni ogni anno si può discostare da quella calcolata su un campione completo. I primi risultati mostrano che i risultati migliorano con il passare del tempo e che dopo 2-3 anni la posizione previste a sei mesi dopo la fine del campione (cioè quando inizia la successiva acquisizione) differiscono di alcuni mm ( fino a 6 per una stazione), quindi piccole ma non trascurabili. Ovviamente con dati discontinui viene meno la possibilità di apprezzare variazioni annuali della serie temporale e quindi la possibilità di una modellizzazione più fine. Si ritiene importante che per un Frame nazionale sia importante associare alle posizioni ad una certa data, anche una indicazione delle velocità. Per avere un idea, al di là di quanto riportato in letteratura, se i dati disponibili su RDN siano sufficienti a definire una attendibile stima della velocità, il campione trattato è stato suddiviso in sottocampioni di diversa lunghezza e le stime di ciascuno di essi per le velocità sono state confrontate con quella ottenuta col campione completo, oltre 8 anni. Considerando sensibili le differenze di velocità superiori a 1 mm/anno (dal punto di vista pratico),si riscontra che si raggiunge questo limite dopo anni per le componenti planimetriche, ma dopo anni per la quota. Questi primi risultati potranno essere approfonditi anche considerando migliori modelli per l errore presente nelle serie temporali Bibliografia Relazione RDN sito IGMI: Boucher C. and Altamimi Z., (2007): Memo: Specifications for reference frame fixing in the analysis of a EUREF GPS Campaing, (Available on line at: Guidelines for European Permanent Network Analysis.. Barbarella M., Gandolfi S., Ricucci L. (2010). Confronto degli spostamenti e velocità di una rete di stazioni permanenti ottenuta con due software di calcolo. Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA, 9 12 novembre 2010, Fiera di Brescia Zumberge J.F., Helfin M.B., Jefferson D.C., Watkins M.M., Webb F.H., Precise point positioning for efficient and robust analysis of GPS data from large networks. Journal of Geophysical Research, 102, Kierulf H.P., Plag H.-P., Bingley R.M., Teferle N., Demir C., Cingoz A., Yildiz H., Garate J., Davila J.M., Silva C.G., Zdunek R., Jaworski L., Martinez-Benjamin J.J., Orus P., Aragon A., Comparison of GPS analysis strategies for high-accuracy vertical land motion. Physics and Chemistry of the Earth, doi: /j. pce , 33, Caporali A., Turturici F., Maseroli R., Farolfi G., (2009), Preliminary results of the computation of the new italia Permanent Network RDN of GPS stations., Bullettin of Geodesy and Geomatics, LXVIII, 2009, 2, Barbarella M., Gandolfi S., Ricucci L., Zanutta A., (2010), The new Italian geodetic reference network (RDN): a comparison of solutions using different software packages, (Accettato ed in corso di stampa sul BGG) 265
Procedure automatiche per il monitoraggio quasi real time di reti di stazioni permanenti mediante approccio Precise Point Positioning
 Procedure automatiche per il monitoraggio quasi real time di reti di stazioni permanenti mediante approccio Precise Point Positioning Stefano Gandolfi, Luca Poluzzi DICAM-ARCES, Facoltà di Ingegneria,
Procedure automatiche per il monitoraggio quasi real time di reti di stazioni permanenti mediante approccio Precise Point Positioning Stefano Gandolfi, Luca Poluzzi DICAM-ARCES, Facoltà di Ingegneria,
Confronto degli spostamenti e velocità di una rete di stazioni permanenti ottenuta con due software di calcolo
 Confronto degli spostamenti e velocità di una rete di stazioni permanenti ottenuta con due software di calcolo Barbarella Maurizio, Gandolfi Stefano, Ricucci Luciano DICAM Topografia Facoltà di Ingegneria,
Confronto degli spostamenti e velocità di una rete di stazioni permanenti ottenuta con due software di calcolo Barbarella Maurizio, Gandolfi Stefano, Ricucci Luciano DICAM Topografia Facoltà di Ingegneria,
Telerilevamento e GIS Prof. Ing. Giuseppe Mussumeci
 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l Ambiente e il Territorio A.A. 2013-2014 Telerilevamento e GIS Prof. Ing. Giuseppe Mussumeci Rete Dinamica Nazionale International Earth Rotation and Reference
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l Ambiente e il Territorio A.A. 2013-2014 Telerilevamento e GIS Prof. Ing. Giuseppe Mussumeci Rete Dinamica Nazionale International Earth Rotation and Reference
Il monitoraggio della rete Rete Dinamica Nazionale dal 2009 al 2013: aspetti geodetici e applicativi
 Il monitoraggio della rete Rete Dinamica Nazionale dal 2009 al 2013: aspetti geodetici e applicativi Maurizio Barbarella, Stefano Gandolfi, Luca Poluzzi, Luca Tavasci DICAM ARCES CIRI-ICT, Scuola di Ingegneria
Il monitoraggio della rete Rete Dinamica Nazionale dal 2009 al 2013: aspetti geodetici e applicativi Maurizio Barbarella, Stefano Gandolfi, Luca Poluzzi, Luca Tavasci DICAM ARCES CIRI-ICT, Scuola di Ingegneria
APPENDICE 2.1.A1 LA TRASFORMAZIONE FRA COORDINATE RETE E COORDINATE UTENTE PER LA REGIONE LOMBARDIA
 PRIN004: I Servizi di posizionamento satellitare per l e-grnment APPENDICE..A LA TRASFORMAZIONE FRA COORDINATE RETE E COORDINATE UTENTE PER LA REGIONE LOMBARDIA Ludovico Biagi, Stefano Caldera, Maria Grazia
PRIN004: I Servizi di posizionamento satellitare per l e-grnment APPENDICE..A LA TRASFORMAZIONE FRA COORDINATE RETE E COORDINATE UTENTE PER LA REGIONE LOMBARDIA Ludovico Biagi, Stefano Caldera, Maria Grazia
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE Direzione Geodetica
 ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE Direzione Geodetica RELAZIONE SUL CALCOLO DELLA RETE DI STAZIONI PERMANENTI GNSS DELLA REGIONE CAMPANIA (Luglio 2015) 1. Caratteristiche della rete e finalità del calcolo La
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE Direzione Geodetica RELAZIONE SUL CALCOLO DELLA RETE DI STAZIONI PERMANENTI GNSS DELLA REGIONE CAMPANIA (Luglio 2015) 1. Caratteristiche della rete e finalità del calcolo La
Reti GNSS per il monitoraggio del territorio e per i servizi di posizionamento
 Reti GNSS per il monitoraggio del territorio e per i servizi di posizionamento Prof. Stefano Gandolfi DICAM - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Università di Bologna
Reti GNSS per il monitoraggio del territorio e per i servizi di posizionamento Prof. Stefano Gandolfi DICAM - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Università di Bologna
LA RETE DINAMICA NAZIONALE: integrazione dei servizi e delle reti a livello nazionale
 LA RETE DINAMICA NAZIONALE: integrazione dei servizi e delle reti a livello nazionale Renzo Maseroli, IGM - Servizio Geodetico Udine, 7 ottobre 2009 1 Perché una nuova rete geodetica? Per le seguenti considerazioni
LA RETE DINAMICA NAZIONALE: integrazione dei servizi e delle reti a livello nazionale Renzo Maseroli, IGM - Servizio Geodetico Udine, 7 ottobre 2009 1 Perché una nuova rete geodetica? Per le seguenti considerazioni
Rete GNSS Interregionale Piemonte - Lombardia
 Rete GNSS Interregionale Piemonte - Lombardia INQUADRAMENTO DELLA RETE Addendum compensazione II semestre 2016 A cura di: CSI-Piemonte Ufficio Geodetico Corso Unione Sovietica 216 10134 Torino +39 (011)
Rete GNSS Interregionale Piemonte - Lombardia INQUADRAMENTO DELLA RETE Addendum compensazione II semestre 2016 A cura di: CSI-Piemonte Ufficio Geodetico Corso Unione Sovietica 216 10134 Torino +39 (011)
RETE GEODETICA DI INQUADRAMENTO E RAFFITTIMENTO DEL COMUNE DI BOLOGNA
 RETE GEODETICA DI INQUADRAMENTO E RAFFITTIMENTO DEL COMUNE DI BOLOGNA Andrea MINGHETTI (*), Isabella CREMONINI (*), Samantha BRIGHETTI (*) Roberto Maria BRIOLI (**) (*) SIT - Comune di Bologna, via San
RETE GEODETICA DI INQUADRAMENTO E RAFFITTIMENTO DEL COMUNE DI BOLOGNA Andrea MINGHETTI (*), Isabella CREMONINI (*), Samantha BRIGHETTI (*) Roberto Maria BRIOLI (**) (*) SIT - Comune di Bologna, via San
CALCOLO DELL ERRORE E VALUTAZIONE DI UN METODO ANALITICO
 CALCOLO DELL ERRORE E VALUTAZIONE DI UN METODO ANALITICO In chimica analitica un settore importante riguarda il calcolo dell errore e la valutazione della significatività di una misura. Generalmente nell
CALCOLO DELL ERRORE E VALUTAZIONE DI UN METODO ANALITICO In chimica analitica un settore importante riguarda il calcolo dell errore e la valutazione della significatività di una misura. Generalmente nell
IL GPS sistema di satelliti segmento di terra segnali elettromagnetici ricevitori
 IL GPS Il GPS Global Positioning System è costituito da un sistema di satelliti orbitanti all altezza di circa 20.000 km, controllati da un segmento di terra che ne determina con precisione le orbite.
IL GPS Il GPS Global Positioning System è costituito da un sistema di satelliti orbitanti all altezza di circa 20.000 km, controllati da un segmento di terra che ne determina con precisione le orbite.
La Rete Dinamica Nazionale (RDN)
 La Rete Dinamica Nazionale (RDN) Renzo Maseroli Servizio Geodetico - IGM Bologna, 15 gennaio 2009 1 Profonda rivoluzione delle scienze del rilievo in tempi brevi con l avvento della geodesia satellitare
La Rete Dinamica Nazionale (RDN) Renzo Maseroli Servizio Geodetico - IGM Bologna, 15 gennaio 2009 1 Profonda rivoluzione delle scienze del rilievo in tempi brevi con l avvento della geodesia satellitare
Indice. Prefazione. 3 Capitolo 1 Gli schemi generali del rilievo topografico e i sistemi di riferimento
 Indice IX Prefazione 3 Capitolo 1 Gli schemi generali del rilievo topografico e i sistemi di riferimento 3 1.1 Lo schema generale del rilevamento Topografico 5 1.1.1 Lo schema del rilevamento topografico
Indice IX Prefazione 3 Capitolo 1 Gli schemi generali del rilievo topografico e i sistemi di riferimento 3 1.1 Lo schema generale del rilevamento Topografico 5 1.1.1 Lo schema del rilevamento topografico
Allegato 2 Specifiche tecniche per le stazioni permanenti appartenenti alla Rete Dinamica Nazionale (RDN)
 Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale Allegato 2 Specifiche tecniche per le stazioni permanenti appartenenti alla Rete Dinamica Nazionale (RDN) 10 Introduzione Scopo delle presenti specifiche
Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale Allegato 2 Specifiche tecniche per le stazioni permanenti appartenenti alla Rete Dinamica Nazionale (RDN) 10 Introduzione Scopo delle presenti specifiche
19 novembre 2009 all 2 - DPCM sistema geodetico v1_0.doc
 Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale Allegato 2 Specifiche tecniche per le stazioni permanenti appartenenti alla Rete Dinamica Nazionale (RDN) 1 di 5 Introduzione Scopo delle presenti
Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale Allegato 2 Specifiche tecniche per le stazioni permanenti appartenenti alla Rete Dinamica Nazionale (RDN) 1 di 5 Introduzione Scopo delle presenti
Rete di Stazioni Permanenti in Sicilia
 Rete di Stazioni Permanenti in Sicilia Trapani, 20 Settembre 2010 Palermo, 20 Settembre 2010 Enna, 21 Settembre 2010 Caltanissetta, 21 Settembre 2010 Siracusa, 22 Settembre 2010 Catania, 23 Settembre 2010
Rete di Stazioni Permanenti in Sicilia Trapani, 20 Settembre 2010 Palermo, 20 Settembre 2010 Enna, 21 Settembre 2010 Caltanissetta, 21 Settembre 2010 Siracusa, 22 Settembre 2010 Catania, 23 Settembre 2010
Monitoraggio di reti permanenti GNSS: schema di azione, procedure implementate e loro applicazione a un caso di studio
 Monitoraggio di reti permanenti GNSS: schema di azione, procedure implementate e loro applicazione a un caso di studio L. Biagi, S. Caldera, C. Porporato, M. Roggero, M. G. Visconti Convegno nazionale
Monitoraggio di reti permanenti GNSS: schema di azione, procedure implementate e loro applicazione a un caso di studio L. Biagi, S. Caldera, C. Porporato, M. Roggero, M. G. Visconti Convegno nazionale
Università degli Studi di Napoli Federico II
 Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Relatore: Classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale, Classe n 35. Corso di Laurea Magistrale
Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Relatore: Classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale, Classe n 35. Corso di Laurea Magistrale
CONFRONTO DI CODICI DI CALCOLO PER L INQUADRAMENTO DI RETI DI STAZIONI PERMANENTI PER IL POSIZIONAMENTO IN TEMPO
 CONFRONTO DI CODICI DI CALCOLO PER L INQUADRAMENTO DI RETI DI STAZIONI PERMANENTI PER IL POSIZIONAMENTO IN TEMPO Maurizio BARBARELLA (*), Stefano GANDOLFI (*), Antonio ZANUTTA (*), Nicola CENNI (**), Luciano
CONFRONTO DI CODICI DI CALCOLO PER L INQUADRAMENTO DI RETI DI STAZIONI PERMANENTI PER IL POSIZIONAMENTO IN TEMPO Maurizio BARBARELLA (*), Stefano GANDOLFI (*), Antonio ZANUTTA (*), Nicola CENNI (**), Luciano
Posizionamento e Navigazione: attività del Laboratorio di Topografia
 Posizionamento e Navigazione: attività del Laboratorio di Topografia Fabio Radicioni Università degli Studi di Perugia EPN 1997 L Università di Perugia ha installato la prima stazione permanente in Umbria
Posizionamento e Navigazione: attività del Laboratorio di Topografia Fabio Radicioni Università degli Studi di Perugia EPN 1997 L Università di Perugia ha installato la prima stazione permanente in Umbria
Procedure di controllo di reti GNSS per Servizi di Posizionamento a scala nazionale: il caso NetGEO Rete Topcon-Sokkia
 Procedure di controllo di reti GNSS per Servizi di Posizionamento a scala nazionale: il caso NetGEO Rete Topcon-Sokkia Nicola Perfetti (*), Paolo Centanni (*), Guido Fastellini (*), Giuliano Molinelli
Procedure di controllo di reti GNSS per Servizi di Posizionamento a scala nazionale: il caso NetGEO Rete Topcon-Sokkia Nicola Perfetti (*), Paolo Centanni (*), Guido Fastellini (*), Giuliano Molinelli
TOPOGRAFIA 2013/2014. Prof. Francesco-Gaspare Caputo
 TOPOGRAFIA 2013/2014 L operazione di misura di una grandezza produce un numero reale che esprime il rapporto della grandezza stessa rispetto a un altra, a essa omogenea, assunta come unità di misura. L
TOPOGRAFIA 2013/2014 L operazione di misura di una grandezza produce un numero reale che esprime il rapporto della grandezza stessa rispetto a un altra, a essa omogenea, assunta come unità di misura. L
L uso della Rete Dinamica Nazionale per l inquadramento delle reti regionali
 L uso della Rete Dinamica Nazionale per l inquadramento delle reti regionali Alberto Caligaris (*), Mattia De Agostino (**), Ambrogio M. Manzino (**) (*) CSI Piemonte, Corso Tazzoli 215/12a, 10137 Torino
L uso della Rete Dinamica Nazionale per l inquadramento delle reti regionali Alberto Caligaris (*), Mattia De Agostino (**), Ambrogio M. Manzino (**) (*) CSI Piemonte, Corso Tazzoli 215/12a, 10137 Torino
Misura del periodo di oscillazione e della costante elastica della molla di un oscillatore armonico semplice
 Misura del periodo di oscillazione e della costante elastica della molla di un oscillatore armonico semplice Crisafulli Paride Curseri Federica Raia Salvatore Torregrossa M. Roberto Valerio Alessia Zarcone
Misura del periodo di oscillazione e della costante elastica della molla di un oscillatore armonico semplice Crisafulli Paride Curseri Federica Raia Salvatore Torregrossa M. Roberto Valerio Alessia Zarcone
Contributi geomatici al progetto MEP (Map for Easy Paths)
 XIX Conferenza ASITA 29-30 Settembre - 1 ottobre 2015 Politecnico di Milano Polo di Lecco Como Campus Laboratorio di Geomatica Contributi geomatici al progetto MEP (Map for Easy Paths) L. Biagi, M. Negretti,
XIX Conferenza ASITA 29-30 Settembre - 1 ottobre 2015 Politecnico di Milano Polo di Lecco Como Campus Laboratorio di Geomatica Contributi geomatici al progetto MEP (Map for Easy Paths) L. Biagi, M. Negretti,
Ancora sulla distribuzione in longitudine dei flocculi di calcio
 Ancora sulla distribuzione in longitudine dei flocculi di calcio G. GODOLI - F. MAZZUCCONI - B. C. MONSIGNORI FOSSI Ricevuto il 17 Aprile 1967 RIASSUNTO. Viene estesa ai numeri caratteristici definitivi
Ancora sulla distribuzione in longitudine dei flocculi di calcio G. GODOLI - F. MAZZUCCONI - B. C. MONSIGNORI FOSSI Ricevuto il 17 Aprile 1967 RIASSUNTO. Viene estesa ai numeri caratteristici definitivi
Valorizzazione delle produzioni vitifrutticole valtellinesi mediante metodi innovativi INNOVI
 Valorizzazione delle produzioni vitifrutticole valtellinesi mediante metodi innovativi INNOVI RAPPORTO N 9 Attività 2 Definizione di curve di maturazione di mirtillo, uva e mela e valutazione non distruttiva
Valorizzazione delle produzioni vitifrutticole valtellinesi mediante metodi innovativi INNOVI RAPPORTO N 9 Attività 2 Definizione di curve di maturazione di mirtillo, uva e mela e valutazione non distruttiva
Il Servizio di Posizionamento Interregionale GNSS Piemonte Lombardia
 Il Servizio di Posizionamento Interregionale GNSS Piemonte Lombardia Cos è? Il Servizio di Posizionamento Interregionale GNSS (SPIN GNSS) di Regione Piemonte e Regione Lombardia è un infrastruttura indispensabile
Il Servizio di Posizionamento Interregionale GNSS Piemonte Lombardia Cos è? Il Servizio di Posizionamento Interregionale GNSS (SPIN GNSS) di Regione Piemonte e Regione Lombardia è un infrastruttura indispensabile
Milano, XX mese 20XX Il monitoraggio locale mediante strumentazione GNSS a basso costo
 61 Convegno Nazionale SIFET 8-1 Giugno 216, Lecce Milano, XX mese 2XX Il monitoraggio locale mediante strumentazione GNSS a basso costo L. Biagi, F. C. Grec, M. Negretti DICA - Polo Territoriale di Como
61 Convegno Nazionale SIFET 8-1 Giugno 216, Lecce Milano, XX mese 2XX Il monitoraggio locale mediante strumentazione GNSS a basso costo L. Biagi, F. C. Grec, M. Negretti DICA - Polo Territoriale di Como
La Rete NeVoCGPS (Neapolitan Volcanoes Continuous GPS), per il monitoraggio delle deformazioni del suolo nell area vulcanica napoletana.
 La Rete NeVoCGPS (Neapolitan Volcanoes Continuous GPS), per il monitoraggio delle deformazioni del suolo nell area vulcanica napoletana. Mario Dolce ( a ), Giuseppe Brandi ( a ), Giovanni Scarpato ( a
La Rete NeVoCGPS (Neapolitan Volcanoes Continuous GPS), per il monitoraggio delle deformazioni del suolo nell area vulcanica napoletana. Mario Dolce ( a ), Giuseppe Brandi ( a ), Giovanni Scarpato ( a
La rete di Stazioni Permanenti GPS della Regione Veneto e la sua integrazione con quelle delle Regioni limitrofe
 La rete di Stazioni Permanenti GPS della Regione Veneto e la sua integrazione con quelle delle Regioni limitrofe AUTHORS: Arch. A. Zampieri (1) Ing. M. De Gennaro (1) Prof. A. Caporali (2) Ing. C. Morini
La rete di Stazioni Permanenti GPS della Regione Veneto e la sua integrazione con quelle delle Regioni limitrofe AUTHORS: Arch. A. Zampieri (1) Ing. M. De Gennaro (1) Prof. A. Caporali (2) Ing. C. Morini
LA GEOMATICA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO. A. Albertella (DICA Sezione di Geodesia e Geomatica)
 LA GEOMATICA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO A. Albertella (DICA Sezione di Geodesia e Geomatica) Cosa è la GEOMATICA? 2 GEOMATICA per il controllo del territorio 3 Conoscere il territorio significa anche
LA GEOMATICA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO A. Albertella (DICA Sezione di Geodesia e Geomatica) Cosa è la GEOMATICA? 2 GEOMATICA per il controllo del territorio 3 Conoscere il territorio significa anche
Incertezza di Misura: Concetti di Base
 Incertezza di Misura: Concetti di Base Roberto Ottoboni Dipartimento di Elettrotecnica Politecnico di Milano 1 Il concetto di misura Nella sua accezione più comune si è sempre inteso come misura di una
Incertezza di Misura: Concetti di Base Roberto Ottoboni Dipartimento di Elettrotecnica Politecnico di Milano 1 Il concetto di misura Nella sua accezione più comune si è sempre inteso come misura di una
Strumentazione GPS e Reti di Stazioni Permanenti. M. Grazia Visconti
 Strumentazione GPS e Reti di Stazioni Permanenti Eugenio Realini eugenio.realini@polimi.it M. Grazia Visconti grazia@geomatica.como.polimi.it Modalità di posizionamento Posizionamento assoluto Posizionamento
Strumentazione GPS e Reti di Stazioni Permanenti Eugenio Realini eugenio.realini@polimi.it M. Grazia Visconti grazia@geomatica.como.polimi.it Modalità di posizionamento Posizionamento assoluto Posizionamento
TRACCIA DI STUDIO. Indici di dispersione assoluta per misure quantitative
 TRACCIA DI STUDIO Un indice di tendenza centrale non è sufficiente a descrivere completamente un fenomeno. Gli indici di dispersione assolvono il compito di rappresentare la capacità di un fenomeno a manifestarsi
TRACCIA DI STUDIO Un indice di tendenza centrale non è sufficiente a descrivere completamente un fenomeno. Gli indici di dispersione assolvono il compito di rappresentare la capacità di un fenomeno a manifestarsi
Errori sistematici e casuali
 Errori sistematici e casuali Errori Casuali Tempo di reazione nel far partire o fermare l orologio: Può essere sia in eccesso che in difetto (ad esempio partenza e arrivo), quindi l errore può avere segno
Errori sistematici e casuali Errori Casuali Tempo di reazione nel far partire o fermare l orologio: Può essere sia in eccesso che in difetto (ad esempio partenza e arrivo), quindi l errore può avere segno
La media e la mediana sono indicatori di centralità, che indicano un centro dei dati.
 La media e la mediana sono indicatori di centralità, che indicano un centro dei dati. Un indicatore che sintetizza in un unico numero tutti i dati, nascondendo quindi la molteplicità dei dati. Per esempio,
La media e la mediana sono indicatori di centralità, che indicano un centro dei dati. Un indicatore che sintetizza in un unico numero tutti i dati, nascondendo quindi la molteplicità dei dati. Per esempio,
Statistica descrittiva in due variabili
 Statistica descrittiva in due variabili 1 / 65 Statistica descrittiva in due variabili 1 / 65 Supponiamo di misurare su un campione statistico due diverse variabili X e Y. Indichiamo come al solito con
Statistica descrittiva in due variabili 1 / 65 Statistica descrittiva in due variabili 1 / 65 Supponiamo di misurare su un campione statistico due diverse variabili X e Y. Indichiamo come al solito con
Questi appunti costituiscono soltanto una traccia sintetica del Corso di Laboratorio di Fisica, a prescindere dalle opportune spiegazioni e dai
 Questi appunti costituiscono soltanto una traccia sintetica del Corso di Laboratorio di Fisica, a prescindere dalle opportune spiegazioni e dai necessari chiarimenti forniti a lezione. 1 MISURA DI UNA
Questi appunti costituiscono soltanto una traccia sintetica del Corso di Laboratorio di Fisica, a prescindere dalle opportune spiegazioni e dai necessari chiarimenti forniti a lezione. 1 MISURA DI UNA
La media e la mediana sono indicatori di centralità, che indicano un centro dei dati.
 La media e la mediana sono indicatori di centralità, che indicano un centro dei dati. Un indicatore che sintetizza in un unico numero tutti i dati, nascondendo quindi la molteplicità dei dati. Per esempio,
La media e la mediana sono indicatori di centralità, che indicano un centro dei dati. Un indicatore che sintetizza in un unico numero tutti i dati, nascondendo quindi la molteplicità dei dati. Per esempio,
Statistica di base per l analisi socio-economica
 Laurea Magistrale in Management e comunicazione d impresa Statistica di base per l analisi socio-economica Giovanni Di Bartolomeo gdibartolomeo@unite.it Definizioni di base Una popolazione è l insieme
Laurea Magistrale in Management e comunicazione d impresa Statistica di base per l analisi socio-economica Giovanni Di Bartolomeo gdibartolomeo@unite.it Definizioni di base Una popolazione è l insieme
Cartografia e open data Utili nel quotidiano, indispensabili nell emergenza
 Cartografia e open data Utili nel quotidiano, indispensabili nell emergenza La rete GNSS «A.Marussi» della Regione FVG ForumPA 2015 - Roma, 26 maggio2015 Michela Furlan - Insiel S.p.A. Aggiornamento ed
Cartografia e open data Utili nel quotidiano, indispensabili nell emergenza La rete GNSS «A.Marussi» della Regione FVG ForumPA 2015 - Roma, 26 maggio2015 Michela Furlan - Insiel S.p.A. Aggiornamento ed
Lezione 6. Tabelle funzionali. Utilizziamo il nostro sistema a portata di mano e ben controllabile
 Tabelle funzionali Riguardano dati in cui si vuole verificare una relazione tra più grandezze. Si organizzano le tabelle delle migliori stime delle coppie di grandezze e delle rispettive incertezze totali.
Tabelle funzionali Riguardano dati in cui si vuole verificare una relazione tra più grandezze. Si organizzano le tabelle delle migliori stime delle coppie di grandezze e delle rispettive incertezze totali.
BLAND-ALTMAN PLOT. + X 2i 2 la differenza ( d ) tra le due misure per ognuno degli n campioni; d i. X i. = X 1i. X 2i
 BLAND-ALTMAN PLOT Il metodo di J. M. Bland e D. G. Altman è finalizzato alla verifica se due tecniche di misura sono comparabili. Resta da comprendere cosa si intenda con il termine metodi comparabili
BLAND-ALTMAN PLOT Il metodo di J. M. Bland e D. G. Altman è finalizzato alla verifica se due tecniche di misura sono comparabili. Resta da comprendere cosa si intenda con il termine metodi comparabili
I sistemi di riferimento geodetici e cartografici utilizzati dall applicativo Conversione di
 Sistemi Geodetici e Sistemi Cartografici considerati I sistemi di riferimento geodetici e cartografici utilizzati dall applicativo Conversione di Coordinate fanno riferimento, nelle tabelle sotto riportate,
Sistemi Geodetici e Sistemi Cartografici considerati I sistemi di riferimento geodetici e cartografici utilizzati dall applicativo Conversione di Coordinate fanno riferimento, nelle tabelle sotto riportate,
ANALISI DI UNA RETE GPS PER SCOPI GEODINAMICI NELL AREA ITALIANA: RISULTATI E PROBLEMI APERTI
 GNGTS Atti del 17 Convegno Nazionale 05.16 F. Riguzzi (1), A. Zanutta (2) e P. Baldi (3) (1) Istituto Nazionale di Geofisica, Roma (2) DISTART, Universita` di Bologna (3) Dipartimento di Fisica, Universita`
GNGTS Atti del 17 Convegno Nazionale 05.16 F. Riguzzi (1), A. Zanutta (2) e P. Baldi (3) (1) Istituto Nazionale di Geofisica, Roma (2) DISTART, Universita` di Bologna (3) Dipartimento di Fisica, Universita`
Derivazione numerica. Introduzione al calcolo numerico. Derivazione numerica (II) Derivazione numerica (III)
 Derivazione numerica Introduzione al calcolo numerico Il calcolo della derivata di una funzione in un punto implica un processo al limite che può solo essere approssimato da un calcolatore. Supponiamo
Derivazione numerica Introduzione al calcolo numerico Il calcolo della derivata di una funzione in un punto implica un processo al limite che può solo essere approssimato da un calcolatore. Supponiamo
REPORT PLUVIOMETRICO DEL MESE DI NOVEMBRE 2012
 1 di 15 REPORT PLUVIOMETRICO DEL MESE DI NOVEMBRE 2012 2 di 15 Commento generale PREMESSA Al fine di valutare l entità gli apporti pluviometrici, sono state considerate tutte le stazioni automatiche (circa
1 di 15 REPORT PLUVIOMETRICO DEL MESE DI NOVEMBRE 2012 2 di 15 Commento generale PREMESSA Al fine di valutare l entità gli apporti pluviometrici, sono state considerate tutte le stazioni automatiche (circa
Il programma è distribuito tramite il file compresso TRASFO.zip contenente i file di programma strutturati in 4 cartelle:
 TRASFO V 1.0 Stefano Caldera stefano@geomatica.como.polimi.it M. Grazia Visconti grazia@geomatica.como.polimi.it Il programma è distribuito tramite il file compresso TRASFO.zip contenente i file di programma
TRASFO V 1.0 Stefano Caldera stefano@geomatica.como.polimi.it M. Grazia Visconti grazia@geomatica.como.polimi.it Il programma è distribuito tramite il file compresso TRASFO.zip contenente i file di programma
Richiami di statistica e loro applicazione al trattamento di osservazioni topografiche e geodetiche
 Richiami di statistica e loro applicazione al trattamento di osservazioni topografiche e geodetiche Ludovico Biagi Politecnico di Milano, DIIAR ludovico.biagi@polimi.it (materiale didattico preparato in
Richiami di statistica e loro applicazione al trattamento di osservazioni topografiche e geodetiche Ludovico Biagi Politecnico di Milano, DIIAR ludovico.biagi@polimi.it (materiale didattico preparato in
L'analisi bivariata (analisi della varianza e correlazione) Prof. Stefano Nobile. Corso di Metodologia della ricerca sociale
 L'analisi bivariata (analisi della varianza e correlazione) Prof. Stefano Nobile Corso di Metodologia della ricerca sociale L analisi della varianza (ANOVA) La tecnica con cui si esplorano le relazioni
L'analisi bivariata (analisi della varianza e correlazione) Prof. Stefano Nobile Corso di Metodologia della ricerca sociale L analisi della varianza (ANOVA) La tecnica con cui si esplorano le relazioni
Relazione misure MASW
 Relazione misure MASW per definizione profilo verticale VS e parametro Vs30 MASW_Cison 7 San Boldo CISON DI VALMARINO Coordinate ED50 Lat. N 46,007387 Long. E 12,170214 Novembre 2012 dott. geol. Simone
Relazione misure MASW per definizione profilo verticale VS e parametro Vs30 MASW_Cison 7 San Boldo CISON DI VALMARINO Coordinate ED50 Lat. N 46,007387 Long. E 12,170214 Novembre 2012 dott. geol. Simone
Maria Prandini Dipartimento di Elettronica e Informazione Politecnico di Milano
 Note relative a test di bianchezza rimozione delle componenti deterministiche da una serie temporale a supporto del Progetto di Identificazione dei Modelli e Analisi dei Dati Maria Prandini Dipartimento
Note relative a test di bianchezza rimozione delle componenti deterministiche da una serie temporale a supporto del Progetto di Identificazione dei Modelli e Analisi dei Dati Maria Prandini Dipartimento
Misure meteorologiche in ambito urbano
 Misure meteorologiche in ambito urbano 3 - L incertezza delle misure in ambito urbano G. Frustaci Osservatorio Cavanis Venezia L incertezza delle misure in ambito urbano Definizione dell incertezza di
Misure meteorologiche in ambito urbano 3 - L incertezza delle misure in ambito urbano G. Frustaci Osservatorio Cavanis Venezia L incertezza delle misure in ambito urbano Definizione dell incertezza di
Corso di Ingegneria del Software. Modelli di produzione del software
 Corso di Ingegneria del Software a.a. 2009/2010 Mario Vacca mario.vacca1@istruzione.it 1. Concetti di base Sommario 2. 2.1 Modello a cascata 2.2 Modelli incrementali 2.3 Modelli evolutivi 2.4 Modelli agili
Corso di Ingegneria del Software a.a. 2009/2010 Mario Vacca mario.vacca1@istruzione.it 1. Concetti di base Sommario 2. 2.1 Modello a cascata 2.2 Modelli incrementali 2.3 Modelli evolutivi 2.4 Modelli agili
Osservazioni e Misura. Teoria degli errori
 Osservazioni e Misura ella misura di una grandezza fisica gli errori sono inevitabili. Una misura non ha significato se non viene stimato l errore. Teoria degli errori La teoria degli errori cerca di trovare
Osservazioni e Misura ella misura di una grandezza fisica gli errori sono inevitabili. Una misura non ha significato se non viene stimato l errore. Teoria degli errori La teoria degli errori cerca di trovare
9.3 Il metodo dei minimi quadrati in formalismo matriciale
 9.3. IL METODO DEI MINIMI QUADRATI IN FORMALISMO MATRICIALE 121 9.3 Il metodo dei minimi quadrati in formalismo matriciale Per applicare il MMQ a funzioni polinomiali, ovvero a dipendenze di una grandezza
9.3. IL METODO DEI MINIMI QUADRATI IN FORMALISMO MATRICIALE 121 9.3 Il metodo dei minimi quadrati in formalismo matriciale Per applicare il MMQ a funzioni polinomiali, ovvero a dipendenze di una grandezza
L A B C di R. Stefano Leonardi c Dipartimento di Scienze Ambientali Università di Parma Parma, 9 febbraio 2010
 L A B C di R 0 20 40 60 80 100 2 3 4 5 6 7 8 Stefano Leonardi c Dipartimento di Scienze Ambientali Università di Parma Parma, 9 febbraio 2010 La scelta del test statistico giusto La scelta della analisi
L A B C di R 0 20 40 60 80 100 2 3 4 5 6 7 8 Stefano Leonardi c Dipartimento di Scienze Ambientali Università di Parma Parma, 9 febbraio 2010 La scelta del test statistico giusto La scelta della analisi
Tipi di variabili. Indici di tendenza centrale e di dispersione
 Tipi di variabili. Indici di tendenza centrale e di dispersione L. Boni Variabile casuale In teoria della probabilità, una variabile casuale (o variabile aleatoria o variabile stocastica o random variable)
Tipi di variabili. Indici di tendenza centrale e di dispersione L. Boni Variabile casuale In teoria della probabilità, una variabile casuale (o variabile aleatoria o variabile stocastica o random variable)
Capitolo 12 La regressione lineare semplice
 Levine, Krehbiel, Berenson Statistica II ed. 2006 Apogeo Capitolo 12 La regressione lineare semplice Insegnamento: Statistica Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale Facoltà di Ingegneria, Università
Levine, Krehbiel, Berenson Statistica II ed. 2006 Apogeo Capitolo 12 La regressione lineare semplice Insegnamento: Statistica Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale Facoltà di Ingegneria, Università
Andamento della mobilità ciclistica a Milano
 Andamento della mobilità ciclistica a Milano I risultati di un indagine autogestita sull uso della bicicletta in città dal 2008 ad oggi (resoconto annuale 2015) π POLINOMIA Polinomia srl Via Nino Bixio,
Andamento della mobilità ciclistica a Milano I risultati di un indagine autogestita sull uso della bicicletta in città dal 2008 ad oggi (resoconto annuale 2015) π POLINOMIA Polinomia srl Via Nino Bixio,
CORSO DI STATISTICA (parte 1) - ESERCITAZIONE 6
 CORSO DI STATISTICA (parte 1) - ESERCITAZIONE 6 Dott.ssa Antonella Costanzo a.costanzo@unicas.it Esercizio 1. Associazione, correlazione e dipendenza tra caratteri In un collettivo di 11 famiglie è stata
CORSO DI STATISTICA (parte 1) - ESERCITAZIONE 6 Dott.ssa Antonella Costanzo a.costanzo@unicas.it Esercizio 1. Associazione, correlazione e dipendenza tra caratteri In un collettivo di 11 famiglie è stata
IL MONITORAGGIO DELLA SUBSIDENZA IN EMILIA-ROMAGNA: DALLA LIVELLAZIONE ALL INTERFEROMETRIA SATELLITARE
 IL MONITORAGGIO DELLA SUBSIDENZA IN EMILIA-ROMAGNA: DALLA LIVELLAZIONE ALL INTERFEROMETRIA SATELLITARE Flavio Bonsignore, Giacomo Zaccanti ARPAE - Direzione Tecnica Bologna, 5 luglio 2017 LA SUBSIDENZA
IL MONITORAGGIO DELLA SUBSIDENZA IN EMILIA-ROMAGNA: DALLA LIVELLAZIONE ALL INTERFEROMETRIA SATELLITARE Flavio Bonsignore, Giacomo Zaccanti ARPAE - Direzione Tecnica Bologna, 5 luglio 2017 LA SUBSIDENZA
ESERCIZI: riportare lo svolgimento dell esercizio e commentare il risultato
 ESERCIZI: riportare lo svolgimento dell esercizio e commentare il risultato A. Nella pubblicazione ISTAT Noi Italia, 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, edizione 2013, con riferimento al
ESERCIZI: riportare lo svolgimento dell esercizio e commentare il risultato A. Nella pubblicazione ISTAT Noi Italia, 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, edizione 2013, con riferimento al
Le quote dei punti determinati con GPS. Variazioni locali degli scostamenti geoidici in Trentino Alto Adige.
 Le quote dei punti determinati con GPS. Variazioni locali degli scostamenti geoidici in Trentino Alto Adige. Antonino Di Girolamo Ufficio per il rilevamento Geodetico - Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Le quote dei punti determinati con GPS. Variazioni locali degli scostamenti geoidici in Trentino Alto Adige. Antonino Di Girolamo Ufficio per il rilevamento Geodetico - Regione Autonoma Trentino Alto Adige
L evoluzione del Sistema Cartografico del Catasto Italiano: Uso del GPS con le reti GNSS
 L evoluzione del Sistema Cartografico del Catasto Italiano: Uso del GPS con le reti GNSS Francesco Corso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia Ufficio Provinciale - Territorio Referente
L evoluzione del Sistema Cartografico del Catasto Italiano: Uso del GPS con le reti GNSS Francesco Corso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia Ufficio Provinciale - Territorio Referente
ANNESSO 1 DISCIPLINARE TECNICO PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI
 DISCIPLINARE TECNICO PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI ANNESSO 1 Elenco delle operazioni da effettuare in occasione dei rilievi idrografici Il presente Annesso si compone di due checklist
DISCIPLINARE TECNICO PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI ANNESSO 1 Elenco delle operazioni da effettuare in occasione dei rilievi idrografici Il presente Annesso si compone di due checklist
Facoltà di Ingegneria. Corso di Laurea in Ingegneria per l Ambiente ed il Territorio Anno accademico: Tesi di Laurea
 Metodologia per la validazione geometrica del catasto della segnaletica verticale della provincia di Frosinone tramite una rete di stazioni permanenti GNSS Relatore: Correlatore: Prof. Ing. Mattia G. Crespi
Metodologia per la validazione geometrica del catasto della segnaletica verticale della provincia di Frosinone tramite una rete di stazioni permanenti GNSS Relatore: Correlatore: Prof. Ing. Mattia G. Crespi
IL RILIEVO DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL ASSE STRADALE
 Provincia Regionale di Catania Unione Europea DICA Università degli Studi di Catania PROJECT TREN-03-ST-S07.31286 Identification of Hazard Location and Ranking of Measures to Improve Safety on Local Rural
Provincia Regionale di Catania Unione Europea DICA Università degli Studi di Catania PROJECT TREN-03-ST-S07.31286 Identification of Hazard Location and Ranking of Measures to Improve Safety on Local Rural
Il ruolo dei materiali di riferimento nelle misure
 Il ruolo dei materiali di riferimento nelle misure ambientali Maria Belli Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) Servizio Metrologia Ambientale ISPRA (prima APAT) Dal 22 agosto
Il ruolo dei materiali di riferimento nelle misure ambientali Maria Belli Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) Servizio Metrologia Ambientale ISPRA (prima APAT) Dal 22 agosto
S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST A.R.O DEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI
 S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST A.R.O DEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI Piano di Intervento ex art. 5, comma 2 ter, della L.R. Sicilia n. 09/2010 5. ANALISI E PROIEZIONE DELL ANDAMENTO DEMOGRAFICO E DELLA PRODUZIONE
S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST A.R.O DEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI Piano di Intervento ex art. 5, comma 2 ter, della L.R. Sicilia n. 09/2010 5. ANALISI E PROIEZIONE DELL ANDAMENTO DEMOGRAFICO E DELLA PRODUZIONE
INDICE PARTE METODOLOGICA
 INDICE PARTE METODOLOGICA 1. Il processo di ricerca 1.1.Individuazione di un problema e formulazione delle ipotesi 1.2.Individuazione e definizione operativa delle variabili 1.2.1. Le variabili definite
INDICE PARTE METODOLOGICA 1. Il processo di ricerca 1.1.Individuazione di un problema e formulazione delle ipotesi 1.2.Individuazione e definizione operativa delle variabili 1.2.1. Le variabili definite
Doc. No H1 Rev. 0 - Ottobre 2016 APPENDICE D PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO GEODETICO
 APPENDICE D PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO GEODETICO D.1 INTRODUZIONE APPENDICE D PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO GEODETICO Edison S.p.a. ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
APPENDICE D PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO GEODETICO D.1 INTRODUZIONE APPENDICE D PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO GEODETICO Edison S.p.a. ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
Analisi e scelta dei dati di input
 Analisi e scelta dei dati di input Corso di Tecniche di Simulazione, a.a. 2005/2006 Francesca Mazzia Dipartimento di Matematica Università di Bari 24 Aprile 2006 Francesca Mazzia (Univ. Bari) Analisi e
Analisi e scelta dei dati di input Corso di Tecniche di Simulazione, a.a. 2005/2006 Francesca Mazzia Dipartimento di Matematica Università di Bari 24 Aprile 2006 Francesca Mazzia (Univ. Bari) Analisi e
5 DETERMINAZIONE DELL'INCERTEZZA TIPO COMPOSTA Grandezze d'ingresso incorrelate Grandezze d'ingresso correlate...
 INDICE PREMESSA 1 0 INTRODUZIONE 3 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4 DEFINIZIONI 5.1 Termini metrologici generali... 5. Il termine "incertezza"... 6.3 Termini specifici della presente Guida... 6 3 CONCETTI
INDICE PREMESSA 1 0 INTRODUZIONE 3 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4 DEFINIZIONI 5.1 Termini metrologici generali... 5. Il termine "incertezza"... 6.3 Termini specifici della presente Guida... 6 3 CONCETTI
RETI TOPOGRAFICHE. 1. Premessa
 RETI TOPOGRAFICHE 1. Premessa Una rete topografica è costituita da un insieme di punti, detti vertici della rete, connessi fra di loro da un insieme di misure di distanze e di angoli azimutali e zenitali;
RETI TOPOGRAFICHE 1. Premessa Una rete topografica è costituita da un insieme di punti, detti vertici della rete, connessi fra di loro da un insieme di misure di distanze e di angoli azimutali e zenitali;
TECNICHE DI SIMULAZIONE
 TECNICHE DI SIMULAZIONE Analisi e scelta dei dati di input Francesca Mazzia Dipartimento di Matematica Università di Bari a.a. 2004/2005 TECNICHE DI SIMULAZIONE p. 1 Dati di input Per l esecuzione di una
TECNICHE DI SIMULAZIONE Analisi e scelta dei dati di input Francesca Mazzia Dipartimento di Matematica Università di Bari a.a. 2004/2005 TECNICHE DI SIMULAZIONE p. 1 Dati di input Per l esecuzione di una
TECNICHE DI MISURAZIONE DEI RISCHI DI MERCATO. VALUE AT RISK VaR. Piatti --- Corso Rischi Bancari: VaR 1
 TECNICHE DI MISURAZIONE DEI RISCHI DI MERCATO VALUE AT RISK VaR Piatti --- Corso Rischi Bancari: VaR 1 Limiti delle misure di sensitivity Dipendono dalla fase in cui si trova il mercato non consentono
TECNICHE DI MISURAZIONE DEI RISCHI DI MERCATO VALUE AT RISK VaR Piatti --- Corso Rischi Bancari: VaR 1 Limiti delle misure di sensitivity Dipendono dalla fase in cui si trova il mercato non consentono
Le reti GNSS nella ricerca accademica. Ludovico Biagi, Politecnico di Milano, DICA.
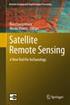 Le reti GNSS nella ricerca accademica Ludovico Biagi, Politecnico di Milano, DICA ludovico.biagi@polimi.it www.geoinformatics.polimi.it Le reti permanenti GNSS Una rete di stazioni GNSS continuamente operante
Le reti GNSS nella ricerca accademica Ludovico Biagi, Politecnico di Milano, DICA ludovico.biagi@polimi.it www.geoinformatics.polimi.it Le reti permanenti GNSS Una rete di stazioni GNSS continuamente operante
Risultati delle prove SDMT con misure di Vp eseguite a Cesano
 Risultati delle prove SDMT con misure di Vp eseguite a Cesano 1 24 Febbraio 2009 Nel sito di prova (Via Ponte degli Incastri 102, Cesano (RM)), sono state registrate onde P, generate colpendo dall alto
Risultati delle prove SDMT con misure di Vp eseguite a Cesano 1 24 Febbraio 2009 Nel sito di prova (Via Ponte degli Incastri 102, Cesano (RM)), sono state registrate onde P, generate colpendo dall alto
OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA QUALITA DEI SERVIZI
 IX CONFERENZA NAZIONALE DI STATISTICA ROMA, 15 16 DICEMBRE 2008 OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA QUALITA DEI SERVIZI Le indagini sulla soddisfazione dell utenza come strumento informativo a supporto dei processi
IX CONFERENZA NAZIONALE DI STATISTICA ROMA, 15 16 DICEMBRE 2008 OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA QUALITA DEI SERVIZI Le indagini sulla soddisfazione dell utenza come strumento informativo a supporto dei processi
Valutazione dell andamento dei casi di meningite nella ASL della Provincia di Milano 3
 Valutazione dell andamento dei casi di meningite nella ASL della Provincia di Milano 3 Introduzione Il primo trimestre 2008 è stato caratterizzato, nell ASL della Provincia di Milano 3, da un numero di
Valutazione dell andamento dei casi di meningite nella ASL della Provincia di Milano 3 Introduzione Il primo trimestre 2008 è stato caratterizzato, nell ASL della Provincia di Milano 3, da un numero di
COMUNE DI CONSIGLIO DI RUMO
 COMUNE DI CONSIGLIO DI RUMO Provincia di Como Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di Governo del Territorio - L.R. 1/05 e successive modifiche. ANALISI
COMUNE DI CONSIGLIO DI RUMO Provincia di Como Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di Governo del Territorio - L.R. 1/05 e successive modifiche. ANALISI
Students with documented disabilities. School Years , ,
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l Emilia-Romagna - Direzione Generale - Alunni in situazione di handicap. Anni scolastici 2008-09, 2009-10 e
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l Emilia-Romagna - Direzione Generale - Alunni in situazione di handicap. Anni scolastici 2008-09, 2009-10 e
STATISTICA. Esercitazione 5
 STATISTICA Esercitazione 5 Esercizio 1 Ad un esame universitario sono stati assegnati in modo casuale due compiti diversi con i seguenti risultati: Compito A Compito B Numero studenti 102 105 Media dei
STATISTICA Esercitazione 5 Esercizio 1 Ad un esame universitario sono stati assegnati in modo casuale due compiti diversi con i seguenti risultati: Compito A Compito B Numero studenti 102 105 Media dei
Regressione Lineare Semplice e Correlazione
 Regressione Lineare Semplice e Correlazione 1 Introduzione La Regressione è una tecnica di analisi della relazione tra due variabili quantitative Questa tecnica è utilizzata per calcolare il valore (y)
Regressione Lineare Semplice e Correlazione 1 Introduzione La Regressione è una tecnica di analisi della relazione tra due variabili quantitative Questa tecnica è utilizzata per calcolare il valore (y)
STATISTICA SOCIALE - Corso di laurea in Scienze Turistiche Prova finale del 18 dicembre 2007 compito B
 STATISTICA SOCIALE - Corso di laurea in Scienze Turistiche Prova finale del 18 dicembre 2007 compito B Esercizio 1 La Tabella 1 riporta la distribuzione dei turisti che hanno soggiornato in una certa città
STATISTICA SOCIALE - Corso di laurea in Scienze Turistiche Prova finale del 18 dicembre 2007 compito B Esercizio 1 La Tabella 1 riporta la distribuzione dei turisti che hanno soggiornato in una certa città
CARATTERIZZAZIONE DINAMICA ED ANALISI DI DECONVOLUZIONE DI ALCUNI SITI DELLA RETE ACCELEROMETRICA NAZIONALE (RAN)
 CARATTERIZZAZIONE DINAMICA ED ANALISI DI DECONVOLUZIONE DI ALCUNI SITI DELLA RETE ACCELEROMETRICA NAZIONALE (RAN) Questo lavoro fa parte del progetto di ricerca DPC-INGV-S2 finalizzato a migliorare le
CARATTERIZZAZIONE DINAMICA ED ANALISI DI DECONVOLUZIONE DI ALCUNI SITI DELLA RETE ACCELEROMETRICA NAZIONALE (RAN) Questo lavoro fa parte del progetto di ricerca DPC-INGV-S2 finalizzato a migliorare le
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Monitoraggio vulcanologico, geochimico e delle deformazioni del suolo dello Stromboli nel periodo 17-23 Settembre 2008 L analisi delle immagini registrate
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Monitoraggio vulcanologico, geochimico e delle deformazioni del suolo dello Stromboli nel periodo 17-23 Settembre 2008 L analisi delle immagini registrate
Università degli Studi di Napoli Federico II
 Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Strutturale e Geotecnica Dipartimento di Ingegneria Geotecnica Tesi di laurea Fondazioni miste platee su
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Strutturale e Geotecnica Dipartimento di Ingegneria Geotecnica Tesi di laurea Fondazioni miste platee su
Gruppo 13 ~INDICE~ Di Benedetto Enrico, Franzella Elia, Guttilla Mattia, Nicoletti Gabriele, Tumbiolo Emanuele
 RELAZIONE LABORATORIO ESPERIENZA III ~MISURA DEL PERIODO DI OSCILLAZIONE E DELLA COSTANTE ELASTICA DELLA MOLLA DI UN OSCILLATORE ARMONICO SEMPLICE~ ANNO ACCADEMICO 2018-2019 Gruppo 13 Di Benedetto Enrico,
RELAZIONE LABORATORIO ESPERIENZA III ~MISURA DEL PERIODO DI OSCILLAZIONE E DELLA COSTANTE ELASTICA DELLA MOLLA DI UN OSCILLATORE ARMONICO SEMPLICE~ ANNO ACCADEMICO 2018-2019 Gruppo 13 Di Benedetto Enrico,
La matrice delle correlazioni è la seguente:
 Calcolo delle componenti principali tramite un esempio numerico Questo esempio numerico puó essere utile per chiarire il calcolo delle componenti principali e per introdurre il programma SPAD. IL PROBLEMA
Calcolo delle componenti principali tramite un esempio numerico Questo esempio numerico puó essere utile per chiarire il calcolo delle componenti principali e per introdurre il programma SPAD. IL PROBLEMA
Le stime italiane per gli effetti a breve termine dell inquinamento atmosferico:metodi e risultati a confronto
 Le stime italiane per gli effetti a breve termine dell inquinamento atmosferico:metodi e risultati a confronto Annibale Biggeri, Michela Baccini Dipartimento di Statistica G. Parenti Università di Firenze
Le stime italiane per gli effetti a breve termine dell inquinamento atmosferico:metodi e risultati a confronto Annibale Biggeri, Michela Baccini Dipartimento di Statistica G. Parenti Università di Firenze
INDAGINE SUI FLUSSI DI TRAFFICO
 INDAGINE SUI FLUSSI DI TRAFFICO Risultati dell indagine del traffico relativa al progetto Franciacorta Sostenibile Campagna di monitoraggio estivo Comune di Ome Dal 28 al 30 giugno 2011 Sommario PREMESSA......
INDAGINE SUI FLUSSI DI TRAFFICO Risultati dell indagine del traffico relativa al progetto Franciacorta Sostenibile Campagna di monitoraggio estivo Comune di Ome Dal 28 al 30 giugno 2011 Sommario PREMESSA......
Teoria e tecniche dei test. Concetti di base
 Teoria e tecniche dei test Lezione 2 2013/14 ALCUNE NOZIONI STATITICHE DI BASE Concetti di base Campione e popolazione (1) La popolazione è l insieme di individui o oggetti che si vogliono studiare. Questi
Teoria e tecniche dei test Lezione 2 2013/14 ALCUNE NOZIONI STATITICHE DI BASE Concetti di base Campione e popolazione (1) La popolazione è l insieme di individui o oggetti che si vogliono studiare. Questi
European Archive at ECMWF. Tiziana Paccagnella ARPA-SIMC, Italy
 TIGGE LAM European Archive at ECMWF Tiziana Paccagnella ARPA-SIMC, Italy TIGGE THORPEX Interactive Grand Global Ensemble A major component of THORPEX: a World Weather Research Programme to accelerate the
TIGGE LAM European Archive at ECMWF Tiziana Paccagnella ARPA-SIMC, Italy TIGGE THORPEX Interactive Grand Global Ensemble A major component of THORPEX: a World Weather Research Programme to accelerate the
Statistica multivariata Donata Rodi 08/11/2016
 Statistica multivariata Donata Rodi 08/11/2016 MANOVA: Multivariate Analysis of Variance Due o più variabili dipendenti quantitative Una o più variabili indipendenti categoriali (con più livelli) Residui
Statistica multivariata Donata Rodi 08/11/2016 MANOVA: Multivariate Analysis of Variance Due o più variabili dipendenti quantitative Una o più variabili indipendenti categoriali (con più livelli) Residui
La ricostruzione delle serie storiche dei principali indicatori del mercato del lavoro. IV Trimestre IV Trimestre 2003
 28 settembre 2004 La ricostruzione delle serie storiche dei principali indicatori del mercato del lavoro IV Trimestre 1992 - IV Trimestre 2003 La nuova Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro (RCFL)
28 settembre 2004 La ricostruzione delle serie storiche dei principali indicatori del mercato del lavoro IV Trimestre 1992 - IV Trimestre 2003 La nuova Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro (RCFL)
