MIGLIORAMENTO GENETICO
|
|
|
- Silvio Quarta
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 MIGLIORAMENTO GENETICO
2 MIGLIORAMENTO GENETICO SCIENZA CHE STUDIA LA TRASMISSIONE, L ESPRESSIONE E L ASSEMBLAGGIO DI CARATTERI UTILI SVILUPPA E APPLICA METODOLOGIE CAPACI DI INDIVIDUARE NELL AMBITO DI POPOLAZIONI VARIABILI - NATURALI O ARTIFICIALMENTE ORIGINATE - I GENOTIPI SUPERIORI
3 GENE: fattore ereditario (segmento di DNA che codifica per la manifestazione di un determinato carattere) ALLELI: forme alternative di un gene L allele può essere DOMINANTE se si manifesta sempre, oppure recessivo, se si manifesta solo in assenza del dominante OMOZIGOSI: presenza di due alleli uguali ETEROZIGOSI: presenza di due alleli diversi GENOTIPO: costituzione genetica (es. GG, eterozigote) FENOTIPO: espressione del carattere (es. giallo, rugoso)
4 Ogni organismo diploide nelle sue cellule somatiche ha due serie di cromosomi omologhi, una di origine materna e l altra paterna. I cromosomi rappresentano le unità strutturali dei nuclei che portano i geni. I locus è il sito occupato da un gene nel cromosoma. Ad un certo locus sono c o n t e m p o r a n e a m e n t e possibili fino a due forme alternative di uno stesso gene, cioè due alleli. Un allele può essere dominante quando è capace di esprimere compiutamente il suo effetto fenotipico anche in presenza di un altra forma allelica che risulta pertanto mascherata (allele recessivo)
5 MIGLIORAMENTO GENETICO NELLE PIANTE ARBOREE Alcune peculiarità dovute a : 1. Ciclo poliennale. Fase improduttiva, stazione produttiva ed economica, senescenza 2. Cicli fisiologici. Fasi fenologiche 3. Possibilità delle propagazione vegetativa
6 Altri aspetti: giovanilità in quelle propagate per seme elevata eterozigosi Poliploidia autoincompatibilità
7 STRUTTURA E PRODUTTIVITà DELL ALBERO Vigore, Habitus, Fertilità, Efficienza produttiva ADATTABILITà ALL AMBIENTE FISICO Aspetti eco-fisiologici, resistenza agli stress RESISTENZA ALLE AVVERSITà BIOTICHE FATTORI QUALITATIVI DEL PRODOTTO
8 Principale obiettivo della riproduzione miglioramento Genetico Creazione di nuovi genotipi con specifiche caratteristiche attraverso una scelta accurata dei parentali (genitori) Processo di selezione nella progenie ottenuta per individuare i genotipi che manifestano i geni ricercati presenti nei genitori
9 CONDIZIONI PER UN PROGRAMMA DI MG CHIAREZZA DEGLI OBIETTIVI CONOSCENZA DEL GERMOPLASMA DISPONIBILE CONOSCERE GRADO DI ETEROZIGOSI DI UNA SPECIE E POSSIBILITà DI EFFETTUARE L AUTO FECONDAZIONE
10 La variabilità genetica intraspecifica CULTIVAR e CLONE
11 Cultivar (cultivated variety) insieme di individui morfologicamente simili distinguibile da altri insiemi per almeno un carattere che possa essere mantenuto attraverso la propagazione In viticoltura il termine vitigno viene di norma indicato come sinonimo di cultivar con una definizione specifica (Roselli e Scaramuzzi, 1974); Il vitigno deriva da un processo di selezione antropica ed è costituito da un insieme di individui che provengono dalla propagazione vegetativa (moltiplicazione) di una unica pianta madre capostipite La variabilità morfologica riscontrabile all interno di una cultivar (biodiversità intravarietale) dovrebbe essere di limitata entità
12 presenza di una certa variabilità fenotipica all interno delle varietà coltivate (variabilità intra-varietale) Quali sono le cause? 1) FATTORI GENETICI : mutazioni gemmarie a partire da una unica pianta capostipite 2) FATTORI NON GENETICI /AMBIENTALI: -fattori sanitari (malattie da virus e virus-simili) -fattori ambientali (sito, tecnica colturale, annata)
13
14 Espressione fenotipica normale Espressione fenotipica alterata
15 mutazioni geniche Possono essere dovute a due meccanismi fondamentali: n mutazione per sostituzioni di basi (fenomeno più frequente) è un cambiamento in un gene tale che una coppia di basi (es. AT) viene sostituita da un'altra coppia di basi (es. GC);
16 mutazioni geniche mutazione per inserzione o delezione di basi : comporta uno spostamento della lettura del codice dal punto della delezione o inserzione in poi, perciò come conseguenza vengono codificate proteine completamente differenti da quelle originarie e, quasi sempre, il gene perde la propria funzione.
17 Conseguenze di mutazioni geniche Le mutazioni geniche sono quasi sempre di natura recessiva perché comportano la perdita di qualche funzione. In linea generale sono piuttosto rare e in genere le mutazioni geniche con lievi effetti fenotipici hanno una frequenza più elevata di quelle con effetti forti. Le mutazioni geniche possono apportare modifiche limitate e consentire così di isolare un clone all interno di una specifica varietà Tasso di mutazione Su 100 mutazioni analizzabili 25 sono letali; tra le non letali 3-4 producono ancora qualche effetto visibile, mentre le rimanenti (circa 70) non hanno effetti dannosi visibili.
18 Raffigurazione schematica della dislocazione dei diversi istogeni in un apice meristematico dove possono avvenire mutazioni gemmarie (somatiche). L1 L2 L3 Epidermidi Mesofillo fogliare, mesocarpo, organi riproduttivi Parte interna corteccia e dei vasi
19 Mutazione totale Mutazione mericlinale Apice normale non mutato Mutazione periclinale Mutazione settoriale Possibili chimere derivanti per mutazione da un apice gemmario normale
20 Possibili chimere derivanti per mutazione da un apice gemmario normale
21 CAUSE DELLE MUTAZIONI Le mutazioni possono avvenire spontaneamente (mutazioni naturali) o possono essere indotte per azione di agenti mutageni chimici o fisici. Le mutazioni spontanee sono mutazioni che avvengono naturalmente: per errori nei processi di replicazione del DNA; per azione di agenti mutageni presenti nell'ambiente (es. radiazioni solari UV; stress termici o idrici). La possibilità di mutare è un fattore indispensabile per la sopravvivenza delle specie nei periodi lunghi.
22
23
24 1. Selezione clonale in vite La selezione clonale è attualmente considerata a livello internazionale uno dei più rapidi ed efficaci mezzi di miglioramento genetico. Tale tecnica consente l individuazione e la moltiplicazione di biotipi ritenuti migliori per caratteri agronomici, produttivi, qualitativi ed enologici geneticamente determinati nell ambito della variabilità presente all interno di un vitigno, particolarmente efficace quando applicato a varietà vecchie. In Italia si è sviluppata dai primi anni 70 in seguito all esigenza di risolvere il problema del decadimento di molte varietà e di regolamentare la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione.
25 Selezione clonale E uno dei più rapidi ed efficaci mezzi di miglioramento genetico Consente l individuazione e la moltiplicazione di biotipi ritenuti migliori per caratteri agronomici, produttivi, qualitativi ed enologici geneticamente determinati, particolarmente efficace quando applicato a varietà vecchie. In Italia si è sviluppata dai primi anni 70 in seguito all esigenza di risolvere il problema del decadimento di molte varietà e di regolamentare la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione.
26 OBIETTIVI DELLA SELEZIONE CLONALE E SANITARIA Esprimere al meglio la variabilità della cultivar con numerosi cloni diversi fra loro Individuare cloni con attitudini agronomiche diversificate Individuare cloni con attitudini enologiche ottimali Ottenere un elevato standard sanitario nei confronti dei virus e delle virosi
27 Clone una discendenza vegetativa derivata da una pianta di vite capostipite scelta per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici (morfologici, agronomici, produttivi ed enologici) ed il suo stato sanitario nei confronti delle malattie virali. Tutte le piante di una discendenza clonale sono identiche fra di loro e con la pianta originaria.
28 BASI TEORICHE DELLA SELEZIONE CLONALE La selezione clonale si basa sulla presenza di una certa variabilità all interno delle varietà coltivate (variabilità intravarietale). Quali sono le cause di tale variabilità fenotipica? 1) FATTORI GENETICI : mutazioni gemmarie a partire da una unica pianta capostipite 2) FATTORI NON GENETICI /AMBIENTALI: -fattori sanitari (malattie da virus e virus-simili) -fattori ambientali (sito, tecnica colturale, annata)
29 CAUSE DELLE MUTAZIONI Le mutazioni possono avvenire spontaneamente (mutazioni naturali) o possono essere indotte per azione di agenti mutageni chimici o fisici. In termini generali le mutazioni sono un processo ricorrente e quelle favorevoli sono state fissate dalla selezione naturale o, nelle piante coltivate, dall'uomo. La possibilità di mutare è un fattore indispensabile per la sopravvivenza delle specie nei lunghi periodi.
30 - Direttiva CEE n. 68/193 del 1968 (recepita in Italia con Dpr 1164 del 1969) che stabilisce la classificazione dei materiali di coltivazione della vite (materiali di base, certificati e standard) e che i materiali commercializzabili devono essere solo quelli certificati (definiti successivamente quelli ottenuti da un processo di selezione clonale realizzato secondo un protocollo preciso successivamente messo a punto) - Istituzione del Registro Nazionale delle Varietà - Istituzione della figura del Costitutore
31 Attualmente, per contenere i rischi di erosione genetica e di riduzione della variabilità, anche nell ambito delle stesse varietà, è stata revisionata e snellita la procedura per l ottenimento della registrazione dei cloni.
32 Nuovo protocollo di selezione clonale per i vitigni ad uva da vino (Decreto del ; G.U n.139 del 18/06/2001) Anche con lo scopo principale di ridurre i tempi tecnici per ottenere nuovi cloni, è stato proposto dal MIPAF un nuovo protocollo tecnico di selezione clonale che, pur mantenendo i principi teorici del precedente, prevede alcune modifiche e si articola nelle seguenti fasi principali: 1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale;
33 2. Indagine sulla variabilità della popolazione varietale con individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni in base alle caratteristiche prescelte e prelievo del materiale di moltiplicazione. L individuazione dei presunti cloni viene effettuata da ricognizioni in tutto l areale di diffusione, comprese le aree marginali. Importante è prelevare molto materiale per evitare di perdere eventuale variabilità intravarietale.
34 3. Propagazione dei biotipi prescelti ed esecuzione dei test previsti dal protocollo fitosanitario (selezione sanitaria) per valutare la presenza di eventuali virosi. Impianto dei campi di conservazione delle piante reperite e autoradicate ove il materiale viene mantenuto per successive moltiplicazioni. Lo scopo di tali campi è quello di conservare la variabilità genetica e costituire una fonte di materiale di propagazione.
35 4. Impianto di almeno 1 vigneto di confronto (campo di omologazione) nella zona di individuazione o di diffusione del vitigno in selezione con almeno 20 ceppi per ogni biotipo su 1 portinnesto (terreno esente da nematodi vettori di virus, non coltivato a vite precedentemente, ecc..) Costituzione del campo di confronto clonale
36 5. Esecuzione di rilievi ed analisi per almeno tre annate (vigneto in piena produzione) Rilievi vegeto-produttivi indispensabili: - epoche fenologiche (germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione); - fertilità delle gemme - peso medio del grappolo - produzione per ceppo - incidenza delle principali malattie - curve di maturazione (prelievo di campioni di acini nel corso della maturazione e determinazione del contenuto in zuccheri, acidità totale e ph) + rilievi specifici legati allo scopo della selezione.
37 6. Valutazione delle potenzialità enologiche varietà con uva a bacca colorata: a) profilo degli antociani della buccia. b) profilo degli acidi idrossicinnaminici legati all acido tartarico della buccia e della polpa. c) profilo dei flavonoli della buccia. d) indici di antociani totali a maturazione e) microvinificazione per almeno 2 annate con analisi chimiche e sensoriali. varietà con uva a bacca bianca: a) microvinificazione per almeno 2 annate con analisi chimiche e sensoriali.
38
39 Selezione sanitaria La selezione sanitaria ha lo scopo di eliminare gli agenti patogeni che determinano effetti negativi e viene operativamente attuata parallelamente alla selezione clonale.
40 Selezione sanitaria Principali malattie virali 1) complesso della degenerazione infettiva (arricciamento GFLV Grapevines fanleaf virus) Nepovirus trasmessi dai nematodi (Xiphinema index) 2) complesso dell accartocciamento fogliare (GLRaV Grapevines Leafroll associated virus) Clostero virus trasmessi da cocciniglie (numerati da 1 a 9; i più gravi GLRaV 1, 2 e 3). 3) complesso del legno riccio Rupestris stem pitting (butteratura di V. rupestris); Kober stem grooving (scanalatura del K5BB); corky bark (suberosi corticale) 3 tipi GVA GVB-GRSPaV, trasmessi da cocciniglie 4) maculatura infettiva o fleck (GFKv) virosi latente si esprime su V. rupestris (portinnesti) - necrosi delle nervature e mosaico delle nervature ed Enazioni sono tollerate per vitigni di Vitis vinifera, ma non per i portinnesti (Flavescenza dorata vite (fitoplasma cicalina Scaphoideus titanus) Mal dell esca )
41 SCHEMA DELLE FASI DELLA SELEZIONE CLONALE Protocollo in vigore dal 2001 FASE 1. Individuazione in campo controlli morfologici e sanitari Campo di conservazione controlli morfologici e sanitari Selezione sanitaria più rigida Biotipi sani Biotipi virosati FASE 2. 3 anni di rilievi ampelografici vegeto-produttiviqualitativi ed enologici 1 Campo di confronto: Termoterapia/ micropropagazione risanamento FASE 3. omologazione Anno 6 1 Campo di confronto: omologazione Anno 9
42 SELEZIONE CLONALE E SANITARIA CORRETTO APPROCCIO METODOLOGICO SALVAGUARDIA BIODIVERSITA' OTTIMIZZAZIONE STATO SANITARIO OTTIMIZZAZIONE POTENZIALITA' ENOLOGICHE Conoscenza vitigno Estesi sopralluoghi Conservare biotipi esclusi CONTROLLO VIROLOGICO ELISA PCR Viti indicatrici MICROVINIFICAZIONE Controllo virologico RISANAMENTO Coltura di meristemi Termoterapia Analisi sensoriale Analisi polifenoli Analisi terpeni
43 Selezione clonale (attuata da Enti pubblici e/o privati COSTITUTORI ) documentazione sui biotipi selezionati inviata all esame del Comitato Nazionale per l esame delle Varietà di Vite valutazione dei risultati OMOLOGAZIONE del MATERIALE e iscrizione al Catalogo Nazionale delle Varietà di Vite
44 Virosi: sono malattie causate da agenti infettivi sistemici (virus) che possono causare alterazioni, talora gravi, alle piante e che permanendo nei tessuti di queste ultime si trasferiscono alle loro discendenze quando propagate.
45 Le principali virosi della vite sono a) la degenerazione infettiva o complesso dell arricciamento, causato da nepovirus (grapevine fanleaf virus GFLV; b) l accartocciamento fogliare, causato da infezioni singole o miste di Ampelovirus (grapevine leafroll associated virus 1 e 3 GLRaV-1 e 3) e da Closterovirus (grapevine leafroll associated virus 2 GLRaV-2); c) il legno riccio, di cui si conoscono quattro sindromi, il kober stem grooving causato dal grapevine virus A (GVA), il corky bark o suberosi corticale associato al grapevine virus B, il rupestris stem pitting riferibile al grapevine rupestris stem pitting associated virus (RSPaV) e l LN33 stem grooving, il cui agente causale specifico è ancora sconosciuto; d) la maculatura infettiva, causata dal grapevine fleck virus (GFkV); e) esistono infine alcune malattie simil-virali, quali il mosaico e la necrosi delle nervature, i cui agenti non sono ancora stati individuati
46 AUTOFECONDAZIONE Per verificare livello eterozigosi Indagare base genetica di specifici caratteri Rivelare stato chimerico Ottenere segregazione dei caratteri INCROCIO PROPRIAMENTE DETTO (intra-specifico) Prelievo polline da un genotipo (cultivar) per fecondare l ovocellula di un altro genotipo REINCROCIO Incrocio dell F1 con uno dei due genitori IBRIDAZIONE (incrocio inter-specifico) Per accrescere il livello di variabilità genetica
47
48 Metodologia pratica dell incrocio Step 1: Raccolta del polline I fiori della pianta padre si raccolgono qualche giorno prima della piena antesi e messi in ambiente protetto oppure si insacchettano sulla pianta fioritura delle pianti maschili contemporanea a quelle femminili fioritura delle pianti maschili anticipata fioritura delle piante maschili posticipata. conservazione a a -80 C o in azoto liquido per l anno successivo.
49
50 Step 2: preparazione delle piante femmine Sulla pianta madre (specialmente se autocompatibile) occorre eliminare la corolla per evitare visite dei pronubi e le antere (demasculazione) Varietà scelta come madre viene sottoposta a demasculazione (eliminazione della caliptra e delle antere) e poi insacchettata (per evitare l impollinazione anemofila)
51 Step 3: incrocio Quando la varietà-madre è in fioritura, si procede alla impollinazione artificiale con il polline prelevato dalla varietà - padre con un pennello.
52 Step 4: Raccolta del seme, conservazione e semina In frutti fisiologicamente maturi il seme viene sottoposto a stratificazione In vite i grappoli prodotti dall incrocio vengono raccolti e i vinaccioli estratti dai singoli acini. Per separare i vinaccioli fecondati dai semi vani vengono immersi in un piccolo beaker contenente dell acqua. Quelli che risultano buoni vengono puliti e conservati a -20 C.
53 Stratificazione per favorire la germinazione e ridurre l incidenza di marciumi a -1 C in contenitori sigillati e con carta inumidita di soluzione anticrittogamica dai 3 ai 6 mesi hydrogen peroxide and or gibberellic acid
54 In viti stenospermocarpiche si procede all espianto del seme prima della piena maturazione del frutto Allevamento del seme espiantato in embriocoltura
55 In Marzo, i vinaccioli vengono seminati in dei piccoli contenitori e lasciati germinare in serra. Quando non c è più rischio di gelate vengono trasferiti all aperto in un sito riparato con la possibilità di essere coperti. In giugno, le giovani piantine sono trasferite in un campo irrigato. Intense cure culturali per favorire il rapido raggingimento della maturità fisiologica
56
57
58
59 Primo stadio. Rilievi fenologici e morfologici in campo. Accorciamento della fase improduttiva mediante impiego di portinnesti nanizzanti o trattamenti che inducono la fioritura. Selezione naturale osservazione dei caratteri così come si presentano Selezione artificiale applicazione di stress abiotici o biotici Selezione assistita da marcatori morfologici o biochimici o molecolari
60 Secondo stadio. Propagazione agamica dei semenzali scelti e messa a dimora degli esemplari in due diverse località in campi di selezione che presentano anche varietà commerciali. Terzo stadio. Soggetti esterni al costitutore effettuano valutazione precommerciale sulle selezioni che risutano decisamente superiori Consumer test Determinazione della shelf life
61 Rappresenta l'unione sessuale tra due individui di specie diverse. Elemento fondamentale per iniziare un lavoro di ibridazione è la conoscenza delle diverse specie cioè dei geni che le singole specie possiedono. Nel genere vitis le specie americane presentano numerosi geni di resistenza alle avversità biotiche e abiotiche, mentre la Vitis vinifera, caratterizzata da alti livelli qualitativi, non presenta geni per la resistenza ad esclusione di quelli per la salinità e calcare.
62 Nella vite è stato applicato prevalentemente per: -ottenere varietà di uve da vino che presentassero le caratteristiche qualitative di V.vinifera unite con resistenza a patogeni di varia origine. -ottenere nuovi portinnesti
63 Queste ricerche sono state condotte inizialmente in Francia allo scopo di ottenere individui aventi produzioni con livelli qualiquantitativi della V.vinifera + la resistenza alla fillossera e ad altre malattie crittogamiche delle viti americane. Inizialmente si sono ottenuti ibridi di prima generazione che si sono diffusi in Francia e limitatamente in Italia Ad es. sono ancora oggi presenti Isabella o uva fragola (forse V. vinifera x V.labrusca) Clinton (V. labrusca x V. Riparia).
64 Dieci nuovi vitigni ibridi iscritti quest anno al Registro Nazionale ottenuti da un programma di selzione dell università di Udine alllo scopo di ridurre l utilizzo di fitofarmaci in viticoltura (in Europa attività agricola tra le più impattanti sull ambiente -pur occupando soltanto il 3,3% della superficie agricola, utilizza il 65% di tutti i funghicidi impiegati in agricoltura) Bacca bianca: Fleurtai, Soreli, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Bacca rossa: Sauvignon Rytos, Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Merlot Khorus, Merlot Kanthus, Julius,
65 Ibridi Produttori diretti Produttori Portinnesti
66 senza impiego di portinnesti: IBRIDI PRODUTTORI DIRETTI di prima generazione. Clinton (V.riparia x V.labrusca) Noah (V.labrusca x V. riparia) i vini derivati mantenevano quasi tutti il caratteristico odore-sapore di Foxy, altrimenti detto volpino, della labrusca. Nonostante gli sforzi dei genetisti, la qualità organolettica non poté essere migliorata senza perdere le caratteristiche di resistenza alla fillossera e ad altre malattie fungine.
67 fine dell'800 IBRIDI tra la vite europea (Vitis vinifera) e le altre specie di viti presenti nel mondo VITE IDEALE le qualità organolettiche della vitis vinifera + resistenza alle malattie (fillossera, oidio peronospora) delle viti americane
68 incrocio con specie di vite americane, ma anche asiatiche: molto noti gli ibridi di prima generazione con utilizzo di portinnesto: IBRIDI PRODUTTORI di seconda generazione Ibridi di prima generazione x V. vinifera Specie pure x V. vinifera Clinton, Isabella, Noah, Bacò, Seyval, Villard Blanc, ecc. IBRIDI PRODUTTORI di terza generazione Ibridi di seconda generazione x V. vinifera Syrius, Cayuga white
69 Seibel Seyve villard 5276
70 Il gruppo di Udine ha lavorato finora con due resistenze monogeniche a peronospora (Rpv3, Rpv12), provenienti rispettivamente da specie americane e asiatiche, e due resistenze monogeniche ad oidio (Ren1 e Run1), la prima delle quali identificata in alcune varietà di 'vinifera' coltivate in alcune repubbliche dell'asia centrale (Uzbekistan, Tadjikistan, Daghestan, Moldova, Armenia, Russia, Georgia); la seconda presente in Muscadinia, un genere affine al genere Vitis, su cui in passato hanno lavorato per alcuni decenni i francesi e introgressa in vinifera dai ricercatori di quel Paese. Gli ibridi interspecifici fertili ottenuti all'inizio del XX secolo da Detjen, nonostante il diverso numero di cromosomi che caratterizza le due specie ( 2n = 38 per Vitis e 2n = 40 per Muscadinia) hanno permesso, con una serie di incroci successivi, di ottenere discendenze con corredo cromosomico 2n = 38, fertili, con il gene RUN1 e caratteristiche interessanti delle bacche. Ovviamente per le resistenze identificate in viti americane e asiatiche non si è partiti dalle specie selvatiche, ma si è fatto uso dei risultati di incroci operati da ricercatori di altri Paesi, come Germania, Francia, Ungheria, Austria, Repubblica Serba e Uzbekistan. Si tratta di selezioni avanzate, alcune già in coltivazione in diversi Paesi dell'ue e fuori Europa. Le selezioni resistenti utilizzate negli incroci sono Bianca, Regent, 20/3, Seyval, Pannonia, SK-00-1/2 e altre. Si tratta di varietà con pedigree a volte molto complessi, che riflettono il grande lavoro svolto da istituti di ricerca stranieri in 50 e a volte più anni di attività
71 PORTINNESTI Riparia Gloire de Montpellier (selezione di Vitis riparia) Rupestris du Lot (selezione di Vitis rupestris) Più fortuna delle specie capostipiti hanno avuto i loro ibridi, detti americani. Principalmente si sono avuti ibridi a due vie: 1. Vitis riparia x Vitis Rupestris 2. Vitis Berlandieri x Vitis riparia 3. Vitis Berlandieri x Vitis Rupestris
72 Gruppo Vitis riparia x Vitis rupestris vigore moderato, adatti a terreni di discreta fertilità scarsa resistenza alla siccità ma non sopportano neppure i ristagni idrici, la compattezza dei terreni e tenori elevati di calcare attivo. inducono anticipo di maturazione e sono quindi consigliati per ambienti settentrionali Non eccellono nell'affinità di innesto. Tra questi citiamo il 3306, il 3309, il , il e lo "Schwarzmann".
73 Gruppo Vitis berlandieri x Vitis riparia resistenza alla clorosi tendono a conferire precocità nella fase di maturazione; sono da preferire in terreni fertili, sciolti, profondi, poco siccitosi Sono maggiormente diffusi nelle regioni settentrionali e centrali buona affinità d innesto con i diversi vitigni Tra i più utilizzati si citano : SO4, 420 A, 34 EM, C, Kober 5BB.
74 Gruppo Vitis berlandieri x Vitis rupestris maggiore vigoria alla marza particolarmente indicati per i terreni più difficili per quanto concerne il potere clorosante, l aridità, il basso contenuto in elementi nutritivi il loro utilizzo ha maggiormente interessato le regioni meridionali Tra i più diffusi abbiamo: 140 Ru, 1103 P, 775 P, 779 P.
75 Un ulteriore passo nel processo di ibridizzazione dei portinnesti viene compiuto con l'introduzione nella linea genetica di altre specie e in particolare della Vitis Vinifera introdotta per apportare maggiore affinità di innesto e maggiore resistenza al calcare. Si hanno così tutta una serie di ibridi complessi difficilmente caratterizzabili in gruppi. I più diffusi in Italia: 41B ibrido di Chasselas x Vitis Berlandieri è caratterizzato da una resistenza notevole al calcare e alla siccità, media vigoria ma per contro una media resistenza alla fillossera. 333 EM da Cabernet Sauvignon x Vitis Berlandieri, anch'esso resistente a calcare, da cui è derivato il Fercal considerato il portinnesto più resistente al calcare attivo.
76 Resistenza e sensibilità alla fillossera delle varie specie e portinnesti Scarsa Medie Resistenti V. vinifera V. cinerea V. rotundifolia V. labrusca V. aestivalis V. riparia V. vinifera x V. labrusca V. candicans V. rupestris V. californica V. solonis V. cordifolia 2G Riparia x Rupestris Ramsey V. monticala 1202 C Mourvèdre x Rupestris Vinifera x Berlandieri V. arizonica Aramon x Rupestris Grezot 1 o G1 (16.16 x Rup. du Lot) x (Aramon x Rup. Ganzin 1) V. lincecumii Riparia x Rupestris C Berlandieri x Rupestris Dod Ridge Harmony Berlandieri x Riparia APPROFONDIMENTO DC0838:IT:HTML
77
78 SEQUENZIAMENTO GENOME DELLA VITE Articles Sabbatini P., Stanley Howell G. e Herrera J. C., Ibridi di Vitis: storia, status e futuro. Italus Hortus 20 (2): 33-43
La Selezione clonale della vite: strategie e modalità operative
 La Selezione clonale della vite: strategie e modalità operative Giuseppe Ferroni Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali Università degli Studi di Pisa Seminario Viticoltura Speciale
La Selezione clonale della vite: strategie e modalità operative Giuseppe Ferroni Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali Università degli Studi di Pisa Seminario Viticoltura Speciale
La Selezione clonale della vite: strategie e modalità operative
 La Selezione clonale della vite: strategie e modalità operative Giancarlo Scalabrelli Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e agro ambientali, Università degli Studi di Pisa gscalabrelli@agr.unipi.it
La Selezione clonale della vite: strategie e modalità operative Giancarlo Scalabrelli Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e agro ambientali, Università degli Studi di Pisa gscalabrelli@agr.unipi.it
IL MIGLIORAMENTO GENETICO DELLA VITE IN LIGURIA TRAMITE SELEZIONE CLONALE
 IL MIGLIORAMENTO GENETICO DELLA VITE IN LIGURIA TRAMITE SELEZIONE CLONALE F. Mannini Istituto Virologia Vegetale Unità Viticoltura - C.N.R., Grugliasco (TO), Italy Presidente Associazione Costitutori Viticoli
IL MIGLIORAMENTO GENETICO DELLA VITE IN LIGURIA TRAMITE SELEZIONE CLONALE F. Mannini Istituto Virologia Vegetale Unità Viticoltura - C.N.R., Grugliasco (TO), Italy Presidente Associazione Costitutori Viticoli
LE NUOVE VARIETA DI VITE RESISTENTI ALLE MALATTIE
 LE NUOVE VARIETA DI VITE RESISTENTI ALLE MALATTIE Enrico Peterlunger Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali UNIUD Convegno «Le nuove sfide della viticoltura» Università di Udine -
LE NUOVE VARIETA DI VITE RESISTENTI ALLE MALATTIE Enrico Peterlunger Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali UNIUD Convegno «Le nuove sfide della viticoltura» Università di Udine -
Certificazione delle barbatelle: un vantaggio o una necessità!
 Département fédéral de l'économie DFE Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW Certificazione delle barbatelle: un vantaggio o una necessità! VIROSI DELLA VITE Giornata del Viticoltore, 30
Département fédéral de l'économie DFE Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW Certificazione delle barbatelle: un vantaggio o una necessità! VIROSI DELLA VITE Giornata del Viticoltore, 30
SELEZIONE CLONALE DEI VITIGNI AUTOCTONI LAZIALI
 SELEZIONE CLONALE DEI VITIGNI AUTOCTONI LAZIALI A. Costacurta, E. Angelini, I. Bazzo, M. Borgo, R. Carraro, G. Casadei, M. Crespan, S. Giannetto, S. Meneghetti, M. Niero U.O. CRA CENTRO DI RICERCA PER
SELEZIONE CLONALE DEI VITIGNI AUTOCTONI LAZIALI A. Costacurta, E. Angelini, I. Bazzo, M. Borgo, R. Carraro, G. Casadei, M. Crespan, S. Giannetto, S. Meneghetti, M. Niero U.O. CRA CENTRO DI RICERCA PER
Caratteristiche vegetative e produttive di 20 biotipi di Cannonau
 Caratteristiche vegetative e produttive di 20 biotipi di Cannonau relatore Franco FRONTEDDU Dorgali 25 ottobre 2016 Progetto di ricerca N.O.V.E.S. (Nuovi Orientamenti per la Viticoltura ed Enologia Sarda)
Caratteristiche vegetative e produttive di 20 biotipi di Cannonau relatore Franco FRONTEDDU Dorgali 25 ottobre 2016 Progetto di ricerca N.O.V.E.S. (Nuovi Orientamenti per la Viticoltura ed Enologia Sarda)
Fattori limitanti nel vigneto Giancarlo Scalabrelli
 Fattori limitanti nel vigneto Giancarlo Scalabrelli Stress abiotici, biotici inerenti al suolo e/o all atmosfera. Stress abiotici Stress biotici Altri parassiti Nuove emergenze fitoiatriche Adattamento
Fattori limitanti nel vigneto Giancarlo Scalabrelli Stress abiotici, biotici inerenti al suolo e/o all atmosfera. Stress abiotici Stress biotici Altri parassiti Nuove emergenze fitoiatriche Adattamento
GRIGNOLINO CVT 113. Vitigni del Piemonte Varietà e Cloni
 GRIGNOLINO CVT 113 Origine: Cuccaro M.to (AL). Anno di omologazione: 2001. Vigneto di riferimento: Scurzolengo (AT); collinare, terreno medio impasto, controspalliera potata a Guyot, densità di impianto
GRIGNOLINO CVT 113 Origine: Cuccaro M.to (AL). Anno di omologazione: 2001. Vigneto di riferimento: Scurzolengo (AT); collinare, terreno medio impasto, controspalliera potata a Guyot, densità di impianto
Si fa presto a dire vite, ma
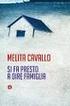 >> TECNICA/ VIGNETO LE NUOVE VARIETÀ RESISTENTI ALLE MALATTIE di Eugenio Sartori Direttore generale dei Vivai Cooperativi Rauscedo I punti di forza delle cultivar messe a punto in Italia, finalmente iscritte
>> TECNICA/ VIGNETO LE NUOVE VARIETÀ RESISTENTI ALLE MALATTIE di Eugenio Sartori Direttore generale dei Vivai Cooperativi Rauscedo I punti di forza delle cultivar messe a punto in Italia, finalmente iscritte
RAFFORZANTE PER LA VIROSI DI VITE, POMODORO E PATATA
 1 RAFFORZANTE PER LA VIROSI DI VITE, POMODORO E PATATA APPLICAZIONE: alla prima comparsa dei sintomi su alcune piante intervenire immediatamente per via fogliare alla dose di Lt 2,5/ha e ripetere l'intervento
1 RAFFORZANTE PER LA VIROSI DI VITE, POMODORO E PATATA APPLICAZIONE: alla prima comparsa dei sintomi su alcune piante intervenire immediatamente per via fogliare alla dose di Lt 2,5/ha e ripetere l'intervento
VITI RESISTENTI: IL FUTURO DI CUI ABBIAMO BISOGNO. Viti resistenti e cura del paesaggio: gli obiettivi del prossimo futuro
 VITI RESISTENTI: IL FUTURO DI CUI ABBIAMO BISOGNO Il vero impegno per un territorio sempre più ecosostenibile. Viti resistenti e cura del paesaggio: gli obiettivi del prossimo futuro En. Emanuele Serafin
VITI RESISTENTI: IL FUTURO DI CUI ABBIAMO BISOGNO Il vero impegno per un territorio sempre più ecosostenibile. Viti resistenti e cura del paesaggio: gli obiettivi del prossimo futuro En. Emanuele Serafin
REGIONE CAMPANIA ASSESSORATO AGRICOLTURA
 CARLO SARDO Unità Nazionale di Coordinamento controllo e commercializzazione del materiale di moltiplicazione della vite LE PRINCIPALI MALATTIE DELLA VITE REGIONE CAMPANIA FUNGHI Peronospora della vite
CARLO SARDO Unità Nazionale di Coordinamento controllo e commercializzazione del materiale di moltiplicazione della vite LE PRINCIPALI MALATTIE DELLA VITE REGIONE CAMPANIA FUNGHI Peronospora della vite
Nuove selezioni resistenti alle principali ampelopatie ottenute a partire da Glera Dr.ssa Barbara De Nardi
 Glera: gli studi del CREA per la sua coltivazione Agronomia, fisiologia, genetica, difesa Nuove selezioni resistenti alle principali ampelopatie ottenute a partire da Glera Dr.ssa Barbara De Nardi Centro
Glera: gli studi del CREA per la sua coltivazione Agronomia, fisiologia, genetica, difesa Nuove selezioni resistenti alle principali ampelopatie ottenute a partire da Glera Dr.ssa Barbara De Nardi Centro
Introduzione alla conoscenza dei vitigni resistenti alle malattie e qualità dei vini
 Introduzione alla conoscenza dei vitigni resistenti alle malattie e qualità dei vini Attività di ricerca e di miglioramento sanitario La selezione genetica e sanitaria del vitigno Nebbiolo Chiavennasca
Introduzione alla conoscenza dei vitigni resistenti alle malattie e qualità dei vini Attività di ricerca e di miglioramento sanitario La selezione genetica e sanitaria del vitigno Nebbiolo Chiavennasca
BARBERA CVT 83. Vitigni del Piemonte Varietà e Cloni
 BARBERA CVT 83 Origine: Calosso (AT). Anno di omologazione: 2001. Nucleo di premoltiplicazione: CE.PRE.MA.VI.- Regione Piemonte. Vigneto di riferimento: Scurzolengo (AT); collinare, terreno medio impasto,
BARBERA CVT 83 Origine: Calosso (AT). Anno di omologazione: 2001. Nucleo di premoltiplicazione: CE.PRE.MA.VI.- Regione Piemonte. Vigneto di riferimento: Scurzolengo (AT); collinare, terreno medio impasto,
La genetica è la scienza dell ereditarietà: Studia la trasmissione delle caratteristiche ereditarie, che distinguono gli individui tra di loro
 La genetica è la scienza dell ereditarietà: Studia la trasmissione delle caratteristiche ereditarie, che distinguono gli individui tra di loro la comprensione di come i geni si trasmettono da genitori
La genetica è la scienza dell ereditarietà: Studia la trasmissione delle caratteristiche ereditarie, che distinguono gli individui tra di loro la comprensione di come i geni si trasmettono da genitori
Gli eventi caratteristici della meiosi sono:
 Gli eventi caratteristici della meiosi sono: 1. la segregazione (=separazione) dei cromosomi omologhi; 2. l assortimento indipendente dei cromosomi; 3. il crossing-over LA COMPRENSIONE DI COME I GENI SI
Gli eventi caratteristici della meiosi sono: 1. la segregazione (=separazione) dei cromosomi omologhi; 2. l assortimento indipendente dei cromosomi; 3. il crossing-over LA COMPRENSIONE DI COME I GENI SI
SPECIALE MIGLIORAMENTO GENETICO
 Tecnica SPECIALE MIGLIORAMENTO GENETICO Dall Università di Udine nuove varietà di vite resistenti alle malattie Gabriele Di Gaspero 1,2 - Michele Morgante 1,2 - Enrico Peterlunger 1 - Simone Diego Castellarin
Tecnica SPECIALE MIGLIORAMENTO GENETICO Dall Università di Udine nuove varietà di vite resistenti alle malattie Gabriele Di Gaspero 1,2 - Michele Morgante 1,2 - Enrico Peterlunger 1 - Simone Diego Castellarin
AVVERSITÀ DELLA VITE
 Michele Borgo con la collaborazione di Giancarlo Moretti AVVERSITÀ DELLA VITE PARTE SECONDA ATLANTE MALATTIE SU VITIGNI SOMMARIO Prefazione 1 Varietà ad uva da vino analizzate A. Vitigni ad uva da vino
Michele Borgo con la collaborazione di Giancarlo Moretti AVVERSITÀ DELLA VITE PARTE SECONDA ATLANTE MALATTIE SU VITIGNI SOMMARIO Prefazione 1 Varietà ad uva da vino analizzate A. Vitigni ad uva da vino
GENETICA. Modulo di 6 CFU. Esame integrato di BIOCHIMICA&GENETICA Secondo anno del corso di laurea triennale in SCIENZE AMBIENTALI
 GENETICA Modulo di 6 CFU Esame integrato di BIOCHIMICA&GENETICA Secondo anno del corso di laurea triennale in SCIENZE AMBIENTALI Docente: Flavia Cerrato Dip.to Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche
GENETICA Modulo di 6 CFU Esame integrato di BIOCHIMICA&GENETICA Secondo anno del corso di laurea triennale in SCIENZE AMBIENTALI Docente: Flavia Cerrato Dip.to Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche
8. La genetica studia la trasmissione dei caratteri ereditari
 8. La genetica studia la trasmissione dei caratteri ereditari La genetica studia le modalità di trasmissione dei caratteri ereditari e il modo in cui questi si manifestano. Ogni genitore trasmette ai figli
8. La genetica studia la trasmissione dei caratteri ereditari La genetica studia le modalità di trasmissione dei caratteri ereditari e il modo in cui questi si manifestano. Ogni genitore trasmette ai figli
Vigneto veneto, andamento e previsioni produttive Tecniche di mitigazione in attesa dei vitigni resistenti Diego Tomasi e Coll.
 Vigneto veneto, andamento e previsioni produttive 2016 Tecniche di mitigazione in attesa dei vitigni resistenti Diego Tomasi e Coll. Quale innovazione è più urgente presso le aziende viticole italiane
Vigneto veneto, andamento e previsioni produttive 2016 Tecniche di mitigazione in attesa dei vitigni resistenti Diego Tomasi e Coll. Quale innovazione è più urgente presso le aziende viticole italiane
La trasmissione dei caratteri genetici. le leggi di Mendel
 La trasmissione dei caratteri genetici e le leggi di Mendel I figli assomigliano ai genitori perché hanno ereditato da loro alcune caratteristiche fisiche. Ma in che modo avviene questa trasmissione dei
La trasmissione dei caratteri genetici e le leggi di Mendel I figli assomigliano ai genitori perché hanno ereditato da loro alcune caratteristiche fisiche. Ma in che modo avviene questa trasmissione dei
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ IN VITICOLTURA: I NUOVI VITIGNI RESISTENTI ALLE MALATTIE UNIUD/IGA/VCR
 INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ IN VITICOLTURA: I NUOVI VITIGNI RESISTENTI ALLE MALATTIE UNIUD/IGA/VCR LA CREAZIONE ATTRAVERSO IBRIDAZIONE DI NUOVI VITIGNI RESISTENTI ALLE MALATTIE 1829: Louis ed Henri Bouschet
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ IN VITICOLTURA: I NUOVI VITIGNI RESISTENTI ALLE MALATTIE UNIUD/IGA/VCR LA CREAZIONE ATTRAVERSO IBRIDAZIONE DI NUOVI VITIGNI RESISTENTI ALLE MALATTIE 1829: Louis ed Henri Bouschet
BIOTECNOLOGIE SOSTENIBILI PER L AGRICOLTURA ITALIANA
 BIOTECNOLOGIE SOSTENIBILI PER L AGRICOLTURA ITALIANA Perché un nuovo programma di miglioramento genetico? il miglioramento genetico delle piante agrarie rappresenta lo strumento potenzialmente più idoneo
BIOTECNOLOGIE SOSTENIBILI PER L AGRICOLTURA ITALIANA Perché un nuovo programma di miglioramento genetico? il miglioramento genetico delle piante agrarie rappresenta lo strumento potenzialmente più idoneo
L offerta di innovazione del vigneto in base ai progressi del miglioramento genetico
 L offerta di innovazione del vigneto in base ai progressi del miglioramento genetico Jose Carlos Herrera Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Università di Udine jc.herrera@uniud.it Quale innovazione
L offerta di innovazione del vigneto in base ai progressi del miglioramento genetico Jose Carlos Herrera Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Università di Udine jc.herrera@uniud.it Quale innovazione
DOLCETTO CVT 8. Vitigni del Piemonte Varietà e Cloni
 DOLCETTO CVT 8 Origine: Alba (CN). Anno di omologazione: 2001. Vigneto di riferimento: La Morra (CN); collinare, terreno medio impasto, controspalliera potata a Guyot, densità di impianto 3250 ceppi/ha;
DOLCETTO CVT 8 Origine: Alba (CN). Anno di omologazione: 2001. Vigneto di riferimento: La Morra (CN); collinare, terreno medio impasto, controspalliera potata a Guyot, densità di impianto 3250 ceppi/ha;
Varietà resistenti ai patogeni tra tradizione e innovazione. M. Morgante, G. Di Gaspero. E. Peterlunger, R. Testolin
 Varietà resistenti ai patogeni tra tradizione e innovazione M. Morgante, G. Di Gaspero. E. Peterlunger, R. Testolin PER UN AGRICOLTURA DEL FUTURO Produttività Impatto ambientale Qualità e salute AGRICOLTURA
Varietà resistenti ai patogeni tra tradizione e innovazione M. Morgante, G. Di Gaspero. E. Peterlunger, R. Testolin PER UN AGRICOLTURA DEL FUTURO Produttività Impatto ambientale Qualità e salute AGRICOLTURA
Le NBT applicate all agricoltura. Michele Morgante Roma, 22 febrraio 2018
 Le NBT applicate all agricoltura Michele Morgante Roma, 22 febrraio 2018 AGRICOLTURA E PROGRESSO TECNOLOGICO Genetica (miglioramento genetico) Chimica Tecniche agronomiche Genetica: >50% di aumento produttività
Le NBT applicate all agricoltura Michele Morgante Roma, 22 febrraio 2018 AGRICOLTURA E PROGRESSO TECNOLOGICO Genetica (miglioramento genetico) Chimica Tecniche agronomiche Genetica: >50% di aumento produttività
Mendel, il padre della genetica
 Mendel, il padre della genetica Gregor Mendel (1822-1894), monaco e naturalista, condusse esperimenti di genetica in un orto del monastero di Brno, nell odierna Repubblica Ceca. La genetica dell Ottocento
Mendel, il padre della genetica Gregor Mendel (1822-1894), monaco e naturalista, condusse esperimenti di genetica in un orto del monastero di Brno, nell odierna Repubblica Ceca. La genetica dell Ottocento
VITE: IL FUTUTO E RESISTENTE? Gli aspetti viticoli
 VITE: IL FUTUTO E RESISTENTE? Gli aspetti viticoli Aspetti sanitari-fenologici-produttivi Paolo Belvini Lorenzo Dalla Costa - Giovanni Pascarella - Angelo Pizzolato Bruno Zanatta - Jacopo Fogal - Luana
VITE: IL FUTUTO E RESISTENTE? Gli aspetti viticoli Aspetti sanitari-fenologici-produttivi Paolo Belvini Lorenzo Dalla Costa - Giovanni Pascarella - Angelo Pizzolato Bruno Zanatta - Jacopo Fogal - Luana
BIOTECNOLOGIE SOSTENIBILI PER L AGRICOLTURA ITALIANA
 BIOTECNOLOGIE SOSTENIBILI PER L AGRICOLTURA ITALIANA Perché un nuovo programma di miglioramento genetico? il miglioramento genetico delle piante agrarie rappresenta lo strumento potenzialmente più idoneo
BIOTECNOLOGIE SOSTENIBILI PER L AGRICOLTURA ITALIANA Perché un nuovo programma di miglioramento genetico? il miglioramento genetico delle piante agrarie rappresenta lo strumento potenzialmente più idoneo
MOSCATO BIANCO CN 4. Vitigni del Piemonte Varietà e Cloni
 MOSCATO BIANCO CN 4 Origine: Castiglione Tinella (CN). Anno di omologazione: 1980. Nucleo di premoltiplicazione: CE.PRE.MA.VI.-Regione Piemonte. Vigneto di riferimento: Canelli (AT); collinare, terreno
MOSCATO BIANCO CN 4 Origine: Castiglione Tinella (CN). Anno di omologazione: 1980. Nucleo di premoltiplicazione: CE.PRE.MA.VI.-Regione Piemonte. Vigneto di riferimento: Canelli (AT); collinare, terreno
Le varietà di vite resistenti da vino, opportunità da scoprire
 Le varietà di vite resistenti da vino, opportunità da scoprire Evoluzioni normative in Italia e nei principali Paesi produttori Paolo Giorgetti DISR V - Servizio fitosanitario Centrale, produzioni vegetali
Le varietà di vite resistenti da vino, opportunità da scoprire Evoluzioni normative in Italia e nei principali Paesi produttori Paolo Giorgetti DISR V - Servizio fitosanitario Centrale, produzioni vegetali
Mendel e l ereditarietà. Anna Onofri
 Mendel e l ereditarietà Anna Onofri Mendel, il padre della genetica Gregor Mendel (1822-1894) era un monaco e naturalista che condusse i suoi studi nel giardino del monastero di Brno, nell odierna Repubblica
Mendel e l ereditarietà Anna Onofri Mendel, il padre della genetica Gregor Mendel (1822-1894) era un monaco e naturalista che condusse i suoi studi nel giardino del monastero di Brno, nell odierna Repubblica
Chi siamo. Produciamo da 30 anni vini Biologici, nel rispetto della natura e dell'ambiente che ci circonda.
 Chi siamo L Azienda Agricola Le Carline si trova nel cuore della zona DOC Lison-Pramaggiore e DOC Venezia, (l area viticola biologica più grande d Europa). Produciamo da 30 anni vini Biologici, nel rispetto
Chi siamo L Azienda Agricola Le Carline si trova nel cuore della zona DOC Lison-Pramaggiore e DOC Venezia, (l area viticola biologica più grande d Europa). Produciamo da 30 anni vini Biologici, nel rispetto
La biodiversità viticola del Pollino
 La biodiversità viticola del Pollino Albanese G., Sunseri F., Zappia R., Rosanova L.* Dipartimento AGRARIA - Università Mediterranea di Reggio Calabria * Campoverde SpA Agricola Castrovillari (CS) La variabilità
La biodiversità viticola del Pollino Albanese G., Sunseri F., Zappia R., Rosanova L.* Dipartimento AGRARIA - Università Mediterranea di Reggio Calabria * Campoverde SpA Agricola Castrovillari (CS) La variabilità
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite
 Ordinanza del DFE concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (Ordinanza del DFE sulle piante di vite) Modifica del 23 maggio 2012 Il Dipartimento
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (Ordinanza del DFE sulle piante di vite) Modifica del 23 maggio 2012 Il Dipartimento
DOSSIER: ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DI VITE VARIETA : CATANESE BIANCA
 Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DOSSIER: ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA'
Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DOSSIER: ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA'
LE LEGGI DI MENDEL SPIEGANO LA TRASMISSIONE DEI CARATTERI MONOFATTORIALI!!
 CARATTERE = una qualsiasi caratteristica di un organismo FENOTIPO (INSIEME DEI CARATTERI OSSERVABILI DELL ORGANISMO) GENOTIPO (COSTITUZIONE GENETICA DELL'INDIVIDUO, PATRIMONIO EREDITARIO) EREDITARIO: carattere
CARATTERE = una qualsiasi caratteristica di un organismo FENOTIPO (INSIEME DEI CARATTERI OSSERVABILI DELL ORGANISMO) GENOTIPO (COSTITUZIONE GENETICA DELL'INDIVIDUO, PATRIMONIO EREDITARIO) EREDITARIO: carattere
Struttura genetica delle popolazioni. Piante a propagazione vegetativa Piante autogame Piante allogame
 Struttura genetica delle popolazioni Piante a propagazione vegetativa Piante autogame Piante allogame PIANTE A PROPAGAZIONE VEGETATIVA La popolazione è costituita da un numero infinitamente grande di individui
Struttura genetica delle popolazioni Piante a propagazione vegetativa Piante autogame Piante allogame PIANTE A PROPAGAZIONE VEGETATIVA La popolazione è costituita da un numero infinitamente grande di individui
PRESENTE E FUTURO DEGLI IBRIDI DI VITE
 Padiglione MiPAAFT PRESENTE E FUTURO DEGLI IBRIDI DI VITE Prof. Luigi BAVARESCO DI.PRO.VE.S., sezione Frutticoltura e Viticoltura Centro di Ricerca sulla Biodiversità e sul DNA antico Università Cattolica
Padiglione MiPAAFT PRESENTE E FUTURO DEGLI IBRIDI DI VITE Prof. Luigi BAVARESCO DI.PRO.VE.S., sezione Frutticoltura e Viticoltura Centro di Ricerca sulla Biodiversità e sul DNA antico Università Cattolica
L ENOLOGO NOVEMBRE 2010
 DOCUMENTO TECNICO *Alessandro Zappata *Jacopo Cricco **Serena Imazio *Luca Toninato **Anna Zorloni **Attilio Scienza *Ager Sc - Agricoltura e Ricerca - Milano ** DIPROVE - Università degli Studi di Milano
DOCUMENTO TECNICO *Alessandro Zappata *Jacopo Cricco **Serena Imazio *Luca Toninato **Anna Zorloni **Attilio Scienza *Ager Sc - Agricoltura e Ricerca - Milano ** DIPROVE - Università degli Studi di Milano
3 modulo didattico - Le
 3 modulo didattico - Le mutazioni del DNA e le malattie monogeniche. Le mutazioni del genoma umano Mutazione: qualsiasi cambiamento permanente ed ereditabile del DNA Mutazione ereditata proveniente dai
3 modulo didattico - Le mutazioni del DNA e le malattie monogeniche. Le mutazioni del genoma umano Mutazione: qualsiasi cambiamento permanente ed ereditabile del DNA Mutazione ereditata proveniente dai
Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino. Scopriamo la biologia
 Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino Scopriamo la biologia Capitolo 5 La basi della genetica 3 1. La genetica e i caratteri ereditari /1 La genetica è la scienza che studia le leggi e i meccanismi di
Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino Scopriamo la biologia Capitolo 5 La basi della genetica 3 1. La genetica e i caratteri ereditari /1 La genetica è la scienza che studia le leggi e i meccanismi di
DOSSIER: ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DI VITE VARIETA : USIRIOTO
 Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DOSSIER: ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA'
Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DOSSIER: ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA'
La nuova biologia.blu
 David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum La nuova biologia.blu Genetica, DNA ed evoluzione PLUS 2 Capitolo B1 Da Mendel ai modelli di ereditarietà 3 Mendel, il padre della genetica
David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum La nuova biologia.blu Genetica, DNA ed evoluzione PLUS 2 Capitolo B1 Da Mendel ai modelli di ereditarietà 3 Mendel, il padre della genetica
PROGETTAZIONE ANNUALE PER COMPETENZE Classe III Biotecnologie GAT
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA AGRARIA Mario Rigoni Stern Bergamo PROGETTAZIONE ANNUALE PER COMPETENZE Classe III Biotecnologie GAT Pagina 1 di 9 AREA TECNICO - SCIENTIFICA Il piano annuale dell
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA AGRARIA Mario Rigoni Stern Bergamo PROGETTAZIONE ANNUALE PER COMPETENZE Classe III Biotecnologie GAT Pagina 1 di 9 AREA TECNICO - SCIENTIFICA Il piano annuale dell
I POTENZIALI MERCATI E LA VALENZA ECONOMICA DEI NUOVI VITIGNI RESISTENTI ALLE MALATTIE
 I POTENZIALI MERCATI E LA VALENZA ECONOMICA DEI NUOVI VITIGNI RESISTENTI ALLE MALATTIE UDINE 18 gennaio 2016 EUGENIO SARTORI LA VITICOLTURA OGGI Superficie a vigneto: 7.573.000 Varietà di Vitis Vinifera:
I POTENZIALI MERCATI E LA VALENZA ECONOMICA DEI NUOVI VITIGNI RESISTENTI ALLE MALATTIE UDINE 18 gennaio 2016 EUGENIO SARTORI LA VITICOLTURA OGGI Superficie a vigneto: 7.573.000 Varietà di Vitis Vinifera:
Le analisi di laboratorio per la viticoltura e l'enologia
 REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA e PROTEZIONE CIVILE Settore Servizi alle Imprese Agricole I servizi Specialistici Regionali a supporto delle Imprese: Le analisi di laboratorio per la viticoltura
REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA e PROTEZIONE CIVILE Settore Servizi alle Imprese Agricole I servizi Specialistici Regionali a supporto delle Imprese: Le analisi di laboratorio per la viticoltura
Cod. VM5U3. Impianto del vigneto Scelta del portinnesto
 Cod. VM5U3 Impianto del vigneto Scelta del portinnesto Scopi del portinnesto Prima della comparsa della fillossera la vite europea si propagava per talea o mediante altra forma di moltiplicazione vegetativa,
Cod. VM5U3 Impianto del vigneto Scelta del portinnesto Scopi del portinnesto Prima della comparsa della fillossera la vite europea si propagava per talea o mediante altra forma di moltiplicazione vegetativa,
Stato dell arte sulle varietà di vite resistenti nel Lazio
 Stato dell arte sulle varietà di vite resistenti nel Lazio Velletri 07 giugno 2019 dott agr Giovanni Pica ARSIAL p.a. Giorgio Casadei ARSIAL dati generali VP: 130 Mln (6% comparto agricoltura regionale
Stato dell arte sulle varietà di vite resistenti nel Lazio Velletri 07 giugno 2019 dott agr Giovanni Pica ARSIAL p.a. Giorgio Casadei ARSIAL dati generali VP: 130 Mln (6% comparto agricoltura regionale
Grapevine Pinot gris virus GPGV. INCONTRO SUL PIANO DEI MONITORAGGI 2017 Milano, Palazzo Lombardia 9 maggio M.Calvi Laboratorio Fitopatologico SFR
 Grapevine Pinot gris virus GPGV INCONTRO SUL PIANO DEI MONITORAGGI 2017 Milano, Palazzo Lombardia 9 maggio M.Calvi Laboratorio Fitopatologico SFR Virus della vite noti ed emergenti La maggioranza dei fitovirus
Grapevine Pinot gris virus GPGV INCONTRO SUL PIANO DEI MONITORAGGI 2017 Milano, Palazzo Lombardia 9 maggio M.Calvi Laboratorio Fitopatologico SFR Virus della vite noti ed emergenti La maggioranza dei fitovirus
La selezione di nuove varietà di vite resistenti alle malattie
 La selezione di nuove varietà di vite resistenti alle malattie Raffaele Testolin Università di Udine & Istituto di Genomica Applicata Padova Centro Congressi A.Luciani 12 dicembre 2013 tradizione vs. innovazione
La selezione di nuove varietà di vite resistenti alle malattie Raffaele Testolin Università di Udine & Istituto di Genomica Applicata Padova Centro Congressi A.Luciani 12 dicembre 2013 tradizione vs. innovazione
IL POTENZIALE MERCATO E LA VALENZA ECONOMICA DEI NUOVI VITIGNI RESISTENTI ALLE MALATTIE UNIUD/IGA
 IL POTENZIALE MERCATO E LA VALENZA ECONOMICA DEI NUOVI VITIGNI RESISTENTI ALLE MALATTIE UNIUD/IGA Verona - 04 febbraio 2016 EUGENIO SARTORI LA VITICOLTURA OGGI Superficie a vigneto: 7.573.000 Varietà di
IL POTENZIALE MERCATO E LA VALENZA ECONOMICA DEI NUOVI VITIGNI RESISTENTI ALLE MALATTIE UNIUD/IGA Verona - 04 febbraio 2016 EUGENIO SARTORI LA VITICOLTURA OGGI Superficie a vigneto: 7.573.000 Varietà di
Cod. VM2U2. Sistematica della vite
 Cod. VM2U2 Sistematica della vite Origine e classificazione della vite Ordine Famiglia Sottofamiglia RHAMNALES VITACEAE AMPELIDEAE Generi - VITIS - Landukia - Puria - Cissus - Parthenocissus - Nothocissus
Cod. VM2U2 Sistematica della vite Origine e classificazione della vite Ordine Famiglia Sottofamiglia RHAMNALES VITACEAE AMPELIDEAE Generi - VITIS - Landukia - Puria - Cissus - Parthenocissus - Nothocissus
MENDEL E L EREDITARIETA
 MENDEL E L EREDITARIETA Gregor Mendel (1822-1884) era un monaco ceco, biologo e matematico; E considerato, per le sue osservazioni sulla trasmissione dei caratteri ereditari, il precursore della moderna
MENDEL E L EREDITARIETA Gregor Mendel (1822-1884) era un monaco ceco, biologo e matematico; E considerato, per le sue osservazioni sulla trasmissione dei caratteri ereditari, il precursore della moderna
Docente Prof. Luigi Ricciardi Tel Obiettivi Formativi
 Corso di Laurea Magistrale: Colture mediterranee Corso Integrato: Miglioramento genetico delle specie vegetali e fisiologia vegetale Modulo: Miglioramento genetico delle specie vegetali (6 CFU) ( CFU Lezioni
Corso di Laurea Magistrale: Colture mediterranee Corso Integrato: Miglioramento genetico delle specie vegetali e fisiologia vegetale Modulo: Miglioramento genetico delle specie vegetali (6 CFU) ( CFU Lezioni
Vitigni resistenti Prima caratterizzazione enologica Vendemmia 2018
 Vitigni resistenti Prima caratterizzazione enologica Vendemmia 18 Stefano Favale stefano.favale@crea.gov.it 7/6/19 1 Vitigni resistenti a bacca bianca Fleurtai Soreli Sauvignon Kretos Sauvignon Nepis Sauvignon
Vitigni resistenti Prima caratterizzazione enologica Vendemmia 18 Stefano Favale stefano.favale@crea.gov.it 7/6/19 1 Vitigni resistenti a bacca bianca Fleurtai Soreli Sauvignon Kretos Sauvignon Nepis Sauvignon
ALLEGATO A. Classificazione delle varietà di vite per la produzione di uve da vino nella Regione Liguria
 ALLEGATO A Classificazione delle varietà di vite per la produzione di uve da vino nella Regione Liguria 1. Generalità La classificazione delle varietà di vite per la produzione di uve da vino, di seguito
ALLEGATO A Classificazione delle varietà di vite per la produzione di uve da vino nella Regione Liguria 1. Generalità La classificazione delle varietà di vite per la produzione di uve da vino, di seguito
CICLO PRODUTTIVO VIVAISMO VITICOLO. CO.VI.P. Consorzio Vivaistico Pugliese Dott. Luigi Catalano
 CICLO PRODUTTIVO VIVAISMO VITICOLO CO.VI.P. Consorzio Vivaistico Pugliese Dott. Luigi Catalano LA MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA DELLA VITE IN PASSATO Nel 1868 appare nella Francia meridionale un terribile
CICLO PRODUTTIVO VIVAISMO VITICOLO CO.VI.P. Consorzio Vivaistico Pugliese Dott. Luigi Catalano LA MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA DELLA VITE IN PASSATO Nel 1868 appare nella Francia meridionale un terribile
LA SELEZIONE CLONALE DELLA VITE IN ITALIA
 LA SELEZIONE CLONALE DELLA VITE IN ITALIA Mannini Franco - Istituto Virologia Vegetale, Unità Staccata Viticoltura, CNR, Grugliasco (TO) 1. Introduzione Negli ultimi decenni in tutti i Paesi in cui il
LA SELEZIONE CLONALE DELLA VITE IN ITALIA Mannini Franco - Istituto Virologia Vegetale, Unità Staccata Viticoltura, CNR, Grugliasco (TO) 1. Introduzione Negli ultimi decenni in tutti i Paesi in cui il
Convegno Il sitema vitivinicolo pugliese fra ricerca della qualità e riforma dei regolamenti comunitari Locorotondo 14 luglio 2006
 Convegno Il sitema vitivinicolo pugliese fra ricerca della qualità e riforma dei regolamenti comunitari Locorotondo 14 luglio 2006 Selezione clonale e sanitaria: strumento per il recupero e la valorizzazione
Convegno Il sitema vitivinicolo pugliese fra ricerca della qualità e riforma dei regolamenti comunitari Locorotondo 14 luglio 2006 Selezione clonale e sanitaria: strumento per il recupero e la valorizzazione
GENOTIPO: costituzione genetica di un individuo (sia riferito ad un singolo gene, sia all insieme dei suoi geni).
 DNA e geni Cosa sono i geni? Sono tratti di DNA ben delimitati Sono sequenze codificanti: tramite le istruzioni contenute in uno specifico gene viene prodotta una caratteristica fenotipica (carattere).
DNA e geni Cosa sono i geni? Sono tratti di DNA ben delimitati Sono sequenze codificanti: tramite le istruzioni contenute in uno specifico gene viene prodotta una caratteristica fenotipica (carattere).
Matematicandoinsieme. Mendel e l ereditarietà
 Matematicandoinsieme Mendel e l ereditarietà 1 Gregor Mendel: il padre della genetica Gregor Mendel(1822-1894) Monaco e naturalista austriaco. Condusse i suoi studi sulle piante del pisello odoroso nel
Matematicandoinsieme Mendel e l ereditarietà 1 Gregor Mendel: il padre della genetica Gregor Mendel(1822-1894) Monaco e naturalista austriaco. Condusse i suoi studi sulle piante del pisello odoroso nel
IL PROBLEMA DELLA VIROSI DA GPGV IN VITICOLTURA. Alessandro Raiola
 IL PROBLEMA DELLA VIROSI DA GPGV IN VITICOLTURA Alessandro Raiola LA SCOPERTA DI UN NUOVO VIRUS DELLA VITE 2012 GPGV: Grapevine pinot gris virus Il GPGV, Virus del Pinot Grigio, è stato identificato per
IL PROBLEMA DELLA VIROSI DA GPGV IN VITICOLTURA Alessandro Raiola LA SCOPERTA DI UN NUOVO VIRUS DELLA VITE 2012 GPGV: Grapevine pinot gris virus Il GPGV, Virus del Pinot Grigio, è stato identificato per
IL NOME DEL VITIGNO NEI SUOI ASPETTI VITIVINICOLI E DI MERCATO. Eugenio Sartori Vivai Cooperativi Rauscedo
 IL NOME DEL VITIGNO NEI SUOI ASPETTI VITIVINICOLI E DI MERCATO Eugenio Sartori Vivai Cooperativi Rauscedo SUDDIVISIONE CONSUMI DI VINO (stima 2015) PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI (Mhl) PAESE 2013 2014
IL NOME DEL VITIGNO NEI SUOI ASPETTI VITIVINICOLI E DI MERCATO Eugenio Sartori Vivai Cooperativi Rauscedo SUDDIVISIONE CONSUMI DI VINO (stima 2015) PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI (Mhl) PAESE 2013 2014
- Riproduzione riservata - 1
 Genetica mendeliana; Mendel elaborò tre leggi sull ereditarietà dei caratteri: - Legge della segregazione - Legge della dominanza - Legge dell assortimento indipendente Legge della segregazione; Per poter
Genetica mendeliana; Mendel elaborò tre leggi sull ereditarietà dei caratteri: - Legge della segregazione - Legge della dominanza - Legge dell assortimento indipendente Legge della segregazione; Per poter
Cromosomi sessuali. Le cellule maschili e femminili differiscono per i cromosomi sessuali o
 Cromosomi sessuali Le cellule maschili e femminili differiscono per i cromosomi sessuali o cromosomi del sesso o eterosomi (cosiddetti perché hanno forma diversa). Nell uomo e in molte altre specie (ma
Cromosomi sessuali Le cellule maschili e femminili differiscono per i cromosomi sessuali o cromosomi del sesso o eterosomi (cosiddetti perché hanno forma diversa). Nell uomo e in molte altre specie (ma
ALLEGATOA alla Dgr n del 28 dicembre 2007 pag. 1/7
 giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 4263 del 28 dicembre 2007 pag. 1/7 Titolo: Programma regionale di conservazione e valorizzazione del materiale genetico, di miglioramento del materiale
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 4263 del 28 dicembre 2007 pag. 1/7 Titolo: Programma regionale di conservazione e valorizzazione del materiale genetico, di miglioramento del materiale
Genetica dei caratteri quantitativi
 PAS Percorsi Abilitanti Speciali Classe di abilitazione A057 Scienza degli alimenti Tracciabilità genetica degli alimenti Genetica dei caratteri quantitativi 1 Concetti di base in genetica L informazione
PAS Percorsi Abilitanti Speciali Classe di abilitazione A057 Scienza degli alimenti Tracciabilità genetica degli alimenti Genetica dei caratteri quantitativi 1 Concetti di base in genetica L informazione
Collega ciascun termine con la sua definizione A. Fenotipo B. B. Genotipo C. C. Carattere D. D. Omozigote E. E. Eterozigote 1.
 Collega ciascun termine con la sua definizione A. Fenotipo B. B. Genotipo C. C. Carattere D. D. Omozigote E. E. Eterozigote 1. Insieme delle caratteristiche contenute nei geni, sia quelle manifeste, sia
Collega ciascun termine con la sua definizione A. Fenotipo B. B. Genotipo C. C. Carattere D. D. Omozigote E. E. Eterozigote 1. Insieme delle caratteristiche contenute nei geni, sia quelle manifeste, sia
I MATERIALI DI PARTENZA. E. Sartori, M. Borgo, G. Pegoraro Vivai Cooperativi Rauscedo
 I MATERIALI DI PARTENZA E. Sartori, M. Borgo, G. Pegoraro Vivai Cooperativi Rauscedo Demoday, Castell Arquato, 06/03/2018 IMPIANTO SPERIMENTALE DI PORTAINNESTI MICRORPOPAGATI (anno 1995/96) Verifiche pluriennali
I MATERIALI DI PARTENZA E. Sartori, M. Borgo, G. Pegoraro Vivai Cooperativi Rauscedo Demoday, Castell Arquato, 06/03/2018 IMPIANTO SPERIMENTALE DI PORTAINNESTI MICRORPOPAGATI (anno 1995/96) Verifiche pluriennali
ALLEGATO A - SEZ. 4. Agenzia Regionale per lo Sviluppo e L'innovazione in Agricoltura nel Lazio via Rodolfo Lanciani, ROMA
 ALLEGATO A - SEZ. 4 FACSIMILE DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE Agenzia Regionale per lo Sviluppo e L'innovazione
ALLEGATO A - SEZ. 4 FACSIMILE DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE Agenzia Regionale per lo Sviluppo e L'innovazione
GREEN BIOTECH. Biotecnologie per il miglioramento delle piante coltivate
 GREEN BIOTECH Biotecnologie per il miglioramento delle piante coltivate Relatore: Luigi Cattivelli Direttore del centro di Genomica e Bioinformatica CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l Analisi
GREEN BIOTECH Biotecnologie per il miglioramento delle piante coltivate Relatore: Luigi Cattivelli Direttore del centro di Genomica e Bioinformatica CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l Analisi
1 modulo didattico - Impatto clinico delle malattie genetiche e
 1 modulo didattico - Impatto clinico delle malattie genetiche e fondamenti di genetica GENETICA MEDICA OBBIETTIVI FORMATIVI Conoscere le basi cellulari e molecolari dell eredità Conoscere le basi genetiche
1 modulo didattico - Impatto clinico delle malattie genetiche e fondamenti di genetica GENETICA MEDICA OBBIETTIVI FORMATIVI Conoscere le basi cellulari e molecolari dell eredità Conoscere le basi genetiche
Vitigni resistenti nel Lazio: Il ruolo del CREA VE
 Velletri Conegliano Vitigni resistenti nel Lazio: Il ruolo del CREA VE Riccardo Velasco, PhD 07/06/2019 1 Velletri Conegliano 5.000 varietà (probabilmente sottostimata) nel mondo, 545 registrate nel catalogo
Velletri Conegliano Vitigni resistenti nel Lazio: Il ruolo del CREA VE Riccardo Velasco, PhD 07/06/2019 1 Velletri Conegliano 5.000 varietà (probabilmente sottostimata) nel mondo, 545 registrate nel catalogo
LE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA E ZOOTECNICA LA BIOTECNOLOGIA E L APPLICAZIONE DELLA BIOLOGIA CHE SFRUTTA I SISTEMI BIOLOGICI, GLI ORGANISMI VIVENTI
 LE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA E ZOOTECNICA LA BIOTECNOLOGIA E L APPLICAZIONE DELLA BIOLOGIA CHE SFRUTTA I SISTEMI BIOLOGICI, GLI ORGANISMI VIVENTI O PARTI DI ESSI (CELLULE ED ENZIMI) PER OTTENERE O MODIFICARE
LE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA E ZOOTECNICA LA BIOTECNOLOGIA E L APPLICAZIONE DELLA BIOLOGIA CHE SFRUTTA I SISTEMI BIOLOGICI, GLI ORGANISMI VIVENTI O PARTI DI ESSI (CELLULE ED ENZIMI) PER OTTENERE O MODIFICARE
Popolazioni sperimentali in genetica delle piante per mappare loci di interesse
 Popolazioni sperimentali in genetica delle piante per mappare loci di interesse Tipi di popolazioni sperimentali F 2 e BC 1 (Backcross) RIL (Recombinant Inbred Lines) DH (Double Haploids) IRIL (Intermated
Popolazioni sperimentali in genetica delle piante per mappare loci di interesse Tipi di popolazioni sperimentali F 2 e BC 1 (Backcross) RIL (Recombinant Inbred Lines) DH (Double Haploids) IRIL (Intermated
I gameti prodotti saranno:
 GENI CONCATENATI Con i principi di Mendel e con lo studio della dinamica della meiosi due geni si trasmettono ciascuno in modo indipendente rispetto all altro se sono localizzati su paia di cromosomi diversi
GENI CONCATENATI Con i principi di Mendel e con lo studio della dinamica della meiosi due geni si trasmettono ciascuno in modo indipendente rispetto all altro se sono localizzati su paia di cromosomi diversi
LA TRASFORMAZIONE GENETICA NELLE PIANTE: PRINCIPI E STATO DEI LAVORI. Michele Morgante
 LA TRASFORMAZIONE GENETICA NELLE PIANTE: PRINCIPI E STATO DEI LAVORI Michele Morgante Per un agricoltura del futuro Produttività Popolazione crescente con bisogni crescenti Scarsità di risorse idriche
LA TRASFORMAZIONE GENETICA NELLE PIANTE: PRINCIPI E STATO DEI LAVORI Michele Morgante Per un agricoltura del futuro Produttività Popolazione crescente con bisogni crescenti Scarsità di risorse idriche
Nocciolo Noce e Castagno Tecnica e opportunità
 Nocciolo Noce e Castagno Tecnica e opportunità 11 GIUGNO 2016 Città di Cherasco PALAEXPO PIAZZA DEGLI ALPINI Il settore nocicolo nel comparto della frutta in guscio Dr. Alberto Manzo Coordinatore Tavolo
Nocciolo Noce e Castagno Tecnica e opportunità 11 GIUGNO 2016 Città di Cherasco PALAEXPO PIAZZA DEGLI ALPINI Il settore nocicolo nel comparto della frutta in guscio Dr. Alberto Manzo Coordinatore Tavolo
Proseguiamo e concludiamo in questo numero la
 inserto I PORTINNESTI DELLA VITE / A cura di GIOVANNI NIGRO - Centro Ricerche Produzioni Vegetali e MIRKO MELOTTI - Astra Innovazione e Sviluppo Crpv Proseguiamo e concludiamo in questo numero la panoramica
inserto I PORTINNESTI DELLA VITE / A cura di GIOVANNI NIGRO - Centro Ricerche Produzioni Vegetali e MIRKO MELOTTI - Astra Innovazione e Sviluppo Crpv Proseguiamo e concludiamo in questo numero la panoramica
Il Vermentino in Toscana
 Il Vermentino in Toscana Scalabrelli Giancarlo Dipartimento Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose G. Scaramuzzi Università di Pisa Oristano 16/05/2008 Le tracce del Vermentino Alcune ipotesi e riferimenti
Il Vermentino in Toscana Scalabrelli Giancarlo Dipartimento Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose G. Scaramuzzi Università di Pisa Oristano 16/05/2008 Le tracce del Vermentino Alcune ipotesi e riferimenti
Il Polimorfismo. Equilibrio di Hardy-Weinberg
 Il Polimorfismo La stima della frequenza multilocus di genotipi è subordianta all assunzione che: Gli alleli in ciascun locus sia ereditato indipendentemente (segua cioè l equilibrio di Hardy-Weinberg)
Il Polimorfismo La stima della frequenza multilocus di genotipi è subordianta all assunzione che: Gli alleli in ciascun locus sia ereditato indipendentemente (segua cioè l equilibrio di Hardy-Weinberg)
GENETICA prima parte
 GENETICA prima parte Le caratteristiche di ogni persona formano il patrimonio ereditario e sono trasmesse dai genitori ai figli. Gregor Mendel per primo spiegò come si trasmettono questi caratteri. Vissuto
GENETICA prima parte Le caratteristiche di ogni persona formano il patrimonio ereditario e sono trasmesse dai genitori ai figli. Gregor Mendel per primo spiegò come si trasmettono questi caratteri. Vissuto
MENDEL E LE SUE LEGGI
 MENDEL E LE SUE LEGGI Gregor Mendel (1822 1884) Era un monaco boemo considerato il padre della genetica, a cui si debbono le prime fondamentali leggi sull ereditarietà (1865). E importante ricordare un
MENDEL E LE SUE LEGGI Gregor Mendel (1822 1884) Era un monaco boemo considerato il padre della genetica, a cui si debbono le prime fondamentali leggi sull ereditarietà (1865). E importante ricordare un
Da Mendel ai modelli di ereditarietà
 Capitolo B1 Da Mendel ai modelli di ereditarietà 1 Mendel, il padre della genetica Gregor Mendel (1822-1894), monaco e naturalista, condusse esperimenti di genetica in un orto del monastero di Brno, nell
Capitolo B1 Da Mendel ai modelli di ereditarietà 1 Mendel, il padre della genetica Gregor Mendel (1822-1894), monaco e naturalista, condusse esperimenti di genetica in un orto del monastero di Brno, nell
La gestione della potatura secca e verde del Cannonau ai fini dell'ottenimento di prodotti di qualità
 Dorgali 25 ottobre 2016 La gestione della potatura secca e verde del Cannonau ai fini dell'ottenimento di prodotti di qualità Luciano De Pau Daniela Satta Servizio Arboricoltura La forma di allevamento
Dorgali 25 ottobre 2016 La gestione della potatura secca e verde del Cannonau ai fini dell'ottenimento di prodotti di qualità Luciano De Pau Daniela Satta Servizio Arboricoltura La forma di allevamento
QUADERNI TECNICI VCR I CLONI ORIGINALI VCR DI GARGANEGA
 QUADERNI TECNICI VCR 06 I CLONI ORIGINALI VCR DI GARGANEGA 3 Diffusione del vitigno e variabilità intravarietale 4 Breve descrizione delle caratteristiche del vitigno 5 La selezione sanitaria 6 Cloni omologati
QUADERNI TECNICI VCR 06 I CLONI ORIGINALI VCR DI GARGANEGA 3 Diffusione del vitigno e variabilità intravarietale 4 Breve descrizione delle caratteristiche del vitigno 5 La selezione sanitaria 6 Cloni omologati
Scelta del portinnesto
 Scelta del portinnesto Giancarlo Scalabrelli Contenuti Problematiche per la scelta del portinnesto Conoscenza dell ambiente Impianto o reimpianto Aspetti geopedologici Adattamento alle condizioni colturali
Scelta del portinnesto Giancarlo Scalabrelli Contenuti Problematiche per la scelta del portinnesto Conoscenza dell ambiente Impianto o reimpianto Aspetti geopedologici Adattamento alle condizioni colturali
LE VARIETA RESISTENTI
 LE VARIETA RESISTENTI Daniele Cecon Vivai Cooperativi Rauscedo Montebelluna, 18.02.2019 VARIETA UNIUD/IGA/VCR Varietà Sigle Incrocio Geni della resistenza alla peronospor a Geni della resistenza all oidio
LE VARIETA RESISTENTI Daniele Cecon Vivai Cooperativi Rauscedo Montebelluna, 18.02.2019 VARIETA UNIUD/IGA/VCR Varietà Sigle Incrocio Geni della resistenza alla peronospor a Geni della resistenza all oidio
DESCRIZIONE DELLA SELEZIONE VARIETALE DI OLIVO DELLA Cv. MAURINO DENOMINATA: Maurino MR-M3 Vittoria
 DESCRIZIONE DELLA SELEZIONE VARIETALE DI OLIVO DELLA Cv. MAURINO DENOMINATA: Maurino MR-M3 Vittoria Origine: La varietà d olivo denominata Maurino MR-M3 Vittoria deriva da un lavoro di miglioramento genetico,
DESCRIZIONE DELLA SELEZIONE VARIETALE DI OLIVO DELLA Cv. MAURINO DENOMINATA: Maurino MR-M3 Vittoria Origine: La varietà d olivo denominata Maurino MR-M3 Vittoria deriva da un lavoro di miglioramento genetico,
CONTROLLI SOTTO SORVEGLIANZA UFFICIALE: CORSO DI PREPARAZIONE PER GLI ISPETTORI PARTE TEORICA CONTROLLI IN CAMPO (CORSO 2) 2019
 19/02/2019 1 CONTROLLI SOTTO SORVEGLIANZA UFFICIALE: CORSO DI PREPARAZIONE PER GLI ISPETTORI PARTE TEORICA (CORSO 2) 2019 I CONTROLLI E LA CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI DI MAIS Marco Venali CREA-DC Bologna
19/02/2019 1 CONTROLLI SOTTO SORVEGLIANZA UFFICIALE: CORSO DI PREPARAZIONE PER GLI ISPETTORI PARTE TEORICA (CORSO 2) 2019 I CONTROLLI E LA CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI DI MAIS Marco Venali CREA-DC Bologna
LE MUTAZIONI. MUTAZIONE: MODIFICAZIONE DEL MESSAGGIO GENETICO, cambiamento raro, casuale, permanente ed EREDITABILE del DNA RIMESCOLAMENTO!!
 LE MUTAZIONI MUTAZIONE: MODIFICAZIONE DEL MESSAGGIO GENETICO, cambiamento raro, casuale, permanente ed EREDITABILE del DNA RIMESCOLAMENTO!! NUOVI GENOTIPI LE MUTAZIONI POLIMORFISMO: un cambiamento presente
LE MUTAZIONI MUTAZIONE: MODIFICAZIONE DEL MESSAGGIO GENETICO, cambiamento raro, casuale, permanente ed EREDITABILE del DNA RIMESCOLAMENTO!! NUOVI GENOTIPI LE MUTAZIONI POLIMORFISMO: un cambiamento presente
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI E AGRARIE SEZIONE: SCIENZE AGRONOMICHE Dottorato di Ricerca in PRODUTTIVITA DELLE PIANTE COLTIVATE Curriculum: Biologia
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI E AGRARIE SEZIONE: SCIENZE AGRONOMICHE Dottorato di Ricerca in PRODUTTIVITA DELLE PIANTE COLTIVATE Curriculum: Biologia
Focus selezione clonale
 Bovolino 3 settembre 2011 Focus selezione clonale Emanuele Tosi - Michela Azzolini La biodiversità comprende tutte le forme di vita (animali, piante, funghi, batteri), i differenti habitat in cui vivono
Bovolino 3 settembre 2011 Focus selezione clonale Emanuele Tosi - Michela Azzolini La biodiversità comprende tutte le forme di vita (animali, piante, funghi, batteri), i differenti habitat in cui vivono
PROTOCOLLO OIV PER LA VALUTAZIONE DELLE VITI OTTENUTE PER TRASFORMAZIONE GENETICA. L ASSEMBLEA GENERALE, su proposta della Commissione I Viticoltura
 RISOLUZIONE OIV/VITI 355/2009 PROTOCOLLO OIV PER LA VALUTAZIONE DELLE VITI OTTENUTE PER TRASFORMAZIONE GENETICA L ASSEMBLEA GENERALE, su proposta della Commissione I Viticoltura PRESO ATTO dei lavori sviluppati
RISOLUZIONE OIV/VITI 355/2009 PROTOCOLLO OIV PER LA VALUTAZIONE DELLE VITI OTTENUTE PER TRASFORMAZIONE GENETICA L ASSEMBLEA GENERALE, su proposta della Commissione I Viticoltura PRESO ATTO dei lavori sviluppati
VITI TRANSGENICHE PER LA RESISTENZA AI VIRUS: SECONDO O CONTRO NATURA?
 Università degli Studi Aldo Moro Bari VITI TRANSGENICHE PER LA RESISTENZA AI VIRUS: SECONDO O CONTRO NATURA? Giovanni P. Martelli Università degli Studi Aldo Moro di Bari In Vitis vinifera e, in misura
Università degli Studi Aldo Moro Bari VITI TRANSGENICHE PER LA RESISTENZA AI VIRUS: SECONDO O CONTRO NATURA? Giovanni P. Martelli Università degli Studi Aldo Moro di Bari In Vitis vinifera e, in misura
