Modulo 8 ASPETTI TIPOLOGICI DELLA LINGUA ITALIANA: IMPLICAZIONI GLOTTODIDATTICHE. Anna De Marco Università della Calabria
|
|
|
- Erico Rubino
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Modulo 8 ASPETTI TIPOLOGICI DELLA LINGUA ITALIANA: IMPLICAZIONI GLOTTODIDATTICHE Anna De Marco Università della Calabria 1
2 Indice 8.0. Guida al modulo 8.1. Il rapporto tra lingua materna (L1) e lingua seconda (L2) 8.2. Il transfer linguistico: gli aspetti problematici e quelli facilitanti 8.3. L Italiano L Verso l italiano: elementi di linguistica acquisizionale La costruzione del sistema fonologico La costruzione del sistema morfologico nominale La costruzione del sistema morfologicoverbale La costruzione del sistema sintattico La costruzione del sistema lessicale Il riferimento all interlingua nella glottodidattica 8.5. I profili linguistici dei bambini stranieri 8.6. Riflessioni sulle L1 degli apprendenti stranieri Due lingue balcaniche, l albanese e il macedone, in contatto con l italiano Apprendimento dell italiano: alcune osservazioni Il cinese, lingua isolante, in contatto con l italiano L apprendimento dell italiano da parte di allievi cinesi: gli aspetti problematici più comuni Altre lingue indoeuropee (il russo, l arabo, il romanè) in contatto con l italiano L apprendimento dell italiano: osservazioni 8.7. Le conseguenze applicative delle diversità tipologiche nella pratica didattica Suggerimenti per attività didattiche con attenzione alla L1 e alla cultura di partenza Attività per l esercitazione della morfosintassi in Italiano L Attività per l esercitazione del lessico in Italiano L Attività per l esercitazione della pragmatica nell Italiano L Spunti per possibili percorsi didattici 8.8. Guida bibliografica 2
3 8.0. Guida al modulo Il Modulo 8 è diviso in tre parti; nella prima (par. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5) sono presentati i concetti di Lingua Materna (L1) nel rapporto con una Lingua Seconda (L2) (par. 8.1), i problemi relativi al trasfert linguistico tra due lingue in contatto (par. 8.2), la necessità, in presenza di alunni stranieri di tracciare una loro biografia linguistica (par. 8.5) ed infine è stata data una definizione dell italiano come L2 (par. 8.3) e indicate alcune caratteristiche del processo di costruzione dell interlingua dell italiano L2 da parte di apprendenti stranieri (par. 8.4), indicando i riferimenti all interlingua nella pratica glottodidattica (par ). La seconda parte illustra le caratteristiche tipologiche di alcune delle lingue maggiormente presenti nelle scuole italiane: albanese e macedone (par ), cinese (par ), russo, arabo e romanè (8.6.3). Si è cercato di conferire una certa omogeneità dividendo le descrizioni per tipologia linguistica, per quanto esse non siano esaustive, né si propongano, ovviamente, come corsi di lingua. La breve descrizione è solo uno strumento utile al confronto (tipologico) tra le varie lingue e poter fare anche dei confronti utili alla la didattica linguistica. La terza ed ultima parte offre dei consigli per l impostazione di attività didattiche (par. 8.7), divedendo le attività pratiche presentate in base ai vari aspetti della struttura linguistica (morfosintassi 8.7.2; lessico 8.7.3; pragmatica 8.7.4) e accompagnate da possibili spunti per percorsi interculturali (par ). Infine viene riportata un ampia guida bibliografica, con indicazioni di siti Internet utili come spunti per attività didattiche (8.8). 3
4 8.1 Il rapporto tra lingua materna (L1) e lingua seconda (L2) Un buon apprendimento della seconda lingua non è legato alla perdita della L1, ma al contrario è dipendente dal suo sviluppo: infatti l abbandono della L1 può comportare un blocco dello sviluppo linguistico-cognitivo, che può essere superato solo quando il livello di conoscenza della L2 rende possibile la ripresa dei processi di acquisizione delle funzioni superiori. Se si permette all allievo di proseguire il suo sviluppo linguistico-cognitivo nella L1, in seguito egli potrà usare tali conoscenze anche nella L2, se, al contrario, questo sviluppo viene arrestato, si potrà verificare un rallentamento nell apprendimento della L2. Perdere la lingua materna può comportare anche dei problemi nella vita di famiglia e nel rapporto con le proprie tradizioni e origini, soprattutto quando la madrelingua viene connotata come un elemento di diversità dal quale liberarsi. La didattica per l insegnamento della L2 non deve relegare la L1 al ruolo di conoscenze buone ma inutili, e la L1 e la L2 non devono essere intese in un rapporto gerarchico, in cui la L2 prevale sulla L1 in quanto legata alla sopravvivenza sociale e all integrazione. L insegnamento della L2 non deve minacciare l identità del bambino ma deve essere uno strumento di apertura verso nuove esperienze. Il rapporto L1-L2 deve essere indirizzato in una convivenza bilingue tra le due in cui il bambino si deve sentire rassicurato nell interazione tra le sue conoscenze presenti e passate, che lo possano guidare in riflessioni e confronti sempre nuovi. La scuola quindi deve favorire il bilinguismo, che deve essere considerato come un valore; ciò non significa che la scuola debba farsi carico dell insegnamento delle L1 dei suoi allievi, ma deve progettare dei percorsi che insegnino il valore della conoscenza di più lingue, sia agli allievi stranieri che italiani. L obiettivo fondamentale dell insegnamento linguistico a livello elementare è la preparazione linguistica, psicologica e culturale che solo in seguito verrà approfondita. Il contatto con una lingua diversa dalla propria promuove nel bambino il rispetto per stili di vita e punti di vista diversi dai propri: la scoperta della pluralità diventa ricchezza e non emarginazione. 4
5 8.2 Il trasfert linguistico: gli aspetti problematici e quelli facilitanti. C è un altra importante valenza nel mantenimento e nella valorizzazione della L1: il parlante straniero di qualsiasi età a contatto con una nuova lingua si costruisce una grammatica spontanea non solo in base all input linguistico della L2 a cui è esposto, ma anche attraverso processi di generalizzazione e di transfert, cioè di trasferimento di quanto già regolarizzato, scoperto nella sua L1, attraverso processi di analisi e comparazione. La L1 quindi ha un ruolo piuttosto importante nel determinare le produzioni iniziali dell apprendente. Il meccanismo che regola l influenza del sistema linguistico di origine nei confronti della L2 è chiamato, appunto, transfert e deve essere inteso in maniera più ampia rispetto all idea di transizione/passaggio di elementi linguistici dalla L1 alla L2 perché si tratta di influenze di diverso genere, non solo di trasferimento di strutture da una lingua all altra; possono verificarsi casi di transfert anche da altre lingue conosciute e non solo dalla L1; il transfert è uno dei processi che danno forma all interlingua. Il meccanismo del transfert è più attivo dove si percepiscono similarità tra le due lingue, se esse hanno una distanza tipologica ridotta. L interferenza può diventare un ostacolo dopo essere stata di aiuto iniziale nell avvicinarsi alle parole o strutture che sembravano uguali a quelle della L1: infatti l apprendente potrebbe evitare di progredire oltre un primo stadio di contatto con la L2, pensando di continuare a poggiarsi sulle conoscenze di cui è già in possesso per comprendere la L2, sedimentando così comportamenti non corretti. La possibilità di trasfert sembra seguire una scala di occorrenza: è più presente nella fonologia, poi nel lessico, nella sintassi, mentre sembra è senz altra molto ridotta a livello morfologico. Il trasfert, inoltre, agisce di più al livello delle produzioni spontanee che nei compiti guidati, più negli adulti che nei bambini, più negli apprendenti iniziali che in quelli avanzati. 5
6 8.3. L italiano L2 Apprendere l italiano L2 implica anche che l insegnamento si imponga scopi e obiettivi diversi per tener conto del coinvolgimento culturale e psicologico che il nuovo codice linguistico assume ai fini di un inserimento positivo nella comunità. L italiano L2, in situazioni di apprendimento spontaneo, non è né vicino alla L1, lingua legata agli affetti e alle emozioni più intime, né alla LS, visto che viene appreso soprattutto dal contatto quotidiano con il luogo in cui esso è usato come lingua di comunicazione, e non solo quindi come lingua di studio. Questa situazione di apprendimento è chiamata mista per la varietà degli input ricevuti in modo vario e non omogeneo. Ancor di più in situazioni di immigrazione l italiano L2 è legato a bisogni di sopravvivenza e a vari fattori psicologici, esso serve per vivere e si carica di aspetti positivi (ma anche negativi) perché serve all immigrato per far parte del gruppo, ma continua a non essere la sua lingua, quelle delle sue storie e dei suoi affetti e ricordi. Il processo di acquisizione della L2 non è mai completo, attraversa stadi diversi e costruzioni instabili per giungere alla conoscenza della lingua obiettivo (target). Questo passaggio progressivo tra stadi linguistici verso la costruzione della propria lingua è chiamato interlingua e presuppone un apprendimento attivo da parte dell apprendente, fatto di tentativi ed errori e di applicazioni di strategie per evitare gli ostacoli. In questa progressione continua sono probabili sbalzi in avanti o ricadute all indietro, fenomeni legati anche ai fattori emotivi e affettivi coinvolti nell apprendimento. L osservazione delle tappe evolutive dell interlingua ha portato a concludere che esistono delle similitudini tra le varie evoluzioni interlinguistiche degli apprendenti, che prescindono dalla loro L1 e che coinvolgono l evoluzione delle strutture verbali, sintattiche, morfologiche e lessicali della L2. L apprendimento della L2 risulterà più veloce e corretto in base al grado di inserimento nella comunità italiana, cioè alla volontà di esprimersi usando la lingua in modo adatto alle diverse situazioni, in modo da saper fare della lingua un mezzo di espressione consono alle proprie esigenze. Questo know how richiede pratiche di insegnamento che portino lo studente a poter comunicare in una dimensione più globale, in modo da poter realizzare i suoi scopi immediati in una lingua veicolo di espressioni e formule necessarie per stabilire e regolare i contatti con gli altri. 6
7 8.4 Elementi di linguistica acquisizionale dell italiano L La costruzione del sistema fonologico. Nell acquisizione spontanea di una L2, la componente fonologica è quella che insieme alla sintassi conosce più fenomeni di interferenza perché più dipendente dalla L1 o meglio, perché più soggetta dalla distanza tipologica tra le lingue coinvolte. Lo sviluppo della fonologia passa per dei fattori di interferenza particolari, quali la semplificazione sillabica, l assimilazione consonantica, il raddoppiamento sillabico o la cancellazione, tutti fenomeni dipendenti da universali linguistici, più che dall interferenza della L1, e fortemente influenzati dalla minore o maggiore marcatezza assunta dai singoli fonemi. Del resto, sul piano della resa grafica, la componente fonologica lascia delle tracce vistose, sia nella difficoltà di realizzazione di alcuni grafemi propri dell ortografia italiana, sia nell incapacità di selezionare i segmenti del continuum fonico secondo le regole morfologiche della L2, preferendo l uso di un fonema familiare della L1 al posto di un fonema simile della L2. 7
8 La costruzione del sistema morfologico nominale. La morfologia è la componente linguistica che meglio evidenzia l elaborazione autonoma effettuata dall apprendente sul materiale a sua disposizione, attraverso la formulazione d ipotesi che hanno un valore momentaneo visto che esse possono essere abbandonate non appena raggiunto uno stadio più avanzato. Al contrario della fonologia e del lessico, la morfologia non subisce forti interferenze della L1 ed è più indipendente della sintassi dai fattori pragmatici. Nelle fasi iniziali dell interlingua, il materiale prevalentemente usato dall apprendente è il materiale lessicale, proveniente e selezionato dall input, che si costituisce come base dei successivi apprendimenti. Infatti, nei primi approcci con la L2, la selezione del materiale morfologico porta ad un primo apprendimento dei morfemi grammaticali più liberi e con un corpo fonetico più esile, somiglianti maggiormente al materiale lessicale. In queste prime fasi, la produzione degli elementi morfologici è quasi del tutto assente: i morfemi liberi e semiliberi (quali copule, articoli e preposizioni) non vengono quasi del tutto prodotti (in questo caso si parla di ellissi) e anche i morfemi flessivi, che non possono essere cancellati nella morfologia italiana, vengono utilizzati in una forma scelta come forma base, ripresa dalle forme flesse più frequenti nell input e poi generalizzata. Infatti, attraverso una strategia di regolarizzazione, gli allomorfi più frequenti sono appresi prima e sovraestesi in formazioni analogiche più trasparenti. È solo in un momento successivo che l elaborazione si fa più complessa, di tipo sintetico, ristabilendo un equilibrio in base, anche, alla facilità articolatoria. Per quanto riguarda l acquisizione della categoria di genere, viene individuata una sequenza di acquisizione della categoria di genere e dei criteri di assegnazione del genere ai sostantivi. Tale sequenza indica che il genere viene appreso in un primo momento seguendo criteri mor(fonologici) legati al riconoscimento dell associazione fra certe terminazioni/classi flessive (nomi in o > genere masch.; nome in a > genere femm.), poi i criteri semantici (che concerne l associazione genere/sesso, ed in fine quelli morfologici che riguardano l uso di specifici morfemi per la derivazione di genere: uso dei morfemi -a, -ina, -trice, -essa per formare nomi femminili; Nell acquisizione della morfologia nominale, uno spazio particolare è occupato dallo sviluppo del sistema pronominale. I pronomi clitici dell italiano costituiscono, dal punto di vista tipologico e per le regole sintattiche cui sono collegati, un sottosistema morfologico ad alta complessità, il cui apprendimento ed uso corretto risulta, delle volte, assai complicato per gli stessi parlanti nativi. Inoltre, l ordine d acquisizione dei clitici è governato da una parte, da fattori semantici e pragmatici e, dall altra, da una gerarchia di difficoltà crescente. Anche se largamente presenti nell input, le forme pronominali, soprattutto nelle prime fasi sono scarsamente presenti nell interlingua. Quindi, le forme usate con funzione di soggetto emergono per prima e sono sovraestese, anche sotto l influenza dell input colloquiale, alle forme usate con funzione oggettivale: un esempio, è l uso di lui e lei, generalmente in funzione del pronome di 3^ persona. 8
9 La costruzione del sistema morfologico verbale. Nei primi stadi di acquisizione, lo sviluppo del sistema verbale dell italiano è molto più precoce dello sviluppo del sistema nominale per la centralità che ricopre nell organizzazione degli enunciati. Il sistema verbale dell italiano è ricco di una morfologia sofisticatissima che favorisce sin dai primi stadi, l emergenza della morfologia flessiva verbale, organizzandola in un paradigma ben preciso. I momenti d acquisizione dei singoli tempi e modi sono così articolati: Primo stadio. In questo stadio rientrano i primi momenti d esposizione e di contatto con la lingua italiana. Gli enunciati sono per lo più formati da elementi lessicali in apparenza non collegati tra loro da una sintassi elementare; compaiono, però, delle forme di negazione e l uso dell elemento predicativo c è, utilizzato in vari casi, anche per esprimere delle relazioni esistenziali e possessive. I verbi compaiono in una forma assunta come basica, di solito la 3^ persona singolare del presente indicativo, mentre l uso delle altre forme verbali è ridotto alla presenza dell infinito e dell imperativo, tutte forme selezionate dall input ricevuto. Secondo stadio. Questo stadio è particolarmente segnato dallo sviluppo del participio passato, la cui presenza può già sussistere dal primo stadio come variante della forma basica, ma il cui uso si specifica in varietà un po più avanzate. Questa forma verbale, marcata dal suffisso to, ha la funzione specifica di portatrice di valori perfettivi e gli apprendenti sembrano, infatti, sensibili a tali sfumature, e con il participio tendono ad indicare, per lo più, un azione completata nel tempo. Il participio passato risulta, così, una forma tipica delle interlingue nell indicazione di un idea passata, più dell imperfetto, che appare successivamente, e più del passato prossimo, dal momento che l ausiliare ha uno sviluppo posteriore e presenta una grande variabilità tra gli apprendenti. Lo sviluppo dell ausiliare (che è gradualmente accompagnato dall accordo con il participio) indica il momento in cui si mette in relazione il tempo dell evento con il momento dell enunciazione, dando una valenza più decisa al riferimento al passato. In questo stadio può sussistere la comparsa del gerundio, soprattutto nella perifrasi composta dal verbo stare e dal gerundio stesso, con cui è espressa l idea di un azione in progress, cioè in atto e non ancora completata. Terzo stadio. Il passaggio ad uno stadio più avanzato è segnato dall emergenza dell imperfetto, la cui presenza riduce progressivamente l uso del presente indicativo in contesti perfettivi. Le prime forme di imperfetto ad emergere sono la 3^ persona singolare e la 1^ persona singolare del verbo essere (era; ero), utilizzate con funzione di copula, e solo in un secondo momento l uso dell imperfetto viene esteso anche agli altri verbi. Inoltre, essendo questo tempo molto presente nell italiano 9
10 colloquiale, la sua presenza nelle varietà iniziali è giustificabile: esso è, infatti, il terzo tempo ad emergere. Quarto stadio. Questo stadio ricopre uno spazio piuttosto vasto di varietà avanzate. La caratteristica principale di queste fasi è costituita dall emergenza delle forme del futuro, del condizionale e del congiuntivo, con le quali viene espressa la relazione tra realtà ed irrealtà, che nelle fasi precedenti. era stata affidata ad elementi lessicali o pragmatici, comuni anche nell italiano colloquiale, come l uso dell imperfetto con un idea modale. 10
11 La costruzione del sistema sintattico. Nelle interlingue degli apprendenti dell italiano, esiste un ordine sintattico riconosciuto come basico, che è quello S V O. Naturalmente, sussistono delle devianze da questa norma, rappresentati dalle costruzioni con soggetto postverbale e dalle costruzioni che recano l oggetto in posizione pre-verbale. Queste variazioni sono motivate dall assenza di stabilità che l ordine sintattico ha nelle sue prime fasi di sviluppo. Le variazioni sono altrettanto influenzate dalla comparsa dei clitici, e dal loro successivo uso, anche se il peso più grande nella stabilizzazione dell ordine sintattico è data dalla distanza tipologica che intercorre tra le lingue e dall influenza della L1 sull interlingua. Il sistema delle subordinazioni viene sviluppato in un momento successivo all acquisizione dell ordine sintattico, giacché per lungo tempo si possono conservare enunciati brevi e frammentari, coordinati semplicemente tramite l utilizzo di e o ma. Le prime frasi complesse a comparire sono le proposizioni oggettive, introdotte da che, e le proposizioni temporali, introdotte da quando. Il ritardo più significativo è segnato dalla comparsa delle proposizioni relative. 11
12 La costruzione del sistema lessicale. Lo sviluppo del lessico appare come un processo cognitivo trasversale ai diversi livelli di conoscenza della lingua ed è la componente più necessaria per iniziare la comunicazione di base nella L2. Il lessico è un sistema più aperto della grammatica e della fonologia, giacché le sue numerose unità di base, i lessemi, si prestano molto più difficilmente alla regolarizzazione. Inoltre, l acquisizione del lessico è normalmente legata a precisi contesti situazionali; infatti, il primo lessico appreso dagli apprendenti in modo semplice e veloce è quello con cui essi sono maggiormente in contatto nei primi tempi d esposizione alla L2, per esempio il lessico della scuola o riguardante la loro situazione lavorativa. In seguito, una grande influenza viene assunta dal lessico appreso durante i momenti liberi dal lavoro o dalla scuola, attraverso le attività praticate o gli ambienti frequentati. Lo sviluppo ulteriore del lessico è legato a strategie universali ma con delle caratteristiche dipendenti anche dalla L1, anche se, di frequente è sul modello e con il materiale della L2 che sono spesso costruite le forme lessicali degli apprendenti. Quando, infatti, un apprendente non conosce un determinato vocabolo può ricorrere a strategie lessicali, basate sulla sinonimia o sull iperonimia, oppure all uso di perifrasi, con la quale viene espresso il significato mancante; è proprio nell uso delle perifrasi che il rapporto comunicativo con i nativi risulta rilevante come fonte di nuovi elementi lessicali che possano arricchirne la costruzione. Inoltre, la percezione della vicinanza tra due lingue può portare gli apprendenti a trasferire elementi lessicali della L1 alla L2, dando luogo ad interferenze o a veri e propri prestiti lessicali. Nelle formazioni lessicali sono state individuate alcune costanti, parallele ai fenomeni di derivazione nominale, apprese piuttosto velocemente e di solito sovraestesi (un esempio è l uso dei suffissi mento e zione applicato alla creazione di parole non esistenti in italiano), che aiutano gli apprendenti nella costruzione del lessico. 12
13 8.4.6 Il riferimento all interlingua nella glottodidattica L insegnamento istituzionale deve tenere conto dei principi naturali di acquisizione linguistica per poter essere efficace. Per questo sembra utile suggerire una didattica che non parta dalla grammatica ma dalle funzioni, che dia, cioè, gli strumenti linguistici per fare qualcosa cioè presentarsi, salutare, ringraziare Per insegnare a narrare bisogna quindi puntare sui mezzi lessicali usati più di frequente che danno un ancoraggio temporale e la sistematica esposizione a queste forme e strutture, presentate in ordine controllato e in un piano di difficoltà crescente, porterà di certo verso un apprendimento di successo, per cui gli apprendenti avranno sempre a disposizione i mezzi più idonei per comunicare e narrarsi. Così l istruzione formale si adegua alle sequenze acquisizionali, attraverso, cioè, la predisposizione di un input (dati linguistici) adeguato all obbiettivo di volta in volta selezionato. Si dovrà quindi scegliere i materiali e la modalità di presentazione degli stessi, che possano aiutare a facilitare il superamento dell errore e l acquisizione di strutture e forme regolari. In seguito, per favorire il ripescaggio di quanto noto e analizzato, si potranno proporre dei compiti comunicativi che mettano gli apprendenti in condizione di riutilizzare i nuovi elementi assunti. Si costruisce così una progressione fondata su principi per lo più universali; questa progressione, però, non ci informa sui tempi di permanenza degli apprendenti nei vari stadi dell interlingua, né sulla velocità dei loro percorsi o delle difficoltà incontrate nel passaggio tra gli stadi. I tempi, infatti, sono diversi a seconda della L1 di partenza, dell età, del tipo di input ricevuto, delle diversità individuali. L insegnamento istituzionale si trova così a lavorare forzando i tempi della maturazione spontanea e, per questo, il suo compito più importante è creare interventi individualizzati e costruire dei materiali idonei. 13
14 8.5. I profili linguistici dei bambini stranieri L apprendimento di una L2 per un immigrato ricopre uno spazio molto ampio che va dall impegno e attenzione psicologica che devono essere rivolti totalmente all apprendimento, alle ragioni strumentali legate alla sopravvivenza linguistica che rientra nell ambito delle necessità primarie durante il soggiorno in un paese straniero. Questa acquisizione, influenzata da vari fattori, diventa ancor più delicata nel caso di bambini immigrati, che hanno dovuto superare il distacco, spesso traumatico, dalla loro terra, dai loro amici e abitudini e dallo loro scuola. In particolare, la scolarità pregressa, cioè già acquisita in nella comunità di partenza, può diventare un problema: il bambino infatti è abituato a ritmi di studio diversi, orari diversi, modalità di insegnamento diverse che rendono difficili i primi periodi di contatto con la nuova realtà scolastica, tanto da apparire agli insegnanti come svogliati o demotivati. Oltre ad imparare una nuova lingua, infatti, il bambino si trova nella condizione di voler mantenere la sua lingua madre. Mantenere e sviluppare la L1 e le competenze relative, infatti, è molto importante per gli immigrati per poter continuare a tenere vivi i principi della propria cultura, ma lo è anche per gli insegnanti che si trovano in contatto con loro perché, ad esempio, confrontare la lingua italiana con la L1 di partenza potrebbe risultare uno strumento utile per riconoscere e comprendere gli errori più ricorrenti dei propri alunni e per aiutarli a superare tali difficoltà. L insegnante che accoglie nella sua classe un allievo straniero dovrà tenere presente che la sua L1 va intesa sotto un duplice aspetto: come patrimonio di dati permeabili, cioè come conoscenze che possono essere trasferite in L2; come patrimonio di dati impermeabili cioè non assimilabili alla L2 e quindi non riutilizzabili, ma che rimangono patrimonio dello studente. In questi casi risulta utile stilare una sorta di biografia linguistica del nuovo arrivato che tenga conto della lingua usata nella comunicazione familiare, di quella usata a scuola e della lingua straniera studiata a scuola, tutti saperi da valorizzare affinché non divengano ostacoli nell apprendimento della L2. 14
15 8.6. Riflessioni sulla L1 degli apprendenti stranieri Due lingue balcaniche, l albanese e il macedone in contatto con l italiano L albanese e il macedone sono due lingue balcaniche, nel senso che entrambe vengono parlate e sono le lingue nazionali di due paesi che si trovano appunto nella penisola balcanica, ma non hanno le stesse radici. L albanese è, infatti, una lingua che fa parte del ceppo indoeuropeo e non di quello slavo a cui appartiene invece il macedone, e quest ultimo non discende direttamente dall antico macedone, che invece era una lingua indoeuropea. Anche l albanese è una delle lingue più antiche d Europa, discendendo dall antico illirico da cui poi si è evoluta a contato con altre lingue, tra cui quelle dei conquistatori dell Albania (latini e turchi, ad esempio). Entrambe le lingue differiscono dall italiano a livello fonetico-fonologico oltre che grafico. Infatti il macedone utilizza l alfabeto cirillico (che consta di 31 lettere a cui è unito un unico suono) e ha due peculiarità fonetiche che lo relazionano al suo gruppo slavo cioè la vocale grande er dell antico slavo ecclesiastico che si è sviluppata in una o e la depalatizzazione delle consonanti molli che oggi sono solo 5. Anche il sistema fonologico albanese è stato codificato in modo da far coincidere ogni lettera ad un suono e per questa ragione si contano 36 lettere, semplici e composte. Vi sono 29 fonemi consonantici con 9 consonanti doppie, che non possono essere divise anche se scritte come fonemi doppi. Questa ragione può indurre gli apprendenti albanesi a dei problemi con la resa delle consonanti doppie italiane che in albanese non esistono: occorre spiegare accuratamente i nuovi suoni italiani e i loro corrispondenti grafici e le possibili interferenze tra le due lingue. Le vocali invece non presentano interferenze: sono 7, con due che non hanno corrispondenze in italiano cioè la ë quasi muta e la y che si rende come la u francese. Per quanto riguarda la componente morfologica, l albanese è una lingua sintetico-analitica, in cui sono presenti la declinazione indeterminata e una determinata per i sostantivi, pronomi, aggettivi e articoli; è proprio la declinazione determinata a ricoprire anche le funzioni degli articoli determinativi, che praticamente in albanese non esistono. Proprio per queste ragioni può capitare che, nelle prime fasi di apprendimento dell italiano da parte di un allievo albanofono, gli articoli determinativi siano omessi o usati senza comprensione, ma lo sono solo sulla base di un assonanza con la vocale finale del nome che segue (es. le monte). Al contrario esiste l articolo indeterminativo nje, che viene sempre unito alla forma indeterminata. Esiste, inoltre, l articolo prepositivo, che non ha corrispondenze in italiano, e non è né una preposizione né un articolo determinativo. Si usa in modo vario, unito al morfema del nome, oppure come segnalatore del caso, genere e numero, e si usa anche prima degli aggettivi. Esso ha quattro forme: i, e, të, së. Da ricordare è che la lingua albanese ha cinque casi (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, ablativo) per la declinazione dell articolo prepositivo, del sostantivo e dell aggettivo. 15
16 Invece i nomi macedoni hanno tre generi: maschile, femminile e neutro, distinzioni che, però, non vengono rispettate negli oggetti plurali. Non ci sono casi per i sostantivi: rimane solo il vocativo per i nomi propri e per nomi di persone o animali; i casi rimangono per i pronomi personali (accusativo, dativo). Per quanto riguarda gli articoli, ne esistono tre serie, ognuna delle quali denota la collocazione dell oggetto rispetto al parlante (articoli generali, articoli per oggetti vicini, articoli per oggetti distanti). Gli articoli vengono posposti e attaccati alla fine del nome. Le preposizioni in albanese si dividono in base ai casi che reggono, nel senso che ogni caso della declinazione richiede delle preposizioni specifiche, anche diverse da quelle italiane. Ad esempio, non esiste una preposizione che indica possesso (es. di ) ma si usa il caso genitivo. Inoltre, mancando l articolo determinativo, non esistono le preposizioni articolate. Una caratteristica del macedone è, in particolare,la duplicazione obbligatoria dei clitici : gli oggetti definiti diretti ed indiretti non possono apparire soli nelle frasi, ma devono essere sempre accompagnati da un clitico, che deve concordare con il nome in genere, persona e numero. Per quanto riguarda la morfologia verbale, l albanese presenta due diatesi, attiva e medio-passiva, come in italiano. Il verbo ha nove modi, due dei quali non esistono in italiano, cioè ammirativo, che esprime meraviglia, e l ottativo, che esprime desiderio. I tempi sono in generali simili a quelli dell italiano; l ausiliare che si usa è avere (un kam). Non c è accordo tra soggetto e participio passato. Proprio queste due ultime caratteristiche, che potrebbero condurre a degli errori, sono quelle su cui l insegnante dovrebbe insistere, nel rinforzo della pratica dell uso dell ausiliare essere oltre che avere e sulla concordanza tra participio e nome del passato prossimo. Nel sistema verbale del macedone i verbi si distinguono in due gruppi: imperfettivi e perfettivi, a seconda che l azione sia completata o meno. I verbi perfettivi non possono essere usati al presente e sono più frequenti al passato definito (aoristo), che è uno degli otto tempi del macedone. I verbi hanno tre persone (prima, seconda, terza) e due numeri (singolare e plurale). Come altre lingue slave ha perso l infinito, che è stato sostituito con una costruzione finita, formata da una particella (da) e un verbo finito al presente che si accorda con i nomi in genere e numero. I modi rimangono tre: indicativo, imperativo e condizionale. Un breve accenno alla componente sintattica: non esistono sostanziali differenze tra la struttura frasale italiana e albanese, che si compone, in genere, come soggetto + predicato + complemento. Solo nel macedone l ordine delle parole è diverso dall italiano perché l aggettivo precede sempre il nome. 16
17 Apprendimento dell italiano: alcune osservazioni E diffuso il luogo comune che gli apprendenti provenienti dai Balcani conoscano già l italiano perché hanno avuto modo di apprenderlo attraverso i media. Di frequente, ci si trova di fronte a falsi principianti che riescono da subito a comprendere e agire nelle interazioni quotidiane in classe, parlando anche un italiano scarno, adatto alle prime interazioni comunicative. Di sicuro, ad influire su questa piccola padronanza della lingua è la zona provenienza dell allievo e il reale contatto con la lingua italiana, oltre che, ovviamente, il grado di alfabetizzazione ricevuto in patria. Oltre a questi fattori, bisognerà considerare l intenzione alla stabilità della famiglia di appartenenza, e quindi il loro progetto migratorio, per valutare in pieno la determinazione e le altre variabili affettive che potrebbero influenzare l apprendimento della L2. 17
18 Il cinese, lingua isolante in contatto con l italiano La lingua cinese ha origini antichissime ed è l unica, tra le lingue ancora in uso a non aver subito variazioni dalle sue origini per lo più nella forma scritta; le prime testimonianze risalgono, infatti, al secondo millennio prima di Cristo. Dal punto di vista linguistico, la Cina è caratterizzata da una forte frammentazione dialettale che può portare addirittura a casi di incomprensione reciproca, dal momento che i dialetti sono vere e proprie lingue, che, se pur con un origine regionale comune, si sono evolute in maniera separata fino a divenire non intelligibili tra loro. Oltre alle varietà dialettali, la lingua cinese conosce un ulteriore differenziazione tra la lingua orale familiare parlata quotidianamente, il chuan zhu yu, e la lingua scritta, il putonghua, insegnata nelle scuole e che, per questo motivo, rimane sconosciuta a chi non ha l opportunità di frequentarle o agli anziani. L elemento di unione tra le due tipologie di lingue orali è la lingua scritta che è identica per tutti i parlanti del cinese e che ne ha preservato l unità e la conservatività nei secoli. È proprio questa lingua scritta che viene insegnata unicamente nelle scuole e perciò non è a disponibile a tutti. Nella pratica scolastica vengono fatti memorizzare ben 2500 caratteri, che però rappresentano solo la cifra a cui si approssima lo standard di alfabetizzazione fissato per la scuola elementare e che non riesce a ricoprire la comprensione dell intera produzione scritta letteraria e di informazione, da cui molta gente rimane esclusa. In Cina la scrittura viene usata non solo per comunicare ma anche per il suo forte valore grafico-pittorico; la tradizione calligrafica, infatti, è molto importante e rappresenta una vera e propria forma d arte, in cui si fondono la tradizione e l innovazione del linguaggio. Nelle scuole, addirittura, la calligrafia, cioè la scrittura regolare, è insegnata come mezzo tramite cui apprendere l equilibrio estetico e il carattere. A ciascuno dei caratteri cinesi corrisponde un suono ed un significato; ogni carattere, come unità grafica, corrisponde al morfema dal punto di vista grammaticale e alla sillaba dal punto di vista fonologico. Ogni carattere ha una sua direzione e un numero minimo di tratti, e tra di loro i caratteri devono seguire una rigida successione. La caratteristica principale del cinese è la sua tendenza monosillabica, per cui ogni carattere designa una sillaba e ogni sillaba rappresenta una sola unità semantica: ogni parola ha unità di significato e suono. Le sillabe sono poco più di 400, quindi i restanti caratteri (circa ) si pronunciano pressoché allo stesso modo. Inoltre i toni, che regolano la modulazione dell elemento vocalico, non risolvono questi problemi di omofonia; essi sono solo 4 nel puntonghua ma aumentano fino ad 8 in altri dialetti. Esiste un sistema di traslitterazione dei caratteri cinesi che permette di trascrivere i caratteri cinesi con un sistema alfabetico: si chiama pinyin zimu e permette di riprodurre i suoni cinesi in modo facilitato, grazie agli accenti posti sulle componenti sillabiche, che segnalano appunto le diverse sillabe. Altra caratteristica peculiare del cinese è il suo essere priva di flessioni, proprio come le altre lingue isolanti. Ogni unità lessicale è invariabile e la sua forma prescinde dal ruolo grammaticale che essa ricopre. Le funzioni grammaticali sono segnalate dalle posizioni che i costituenti occupano nella frase e dall uso di particelle grammaticali. Infatti, ogni frase segue un ordine preciso di 18
19 organizzazione e successione che deve essere mantenuto per rendere la frase comprensibile. Il genere e il numero dei nomi non è di solito specificato e di solito viene indicato da quantificatori indefiniti, che si mettono a sinistra del nome, o con l aggiunta del suffisso nominale men, che indica la collettività per i nomi di persona. Il caso dei nomi non è segnalato da flessione ma attraverso le proposizioni. Non esistono gli articoli determinativi o indeterminativi, anche se esistono dei referenti determinativi che si pongono a sinistra del verbo, mentre quelli indefiniti alla sua destra. Il verbo è invariabile in genere e numero e può assumere una funzione reggente solo nei gruppi verbali. In molte occasioni è il contesto a fornire le indicazioni modali e temporali. Inoltre, sono le particelle che seguono il verbo a fornire le indicazioni sullo stato di svolgimento dell azione. I verbi transitivi reggono sempre l oggetto diretto che deve essere sempre espresso, mentre un certo numero di verbi intransitivi regge come oggetto diretto il luogo a cui si riferisce il moto espresso. Esempio: Yun Jing jingtian zai tushuguan : Yun Jing oggi stare biblioteca: Oggi Yun Jing è in biblioteca. La composizione frasale cinese si compone di una struttura con tema e commento; il tema è un gruppo nominale che si trova all inizio della frase, mentre il commento è di solito una frase costruita di solito sullo schema S O V, in cui S (soggetto) e O (oggetto) possono a loro volta essere costituiti da altre frasi. Nella costruzione frasale possiamo notare l assenza totale di connettivi, dal momento che la lingua cinese è molto più essenziale, per cui non ha forme molto complesse e pesanti ma punta molto sul contesto in cui la frase è inserita per la sua comprensione. 19
20 L apprendimento dell italiano da parte di allievi cinesi: gli aspetti problematici più comuni. Nel ricordare che l apprendimento dell italiano da parte dei cinesi di solito è molto lento, per una lentezza dovuta in parte alla chiusura della comunità cinese ed in parte alla distanza tipologica tra le due lingue, cercheremo, di seguito, di indicare le difficoltà più ricorrenti dividendole secondo i vari livelli linguistici. Dal punto di vista fonetico, come è risaputo, la maggiore difficoltà è quella della corretta produzione dei fonemi l e r, che vengono dette ipodifferenziate, poiché nel putonghua non sono distinte, con produzione del tipo loba, aplile, oppure nella realizzazione sonora delle occlusive sorde t e p (es. dembo per tempo ) e nella realizzazione delle consonanti doppie, che il pinyin non prevede e nella mente di un parlante cinese raddoppiare i caratteri vuol dire assegnare una diverso significato alla parola. L insegnante potrà aiutare l allievo a rafforzare la memorizzazione scandendo meglio i suoni per metterli in evidenza confrontando, con vari esercizi, la produzione corretta ed errata dello stesso suono. Dal punto di vista grafico, le maggiori difficoltà nella produzione di caratteri alfabetici potrà essere incontrata da allievi già scolarizzati in patria e che per questo hanno memorizzato ed utilizzato una parte dei caratteri che compongono la resa grafica tipica della loro lingua. Per gli altri, non ancora scolarizzati, basterà un po di allenamento in più per familiarizzare con dei tratti grafici diversi e con le diverse modalità di scrittura (maiuscolo, minuscolo, corsivo, stampatello). Ricordiamo che gli allievi cinesi sono molto portati all ordine e alla bella scrittura (calligrafia) proprio per tradizione ed educazione, e quindi non è raro che la riproduzione della scrittura occidentale sia effettuata senza sbagli e con molta disciplina. Nel caso della morfologia nominale, praticamente assente nel cinese, potrebbero essere incontrate delle difficoltà nell uso dell articolo, ad esempio, che viene collocato nella frase a seconda di posizioni specifiche più che per accordi di genere o numero, sulla base dell uso dei classificatori in cinese, che di per sé non sono unità di significato autonomo. L acquisizione della flessione nominale di genere, invece, non risulta molto problematica, mentre lo è di più il concetto di numerabilità, spesso scambiato o usato come il genere. Utile in questi casi può risultare l associazione tra figure e nomi. Nella morfologia verbale, l apprendimento delle varie forme avviene più per memorizzazione, a cui il cinese è abituato per cultura, che per comprensione, e frequenti sono i casi di sovraestensioni dell uso della terza persona del presente indicativo o dell infinito, recepiti dall input a cui sono sottoposti e memorizzati. Proprio l infinito viene usato spesso come tempo principale, forse proprio per ragioni culturali. Infatti i cinesi più di altri sono abituati ad utilizzare forme di citazione memorizzandole e senza la tendenza ad analizzarle in morfemi. Per quanto riguarda la componente sintattica, essendo l ordine frasale del cinese basato sulla struttura S O V, di frequente, almeno nei primi periodi di contatto con l italiano, poterebbero essere prodotti enunciati coerenti con quest ordine sintattico e quindi frasi del tipo scuola dopo io vado oppure io Cina torno 8. 20
21 Solo un uso costante di input ricco e vario più aiutare nell apprendimento di forme nuove, varie, e declinate in genere, numero e caso. 21
22 Altre lingue indoeuropee (russo, arabo, romanè) a contatto con l italiano Russo, arabo e romanè sono tre lingue chiaramente diverse tra loro sia per la storia che per la zona geografica che rappresentano. Ad esempio, la lingua russa è parlata in un territorio immenso quale quello dell ex Unione Sovietica e perciò unisce linguisticamente popoli di diverse nazionalità, con una grande varietà culturale. Anche l arabo vanta una storia antica la cui importanza è radicata profondamente nei suoi parlanti: non è una lingua unitaria nel senso che i parlanti arabi utilizzano per la comunicazione quotidiana le forme dialettali, molto diverse e talvolta incomprensibili tra loro (lingua dârija), tramandate oralmente e diffuse anche nei media. La lingua scritta (fusha) è l unica forma scritta di riferimento, viene insegnata nelle scuole e si rifà all arabo classico del Corano. La lingua romanè invece ha origini indiane ed è parlata dai popoli rom dispersi nelle varie parti del mondo. Non possiede una lingua scritta unitaria, visto che le varie lingue rom, partite da un unica radice, si sono differenziate a contatto delle lingue delle zone di stanziamento. Solo di recente si sta diffondendo un forma grafica unica basata sulle modalità utilizzate dalle lingue slave. Gli elementi comuni tra i gruppi riguardano il lessico della vita quotidiana, la morfologia nominale con i suoi casi e il sistema verbale e i suoi tempi. Le lingue russe ed arabe utilizzano delle grafie diverse da quelle di tipo occidentale. Il russo infatti utilizza l alfabeto cirillico che ha tra le altre caratteristiche quella di basarsi sulla corrispondenza totale tra grafema e fonema e di variare nella forma grafica tra corsivo e stampatello. La lingua araba ha una grafia di tipo alfabetico e utilizza 28 lettere che si scrivono in modo diverso a seconda che trovino ad inizio, in mezzo o in fine parola. Ci sono anche altri segni ortografici che danno indicazioni importanti sulla pronuncia e sulla lettura del carattere. Le tre vocali di base sono a (fatha), i (kasra), u (damma) che possono essere lunghe o brevi, e quando lo sono non vengono scritte. Ogni grafema è associato ad un fonema e non esistono digrammi o trigrammi. C è solo un tipo di scrittura, cioè non esistono corsivo o stampatello, cui sono diversi caratteri tipografici, ma la scuola insegna a scrivere solo in un modo. La punteggiatura è usata di rado, perché si pensa che interrompa il discorso, e non esiste neanche la sillabazione. Una particolarità della grafia araba è la procedura, nella scrittura, da destra verso sinistra: anche i quaderni vengono cominciati da quella che per noi è l ultima pagina. L arabo, come altre lingue semitiche, è una lingua che si sviluppa da radici, che spesso sono formate da tre consonanti, e si dicono perciò trilittere. Ci sono sei mila radici di derivazione, da cui si possono creare milioni di termini. Questa è una caratteristiche molto affascinante dell arabo, che richiama anche i principi matematici. Le parole possono appartenere a tre categorie: nomi, verbi e particelle. Esiste solo un articolo (al-), che è l articolo determinativo per tutti i generi e i numeri. I nomi si declinano in tre casi, nominativo, ablativo e obliquo, a cui si riferiscono i vari complementi indiretti. Vi sono tre numeri, dal momento che 22
23 oltre al singolare e al plurale esiste il duale che si usa nel caso in cui i referenti siano in coppia (es. occhi, braccia). Nel russo la componente morfologica è formata da categorie classificabili e declinabili, sulla base delle quali variano le parole e sulle quali viene costruita la frase. Dal momento che esiste un forte apparato morfologico non esistono articoli, perché superflui. Anche i pronomi e gli aggettivi si declinano in base a genere, numero e caso. Inoltre, la loro animatezza o meno influisce sull attribuzione delle desinenze dei casi. Infatti, ci sono sei casi nella declinazione: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, strumentale, prepositivo, ognuno dei quali è ricco di significati e di riferimenti ad altri campi. Gli aggettivi numerali hanno, inoltre, un sistema di declinazione molto ricco di eccezioni e, quindi, complesso, che addirittura i linguisti vorrebbero semplificare per ragioni di studio. Per quanto riguarda il verbo, esso ha cinque forme (infinito, indicativo, condizionale, imperativo, participio, gerundio) che possono cambiare anche in relazione al tempo, al genere e la numero. La sua caratteristica peculiare è la categoria dell aspetto, cioè perfettivo ed imperfettivo, che si basa sulla durata dell azione nel tempo. Molti verbi si formano aggiungendo dei prefissi che possono attribuire alla stessa radice dei significati opposti. Inoltre esistono verbi di moto unidirezionale e pluridirezionali, di aspetto imperfettivo, e altri che indicano tipi di movimento in direzioni specifiche e/o generiche. Nel romanè il sostantivo ha due generi e due numeri. I sostantivi maschili terminano prevalentemente in o oppure in consonante e quelli femminili in i oppure in consonante. L articolo maschile è o, quello femminile è e. Al plurale troviamo gli articoli le o e per entrambi i generi. Il nome viene declinato in otto casi. Il nominativo corrisponde alla radice, l accusativo al caso obliquo per gli animali; si usano le stesse desinenze per femminile e maschile, con qualche variazione fonetica. Esistono anche delle proposizioni che esprimono le relazioni di caso. La forma base del verbo, invece, è la radice verbale, visto che non esiste l infinito. Il sistema verbale si basa su quattro tempi: presente, imperfetto, perfetto, trapassato. Il presente e l imperfetto si basano sulla radice verbale: aggiungendo le desinenze delle varie persone si forma il presente, e aggiungendo a queste la desinenza a si forma l imperfetto. Il perfetto e il trapassato si formano sulla radice del participio passato, il quale a sua volta si forma con l aggiunta dei suffissi d o l alla radice del verbo. Esiste anche un futuro perifrastico formato da ka e il presente del verbo; questa costruzione, di origine greca moderna, non si trova nei dialetti dell Europa centrale e settentrionale. Non esistono tempi composti, quindi non si usano ausiliari, e non esiste un verbo corrispondente ad avere, dal momento che si ricorre alla locuzione è a me, quindi si usa il presente del verbo essere e il dativo. Lo stile della lingua russa è ancora fortemente influenzato dal russo arcaico che non si è perso e che è rimasto nella lingua moderna con i suoi suffissi, le sue voci auliche e con molti termini. Non esiste la concordanza temporale: i tempi delle proposizioni principali e secondarie devono essere usati nello stesso modo. L ordine dei costituenti frasali è abbastanza libero e anzi non sono rari 23
24 casi di inversione nella frase, che le conferiscono particolari sfumature e danno rilievo ai suoi componenti in modo diverso, ma senza ambiguità, dal momento che le declinazioni aiutano nell organizzazione frasale. Si usano le frasi impersonali molto di frequente, anzi l uso dell avverbio predicativo come predicato delle forme impersonali è una forma tipica del russo, che indica lo stato o la condizione di una persona o di un ambiente. La lingua araba moderna sta evolvendo le sue strutture frasali in costruzioni tipo S V O. oltre a queste costruzioni, l arabo presenta frasi di tipo verbale, il cui ordine è V S O, oppure di tipo nominale in cui soggetto e predicato non sono congiunti da copula. Se il predicato è determinato si introduce il cosiddetto pronome separante che si riferisce al predicato e lo distingue dal soggetto. Come corrispondenti del verbo essere e avere si usano due costruzioni particolari: per indicare l essere si usa kâna, che significa esistere; per il concetto di appartenenza si utilizzano frasi nominali rette da preposizioni visto che il verbo avere non esiste. Anche nel romanè l ordine frasale basico è Soggetto-Verbo-Oggetto (S V O), ma l ordine delle parole non è rigido, visto che l uso dei casi facilita il riconoscimento delle relazioni tra i costituenti. Addirittura non si usa molto neanche il pronome soggetto vista la flessibilità del sistema verbale. Ciò che distingue fondamentalmente l italiano dal romanè è la mancanza dell infinito, che incide non solo nel sistema verbale ma anche nelle strutture frasali. In tutte le proposizioni subordinate infatti si trova sempre un tempo finito. Come tutte le lingue orali il vocabolario del romanè è piuttosto ridotto. Questo avviene anche perché non esiste un linguaggio scientifico che porti a delle differenziazioni specifiche e settoriali; ad esempio tutti gli uccelli sono čiriklì, così come tutti i fiori sono luluği. Anche i nomi delle parti del corpo sono piuttosto generici: muj significa sia bocca che viso, e vah significa mano e braccio. Essendo il sistema familiare impostato in modo diverso dal nostro, anche i termini di parentela indicano legami diversi anche se il lessico è piuttosto vario dal momento che la famiglia è al centro dell organizzazione sociale. Una giovane sposa, ad esempio, sarà chiamata borì (sposa) e sarà la borì di tutti, anche per la suocera e per le cognate. 24
Nella lingua macedone esistono tre serie di articoli, ognuna delle quali viene usata per indicare la collocazione dell oggetto rispetto al parlante
 Alcuni spunti di riflessione sulle interferenze della lingua materna nell apprendimento della lingua italiana in riferimento alla lingua balcanica a quella cinese, araba e russa. Le lingue balcaniche :
Alcuni spunti di riflessione sulle interferenze della lingua materna nell apprendimento della lingua italiana in riferimento alla lingua balcanica a quella cinese, araba e russa. Le lingue balcaniche :
2 LE PARTI DEL DISCORSO Le nove parti del discorso Caratteristiche delle parti del discorso 48 ESERCIZI 50 INDICE
 1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
GRAMMATICA - TESTO PAROLE E TESTI IN GIOCO Progettazione didattica annuale per unità e competenze Classi Prime
 GRAMMATICA - TESTO PAROLE E TESTI IN GIOCO Progettazione didattica annuale per unità e competenze Classi Prime Unità 1 Suoni, lettere e ortografia fondamentali relative alla fonologia e all ortografia
GRAMMATICA - TESTO PAROLE E TESTI IN GIOCO Progettazione didattica annuale per unità e competenze Classi Prime Unità 1 Suoni, lettere e ortografia fondamentali relative alla fonologia e all ortografia
Traccia di analisi della competenza linguistica e comunicativa. Usa il linguaggio verbale sì no. Usa il corpo per esprimere le sue emozioni sì no
 Traccia di analisi della competenza linguistica e comunicativa a cura di Francesco De Renzo (Facoltà di Studi Orientali, Sapienza-Università di Roma) Comunicazione Interazione In che modo comunica e interagisce:
Traccia di analisi della competenza linguistica e comunicativa a cura di Francesco De Renzo (Facoltà di Studi Orientali, Sapienza-Università di Roma) Comunicazione Interazione In che modo comunica e interagisce:
LINGUA E CULTURA GRECA PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV B ANNO SCOLASTICO
 LINGUA E CULTURA GRECA PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV B ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Libro di testo: P. Agazzi, M. Villardo Ellenistì, Corso di lingua e cultura greca, Manuale ed Esercizi vol.1, Zanichelli 2014,
LINGUA E CULTURA GRECA PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV B ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Libro di testo: P. Agazzi, M. Villardo Ellenistì, Corso di lingua e cultura greca, Manuale ed Esercizi vol.1, Zanichelli 2014,
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLA SITUAZIONE LINGUISTICA ALUNNO..NAZIONALITÀ LINGUA D ORIGINE.. CLASSE CAMPO D OSSERVAZIONE. Data di rilevazione
 GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLA SITUAZIONE LINGUISTICA ALUNNO..NAZIONALITÀ LINGUA D ORIGINE.. CLASSE CAMPO D OSSERVAZIONE. Data di rilevazione ASPETTI FONOLOGICI Confonde nella pronuncia e nello scritto:
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLA SITUAZIONE LINGUISTICA ALUNNO..NAZIONALITÀ LINGUA D ORIGINE.. CLASSE CAMPO D OSSERVAZIONE. Data di rilevazione ASPETTI FONOLOGICI Confonde nella pronuncia e nello scritto:
ALLEGATO AL CURRICOLO DI ISTITUTO ITALIANO L2. Dalle linee guida CILS Livello A1
 ALLEGATO AL CURRICOLO DI ISTITUTO ITALIANO L2 Dalle linee guida CILS Livello A1 È il livello di avvio del processo di apprendimento dell italiano. Verifica la capacità di comprendere brevi testi e utilizzare
ALLEGATO AL CURRICOLO DI ISTITUTO ITALIANO L2 Dalle linee guida CILS Livello A1 È il livello di avvio del processo di apprendimento dell italiano. Verifica la capacità di comprendere brevi testi e utilizzare
che cosa sai fare Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua parlata 4 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua scritta 5
 Percorso 1 La fonortografia mappa del percorso 2 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua parlata 4 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua scritta 5 Come si parla e come si scrive
Percorso 1 La fonortografia mappa del percorso 2 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua parlata 4 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua scritta 5 Come si parla e come si scrive
Osservare l interlingua. Stefania Ferrari
 Osservare l interlingua Stefania Ferrari www.glottonaute.it Si può visualizzare il concetto di acquisizione di una lingua utilizzando l immagine di un labirinto. All inizio del suo percorso l apprendente
Osservare l interlingua Stefania Ferrari www.glottonaute.it Si può visualizzare il concetto di acquisizione di una lingua utilizzando l immagine di un labirinto. All inizio del suo percorso l apprendente
APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA
 APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? I sistemi di comunicazione distinzione tra sistemi comunicativi verbali e non - verbali; i sistemi di scrittura sono strettamente
APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? I sistemi di comunicazione distinzione tra sistemi comunicativi verbali e non - verbali; i sistemi di scrittura sono strettamente
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
NUOVI ITINERARI. Sommario. Premessa
 NUOVI ITINERARI V Sommario Premessa XI Prima unità Cap. 1 Alfabeto e sistema fonetico 3 1.1 Vocali 5 1.2 Consonanti 8 1.3 Aspirazione 10 1.4 Il sistema di accentazione 12 1.5 Proclitiche ed enclitiche.
NUOVI ITINERARI V Sommario Premessa XI Prima unità Cap. 1 Alfabeto e sistema fonetico 3 1.1 Vocali 5 1.2 Consonanti 8 1.3 Aspirazione 10 1.4 Il sistema di accentazione 12 1.5 Proclitiche ed enclitiche.
!!" # &!" $ '()! *#!$$$ &! '! " (#!& $ ##(## - +#%& ##,#( !# "
 # ) *# *# # # #### - - + ##,# # / PRODUZ I O N E ORALE COMPRENS I O N E ORAL E ) * + + ) * # # % %, I N T E R A Z I O N E ORALE ) -* / # PRODUZ I O N E SCR I T T A COMPRENS I O N E SCR I T T A I N T E
# ) *# *# # # #### - - + ##,# # / PRODUZ I O N E ORALE COMPRENS I O N E ORAL E ) * + + ) * # # % %, I N T E R A Z I O N E ORALE ) -* / # PRODUZ I O N E SCR I T T A COMPRENS I O N E SCR I T T A I N T E
VIII. Indice. Unità 2 La semantica 20
 Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
Istituto Comprensivo Campagnola-Galilei. Area Didattica
 Sezione Competenze Contenuti/attività Scuola dell Infanzia Sezione 3 anni 1. Essere in grado di esprimersi in modo comprensibile. 2. Essere in grado di ascoltare. Narrazioni orali Letture Comprensioni
Sezione Competenze Contenuti/attività Scuola dell Infanzia Sezione 3 anni 1. Essere in grado di esprimersi in modo comprensibile. 2. Essere in grado di ascoltare. Narrazioni orali Letture Comprensioni
Istituto Comprensivo Statale di Goito (MN) Via D. Alighieri, Goito (MN) a.s PROGRAMMAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE
 Istituto Comprensivo Statale di Goito (MN) Via D. Alighieri, 49-46044 Goito (MN) a.s. 2014-2015 PROGRAMMAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE OBIETTIVO GENERALE L obiettivo generale sarà quello di fornire ai bambini
Istituto Comprensivo Statale di Goito (MN) Via D. Alighieri, 49-46044 Goito (MN) a.s. 2014-2015 PROGRAMMAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE OBIETTIVO GENERALE L obiettivo generale sarà quello di fornire ai bambini
LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE
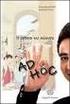 Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO greco classico biennio
 OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO greco classico biennio Competenze chiave di Cittadinanza Competenze generali di Asse Linguaggi (dalle Indicazioni Nazionali e dagli Assi Culturali)
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO greco classico biennio Competenze chiave di Cittadinanza Competenze generali di Asse Linguaggi (dalle Indicazioni Nazionali e dagli Assi Culturali)
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME. Competenze specifiche Abilità Conoscenze ABILITÀ MORFO-SINTATTICHE
 OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
La padronanza linguistica, Academia Universa Press 2011 PARTE PRIMA FARE GRAMMATICA 1. INSEGNARE ANCORA LA GRAMMATICA?
 La padronanza linguistica, Academia Universa Press 2011 PARTE PRIMA FARE GRAMMATICA 1. INSEGNARE ANCORA LA GRAMMATICA? 2. LA TRADIZIONE Analisi grammaticale Analisi logica Analisi del periodo Analisi testuale
La padronanza linguistica, Academia Universa Press 2011 PARTE PRIMA FARE GRAMMATICA 1. INSEGNARE ANCORA LA GRAMMATICA? 2. LA TRADIZIONE Analisi grammaticale Analisi logica Analisi del periodo Analisi testuale
Programma Italiano I BIO
 Programma Italiano I BIO 1. Grammatica La grammatica La morfologia Parti variabili Parti invariabili La sintassi Sintassi della frase semplice Sintassi del periodo L analisi Grammaticale Logica Del periodo
Programma Italiano I BIO 1. Grammatica La grammatica La morfologia Parti variabili Parti invariabili La sintassi Sintassi della frase semplice Sintassi del periodo L analisi Grammaticale Logica Del periodo
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO latino classico biennio
 OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO latino classico biennio Competenze chiave di Cittadinanza Competenze generali di Asse Linguaggi (dalle Indicazioni Nazionali e dagli Assi Culturali)
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO latino classico biennio Competenze chiave di Cittadinanza Competenze generali di Asse Linguaggi (dalle Indicazioni Nazionali e dagli Assi Culturali)
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2018/19
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2018/19 PROF. VINTI ANNA RITA.. CLASSE IV F. MATERIA LATINO. Finalità Sviluppo dell interesse per il patrimonio culturale classico come una delle radici da cui si è sviluppata
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2018/19 PROF. VINTI ANNA RITA.. CLASSE IV F. MATERIA LATINO. Finalità Sviluppo dell interesse per il patrimonio culturale classico come una delle radici da cui si è sviluppata
Sommario. Premessa XIII
 Sommario Premessa XIII Cap. 1 Alfabeto e sistema fonetico 1 1.1 Vocali 3 1.2 Consonanti 6 1.3 Aspirazione 8 1.4 Il sistema di accentazione 10 1.5 Proclitiche ed enclitiche. Appositive e ortotoniche 12
Sommario Premessa XIII Cap. 1 Alfabeto e sistema fonetico 1 1.1 Vocali 3 1.2 Consonanti 6 1.3 Aspirazione 8 1.4 Il sistema di accentazione 10 1.5 Proclitiche ed enclitiche. Appositive e ortotoniche 12
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DISCIPLINA: Seconda lingua comunitaria - spagnolo Classi: prime NUCLEI ESSENZIALI ASCOLTO E COMPRENSIONE DI MESSAGGI ORALI PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) TRAGUARDI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DISCIPLINA: Seconda lingua comunitaria - spagnolo Classi: prime NUCLEI ESSENZIALI ASCOLTO E COMPRENSIONE DI MESSAGGI ORALI PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) TRAGUARDI
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Greco Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Greco Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
PROGRAMMAZIONE CLASSI TERZE A.S. 2018/19 ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE CLASSI TERZE A.S. 2018/19 ITALIANO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Competenza digitale. Imparare ad imparare. COMPETENZE TRASVERSALI Comprendere
PROGRAMMAZIONE CLASSI TERZE A.S. 2018/19 ITALIANO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Competenza digitale. Imparare ad imparare. COMPETENZE TRASVERSALI Comprendere
3. Dalla linearità alla struttura La dipendenza dalla struttura La ricorsività 31
 Indice Parte I Fare grammatica 9 1. Insegnare ancora la grammatica? 9 2. La tradizione 15 2.1. Analisi grammaticale 16 2.2. Analisi logica 19 2.3. Analisi del periodo 22 2.4. Analisi testuale 24 2.5. Verso
Indice Parte I Fare grammatica 9 1. Insegnare ancora la grammatica? 9 2. La tradizione 15 2.1. Analisi grammaticale 16 2.2. Analisi logica 19 2.3. Analisi del periodo 22 2.4. Analisi testuale 24 2.5. Verso
INDICE GENERALE Capitolo 1 - preliminari... 3 Capitolo 2 - Morfologia: preliminari... 12
 INDICE GENERALE Capitolo 1 - Preliminari... 3 1. L alfabeto latino...3 2. La pronunzia del latino...4 3. Vocali e semivocali...5 4. Dittonghi...6 5. La dieresi...7 6. L apofonia...7 7. Consonanti...7 8.
INDICE GENERALE Capitolo 1 - Preliminari... 3 1. L alfabeto latino...3 2. La pronunzia del latino...4 3. Vocali e semivocali...5 4. Dittonghi...6 5. La dieresi...7 6. L apofonia...7 7. Consonanti...7 8.
ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna LICEO LINGUISTICO. Riconoscere la situazione di comunicazione ( chi, dove e quando) Comprendere il messaggio globale
 Classe 1^ - FRANCESE (seconda lingua) OBIETTIVI Comprensione orale ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna LICEO LINGUISTICO Riconoscere la situazione di comunicazione ( chi, dove e quando) Comprendere il messaggio
Classe 1^ - FRANCESE (seconda lingua) OBIETTIVI Comprensione orale ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna LICEO LINGUISTICO Riconoscere la situazione di comunicazione ( chi, dove e quando) Comprendere il messaggio
E LESSICO 13 PARTE A FONOLOGIA, SEMANTICA. UNITÀ 1 Fonologia, ortografia e punteggiatura 14 LA LINGUA SIAMO NOI 2 1 LA FONOLOGIA 14 2 L ORTOGRAFIA 20
 LA LINGUA SIAMO NOI 2 LA NASCITA DELL ITALIANO 2 Che lingua parliamo? 2 Dal latino all italiano, 2 Latino scritto e latino parlato, 2 Cade l Impero, cambia la lingua, 3 Le sorelle della nostra lingua,
LA LINGUA SIAMO NOI 2 LA NASCITA DELL ITALIANO 2 Che lingua parliamo? 2 Dal latino all italiano, 2 Latino scritto e latino parlato, 2 Cade l Impero, cambia la lingua, 3 Le sorelle della nostra lingua,
Fonologia e ortografia
 Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
Corso propedeutico Ditals 1
 Progetto Vivere in Italia. L'italiano per il lavoro e la cittadinanza. Terza edizione. Convenzione di Sovvenzione n. 2012/FEI/PROG-104481 CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E83D13000880007 Corso propedeutico Ditals
Progetto Vivere in Italia. L'italiano per il lavoro e la cittadinanza. Terza edizione. Convenzione di Sovvenzione n. 2012/FEI/PROG-104481 CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E83D13000880007 Corso propedeutico Ditals
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO CLASSE QUARTA NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO CLASSE QUARTA NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA ASCOLTO E PARLATO Partecipare a scambi comunicativi: conversazione, discussione a tema.
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO CLASSE QUARTA NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA ASCOLTO E PARLATO Partecipare a scambi comunicativi: conversazione, discussione a tema.
376 Introduzione alla lingua di Roma nel Duecento
 INDICE Introduzione Preliminare» 3 Riferimenti testuali e bibliografici» 4 I. La lingua di Roma nel Duecento» 5 II. La trascrizione dei testi e le abbreviazioni» 7 III. Correzioni alle trascrizioni dei
INDICE Introduzione Preliminare» 3 Riferimenti testuali e bibliografici» 4 I. La lingua di Roma nel Duecento» 5 II. La trascrizione dei testi e le abbreviazioni» 7 III. Correzioni alle trascrizioni dei
a. s CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino
 a. s. 2015-2016 CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino PROGRAMMA SVOLTO Segni e suoni L alfabeto: confronto italiano - latino Vocali e dittonghi Come si legge il latino La quantità della penultima
a. s. 2015-2016 CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino PROGRAMMA SVOLTO Segni e suoni L alfabeto: confronto italiano - latino Vocali e dittonghi Come si legge il latino La quantità della penultima
LINGUA INGLESE CLASSE 4^
 DISCIPLINA LINGUA INGLESE CLASSE 4^ LEGENDA per gli : A= Ascolto (comprensione orale) P = Parlato (produzione e interazione orale) L = Lettura (comprensione scritta) S = Scrittura (produzione scritta)
DISCIPLINA LINGUA INGLESE CLASSE 4^ LEGENDA per gli : A= Ascolto (comprensione orale) P = Parlato (produzione e interazione orale) L = Lettura (comprensione scritta) S = Scrittura (produzione scritta)
SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: FRANCESE CLASSE PRIMA
 Fonti di legittimazione : Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: FRANCESE CLASSE PRIMA
Fonti di legittimazione : Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: FRANCESE CLASSE PRIMA
LE COMPETENZE ESSENZIALI DI FRANCESE
 LE ESSENZIALI DI FRANCESE classe prima Liceo linguistico comprendere informazioni dirette e concrete su argomenti di vita quotidiana (famiglia, acquisti, lavoro, ambiente circostante) comprendere e seguire
LE ESSENZIALI DI FRANCESE classe prima Liceo linguistico comprendere informazioni dirette e concrete su argomenti di vita quotidiana (famiglia, acquisti, lavoro, ambiente circostante) comprendere e seguire
Istituto Comprensivo di Gaggio Montano. Scuola Primaria di Castel d Aiano PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO. Classe quarta. Anno scolastico 2015/2016
 Istituto Comprensivo di Gaggio Montano. Scuola Primaria di Castel d Aiano PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe quarta Anno scolastico 2015/2016 Insegnante: Ropa Lina La presente Programmazione annuale
Istituto Comprensivo di Gaggio Montano. Scuola Primaria di Castel d Aiano PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe quarta Anno scolastico 2015/2016 Insegnante: Ropa Lina La presente Programmazione annuale
Abilità L alunno sa: Acquisire un comportamento di ascolto attento e partecipativo. Ascoltare semplici letture di testi di vario genere.
 DISCIPLINA ITALIANO CLASSE PRIMA COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE Comunicazione nella madrelingua. COMPETENZA/E TRASVERSALI Imparare a imparare. Competenze digitali. Conoscenze L alunno conosce: Ascolto e parlato.
DISCIPLINA ITALIANO CLASSE PRIMA COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE Comunicazione nella madrelingua. COMPETENZA/E TRASVERSALI Imparare a imparare. Competenze digitali. Conoscenze L alunno conosce: Ascolto e parlato.
Disciplina Greco Campanini C.-Scaglietti P., Il Greco di Campanini, Grammatica,
 Istituto d Istruzione Superiore POLO-LICEO ARTISTICO - VEIS02400C VENEZIA Liceo Artistico, Liceo Classico e Musicale Dorsoduro, 1073 30123 Venezia tel 0415225252, fax 041 2414154 e-mail: veis02400c@istruzione.it
Istituto d Istruzione Superiore POLO-LICEO ARTISTICO - VEIS02400C VENEZIA Liceo Artistico, Liceo Classico e Musicale Dorsoduro, 1073 30123 Venezia tel 0415225252, fax 041 2414154 e-mail: veis02400c@istruzione.it
PERCORSO A I SUONI E IL SENSO DELLE PAROLE. Conoscenze Abilità Competenze Che lingua parliamo? Arricchiamo il lessico
 La comunicazione XIV A PERCORSO A I SUONI E IL SENSO DELLE PAROLE Unità 1 I suoni, l alfabeto e la scrittura 2 PARTIAMO DAL TESTO 2 1 I suoni della lingua 3 PER SAPERNE DI PIÙ La produzione dei foni 3
La comunicazione XIV A PERCORSO A I SUONI E IL SENSO DELLE PAROLE Unità 1 I suoni, l alfabeto e la scrittura 2 PARTIAMO DAL TESTO 2 1 I suoni della lingua 3 PER SAPERNE DI PIÙ La produzione dei foni 3
Istituto Comprensivo di Pralboino Curricolo Verticale
 ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009
 QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009 RIFERIMENTI NORMATIVI INDICAZIONI NAZIONALI 2003 (OSA) L. n 53/2003 e D. Lgs 59/2004 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO 2007 QUADRO DI RIFERIMENTO
QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009 RIFERIMENTI NORMATIVI INDICAZIONI NAZIONALI 2003 (OSA) L. n 53/2003 e D. Lgs 59/2004 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO 2007 QUADRO DI RIFERIMENTO
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 2LC (V Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Periodo 1 Ripasso del programma svolto
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 2LC (V Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Periodo 1 Ripasso del programma svolto
1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare. 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare
 1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare 3 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: leggere 4 Modulo operativo: Le abilità linguistiche:
1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare 3 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: leggere 4 Modulo operativo: Le abilità linguistiche:
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MANDRALISCA LICEO GINNASIO STATALE
 REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MANDRALISCA LICEO GINNASIO STATALE e I.P.S.S.E.O.A. - CEFALU Via Maestro Vincenzo Pintorno 27 - e-mail: PAIS00200N@istruzione.it
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MANDRALISCA LICEO GINNASIO STATALE e I.P.S.S.E.O.A. - CEFALU Via Maestro Vincenzo Pintorno 27 - e-mail: PAIS00200N@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO INCISA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO
 ASCOLTARE E PARLARE ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO INCISA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classi QUARTE Primo quadrimestre Obiettivi Attività - Interagire in una conversazione formulando domande e dando
ASCOLTARE E PARLARE ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO INCISA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classi QUARTE Primo quadrimestre Obiettivi Attività - Interagire in una conversazione formulando domande e dando
BFLR A Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA. edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto
 BFLR A 351667 Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto INDICE ABBREVIATURE 1. Principali abbreviature usate, p. 11 n INTRODUZIONE
BFLR A 351667 Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto INDICE ABBREVIATURE 1. Principali abbreviature usate, p. 11 n INTRODUZIONE
SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE. Anno scolastico
 SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Anno scolastico 2017-2018 Istituto Docente Materia Classe GESU - MARIA ROLLETTA CHIARA LATINO I LICEO CLASSICO Numero di studenti 3 1. COMPETENZE IN USCITA 1. L alunno
SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Anno scolastico 2017-2018 Istituto Docente Materia Classe GESU - MARIA ROLLETTA CHIARA LATINO I LICEO CLASSICO Numero di studenti 3 1. COMPETENZE IN USCITA 1. L alunno
CURRICOLO VERTICALE ITALIANO
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo R. Franceschi Via Concordia, 2/4-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel. 02 48 40 20 46 - Fax 02 48 49 01 97 E-mail: segreteria@icfranceschi.gov.it
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo R. Franceschi Via Concordia, 2/4-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel. 02 48 40 20 46 - Fax 02 48 49 01 97 E-mail: segreteria@icfranceschi.gov.it
ITALIANO interclasse 3 18/19
 ASCOLTO interclasse 3 18/19 Assumere una corretta posizione per un ascolto attivo. Conversazioni L alunno: Distinguere tra i momenti Discussioni ascolta in modo attivo e di ascolto e di possibilità di
ASCOLTO interclasse 3 18/19 Assumere una corretta posizione per un ascolto attivo. Conversazioni L alunno: Distinguere tra i momenti Discussioni ascolta in modo attivo e di ascolto e di possibilità di
Latino Liceo delle scienze umane Classe prima Trimestre
 Classe prima n.2 scritti e n.2 orali, Leggere un testo in lingua latina,prestando attenzione alle regole della pronuncia e alla quantità delle vocali Cogliere analogie e differenze tra la frase italiana
Classe prima n.2 scritti e n.2 orali, Leggere un testo in lingua latina,prestando attenzione alle regole della pronuncia e alla quantità delle vocali Cogliere analogie e differenze tra la frase italiana
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA
 CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA Conoscere l ordine alfabetico; Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico; Riconoscere e isolare le vocali nelle parole che le contengono; Riconoscere
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA Conoscere l ordine alfabetico; Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico; Riconoscere e isolare le vocali nelle parole che le contengono; Riconoscere
LINGUA E CULTURA TEDESCA
 A conclusione del biennio lo studente dovrà: LINGUA E CULTURA TEDESCA PRIMO BIENNIO Area metodologica: - Aver acquisito un metodo di lavoro autonomo e flessibile - Essere consapevole della diversità dei
A conclusione del biennio lo studente dovrà: LINGUA E CULTURA TEDESCA PRIMO BIENNIO Area metodologica: - Aver acquisito un metodo di lavoro autonomo e flessibile - Essere consapevole della diversità dei
LINGUA INGLESE CLASSE 5^ ABILITA -Sa ascoltare e comprendere il tema generale di un breve discorso e/o dialogo. ABILITA
 DISCIPLINA LINGUA INGLESE CLASSE 5^ LEGENDA per gli : A= Ascolto (comprensione orale) P = Parlato (produzione e interazione orale) L = Lettura (comprensione scritta) S = Scrittura (produzione scritta)
DISCIPLINA LINGUA INGLESE CLASSE 5^ LEGENDA per gli : A= Ascolto (comprensione orale) P = Parlato (produzione e interazione orale) L = Lettura (comprensione scritta) S = Scrittura (produzione scritta)
GRUPPO SCUOLA DELL INFANZIA Mirella Pezzin
 GRUPPO SCUOLA DELL INFANZIA Mirella Pezzin PERCHÉ OCCUPARSI DELL INSEGNAMENTO DELL ITALIANO AGLI STRANIERI? DALLE INDICAZIONI NAZIONALI NELLA SOCIETA COMPLESSA E IN CONTINUA TRASFORMAZIONE ogni singola
GRUPPO SCUOLA DELL INFANZIA Mirella Pezzin PERCHÉ OCCUPARSI DELL INSEGNAMENTO DELL ITALIANO AGLI STRANIERI? DALLE INDICAZIONI NAZIONALI NELLA SOCIETA COMPLESSA E IN CONTINUA TRASFORMAZIONE ogni singola
UNITÀ DI APPRENDIMENTO ITALIANO 1. ASCOLTO Terze Bornato Cazzago - Pedrocca
 NUMERO UNITÀ D APPRENDIMENTO 1 ASCOLTO ARTICOLAZIONE DELL 1. Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti 2. Comprendere l argomento e le informazioni di discorsi affrontati
NUMERO UNITÀ D APPRENDIMENTO 1 ASCOLTO ARTICOLAZIONE DELL 1. Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti 2. Comprendere l argomento e le informazioni di discorsi affrontati
DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013
 ISIS VINCENZO MANZINI PIANO DI LAVORO ANNUALE CLASSE : 1 A LL DISCIPLINA : LATINO DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013 Situazione della classe. La classe 1^ALL è formata da 22 allievi,
ISIS VINCENZO MANZINI PIANO DI LAVORO ANNUALE CLASSE : 1 A LL DISCIPLINA : LATINO DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013 Situazione della classe. La classe 1^ALL è formata da 22 allievi,
ITALIANO Competenza 1 al termine del terzo biennio della scuola primaria e secondaria di primo grado
 ITALIANO Competenza 1 al termine del terzo biennio della scuola primaria e secondaria di primo grado Competenza Abilità Quando ascolta, lo studente al termine del terzo biennio è in grado di: 1. Interagire
ITALIANO Competenza 1 al termine del terzo biennio della scuola primaria e secondaria di primo grado Competenza Abilità Quando ascolta, lo studente al termine del terzo biennio è in grado di: 1. Interagire
PIANI DI STUDIO LINGUA ITALIANA
 Istituto Comprensivo Taio PIANI DI STUDIO LINGUA ITALIANA Primo biennio Classe Seconda ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Competenza 1 1. Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura Attenzione
Istituto Comprensivo Taio PIANI DI STUDIO LINGUA ITALIANA Primo biennio Classe Seconda ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Competenza 1 1. Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura Attenzione
INGLESE IL CURRICOLO DI BASE - OBIETTIVI SPECIFICI D APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA
 INGLESE IL CURRICOLO DI BASE - OBIETTIVI SPECIFICI D APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA DELLA LINGUA ORALE DELLA LINGUA SCRITTA MONOENNIO I BIENNIO II BIENNIO Comprendere il senso globale di unità fonico-acustica
INGLESE IL CURRICOLO DI BASE - OBIETTIVI SPECIFICI D APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA DELLA LINGUA ORALE DELLA LINGUA SCRITTA MONOENNIO I BIENNIO II BIENNIO Comprendere il senso globale di unità fonico-acustica
1 MODULO OPERATIVO LE ABILITA LINGUISTICHE
 1 MODULO OPERATIVO LE ABILITA LINGUISTICHE N 1 Acquisire gradualmente, attraverso l osservazione e l esercizio dell attenzione e della memoria la padronanza delle regole comunicative relative all ascoltare
1 MODULO OPERATIVO LE ABILITA LINGUISTICHE N 1 Acquisire gradualmente, attraverso l osservazione e l esercizio dell attenzione e della memoria la padronanza delle regole comunicative relative all ascoltare
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Latino Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Latino Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
 PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 4^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE 1a) Ascolto del contenuto di una conversazione o di un testo letto. 1b) Intuizione in un messaggio orale
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 4^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE 1a) Ascolto del contenuto di una conversazione o di un testo letto. 1b) Intuizione in un messaggio orale
SAINT-ROCH ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE ITALIANO SCUOLA PRIMARIA
 ITALIANO SCUOLA PRIMARIA Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo le Indicazioni nazionali: L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione
ITALIANO SCUOLA PRIMARIA Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo le Indicazioni nazionali: L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione
LICEO SCIENTIFICO A. VOLTA ANNO SCOLASTICO 2015/16 LATINO
 1 LICEO SCIENTIFICO A. VOLTA ANNO SCOLASTICO 2015/16 PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI LETTERE CLASSI DEL BIENNIO LATINO FINALITA GENERALI DELLA DISCIPLINA L insegnamento della Lingua latina si propone di
1 LICEO SCIENTIFICO A. VOLTA ANNO SCOLASTICO 2015/16 PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI LETTERE CLASSI DEL BIENNIO LATINO FINALITA GENERALI DELLA DISCIPLINA L insegnamento della Lingua latina si propone di
Lingua italiana livello 1
 Griglia di valutazione relativa a Classe Anno scolastico Lingua italiana livello 1 A) Ascoltare, comprendere, e comunicare oralmente Riconosce, isola e discrimina suoni e parole 1 Q 2 Q Comprende semplice
Griglia di valutazione relativa a Classe Anno scolastico Lingua italiana livello 1 A) Ascoltare, comprendere, e comunicare oralmente Riconosce, isola e discrimina suoni e parole 1 Q 2 Q Comprende semplice
Alda Baldaccini Patrizia Pugliese Maria Cristina Zanti IL MIO LIBRO DI ITALIANO
 Alda Baldaccini Patrizia Pugliese Maria Cristina Zanti IL MIO LIBRO DI ITALIANO 1998 by G. B. Palumbo & C. Editore S.p.A. progetto grafico e coordinamento tecnico Federica Giovannini videoimpaginazione
Alda Baldaccini Patrizia Pugliese Maria Cristina Zanti IL MIO LIBRO DI ITALIANO 1998 by G. B. Palumbo & C. Editore S.p.A. progetto grafico e coordinamento tecnico Federica Giovannini videoimpaginazione
Linguistica generale a.a Federica Da Milano.
 Linguistica generale a.a. 2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it L'acquisizione del linguaggio Studio dell'acquisizione del linguaggio come fonte di informazioni sulla natura stessa del
Linguistica generale a.a. 2014-2015 Federica Da Milano federica.damilano@unimib.it L'acquisizione del linguaggio Studio dell'acquisizione del linguaggio come fonte di informazioni sulla natura stessa del
Disciplina TEDESCO 1 biennio Classi 1ATT-1BTT-1CTT -2BTT A. S
 Disciplina TEDESCO 1 biennio Classi 1ATT-1BTT-1CTT -2BTT A. S. 2018-2019 Competenze Abilità Conoscenze Metodologia Valutazione Risultati attesi Comunicazione nelle lingue straniere Riconoscere gli aspetti
Disciplina TEDESCO 1 biennio Classi 1ATT-1BTT-1CTT -2BTT A. S. 2018-2019 Competenze Abilità Conoscenze Metodologia Valutazione Risultati attesi Comunicazione nelle lingue straniere Riconoscere gli aspetti
Presentazione della classe
 Presentazione della classe La classe IIA del Liceo Scientifico è composta da 23 alunni (6 maschi e 17 femmine) di cui 2 sono ripetenti (dallo stesso corso). Dal punto di vista relazionale, gli alunni per
Presentazione della classe La classe IIA del Liceo Scientifico è composta da 23 alunni (6 maschi e 17 femmine) di cui 2 sono ripetenti (dallo stesso corso). Dal punto di vista relazionale, gli alunni per
COMPETENZE DI ITALIANO DA PROVE INVALSI
 COMPETENZE DI ITALIANO DA PROVE INVALSI COMPETENZE DI ITALIANO TRATTE DAL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA DI ITALIANO DELL INVALSI AGGIORNATO AL 28 FEBBRAIO 2011. 1. LETTURA. PREMESSA: tipo di testo
COMPETENZE DI ITALIANO DA PROVE INVALSI COMPETENZE DI ITALIANO TRATTE DAL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA DI ITALIANO DELL INVALSI AGGIORNATO AL 28 FEBBRAIO 2011. 1. LETTURA. PREMESSA: tipo di testo
DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N. Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato.
 DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N Contenuti da recuperare Tipologia della prova Modalità di recupero Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato. -
DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N Contenuti da recuperare Tipologia della prova Modalità di recupero Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato. -
ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna. LICEO DELLE SCIENZE UMANE (opzione economico-sociale)
 ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna LICEO DELLE SCIENZE UMANE (opzione economico-sociale) Classe 1^ - FRANCESE (seconda lingua) OBIETTIVI Comprensione orale Riconoscere la situazione di comunicazione ( chi,
ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna LICEO DELLE SCIENZE UMANE (opzione economico-sociale) Classe 1^ - FRANCESE (seconda lingua) OBIETTIVI Comprensione orale Riconoscere la situazione di comunicazione ( chi,
COMPETENZE IN ITALIANO L2 DELL ALUNNO/ A..
 COMPETENZE IN ITALIANO L2 DELL ALUNNO/ A.. IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Anno Scolastico Anno di nascita Anno di arrivo in Italia Scuola media frequentata Insegnante facilitatore L alunn
COMPETENZE IN ITALIANO L2 DELL ALUNNO/ A.. IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Anno Scolastico Anno di nascita Anno di arrivo in Italia Scuola media frequentata Insegnante facilitatore L alunn
DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA a.s
 DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA a.s. 2017 2018 LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO LATINO - PRIMO BIENNIO PREMESSA Al fine di uniformare finalità, obiettivi didattici, contenuti
DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA a.s. 2017 2018 LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO LATINO - PRIMO BIENNIO PREMESSA Al fine di uniformare finalità, obiettivi didattici, contenuti
I.I.S. De Amicis Cattaneo. Programmazione di istituto Classi prime Italiano A.s 2018/19
 I.I.S. De Amicis Cattaneo Programmazione di istituto Classi prime Italiano A.s 2018/19 FINALITA E OBIETTIVI GENERALI Il percorso didattico mira all acquisizione delle competenze relative alla lettura,
I.I.S. De Amicis Cattaneo Programmazione di istituto Classi prime Italiano A.s 2018/19 FINALITA E OBIETTIVI GENERALI Il percorso didattico mira all acquisizione delle competenze relative alla lettura,
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. Micro- obiettivi
 SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
LATINO E GRECO. TEMPI DI RICONSEGNA DEGLI ELABORATI SCRITTI E DEI TEST OGGETTIVI: entro 15 giorni.
 LATINO E GRECO TEST D INGRESSO Non essendovi prerequisiti specifici, il test d ingresso è quello già somministrato per italiano. OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL BIENNIO CONOSCENZE: - Morfologia (articolo per
LATINO E GRECO TEST D INGRESSO Non essendovi prerequisiti specifici, il test d ingresso è quello già somministrato per italiano. OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL BIENNIO CONOSCENZE: - Morfologia (articolo per
CLASSE SECONDA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ITALIANO A) ASCOLTARE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA ITALIANO A) ASCOLTARE 1 1. Ascoltare e comprendere vari messaggi 1. Ascoltare messaggi orali di vario genere e individuare l'argomento centrale 2. Ascoltare
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA ITALIANO A) ASCOLTARE 1 1. Ascoltare e comprendere vari messaggi 1. Ascoltare messaggi orali di vario genere e individuare l'argomento centrale 2. Ascoltare
Tipologia di prova per il recupero dell insufficienza rilevata nel I trimestre: prova strutturata di grammatica, produzione scritta.
 Liceo Linguistico C. Livi Lingua e cultura francese Attività di recupero per le classi prime a.s. 2018-19 Le attività di recupero di lingua e cultura francese avranno come punto di riferimento per le classi
Liceo Linguistico C. Livi Lingua e cultura francese Attività di recupero per le classi prime a.s. 2018-19 Le attività di recupero di lingua e cultura francese avranno come punto di riferimento per le classi
PIANO DI LAVORO ANNUALE
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA Via Ada Negri, 14 10024 MONCALIERI (TO) Codice fiscale 84511990016 Sezione Liceale E.Majorana Sezione Tecnico Economica Scientifico - Linguistico A.Marro Via Ada
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA Via Ada Negri, 14 10024 MONCALIERI (TO) Codice fiscale 84511990016 Sezione Liceale E.Majorana Sezione Tecnico Economica Scientifico - Linguistico A.Marro Via Ada
Programmazione curricolare d istituto
 Programmazione curricolare d istituto DISCIPLINA: Lingua tedesca COMPETENZE 1. Ascoltare e comprendere in modo globale la lingua orale e scritta 2. Esprimersi in modo appropriato nell interazione e nella
Programmazione curricolare d istituto DISCIPLINA: Lingua tedesca COMPETENZE 1. Ascoltare e comprendere in modo globale la lingua orale e scritta 2. Esprimersi in modo appropriato nell interazione e nella
Liceo Scientifico Statale Federico II di Svevia
 Liceo Scientifico Statale Federico II di Svevia PIANO DI LAVORO Materia d insegnamento LINGUA E CULTURA LATINA Classe I B S anno scolastico 2018-2019 Prof.ssa : Maria Rosaria MONACO FINALITA L insegnamento
Liceo Scientifico Statale Federico II di Svevia PIANO DI LAVORO Materia d insegnamento LINGUA E CULTURA LATINA Classe I B S anno scolastico 2018-2019 Prof.ssa : Maria Rosaria MONACO FINALITA L insegnamento
Istituto Comprensivo di Cologna Veneta Curricolo Scuola Primaria
 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni, di classe o di gruppi) con compagni e insegnanti rispettando
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni, di classe o di gruppi) con compagni e insegnanti rispettando
TRACCIA PER LA BIOGRAFIA SCOLASTICA E LINGUISTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI IN USCITA
 TRACCIA PER LA BIOGRAFIA SCOLASTICA E LINGUISTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI IN USCITA Anno scolastico ( Classe quinta Scuola Primaria e Classe terza Scuola Secondaria di primo grado) Dati personali - Cognome:..
TRACCIA PER LA BIOGRAFIA SCOLASTICA E LINGUISTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI IN USCITA Anno scolastico ( Classe quinta Scuola Primaria e Classe terza Scuola Secondaria di primo grado) Dati personali - Cognome:..
La tipologia e gli universali
 La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
ITALIANO A. S. 2018/2019
 A. S. 2018/2019 Ascoltare in modo attivo e comprendere l argomento di una conversazione. Ascoltare in modo attivo e comprendere l oggetto e le diverse argomentazioni di una discussione. Ascoltare in modo
A. S. 2018/2019 Ascoltare in modo attivo e comprendere l argomento di una conversazione. Ascoltare in modo attivo e comprendere l oggetto e le diverse argomentazioni di una discussione. Ascoltare in modo
DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE
 DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE PREMESSA Il Curricolo di lingua straniera attualmente in uso nel nostro circolo è stato elaborato tenendo presenti le indicazioni del Progetto
DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE PREMESSA Il Curricolo di lingua straniera attualmente in uso nel nostro circolo è stato elaborato tenendo presenti le indicazioni del Progetto
AREA LINGUISTICA : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE 1^ FRANCESE
 AREA LINGUISTICA : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE 1^ FRANCESE Legenda: A = Ascolto ( comrensione orale ) P = Parlato ( produzione e interazione orale ) L = Lettura ( comprensione scritta ) S =
AREA LINGUISTICA : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE 1^ FRANCESE Legenda: A = Ascolto ( comrensione orale ) P = Parlato ( produzione e interazione orale ) L = Lettura ( comprensione scritta ) S =
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 CURRICOLO DI FRANCESE SPAGNOLO CLASSE PRIMA TRAGUARDI DI COMPETENZA Comprendere il significato globale di un breve e semplice messaggio orale e riconoscere in esso informazioni utili. NUCLEI TEMATICI ASCOLTO
CURRICOLO DI FRANCESE SPAGNOLO CLASSE PRIMA TRAGUARDI DI COMPETENZA Comprendere il significato globale di un breve e semplice messaggio orale e riconoscere in esso informazioni utili. NUCLEI TEMATICI ASCOLTO
LE COMPETENZE CHIAVE PER L APPRENDIMENTO PERMANENTE
 FRANCESE LE COMPETENZE CHIAVE PER L APPRENDIMENTO PERMANENTE L intero iter scolastico ha come finalità il raggiungimento delle seguenti competenze definite dal Parlamento e dal Consiglio dell Unione Europea
FRANCESE LE COMPETENZE CHIAVE PER L APPRENDIMENTO PERMANENTE L intero iter scolastico ha come finalità il raggiungimento delle seguenti competenze definite dal Parlamento e dal Consiglio dell Unione Europea
SCHEDA CONSUNTIVA PROGETTO
 SCHEDA CONSUNTIVA PROGETTO Anno scolastico 2016/2017 Progetto CORSO DI LINGUA TEDESCA (PER ADULTI) Referente SANTARPIA PAOLA Il progetto continua il prossimo anno scolastico SI NO Il progetto verrà riproposto
SCHEDA CONSUNTIVA PROGETTO Anno scolastico 2016/2017 Progetto CORSO DI LINGUA TEDESCA (PER ADULTI) Referente SANTARPIA PAOLA Il progetto continua il prossimo anno scolastico SI NO Il progetto verrà riproposto
