4-5 RIVISTA BANCARIA. Luglio-Ottobre 2012 MINERVA BANCARIA ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» N. 4-5/2012.
|
|
|
- Berta Puglisi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 MINERVA BANCARIA RIVISTA BANCARIA N. 4-5/2012 RIVISTA BANCARIA ANNO LXVIII ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» Luglio-Ottobre 2012 Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento Postale-70%-DCB Roma 4-5
2 RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA COMITATO SCIENTIFICO (Editorial board) PRESIDENTE (Editor): GIORGIO DI GIORGIO, Università LUISS - Guido Carli, Roma MEMBRI DEL COMITATO (Associate Editors): ADALBERTO ALBERICI, Università di Milano PIETRO ALESSANDRINI, Università Politecnica delle Marche PAOLO ANGELINI, Banca d Italia PIERFRANCESCO ASSO, Università di Palermo CONCETTA BRESCIA MORRA, Università del Sannio FRANCESCO CANNATA, Banca d Italia ALESSANDRO CARRETTA, Università di Roma, Tor Vergata NICOLA CETORELLI, Federal Reserve Bank of New York FABIANO COLOMBINI, Università di Pisa MARIO COMANA, Università LUISS Guido Carli Roma RITA D ECCLESIA, Università di Roma, Sapienza GIAMPAOLO DELL ARICCIA, International Monetary Fund GIANNI DE NICOLÒ, International Monetary Fund CARMINE DI NOIA, Assonime LUCA ENRIQUES, Consob GIOVANNI FERRI, Università di Bari LUCA FIORITO, Università di Palermo MICHELE FRATIANNI, Indiana University EUGENIO GAIOTTI, Banca d Italia GUR HUBERMANN, Columbia University DONATO MASCIANDARO, Università Bocconi, Milano FABRIZIO MATTESINI, Università di Roma, Tor Vergata PINA MURÈ, Università di Roma, Sapienza FABIO PANETTA, Banca d Italia ALBERTO FRANCO POZZOLO, Università del Molise ZENO ROTONDI, Unicredit Group ANDREA SIRONI, Università Bocconi, Milano MARIO STELLA RICHTER, Università di Roma, Tor Vergata MARTI SUBRAHMANYAM, New York University ALBERTO ZAZZARO, Università Politecnica delle Marche COMITATO ACCETTAZIONE SAGGI E CONTRIBUTI: GIORGIO DI GIORGIO (editor in chief) - ALBERTO POZZOLO (co-editor) MARIO STELLA RICHTER (co-editor) - DOMENICO CURCIO (assistant editor) ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» PRESIDENTE CLAUDIO CHIACCHIERINI CONSIGLIO CARLO BELLINI, TANCREDI BIANCHI, MARIO CATALDO, GIAN GIACOMO FAVERIO, ANTONIO FAZIO, GIUSEPPE GUARINO, ANTONIO MARZANO, PINA MURÈ, FULVIO MILANO, GIOVANNI PARRILLO, CARLO SALVATORI, MARIO SARCINELLI, FRANCO VARETTO Segretario LUIGI BELLINI In copertina: Un banchiere e sua moglie di Marinus Van Reymerswaele (1493 c ) Musée des Beaux Arts - Nantes
3 RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA ANNO LXVIII (NUOVA SERIE) LUGLIO-OTTOBRE 2012 N.4-5 SOMMARIO Editoriale G. DI GIORGIO Verso l Unione bancaria europea.» 3 Contributi M. MILIČ La remunerazione degli amministratori in Europa: l intervento del legislatore tedesco» 7 A. IANNUZZI Soundness e disclosure dei sistemi di remunerazione nelle banche: alcune evidenze empiriche nei gruppi bancari quotati italiani» 47 V. PACELLI Normativa e contesto congiunturale: quali impulsi S. SYLOS LABINI nella gestione delle relazioni di clientela per le banche locali?» 89 Rubriche La distribuzione dei prodotti finanziari in Europa (D. Curcio - M. Donadelli - D. Frigeri)» 113 L embedded risk management, ovvero il pieno utilizzo gestionale delle stime di rischio (M. Berlanda)» 122 I project bond come strumento di rilancio dell economia (F. Capponi - R. Moscaroli)» 132 Bankpedia: Fair value nei bilanci che adottano gli IAS/IFRS (G. Vittorioso e S. Anchino); Interlocking (divieto di) (M. Monaco Sorge)» 136 Presidente del Comitato Scientifico: Giorgio Di Giorgio Direttore Responsabile: Giovanni Parrillo Comitato di Redazione: Eloisa Campioni, Mario Cataldo, Vincenzo Formisano, Stefano Marzioni, Biancamaria Raganelli, Giovanni Scanagatta, Giuseppe Zito e.mail: redazione@rivistabancaria.it - amministrazione@rivistabancaria.it Amministrazione: presso P&B Gestioni Srl, Via G. Severano Roma - tel fax Spedizione in abbonamento postale - Pubblicazione bimestrale - 70% - Roma ISSN: Econ.Lit
4 , IL DIZIONARIO ENCICLOPEDICO ON-LINE DI BANCA, BORSA E FINANZA (*) VOCI PUBBLICATE 1. Fair value nei bilanci che adottano gli IAS/IFRS, di G. Vittorioso e S. Anchino 2. Interlocking (divieto di), di M. Monaco Sorge *** 1. Fair value nei bilanci che adottano gli IAS/IFRS 1. (G. Vittorioso e S. Anchino) Nei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) il fair value viene definito come il corrispettivo al quale un attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. 1 Esso costituisce il valore al quale talune attività e passività vengono iscritte e valutate nei bilanci. I principi contabili internazionali che prevedono l uso del fair value quale regola di valutazione sono, ad esempio, lo IAS 18 Ricavi, lo IAS 19 Benefici per i dipendenti, lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, lo IAS 40 Investimenti Immobiliari, lo IAS 41 Agricoltura, e l IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. In generale i modelli di valutazione previsti dai principi IAS/IFRS si distinguono in modelli basati sul costo storico (cost model) e modelli basati sui valori cor- * Vengono pubblicate sulla Rivista Bancaria - Minerva Bancaria alcune voci del progetto Bankpedia, il Dizionario Enciclopedico on-line di Banca, Borsa e Finanza sponsorizzato dall Associazione Nazionale per l Enciclopedia della Banca e della Borsa (ASSONEBB) di Roma. 1 Il paragrafo 9 dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione fornisce la seguente definizione di fair value: the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm s lenght transaction. Nell ambito del progetto di revisione dello IAS 39 è stata introdotta dall International Accounting Standard Board nell Exposure Draft n.2009/5 (emesso nel maggio 2009) una nuova definizione di fair value che tende a far coincidere lo stesso con un prezzo d uscita, direttamente osservabile o stimato usando una tecnica valutativa, in una transazione ordinaria tra partecipanti al mercato. In particolare l ED 2009/5 identifica il fair value degli strumenti finanziari come il prezzo che verrebbe ricevuto per la vendita di un attività o pagato per trasferire una passività nel mercato più vantaggioso alla data di misurazione. 136
5 renti (fair value model). Il primo tipo di modello prevede la valutazione di attività e passività di bilancio al costo storico, detratti gli ammortamenti, le svalutazioni e le perdite da impairment; il secondo modello prevede che le attività e le passività siano esposte in bilancio al fair value della data alla quale il bilancio si riferisce. Nell ambito dei cost model il fair value rileva nelle seguenti circostanze: a) alla data di effettuazione dell operazione (transaction date), b) alla data di transizione per determinare i deemed cost, c) alla data di bilancio per valutare se esistono condizioni di impairment e di conseguenza l importo dell eventuale perdita da impairment. a) Il fair value alla transaction date viene infatti utilizzato per determinare il costo di rilevazione iniziale nei casi di: - pagamenti basati su azioni (share-based payments - IFRS 2); - determinazione del valore delle attività immateriali e dell avviamento in sede di attribuzione del prezzo d acquisto nelle aggregazioni aziendali (purchase price allocation - IFRS 3) - attività e passività acquisite in un aggregazione aziendale (acquired assets and liabilities in business combinations - IFRS 3); - leasing finanziari (IAS 17) - attività e passività finanziarie (IAS 39) - altri scambi di attività o passività (IAS 16, IAS 18, IAS 38 etc.) - distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide (IFRIC 17) L uso del fair value alla transaction date è inoltre previsto per determinare il valore di iscrizione delle componenti di transazioni complesse quali: ricavi e costi da transazioni composte da diversi elementi (es: vendita con dilazione di pagamento senza interessi - IAS 18), strumenti derivati incorporati in un contratto combinato (cosiddetto strumento ibrido - IAS 39), ricavi da servizi di costruzione su servizi in concessione (IFRIC 12). b) Il fair value può essere utilizzato in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS, con riferimento alla data di transizione dai principi nazionali agli IAS/IFRS o ad una data precedente, per determinare il cosiddetto costo stimato (deemed cost) dei beni strumentali. La transizione dai principi nazionali ai principi contabili internazionali richiederebbe infatti l applicazione retroattiva delle disposizioni previste dagli IAS 16, IAS 17, IAS 23, IAS 40 e IAS 27 in tema di iscrizione delle attività materiali, immateriali, investimenti in immobili e partecipazioni. L IFRS 1 permette di utilizzare quale costo che si sarebbe avuto applicando i principi contabili internazionali con effetti retroattivi un valore di costo che può coincidere con il fair value del bene; tale valore sostituisce quindi il costo storico (o del costo ammortizzato ad una certa data) di alcuni elementi dell attivo patrimoniale di apertura. c) Il fair value è inoltre il termine al quale raffrontare il valore contabile iscritto in bilancio nella procedura di impairment test al fine di stimare il valore recuperabile di un attività, secondo lo schema illustrato nella seguente tabella: RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5/
6 Tipologia di attività Immmobili, impianti e macchinari, immobilizzazioni immateriali, goodwill Attività non correnti detenute per la vendita Investimenti azionari ed altri detenuti per il trading e attività finanziarie available-for-sale Recoverable amount (valore recuperabile) Maggiore tra valore d uso e fair value al netto dei costi di vendita. (IAS 36) Fair value meno i costi di vendita (IFRS 5) Fair value (IAS 39) Per completezza si osserva che nell impairment test, oltre al fair value, vengono utilizzati per i prestiti e crediti detenuti a scadenza il valore attuale dei futuri flussi all originario tasso di interesse effettivo (IAS 39) e per le rimanenze il valore di netto realizzo (IAS 2). L utilizzo di valutazioni basate sul fair value model è obbligatorio per le voci di bilancio quali i derivati, la maggior parte degli investimenti in equity, altre attività e passività detenute per il trading, gli item oggetto di fair value hedge, i piani pensione a benefici definiti, alcune attività biologiche (animali e piante viventi). L utilizzo del fair value è facoltativo per gli investimenti immobiliari (IAS 40) e, in casi poco diffusi, per gli impianti e macchinari (IAS 16), immobilizzazioni immobiliari (IAS 38) (per le valutazioni di mercato attivo) prestiti e crediti e debiti emessi e altre passività finanziarie (IAS 39). I principi IAS/IFRS richiedono che le imprese forniscano nelle note al bilancio informazioni in merito al fair value corrente alla data di bilancio degli immobili misurati utilizzando il modello del costo e delle attività finanziarie e delle passività finanziare misurate utilizzando il costo ammortizzato. Le variazioni di fair value registrate nell ambito dei modelli basati sul fair value vengono iscritte nella sezione Others Comprehensive Income 2 del bilancio se derivano da variazioni di valore di immobili, impianti e macchinari, attività finanziarie disponibili per la vendita; le variazioni di fair value vengono registrate in conto economico e contribuiscono all utile o alla perdita dell esercizio se costituiscono la contropartita della valutazione di derivati, attività finanziarie destinate alla negoziazione, altri item per cui è stata esercitata l opzione al fair value, immobili detenuti per l investimento, attività biologiche e prodotti agricoli. È da evidenziare che, diversamente dai modelli basati sul costo, le valutazioni al fair value consentono l iscrizione di plusvalenze che non sono ancora realizzate e conferiscono al reddito una maggiore volatilità e incertezza. Al riguardo, in sede di recepimento dei principi contabili internazionali nel nostro ordinamento, si è posto il problema di evitare che l applicazione del fair value potesse dar vita alla distribuzione o comunque all utilizzo di utili non realizzati e per lo più incerti. Il D. Lgs. 38/2005 ha introdotto la previsione di riserve formate dai plusvalori de- 2 Lo IAS 1 (rivisto nel 2007, entrato in vigore per gli esercizi successivi al 01/01/2009) ha modificato la struttura di conto economico introducendo un prospetto che contiene sia i costi e i ricavi che rappresentano l utile o la perdita dell esercizio, sia i costi e i ricavi che sono stati imputati direttamente nel patrimonio netto. Il nuovo prospetto può essere presentato secondo due modalità: un unico prospetto di tutte le voci di costo e di ricavo, con un apposita sezione per gli altri componenti del conto economico complessivo oppure mediante due prospetti distinti. 138 RUBRICHE
7 rivanti dall applicazione del fair value, che in linea generale sono indisponibili. Tale indisponibilità si sostanzia nel divieto di distribuire le suddette plusvalenze fino al momento del loro effettivo realizzo e nell impossibilità di utilizzarle per l aumento del capitale sociale o per altre operazioni aventi effetti equivalenti. L applicazione del fair value nell attuale contesto di crisi dei mercati finanziari ha fatto emergere quale effetto rilevante l amplificazione dei risultati negativi derivanti da minusvalenze su attività valutate a prezzi di mercato (il cosiddetto fenomeno della prociclicità). Le attuali regole tendono infatti ad amplificare i redditi nei periodi positivi del ciclo economico e a deprimere i risultati nei periodi di rallentamento dell economia. Un tale approccio comporta la volatilità dei patrimoni aziendali che in alcuni settori (come quello bancario) può far sorgere problemi di stabilità e patrimonializzazione. Al riguardo riveste un ruolo centrale la valutazione degli strumenti finanziari. In relazione alla valutazione degli strumenti finanziari e derivati la complessa disciplina di contabilizzazione è contenuta negli IAS 32 e 39. Tali principi, dopo aver fornito le definizioni di strumento finanziario e strumento derivato e aver circoscritto l ambito di applicazione della disciplina mediante la previsione di una serie di attività finanziarie cui non si applica lo IAS 39, stabiliscono che la rilevazione iniziale di tali cespiti debba avvenire al fair value, corrispondente al corrispettivo dato in cambio. Dunque la prima rilevazione deve effettuarsi al costo, che si specifica deve esser comprensivo delle spese di transazione. La differenza rispetto alla disciplina nazionale riguarda invece i criteri di valutazione utilizzabili nelle contabilizzazioni successive; il paragrafo 46 dello IAS 39 stabilisce i seguenti criteri: - per gli strumenti rilevati al fair value a conto economico (cosiddetti held for trading): fair value; - per gli investimenti posseduti fino a scadenza (cosiddetti held to maturity): costo ammortizzato 3 ; - per finanziamenti e crediti originati non a scopo di trading: costo ammortizzato; - per le attività finanziarie disponibili per la vendita (cosiddetti available for sale): fair value. È infine stabilito che nel caso di perdita durevole di valore, ossia se il valore contabile dell attività è maggiore del suo valore di realizzo stimato, deve operarsi una riduzione corrispondente del suo valore contabile. Sul tema della prociclicità, i paesi del G20 hanno formulato raccomandazioni al Financial Stability Forum ed altri gruppi internazionali (in particolare BCBS-Basel Committee on Banking Supervision) affinché vengano sviluppati ed implementati nell attività di vigilanza e di regolamentazione degli approcci finalizzati a mitigare la prociclicità del sistema finanziario promuovendo la costituzione di riserve nelle fasi di espansione. In ambito europeo è in corso il dibattito circa gli elementi di prociclicità connessi al bilancio, ed in particolare è oggetto di discussione la proposta che in sede di redazione dei conti vengano effettuati accantonamenti aggiuntivi nella fase di espansione economica per far fronte alle perdite che possono manifestarsi nelle fasi di recessione dei mercati. Tale tecnica, definita dynamic provisioning, è stata sviluppata soprattutto in Spagna. Sulla base 3 Per costo ammortizzato si intende il valore cui è stata effettuata la prima contabilizzazione rettificato ad opera delle seguenti rilevazioni successive: rimborsi di capitale, ammortamento complessivo calcolato come differenza tra valore iniziale e quello alla scadenza, svalutazione derivante da riduzione durevole di valore, insolvenza. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5/
8 di questo modello verrebbero rilevati in bilancio ulteriori accantonamenti calcolati sulla base di indici sintetici, pubblicati dalle autorità locali, calcolati in base all andamento del ciclo economico in cui l impresa si trova ad operare. Ancorché tale modello sia stato suggerito da più parti, lo IASB ha proposto nell Exposure Draft Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment un diverso modello di rilevazione delle perdite di valore degli strumenti finanziari basato sulle perdite attese su tali strumenti (expected loss). Secondo lo standard setter, infatti, tale modello ha il pregio di superare diversi limiti evidenziati dal modello attualmente previsto dallo IAS 39 e basato sulle perdite incorse (incurred loss). Il processo di revisione delle attuali norme che disciplinano la valutazione degli strumenti finanziari, ed in particolare il fair value, è tuttora in corso. Al fine di fornire informazioni in grado di illustrare l esposizione ai rischi finanziari assume notevole rilevanza l informativa fornita dalle imprese in merito alla valutazione al fair value degli strumenti finanziari. Tale tema è stato oggetto, sia in ambito europeo sia nazionale, di specifiche iniziative 4. Nel marzo 2009 lo IASB ha emesso un emendamento all IFRS 7 introducendo una serie di modifiche volte a dare adeguata risposta alle esigenze di maggiore trasparenza suscitate dalla crisi finanziaria e connesse con l elevata incertezza dei prezzi espressi dal mercato. Tra tali modifiche rileva l istituzione della c.d. gerarchia del fair value. In particolare, l emendamento definisce tre livelli di fair value (IFRS 7, par. 27A): livello 1: se lo strumento finanziario è quotato in un mercato attivo; livello 2: se il fair value è misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario; livello 3: se il fair value è calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri non osservabili sul mercato. L emendamento all IFRS 7 è stato recepito in ambito europeo con il Regolamento (CE) n del 27 novembre 2009 della Commissione. La corretta individuazione del livello di fair value al quale riferire la valutazione dell intero strumento finanziario richiede un attenta ponderazione, da parte delle società, della rilevanza degli input utilizzati nella valutazione. Ad esempio, se il fair value è stimato utilizzando dati di mercato (diversi dalle quotazioni rilevate su un mercato attivo) che richiedono, tuttavia, un significativo aggiustamento basato su dati non osservabili sul mercato, tale misurazione rientra nel livello 3. Per tale ragione è fondamentale fornire nelle note al bilancio un adeguata informativa sui metodi e 4 Il CESR ha pubblicato nel 2008 e 2009 dei documenti contenenti un analisi compiuta sull uso dell opzione della riclassificazione degli strumenti finanziari prevista dallo IAS 39 con riferimento ai bilanci 2008 e 2009 ( CESR Statement on re-classifications ) nonché, nel 2009, il documento CESR statement on the Application of Disclosure Requirements related to financial instruments in 2008 financial statements relativo ad un indagine in merito alla disclosure fornita nei conti 2008 dalle società quotate europee nell area dei rischi e delle incertezze relative agli strumenti finanziari. In Italia, Banca d Italia, Consob, Isvap hanno emanato il Documento n. 4 Esercizi 2009 e Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sugli impairment test, sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla Gerarchia del fair value, per richiamare l attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo delle società e dei dirigenti preposti sulla necessità di garantire un adeguata informativa dell impatto della crisi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria nella convinzione che una appropriata trasparenza informativa contribuisce a ridurre l incertezza e le sue conseguenze negative. 140 RUBRICHE
9 sulle assunzioni utilizzate per stimare il fair value nonché su eventuali modifiche nelle tecniche valutative rispetto al periodo precedente (cfr. IFRS 7, par. 27). In tema di valutazione del fair value degli strumenti finanziari è da evidenziare che lo IAS 39 9 definisce il fair value come il corrispettivo al quale un attività può essere cambiata o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. Per i criteri di determinazione del fair value, occorre far riferimento ai paragrafi dello IAS 39 AG69-AG82 secondo i quali, sottostante la definizione di fair value c è la presunzione che l impresa si trovi nel normale esercizio della sua attività senza alcuna intenzione di liquidare i propri beni, di ridurre in via significativa il livello delle proprie attività ovvero di procedere alla definizione di transazioni a condizioni sfavorevoli. Il fair value non deve tener conto di situazioni di bisogno dell impresa venditrice che possono indurla a cedere lo strumento a condizioni potenzialmente sfavorevoli. Altro aspetto rilevante nella citata definizione riguarda l esigenza di neutralità e di trasparenza nello scambio confermata dal richiamo alla necessità che la transazione avvenga tra soggetti indipendenti e dalla presenza dell ulteriore condizione che le parti dispongano di sufficienti informazioni in merito alle condizioni e caratteristiche dell oggetto della transazione, ai suoi impieghi effettivi e potenziali ed alla situazione del mercato alla data della valutazione. Al fine di determinare il fair value che maggiormente esprime il valore di mercato insito in una transazione libera e fra controparti indipendenti, lo IAS 39 presuppone la seguente gerarchia di fonti/metodologie utilizzabili: 1. il fair value deve essere valutabile attendibilmente facendo riferimento, in primis, ai prezzi di mercato per tutti gli strumenti trattati su mercati attivi. In linea generale, un mercato può essere definito attivo se gli strumenti in esso negoziati risultano sufficientemente liquidi. Per valutare la liquidità di un mercato o di uno specifico strumento finanziario occorre considerare i seguenti fattori: l ampiezza, cioè la presenza di numerosi operatori; lo spessore, cioè cadute di domanda e offerta in presenza di forti oscillazioni di prezzo; l elasticità, cioè la velocità di reazione di domanda e offerta alle variazioni di prezzo; i costi di smobilizzo, rappresentati da commissioni, differenze denaro-lettera, ecc. Il fair value di uno strumento finanziario deve rappresentare il prezzo al quale esso verrebbe scambiato alla data di bilancio sul mercato considerato più vantaggioso, al quale l impresa ha immediato accesso. L esistenza di quotazioni pubbliche in un mercato attivo è la migliore rappresentazione del fair value e, quando esistono, sono da utilizzare per valutare un attività od una passività finanziaria. Lo IAS 39 specifica che, in presenza di quotazioni di mercato rappresentative del fair value, l appropriato prezzo per un attività posseduta o per una passività che deve essere emessa solitamente è il prezzo di offerta (bid), mentre per un attività che deve essere acquistata o per una passività posseduta è il prezzo richiesto (offer). Le quotazioni di mercato sono fissate dagli operatori che determinano i prezzi denaro ed i prezzi lettera, cioè rispettivamente il prezzo al quale sono disposti ad acquistare e a vendere i beni oggetto di quotazione. Pertanto, si richiede che il soggetto detentore (cessionario) valuti la posizione non in base al proprio prezzo lettera (denaro), cioè al prezzo al quale offre di vendere (comprare), ma al prezzo denaro (lettera) degli altri operatori, cioè al RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5/
10 prezzo al quale altri dichiarano di voler acquistare (vendere). In questo modo, prudenzialmente non si tiene conto, nella valutazione, del differenziale che una delle parti della transazione è in grado di spuntare. In subordine - e qualora ci si trovi di fronte a strumenti scomponibili per i quali sia possibile individuare i valori di mercato delle singole componenti - si dovrà procedere alla scomposizione dello strumento e utilizzare i valori di mercato delle singole componenti per la definizione del fair value complessivo. Qualora, ancora, lo strumento non sia scomponibile, ovvero non sia possibile determinare un valore di mercato per una parte significativa di componenti, si potrà procedere ad analisi comparative utilizzando i valori di mercato di strumenti analoghi; 2. nel caso di assenza di un mercato attivo l impresa dovrà far riferimento a modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati a condizione che tali tecniche e modelli di valutazione conducano comunque ad una ragionevole approssimazione del valore di mercato; 3. infine, nel caso eccezionale in cui non sia possibile individuare in maniera attendibile il fair value degli strumenti finanziari seguendo la gerarchia sopra riportata (prezzi di mercato, comparazioni, e soprattutto, tecniche di valutazione) lo IAS 39, che comunque presuppone che un impresa sia sempre in grado di valutare uno strumento finanziario posseduto o emesso, prevede una deroga con riferimento a strumenti rappresentativi di capitale ed a contratti derivati correlati a titoli azionari che non hanno un prezzo rilevabile su un mercato attivo e per i quali esiste una gamma ampia di stime ragionevoli di fair value e l impresa non sia in grado di stabilire all interno della gamma il valore più corretto. Tali strumenti possono essere iscritti al costo con l obbligo di sottoporli all impairment test. Tuttavia le situazioni in cui l impresa non è in grado di stabilire il fair value dello strumento devono risultare eccezionali e la mancata rilevazione dello stesso deve essere adeguatamente motivata. Il fair value non include i costi che l impresa potrà/dovrà sostenere in sede di trasferimento o liquidazione dello strumento finanziario. Esaminando l applicazione del fair value ad altre voci di bilancio, diverse dagli strumenti finanziari, si possono formulare le seguenti osservazioni. Lo IAS 18 considera necessario che qualsiasi ricavo l impresa realizzi nel corso della sua attività sia esposto al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante (paragrafo 9 dello IAS 18); un entità può concedere al compratore un credito senza interessi o accettare un titolo di credito con un interesse minore di quello di mercato come corrispettivo della vendita di merci. Quando l accordo costituisce, di fatto, un operazione finanziaria, il fair value del corrispettivo è determinato scontando tutte le future entrate utilizzando un tasso di interesse figurativo. Il tasso di interesse figurativo è quello più distintamente identificabile fra: a) il tasso prevalente per uno strumento simile di un emittente con una situazione finanziaria simile; o b) un tasso di interesse che sconti il valore nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per pagamento in contanti delle merci o dei servizi. La differenza tra il fair value al quale viene rilevato il ricavo e il valore nominale del corrispettivo è rilevata come interessi attivi da contabilizzare per competenza (secondo quanto previsto dai paragrafi 29 e 30 in conformità a ciò che è disposto dallo IAS 39). In tema di rimanenze, il criterio di valutazione di riferimento è invece quello del valore di netto realizzo. Al riguardo lo IAS 2 (paragrafo 7) precisa che il valore netto di 142 RUBRICHE
11 realizzo per le rimanenze può non essere uguale al fair value al netto dei costi di vendita. Il fair value riflette, infatti, l importo per il quale la stessa rimanenza potrebbe essere scambiata tra compratori e venditori consapevoli e disponibili sul mercato e pertanto è un valore generalmente rilevabile esternamente. Il valore netto di realizzo è un valore specifico dell entità che redige il bilancio e fa riferimento all importo netto che l entità si aspetta di realizzare dalla vendita delle rimanenze nel normale svolgimento dell attività. In merito alle immobilizzazioni materiali, lo IAS 16 prevede che per i beni strumentali un impresa scelga tra il criterio di valutazione del costo e il modello rivalutato. In base al primo criterio, le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, successivamente rettificato per tener conto di ammortamenti, perdite di valore, ripristini di valore. Se il fair value di una immobilizzazione materiale è quantificabile in modo attendibile è possibile adottare il criterio di valutazione del costo rivalutato, per il quale il valore dell attività sarà rivalutato in modo da portarlo a un valore pari al fair value alla data di rivalutazione meno gli ammortamenti accumulati e le eventuali perdite di valore. Il fair value di terreni ed edifici è in genere rappresentato dal valore di mercato determinato mediante una perizia redatta da professionisti qualificati. Il fair value degli impianti e macchinari è rappresentato solitamente dal valore di mercato determinato da una perizia; quando il valore di mercato non è disponibile l impresa stima il fair value mediante il metodo del costo di sostituzione o l approccio economico. La rivalutazione di un elemento di immobili, impianti o macchinari determina che l intera classe di immobili, impianti e macchinari alla quale l asset rivalutato appartiene venga rivalutata. In relazione agli investimenti immobiliari lo IAS 40 prevede che la valutazione iniziale venga effettuata utilizzando il criterio del costo, ma nelle contabilizzazioni successive viene concessa all impresa la facoltà di scegliere se continuare ad applicare il criterio del costo o se effettuare una valutazione al fair value. Inoltre, laddove l impresa opti per la valutazione al costo, è prescritta l indicazione nelle note a bilancio del valore corrispondente al fair value. Per quanto riguarda gli oneri pluriennali, per i soli costi di sviluppo aventi utilità pluriennale comprovata 5, lo IAS 38 prevede la possibilità di contabilizzarli secondo il valore recuperabile dalle at- 5 Al riguardo lo IAS 38 prescrive una serie di condizioni necessarie, la cui mancanza preclude la possibilità di iscrivere all attivo di stato patrimoniale i costi di sviluppo. In particolare l impresa deve dimostrare: - l intenzione dell impresa di completare l attività immateriale per l uso o la vendita; - la possibilità tecnica di completare l attività immateriale in modo che essa sia disponibile per l uso o la vendita; - la capacità di usare o vendere l attività immateriale; - le modalità mediante le quali l attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri; - la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l utilizzo o la vendita dell attività immateriale; - la capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all attività immateriale durante il suo sviluppo. Tutti i restanti oneri pluriennali, quali i costi di ricerca, i costi di impianto e di ampliamento, i costi di formazione e di pubblicità, nonché i costi di sviluppo che non rispettano i suddetti requisiti, devono invece iscritti in conto economico, senza alcuna possibilità di capitalizzarli. Si osserva che mentre lo IAS 38 stabilisce che al ricorrere delle condizioni richieste sorge l obbligo di capitalizzare il costo, secondo la normativa nazionale, anche in presenza di tutte le condizioni per l iscrizione, è comunque lasciato alla discrezionalità dell impresa la scelta se iscrivere il costo all attivo di stato patrimoniale o tra i costi di conto economico. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5/
12 tività immateriali generate. Per quanto riguarda il TFR, lo IAS 19 prevede che l impresa in ogni bilancio determini, con l utilizzo di tecniche attuariali e in modo affidabile l ammontare dei benefici maturati dai dipendenti in relazione sia all esercizio corrente che a quelli precedenti. L IFRIC 14 ha assimilato il TFR a un beneficio successivo al rapporto di lavoro classificabile all interno dei cosiddetti piani a benefici definiti, pertanto nella stima deve tenersi conto anche delle variabili sia demografiche (mortalità e rotazione dei dipendenti) che finanziarie (i futuri incrementi retributivi) e della loro influenza sull ammontare delle quote di TFR che matureranno negli esercizi successivi. Per quanto attiene ai prodotti agricoli e biologici, lo IAS 41 prevede che le stesse siano iscritte inizialmente e successivamente valutate al fair value, eccetto casi in cui non sia misurabile attendibilmente. La nozione di fair value è la medesima di altri principi anche se con alcune specificità legate alle condizioni e al luogo in cui i beni si trovano al momento della valutazione. 2. Interlocking (divieto di) (M. Monaco Sorge) Divieto di cumulo di incarichi nel settore bancario, finanziario e assicurativo (c.d. divieto di interlocking ) Il 26 Aprile 2012 è entrato il vigore l articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. Salva Italia ) convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n L art. 36 Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari stabilisce il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese, o gruppi di imprese, concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto di interlocking ), come di seguito specificato. La Banca d Italia, la Consob e l Isvap hanno emanato, in un documento congiunto, i criteri applicativi dell art.36 in attesa di ulteriori chiarimenti normativi. Questi criteri sono stati elaborati nell ambito di un tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze; l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fornito la propria collaborazione e ha condiviso i suddetti criteri applicativi. Il divieto di cumulo deve intendersi tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione (incluso consiglio di gestione o sorveglianza), nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (amministratore con sindaco, o amministratore con consigliere di sorveglianza e così via) ivi incluse le cariche analoghe (quindi anche quelle non esecutive e di controllo) ed i funzionari di vertice (direttori generali e, nelle società quotate anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari previsti dall art. 154-bis TUF). Il divieto non si applica agli incarichi di sindaco supplente fintanto che permanga la supplenza e non venga quindi effettivamente esercitato l incarico. La normativa considera concorrenti le imprese operanti nei mercati del credito (banche), assicurativi (compagnie di assicurazione e di riassicurazione), e finanziari (Sim, Sgr, Sicav, intermediari finanziari ex titolo V del TUB e relative società capogruppo, istituti di pagamento, IMEL, Poste Italiane S.p.A. per l attività di Bancoposta, Cassa Depositi e Prestiti) sogget- 144 RUBRICHE
13 ti alle procedure di autorizzazione e di vigilanza ai sensi della normativa bancaria, finanziaria e assicurativa applicabile. Sono estranee al divieto le società che svolgono servizi accessori o strumentali. Rileva, inoltre, anche la dimensione delle imprese e/o dei gruppi di imprese: il divieto di interlocking opera per le cariche detenute in imprese con fatturato nazionale annuo di almeno 47 milioni. Per le banche e gli altri intermediari finanziari si intende come fatturato un decimo dell attivo dello stato patrimoniale esclusi i conti d ordine, e per le imprese di assicurazione i valori dei premi incassati. Tali criteri e valori sono calcolati ex legge 10 ottobre 1990 n. 287, come di seguito specificato. Il punto 2 dell art. 36, considerando l operatività nei medesimi mercati del prodotto e geografici, definisce il concetto di concorrenza e di assenza di controllo richiamando quanto previsto dall art. 7 Controllo della legge 10 ottobre n. 287 Norme a tutela della concorrenza e del mercato e per analogia anche le previsioni dell art c.c. Società controllate e società collegate. Inoltre si richiama l attenzione sulle previsioni ex art c.c. Divieto di concorrenza nonché sul Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (criterio 2.C.5) - il cui ultimo aggiornamento è stato presentato il 5 dicembre 2011 a Milano dal Comitato per la Corporate Governance. Se ne desume che il criterio di interlocking non si applica alle imprese tra cui intercorre un rapporto di controllo né alla cariche detenute nell impresa comune risultante da joint venture, né alle cariche assunte in società estere anche se operanti in Italia attraverso succursali; invece, il divieto si applica in caso di filiali italiane di società estere. Il punto 2-bis dell art. 36 stabilisce il termine di 90 giorni decorrente dalla nomina entro cui i titolari possono scegliere a quale carica incompatibile rinunciare. In difetto dell esercizio di tale opzione entro il suddetto termine, la normativa prevede la decadenza dall insieme delle cariche tra loro incompatibili con deliberazione degli organi competenti la quale dovrà essere adottata entro i successivi trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia, la decadenza verrà dichiarata dall Autorità di vigilanza competente nel settore. Infine, il punto 2-ter prevede che, in sede di prima applicazione, il suddetto termine di 90 giorni sia aumentato a 120, con decorrenza dall entrata in vigore della legge di conversione del decreto (26 Aprile 2012). Nelle situazioni di concorrenza sopravvenuta, la valutazione sull applicazione o meno del divieto di interlocking dovrà essere effettuata dai competenti organi aziendali con cadenza annuale sulla base dei dati risultanti dall ultimo bilancio. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5/
4-5 RIVISTA BANCARIA. Luglio-Ottobre 2012 MINERVA BANCARIA ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» N. 4-5/2012.
 www.rivistabancaria.it MINERVA BANCARIA RIVISTA BANCARIA N. 4-5/2012 RIVISTA BANCARIA ANNO LXVIII ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» Luglio-Ottobre 2012 Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane
www.rivistabancaria.it MINERVA BANCARIA RIVISTA BANCARIA N. 4-5/2012 RIVISTA BANCARIA ANNO LXVIII ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» Luglio-Ottobre 2012 Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane
RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA
 RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» www.rivistabancaria.it L eredità della crisi: stabilità ed efficienza come sfide per l euro. Atti del Convegno per il
RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» www.rivistabancaria.it L eredità della crisi: stabilità ed efficienza come sfide per l euro. Atti del Convegno per il
INDICE ANALITICO pag. XXIII IAS 1 - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO IAS 2 - RIMANENZE
 INDICE ANALITICO pag. XXIII IAS 1 - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 1.1. Premessa pag. 3 1.2. Finalità e definizioni pag. 4 1.2.1. Confronto con i Principi italiani pag. 5 1.3. Componenti del bilancio di esercizio
INDICE ANALITICO pag. XXIII IAS 1 - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 1.1. Premessa pag. 3 1.2. Finalità e definizioni pag. 4 1.2.1. Confronto con i Principi italiani pag. 5 1.3. Componenti del bilancio di esercizio
IFRS 7 Strumenti finanziari
 IFRS 7 Strumenti finanziari Principi contabili e informativa finanziaria a.a. 2009 2010 Prof. Sabrina Pucci 21/06/2011 1 Impostazione generale Il bilancio deve fornire indicazioni integrative che consentano
IFRS 7 Strumenti finanziari Principi contabili e informativa finanziaria a.a. 2009 2010 Prof. Sabrina Pucci 21/06/2011 1 Impostazione generale Il bilancio deve fornire indicazioni integrative che consentano
Economia e Performance dei Gruppi. Il bilancio consolidato di gruppo secondo i principi Ias/Ifrs
 Il bilancio consolidato di gruppo secondo i principi Ias/Ifrs Riferimenti normativi Ifrs 3 - «Aggregazioni aziendali»: riguarda la contabilizzazione dei processi di aggregazione e disciplina il trattamento
Il bilancio consolidato di gruppo secondo i principi Ias/Ifrs Riferimenti normativi Ifrs 3 - «Aggregazioni aziendali»: riguarda la contabilizzazione dei processi di aggregazione e disciplina il trattamento
Il Bilancio e i Principi Internazionali IAS-IFRS. Valentina Lazzarotti anno accademico
 Il Bilancio e i Principi Internazionali IAS-IFRS Valentina Lazzarotti anno accademico 2007-2008 1 Attività immateriali Lo Ias 38 definisce le attività immateriali come beni non monetari, identificabili
Il Bilancio e i Principi Internazionali IAS-IFRS Valentina Lazzarotti anno accademico 2007-2008 1 Attività immateriali Lo Ias 38 definisce le attività immateriali come beni non monetari, identificabili
Transizione ai principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards)
 Transizione ai principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) Prima applicazione dei Principi Contabili Internazionali IFRS (1) A partire dall esercizio 2005 le società
Transizione ai principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) Prima applicazione dei Principi Contabili Internazionali IFRS (1) A partire dall esercizio 2005 le società
Documenti di bilancio
 Risk and Accounting Documenti di bilancio Marco Venuti 2016 Agenda Il bilancio codicistico: struttura e schemi Il bilancio IAS/IFRS Situazione patrimoniale-finanziaria Conto economico complessivo Rendiconto
Risk and Accounting Documenti di bilancio Marco Venuti 2016 Agenda Il bilancio codicistico: struttura e schemi Il bilancio IAS/IFRS Situazione patrimoniale-finanziaria Conto economico complessivo Rendiconto
PROBLEMATICHE INERENTI ALLA PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
 PROBLEMATICHE INERENTI ALLA PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI Relatore: Mario FRATTAROLO Macerata 7 ottobre 2005 1 AGENDA Riferimenti Normativi Prima adozione degli IAS/IFRS Rettifiche
PROBLEMATICHE INERENTI ALLA PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI Relatore: Mario FRATTAROLO Macerata 7 ottobre 2005 1 AGENDA Riferimenti Normativi Prima adozione degli IAS/IFRS Rettifiche
Il Rendiconto Finanziario. Inquadramento normativo e OIC n.10
 Il Rendiconto Finanziario Inquadramento normativo e OIC n.10 Art. 2423 c.c. Redazione del bilancio. In vigore fino al 31.12.2015 Gliamministratoridevonoredigereilbilanciodiesercizio, costituito dallo stato
Il Rendiconto Finanziario Inquadramento normativo e OIC n.10 Art. 2423 c.c. Redazione del bilancio. In vigore fino al 31.12.2015 Gliamministratoridevonoredigereilbilanciodiesercizio, costituito dallo stato
Quali risorse? Identificabilità. Benefici futuri. Controllo. Attività immateriali. I benefici futuri Sono probabili
 QUESITI 1. Indicare i soggetti che, ai sensi del D.Lgs. 38/2005 hanno l obbligo a passare agli IAS/IFRS. l Società quotate l Banche l Enti finanziari vigilati da parte di Banca d Italia l Società con strumenti
QUESITI 1. Indicare i soggetti che, ai sensi del D.Lgs. 38/2005 hanno l obbligo a passare agli IAS/IFRS. l Società quotate l Banche l Enti finanziari vigilati da parte di Banca d Italia l Società con strumenti
I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS
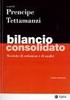 I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS 1 Schemi di bilancio 2 I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS Nel marzo del 2004 è stato emesso dallo IASB l IFRS 4 Il principio contabile internazionale
I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS 1 Schemi di bilancio 2 I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS Nel marzo del 2004 è stato emesso dallo IASB l IFRS 4 Il principio contabile internazionale
(Riduzione durevole di valore delle attività)
 (Riduzione durevole di valore delle attività) «IMPAIRMENT OF ASSETS»: SIGNIFICATO Traduzione ufficiale italiana di «Impairment of Assets» (regolamento (CE) n. 2236/2004): «Riduzione durevole di valore
(Riduzione durevole di valore delle attività) «IMPAIRMENT OF ASSETS»: SIGNIFICATO Traduzione ufficiale italiana di «Impairment of Assets» (regolamento (CE) n. 2236/2004): «Riduzione durevole di valore
Definizione di strumenti finanziari e contratti assicurativi
 Risk and Accounting Definizione di strumenti finanziari e contratti assicurativi Marco Venuti 2017 Agenda Stato dell arte Definizione strumento finanziario Strumenti derivati impliciti Contratti e rischi
Risk and Accounting Definizione di strumenti finanziari e contratti assicurativi Marco Venuti 2017 Agenda Stato dell arte Definizione strumento finanziario Strumenti derivati impliciti Contratti e rischi
Cenni sull applicazione dei Principi Contabili Internazionali nella disciplina nazionale italiana
 Cenni sull applicazione dei Principi Contabili Internazionali nella disciplina nazionale italiana Definizione di fair value Per i Principi Contabili Internazionali NON esiste una definizione univoca di
Cenni sull applicazione dei Principi Contabili Internazionali nella disciplina nazionale italiana Definizione di fair value Per i Principi Contabili Internazionali NON esiste una definizione univoca di
040 Sovrapprezzo azioni IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR
 31.7.2015 L 205/185 ALLEGATO III 1. Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria] 1.3 Patrimonio netto Disaggregazione nella tabella Valore contabile 010 010 Capitale 54, lettera
31.7.2015 L 205/185 ALLEGATO III 1. Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria] 1.3 Patrimonio netto Disaggregazione nella tabella Valore contabile 010 010 Capitale 54, lettera
LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CON- TABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS)
 LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CON- TABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS) Natura dei Principi Contabili Internazionali Corpus di principi contabili riconosciuti in ambito internazionale,
LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CON- TABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS) Natura dei Principi Contabili Internazionali Corpus di principi contabili riconosciuti in ambito internazionale,
LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI o Classificazione secondo codice civile o Criteri di valutazione secondo codice civile e principi contabili nazionali
 LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI o Classificazione secondo codice civile o Criteri di valutazione secondo codice civile e principi contabili nazionali o Ammortamenti, rivalutazione e svalutazione secondo
LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI o Classificazione secondo codice civile o Criteri di valutazione secondo codice civile e principi contabili nazionali o Ammortamenti, rivalutazione e svalutazione secondo
Le principali differenze contabili internazionali
 Università degli Studi di Trieste Ragioneria Generale ed Applicata (corso magistrale) Modulo di Ragioneria Internazionale Le principali differenze contabili internazionali di 1 Le aree critiche per l armonizzazione
Università degli Studi di Trieste Ragioneria Generale ed Applicata (corso magistrale) Modulo di Ragioneria Internazionale Le principali differenze contabili internazionali di 1 Le aree critiche per l armonizzazione
Bilancio Consolidato di Gruppo a.a Le partecipazioni nel bilancio consolidato
 Le partecipazioni nel bilancio consolidato Partecipazioni In Imprese non controllate, né collegate, né joint venture Si vedano principi relativi al bilancio individuale In imprese controllate (non consolidate)
Le partecipazioni nel bilancio consolidato Partecipazioni In Imprese non controllate, né collegate, né joint venture Si vedano principi relativi al bilancio individuale In imprese controllate (non consolidate)
Schema di stato patrimoniale ai sensi dell art c.c.
 Schema di stato patrimoniale ai sensi dell art. 2424 c.c. ATTIVO PASSIVO A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni, con
Schema di stato patrimoniale ai sensi dell art. 2424 c.c. ATTIVO PASSIVO A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni, con
Ragioneria Generale e Applicata a.a Immobilizzazioni immateriali
 Immobilizzazioni immateriali 1 Caratteri economico-aziendali Simili a quelli delle immobilizzazioni materiali Non è sempre facile da verificare l effettiva possibilità di utilizzo durevole (es. costi di
Immobilizzazioni immateriali 1 Caratteri economico-aziendali Simili a quelli delle immobilizzazioni materiali Non è sempre facile da verificare l effettiva possibilità di utilizzo durevole (es. costi di
Le valutazioni al costo ammortizzato e al fair value nei principi contabili nazionali
 Le valutazioni al costo ammortizzato e al fair value nei principi contabili nazionali Prof. Riccardo Tiscini Convegno: Prima applicazione dei nuovi OIC e prospettive dell informativa di bilancio Roma,
Le valutazioni al costo ammortizzato e al fair value nei principi contabili nazionali Prof. Riccardo Tiscini Convegno: Prima applicazione dei nuovi OIC e prospettive dell informativa di bilancio Roma,
Ragioneria Generale e Applicata I. Rimanenze di magazzino Rimanenze di opere in corso su ordinazione Crediti
 Rimanenze di magazzino Rimanenze di opere in corso su ordinazione Crediti Caratteri economico-aziendali Fattori produttivi a veloce ciclo di utilizzo Beni che si trovano ad un diverso stadio del ciclo
Rimanenze di magazzino Rimanenze di opere in corso su ordinazione Crediti Caratteri economico-aziendali Fattori produttivi a veloce ciclo di utilizzo Beni che si trovano ad un diverso stadio del ciclo
LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. Problematiche correlate
 LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Problematiche correlate 1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LEASING IAS 17 Trasferimento sostanziale tutti i rischi ed i benefici inerenti alla proprietà di un attività. NO SI LEASING
LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Problematiche correlate 1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LEASING IAS 17 Trasferimento sostanziale tutti i rischi ed i benefici inerenti alla proprietà di un attività. NO SI LEASING
Iscrizione e classificazione degli strumenti finanziari
 Risk and Accounting Iscrizione e classificazione degli strumenti finanziari Marco Venuti 2017 Agenda Iscrizione Classificazione attività finanziarie Fair value option Trasferimenti di comparto (Riclassificazioni)
Risk and Accounting Iscrizione e classificazione degli strumenti finanziari Marco Venuti 2017 Agenda Iscrizione Classificazione attività finanziarie Fair value option Trasferimenti di comparto (Riclassificazioni)
Direttiva 2013/34/UE D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 Le immobilizzazioni immateriali
 Direttiva 2013/34/UE D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 Le immobilizzazioni immateriali 25 febbraio 2016 Stefano Lania Servizio Fiscale e Societario Confindustria Bergamo Quadro normativo D. Lgs. 18 agosto
Direttiva 2013/34/UE D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 Le immobilizzazioni immateriali 25 febbraio 2016 Stefano Lania Servizio Fiscale e Societario Confindustria Bergamo Quadro normativo D. Lgs. 18 agosto
STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale
 OGGETTO: Bilancio: le principali novità dal 2016 Premessa Con il D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015, pubblicato nella G.U. n. 205 del 04.09.2015, sono state introdotte importanti novità nella disciplina del
OGGETTO: Bilancio: le principali novità dal 2016 Premessa Con il D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015, pubblicato nella G.U. n. 205 del 04.09.2015, sono state introdotte importanti novità nella disciplina del
L equilibrio finanziario
 L equilibrio finanziario Il bilancio secondo i principi contabili internazionali Analisi Economico-Finanziaria delle P.M.I. Prof. Andrea Calabrò E-mail: andrea.calabro@uniroma2.it Le finalità e il contenuto
L equilibrio finanziario Il bilancio secondo i principi contabili internazionali Analisi Economico-Finanziaria delle P.M.I. Prof. Andrea Calabrò E-mail: andrea.calabro@uniroma2.it Le finalità e il contenuto
TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS). 25
 INDICE PREMESSA...................................... 1 APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS: REGOLAMENTO 1606/02............... 2 Raccomandazione 30 dicembre 2003 del Cesr................ 4 DELIBERA CONSOB N.
INDICE PREMESSA...................................... 1 APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS: REGOLAMENTO 1606/02............... 2 Raccomandazione 30 dicembre 2003 del Cesr................ 4 DELIBERA CONSOB N.
IFRS 1: Prima adozione degli IFRS
 21 ottobre 2008 Dr. Orazio Vagnozzi KPMG, partner responsabile progetti di conversione agli IFRS 1 2003 Firm Name/Legal Entity Finalità e ambitoa di applicazione La finalità dell IFRS 1 è assicurare che
21 ottobre 2008 Dr. Orazio Vagnozzi KPMG, partner responsabile progetti di conversione agli IFRS 1 2003 Firm Name/Legal Entity Finalità e ambitoa di applicazione La finalità dell IFRS 1 è assicurare che
COMUNICATO STAMPA. Il Consiglio di Amministrazione di Alerion approva il resoconto intermedio sulla gestione del Gruppo al 31 marzo 2008
 COMUNICATO STAMPA Milano, 14 maggio 2008 Il Consiglio di Amministrazione di Alerion approva il resoconto intermedio sulla gestione del Gruppo al 31 marzo 2008 Crescita dell attività industriale del Gruppo
COMUNICATO STAMPA Milano, 14 maggio 2008 Il Consiglio di Amministrazione di Alerion approva il resoconto intermedio sulla gestione del Gruppo al 31 marzo 2008 Crescita dell attività industriale del Gruppo
Contabilità e Bilancio Edizione 2010/2011. I principi generali e particolari di valutazione
 Contabilità e Bilancio Edizione 2010/2011 I principi generali e particolari di valutazione 1 2 Clausole generali Art. 2423 c.c. Principi generali Art. 2423 bis c.c. Le regole specifiche Art. 2426 c.c.
Contabilità e Bilancio Edizione 2010/2011 I principi generali e particolari di valutazione 1 2 Clausole generali Art. 2423 c.c. Principi generali Art. 2423 bis c.c. Le regole specifiche Art. 2426 c.c.
Immobilizzazioni materiali (IAS 16) Costo (criterio preferito) Costo rivalutato(criterio consentito)
 LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Problematiche correlate 1 Immobilizzazioni materiali (IAS 16) Costo (criterio preferito) Costo rivalutato(criterio consentito) 1 Ele plusvalenze/minusvalenze da rivalutazione?
LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Problematiche correlate 1 Immobilizzazioni materiali (IAS 16) Costo (criterio preferito) Costo rivalutato(criterio consentito) 1 Ele plusvalenze/minusvalenze da rivalutazione?
Le rimanenze. Ias n. 2. di Alfonso Lucarelli
 Le rimanenze Ias n. 2 di Alfonso Lucarelli DI COSA PARLIAMO? LE REGOLE DI VALUTAZIONE CASI PARTICOLARI DIFFERENZE CON I PCN La contabilizzazione delle rimanenze ha lo scopo di rinviare determinati costi
Le rimanenze Ias n. 2 di Alfonso Lucarelli DI COSA PARLIAMO? LE REGOLE DI VALUTAZIONE CASI PARTICOLARI DIFFERENZE CON I PCN La contabilizzazione delle rimanenze ha lo scopo di rinviare determinati costi
Modello e Teoria del Bilancio di Esercizio. La valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
 La valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali Immobilizzazioni materiali Caratteri economico aziendali Beni di uso durevole strumentali alla produzione del reddito Se soggetti a logorio
La valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali Immobilizzazioni materiali Caratteri economico aziendali Beni di uso durevole strumentali alla produzione del reddito Se soggetti a logorio
Modello e Teoria del Bilancio di Esercizio. La valutazione delle partecipazioni
 La valutazione delle partecipazioni 1 Caratteri economico aziendali Investimenti nelle quote o azioni rappresentative del capitale di altre imprese Iscrizione in bilancio Per destinazione economica, si
La valutazione delle partecipazioni 1 Caratteri economico aziendali Investimenti nelle quote o azioni rappresentative del capitale di altre imprese Iscrizione in bilancio Per destinazione economica, si
I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna
 Stampa I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna admin in Quadro normativo Il regolamento (CE) n. 1606/02
Stampa I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna admin in Quadro normativo Il regolamento (CE) n. 1606/02
S. Guidantoni. Firenze, 1 dicembre 2016
 S. Guidantoni Firenze, 1 dicembre 2016 I punti da analizzare La rilevazione: Identificazione dei derivati / Contratto ibrido Valutazione dei derivati Strumento di copertura / Oggetto di copertura Hedge
S. Guidantoni Firenze, 1 dicembre 2016 I punti da analizzare La rilevazione: Identificazione dei derivati / Contratto ibrido Valutazione dei derivati Strumento di copertura / Oggetto di copertura Hedge
INDICE SOMMARIO. pag. Presentazione...
 INDICE SOMMARIO Presentazione.......................................... pag. XIX 1. LA REVISIONE CONTABILE: INQUADRAMENTO E APPROCCIO AL RISCHIO 1. Il ruolo dei controlli interni ed esterni nell impresa.................
INDICE SOMMARIO Presentazione.......................................... pag. XIX 1. LA REVISIONE CONTABILE: INQUADRAMENTO E APPROCCIO AL RISCHIO 1. Il ruolo dei controlli interni ed esterni nell impresa.................
Il bilancio in forma abbreviata
 Il bilancio in forma abbreviata Soggetti interessati Società di capitali Società di persone con soci società di capitali Che nel 1 esercizio, o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato
Il bilancio in forma abbreviata Soggetti interessati Società di capitali Società di persone con soci società di capitali Che nel 1 esercizio, o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato
Lezioni 8 e 9: Gli schemi di bilancio
 Principi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende Lezioni 8 e 9: Gli schemi di bilancio by Marco Papa IAS 1 Presentazione del bilancio Lo IAS 1 ha la finalità
Principi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende Lezioni 8 e 9: Gli schemi di bilancio by Marco Papa IAS 1 Presentazione del bilancio Lo IAS 1 ha la finalità
UNITA DIDATTICA: IL BILANCIO D ESERCIZIO
 UNITA DIDATTICA: IL BILANCIO D ESERCIZIO PREREQUISITI: CONOSCENZA ASPETTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI AZIENDALI CONOSCENZA FINALITA DELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO CONOSCENZA MODALITA DI CHIUSURA
UNITA DIDATTICA: IL BILANCIO D ESERCIZIO PREREQUISITI: CONOSCENZA ASPETTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI AZIENDALI CONOSCENZA FINALITA DELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO CONOSCENZA MODALITA DI CHIUSURA
ASSEMBLEA ORDINARIA ANNO 2013
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ASSEMBLEA ORDINARIA ANNO 2013 TORINO, 26 marzo 2013 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31.12. 2012 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ASSEMBLEA ORDINARIA ANNO 2013 TORINO, 26 marzo 2013 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31.12. 2012 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA FINANZIARIE
 LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA FINANZIARIE Corso di Prof. E. Viganò Dott.ssa Donata Mussolino 5 Dicembre 2011 La rappresentazione in Bilancio delle Attività Finanziarie Titoli di Stato Titoli Obbligazionari
LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA FINANZIARIE Corso di Prof. E. Viganò Dott.ssa Donata Mussolino 5 Dicembre 2011 La rappresentazione in Bilancio delle Attività Finanziarie Titoli di Stato Titoli Obbligazionari
Percorso professionalizzante - Il bilancio delle banche
 www.abiformazione.it Percorso professionalizzante - Il bilancio delle banche Fiscalità e bilancio / Bilancio Il bilancio della banca è un documento fondamentale d'informazione per una pluralità di soggetti
www.abiformazione.it Percorso professionalizzante - Il bilancio delle banche Fiscalità e bilancio / Bilancio Il bilancio della banca è un documento fondamentale d'informazione per una pluralità di soggetti
Modello e Teoria del Bilancio di Esercizio. La valutazione dei crediti
 La valutazione dei crediti 1 Crediti Caratteri economico aziendali Rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da soggetti identificati Distinzioni: in base alla natura economica
La valutazione dei crediti 1 Crediti Caratteri economico aziendali Rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da soggetti identificati Distinzioni: in base alla natura economica
Ragioneria Generale e Applicata I. Il contenuto e la struttura degli schemi di Bilancio secondo i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs)
 Il contenuto e la struttura degli schemi di Bilancio secondo i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) Stato Patrimoniale Ias/Ifrs Schema esemplificativo OIC ATTIVO Attività non correnti Immobili,
Il contenuto e la struttura degli schemi di Bilancio secondo i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) Stato Patrimoniale Ias/Ifrs Schema esemplificativo OIC ATTIVO Attività non correnti Immobili,
Indice. Indice. Presentazione del lavoro. Parte I Il bilancio del sistema aziendale. Inquadramento teorico-concettuale
 IX Prefazione Presentazione del lavoro XVII XXI Parte I Il bilancio del sistema aziendale. Inquadramento teorico-concettuale Capitolo 1 Premessa. Impresa, informazione, ambiente. Le funzioni del bilancio
IX Prefazione Presentazione del lavoro XVII XXI Parte I Il bilancio del sistema aziendale. Inquadramento teorico-concettuale Capitolo 1 Premessa. Impresa, informazione, ambiente. Le funzioni del bilancio
Il contenuto e la struttura degli schemi di Bilancio secondo i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs)
 Il contenuto e la struttura degli schemi di Bilancio secondo i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) 1 Contenuto Stato Patrimoniale Ias/Ifrs Contenuto minimo obbligatorio: a) immobili, impianti
Il contenuto e la struttura degli schemi di Bilancio secondo i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) 1 Contenuto Stato Patrimoniale Ias/Ifrs Contenuto minimo obbligatorio: a) immobili, impianti
Conto economico separato consolidato
 Gli schemi riclassificati di Conto Economico, di Stato Patrimoniale e di Rendiconto Finanziario del Gruppo Telecom Italia Media e di Telecom Italia Media S.p.A., nel seguito presentati, sono quelli riportati
Gli schemi riclassificati di Conto Economico, di Stato Patrimoniale e di Rendiconto Finanziario del Gruppo Telecom Italia Media e di Telecom Italia Media S.p.A., nel seguito presentati, sono quelli riportati
INDICE 3. PROCEDURA DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE E DEPOSITO... 49
 INDICE PREMESSA... 15 1. IL BILANCIO D ESERCIZIO: FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI... 17 1. Soggetti obbligati... 19 2. Documenti che compongono il bilancio... 19 3. Principi generali... 20 3.1 Finalità
INDICE PREMESSA... 15 1. IL BILANCIO D ESERCIZIO: FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI... 17 1. Soggetti obbligati... 19 2. Documenti che compongono il bilancio... 19 3. Principi generali... 20 3.1 Finalità
La gestione delle riserve IAS/IFRS iscritte nel Patrimonio Netto
 La gestione delle riserve IAS/IFRS iscritte nel Patrimonio Netto Alberto Tron Presidente Comitato Tecnico ANDAF Financial Reporting Standards Docente di Sistemi Informativi Gestionali nell Università di
La gestione delle riserve IAS/IFRS iscritte nel Patrimonio Netto Alberto Tron Presidente Comitato Tecnico ANDAF Financial Reporting Standards Docente di Sistemi Informativi Gestionali nell Università di
DEBITI. o Aspetti definitori e rappresentazione in bilancio secondo il codice civile o Regole IASB
 DEBITI o Aspetti definitori e rappresentazione in bilancio secondo il codice civile o Regole IASB Aspetti definitori Secondo l OIC 19 i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che
DEBITI o Aspetti definitori e rappresentazione in bilancio secondo il codice civile o Regole IASB Aspetti definitori Secondo l OIC 19 i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che
Esercitazione: l impairment test
 Esercitazione: l impairment test L IMPAIRMENT TEST DI UN MARCHIO Il 1 febbraio 2008 la società Alfa S.p.A., che produce e commercializza abbigliamento sportivo, acquista da un altra società un nuovo marchio
Esercitazione: l impairment test L IMPAIRMENT TEST DI UN MARCHIO Il 1 febbraio 2008 la società Alfa S.p.A., che produce e commercializza abbigliamento sportivo, acquista da un altra società un nuovo marchio
L applicazione degli IFRS in Italia
 Università degli Studi di Trieste Ragioneria Generale ed Applicata (corso magistrale) Modulo di Ragioneria Internazionale L applicazione degli IFRS in Italia di 1 Il regolamento 1606/2002 Il regolamento
Università degli Studi di Trieste Ragioneria Generale ed Applicata (corso magistrale) Modulo di Ragioneria Internazionale L applicazione degli IFRS in Italia di 1 Il regolamento 1606/2002 Il regolamento
I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS = INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS)
 I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS = INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS) 20/01/2016 ECONOMIA AZIENDALE Prof. Antoni Sara 1 PERCHE? Armonizzazione regole contabili Creazione linguaggio comune al fine
I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS = INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS) 20/01/2016 ECONOMIA AZIENDALE Prof. Antoni Sara 1 PERCHE? Armonizzazione regole contabili Creazione linguaggio comune al fine
Genova, 10 marzo Titolo OIC 16 Immobilizzazioni materiali. Sede di svolgimento Genova
 Genova, 10 marzo 2016 Titolo OIC 16 Immobilizzazioni materiali Sede di svolgimento Genova 1 Cespiti destinati alla vendita, nuova versione OIC 16: «le immobilizzazioni immateriali che società decide di
Genova, 10 marzo 2016 Titolo OIC 16 Immobilizzazioni materiali Sede di svolgimento Genova 1 Cespiti destinati alla vendita, nuova versione OIC 16: «le immobilizzazioni immateriali che società decide di
IL NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO IL CODICE CIVILE (parte II)
 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Convegno IL NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO IL CODICE CIVILE (parte II) Dott. Luca Magnano San Lio Senior Manager, KPMG S.p.A. 11 dicembre 2009 Sala Consiliare di Casa
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Convegno IL NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO IL CODICE CIVILE (parte II) Dott. Luca Magnano San Lio Senior Manager, KPMG S.p.A. 11 dicembre 2009 Sala Consiliare di Casa
1.IFRS 3 REV: LE PRINCIPALI NOVITA 2. LE STEP ACQUISITION: ASPETTI TEORICI ED ESEMPI PRATICI
 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IFRS 3: ASPETTI TEORICI ED ESEMPI PRATICI 1.IFRS 3 REV: LE PRINCIPALI NOVITA 2. LE STEP ACQUISITION: ASPETTI TEORICI ED ESEMPI PRATICI Claudia MEZZABOTTA
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IFRS 3: ASPETTI TEORICI ED ESEMPI PRATICI 1.IFRS 3 REV: LE PRINCIPALI NOVITA 2. LE STEP ACQUISITION: ASPETTI TEORICI ED ESEMPI PRATICI Claudia MEZZABOTTA
Il contenuto e la struttura degli schemi di Bilancio secondo i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs)
 Il contenuto e la struttura degli schemi di Bilancio secondo i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) Stato Patrimoniale Ias/Ifrs Schema esemplificativo OIC ATTIVO Attività non correnti Immobili,
Il contenuto e la struttura degli schemi di Bilancio secondo i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) Stato Patrimoniale Ias/Ifrs Schema esemplificativo OIC ATTIVO Attività non correnti Immobili,
Le immobilizzazioni materiali. Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria 1
 Le immobilizzazioni materiali Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria 1 Schema della presentazione 1.Il concetto di immobilizzazioni materiali 2.Le classificazioni 3.Le modalità
Le immobilizzazioni materiali Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria 1 Schema della presentazione 1.Il concetto di immobilizzazioni materiali 2.Le classificazioni 3.Le modalità
I metodi misti di determinazione del valore
 8. I metodi misti di determinazione del valore La valutazione della componente patrimoniale: rivalutazione delle attività e passività aziendali, le attività immateriali, i surplus assets La stima autonoma
8. I metodi misti di determinazione del valore La valutazione della componente patrimoniale: rivalutazione delle attività e passività aziendali, le attività immateriali, i surplus assets La stima autonoma
Dal bilancio contabile al Bilancio d esercizio destinato a pubblicazione. Il caso TECNIC S.p.a.
 Dal bilancio contabile al Bilancio d esercizio destinato a pubblicazione Il caso TECNIC S.p.a. Bilancio d esercizio contabile o Situazione contabile (patrimoniale ed economica) finale della SpA Tecnic
Dal bilancio contabile al Bilancio d esercizio destinato a pubblicazione Il caso TECNIC S.p.a. Bilancio d esercizio contabile o Situazione contabile (patrimoniale ed economica) finale della SpA Tecnic
Il fascicolo di Bilancio secondo gli IAS/IFRS
 Il fascicolo di Bilancio secondo gli IAS/IFRS Lucido n. 21 Il fascicolo di Bilancio Ias/Ifrs Relazione degli amministratori Stato patrimoniale Conto economico Prospetto variazioni P.n. Rendiconto finanziario
Il fascicolo di Bilancio secondo gli IAS/IFRS Lucido n. 21 Il fascicolo di Bilancio Ias/Ifrs Relazione degli amministratori Stato patrimoniale Conto economico Prospetto variazioni P.n. Rendiconto finanziario
INDICE-SOMMARIO. Presentazione Parte I I «MODELLI DI BILANCIO»
 INDICE-SOMMARIO Presentazione...15 Parte I I «MODELLI DI BILANCIO» Capitolo Primo IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE...19 1.1 I principi generali...19 1.1.1 Le finalità del bilancio d esercizio...19
INDICE-SOMMARIO Presentazione...15 Parte I I «MODELLI DI BILANCIO» Capitolo Primo IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE...19 1.1 I principi generali...19 1.1.1 Le finalità del bilancio d esercizio...19
RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa
 RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA Rif. dispensa 1. Le valutazioni di bilancio nel Codice Civile Sono prioritariamente individuati dall art 2426 del Codice Civile
RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA Rif. dispensa 1. Le valutazioni di bilancio nel Codice Civile Sono prioritariamente individuati dall art 2426 del Codice Civile
RIVISTA BANCARIA ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»
 RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA www.rivistabancaria.it ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» Gennaio-Febbraio 2014 1 Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento
RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA www.rivistabancaria.it ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» Gennaio-Febbraio 2014 1 Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento
Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2012 redatta ai sensi e per gli effetti dagli artt comma 1 e 2447 c.c.
 Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2012 redatta ai sensi e per gli effetti dagli artt. 2446 comma 1 e 2447 c.c. Approvata dal Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. in data 5 aprile 2013
Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2012 redatta ai sensi e per gli effetti dagli artt. 2446 comma 1 e 2447 c.c. Approvata dal Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. in data 5 aprile 2013
Ragioneria Generale e Applicata
 Partecipazioni 1 Caratteri economico-aziendali Quote di proprietà di altre imprese Allocazione dei valori in bilancio B)III. Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in: a) imprese controllate b)
Partecipazioni 1 Caratteri economico-aziendali Quote di proprietà di altre imprese Allocazione dei valori in bilancio B)III. Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in: a) imprese controllate b)
 D.Lgs 127/91 recepisce Direttive Europee in materia di redazione del bilancio Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai
D.Lgs 127/91 recepisce Direttive Europee in materia di redazione del bilancio Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai
Indice XIII. Premessa
 Indice Premessa XIII 1. Finalità e principi del bilancio d esercizio 1 1.1. La finalità e l oggetto del bilancio d esercizio 3 1.1.1. La finalità del bilancio d esercizio 3 1.1.2. L oggetto della rappresentazione
Indice Premessa XIII 1. Finalità e principi del bilancio d esercizio 1 1.1. La finalità e l oggetto del bilancio d esercizio 3 1.1.1. La finalità del bilancio d esercizio 3 1.1.2. L oggetto della rappresentazione
La struttura e il contenuto degli schemi di Bilancio Normativa nazionale
 La struttura e il contenuto degli schemi di Bilancio Normativa nazionale 1 Rigidità degli schemi I principi generali di struttura ex art. 2423 ter c.c. Salvo le disposizioni di leggi speciali per le società
La struttura e il contenuto degli schemi di Bilancio Normativa nazionale 1 Rigidità degli schemi I principi generali di struttura ex art. 2423 ter c.c. Salvo le disposizioni di leggi speciali per le società
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
 PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Dott. Sebastiano Deias Rag. Alessandro Tuveri PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Definizione: I principi contabili sono regole tecnico ragioneristiche che stabiliscono le modalità
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Dott. Sebastiano Deias Rag. Alessandro Tuveri PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Definizione: I principi contabili sono regole tecnico ragioneristiche che stabiliscono le modalità
ALFA SpA. Bilancio al DATI ANAGRAFICI
 Bilancio al 31-12-2015 DATI ANAGRAFICI Sede in Via Giacomo Leopardi n. 15 - MILANO Codice Fiscale 11537330158 Numero Rea MI 113085 P.I. 11537330158 Capitale Sociale Euro 46.000 i.v. Forma giuridica SPA
Bilancio al 31-12-2015 DATI ANAGRAFICI Sede in Via Giacomo Leopardi n. 15 - MILANO Codice Fiscale 11537330158 Numero Rea MI 113085 P.I. 11537330158 Capitale Sociale Euro 46.000 i.v. Forma giuridica SPA
San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche
 San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche Reddito d impresa L art. 29, in particolare, specifica che è considerato reddito d impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali,
San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche Reddito d impresa L art. 29, in particolare, specifica che è considerato reddito d impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali,
3.9 Appendice: Transazione ai principi Contabili Internazionali (IRFS)
 BE INDICE Premessa Stato patrimoniale consolidato IAS/IFRS al 1 gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004 Conto economico consolidato IAS/IFRS al 31 dicembre 2004 Note di commento alle principali rettifiche IAS/IFRS
BE INDICE Premessa Stato patrimoniale consolidato IAS/IFRS al 1 gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004 Conto economico consolidato IAS/IFRS al 31 dicembre 2004 Note di commento alle principali rettifiche IAS/IFRS
REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART.
 REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART. 118-BIS DEL TUF) DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 2 marzo 2007 Le osservazioni al presente
REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART. 118-BIS DEL TUF) DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 2 marzo 2007 Le osservazioni al presente
6. Le altre normative per l'incremento dei requisiti patrimoniali e nuovi principi contabili Roberto Vertolli
 6. Le altre normative per l'incremento dei requisiti patrimoniali e nuovi principi contabili Roberto Vertolli Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza 2 Le altre normative per l'incremento dei requisiti
6. Le altre normative per l'incremento dei requisiti patrimoniali e nuovi principi contabili Roberto Vertolli Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza 2 Le altre normative per l'incremento dei requisiti
Soluzioni Casi. Stato patrimoniale al Passività e patrimonio netto
 Soluzioni Casi Caso 1 Fabbricati e terreni Attività Terreni e Fabbricati 3.000 - Fondo ammortamento fabbricati (80) (2.400/30 anni Stato patrimoniale al 31.12 Passività e patrimonio netto Componenti negativi
Soluzioni Casi Caso 1 Fabbricati e terreni Attività Terreni e Fabbricati 3.000 - Fondo ammortamento fabbricati (80) (2.400/30 anni Stato patrimoniale al 31.12 Passività e patrimonio netto Componenti negativi
Il bilancio di esercizio
 1 con tale termine, si intende quel documento composto da CONTO ECONOMICO Espone i RICAVI ed i COSTI attribuiti, per competenza, ad un determinato periodo amministrativo STATO PATRIMONIALE Espone gli ELEMENTI
1 con tale termine, si intende quel documento composto da CONTO ECONOMICO Espone i RICAVI ed i COSTI attribuiti, per competenza, ad un determinato periodo amministrativo STATO PATRIMONIALE Espone gli ELEMENTI
Il Conto economico che segue è stato riclassificato mettendo in evidenza in una linea separata i proventi e gli oneri non ricorrenti.
 La Capogruppo KME Group S.p.A. Nell esercizio 2011 KME Group S.p.A. ha registrato una perdita, al netto del calcolo delle imposte, di Euro 9,9 milioni (utile di Euro 61,1 milioni nel 2010). Il Conto economico
La Capogruppo KME Group S.p.A. Nell esercizio 2011 KME Group S.p.A. ha registrato una perdita, al netto del calcolo delle imposte, di Euro 9,9 milioni (utile di Euro 61,1 milioni nel 2010). Il Conto economico
DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A.
 Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007 pagina 1 di 6 DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A. sede in via Filippo Turati, 27 MILANO Capitale Sociale 29.040.000 Euro Codice Fiscale Registro Imprese 06672120158 REA
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007 pagina 1 di 6 DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A. sede in via Filippo Turati, 27 MILANO Capitale Sociale 29.040.000 Euro Codice Fiscale Registro Imprese 06672120158 REA
Il leasing è un contratto atipico non disciplinato dal codice civile che consente all impresa o al lavoratore autonomo (conduttore) di:
 I BENI IN LEASING 1. Nozioni generali Il leasing è un contratto atipico non disciplinato dal codice civile che consente all impresa o al lavoratore autonomo (conduttore) di: 1 2 Ottenere la disponibilità
I BENI IN LEASING 1. Nozioni generali Il leasing è un contratto atipico non disciplinato dal codice civile che consente all impresa o al lavoratore autonomo (conduttore) di: 1 2 Ottenere la disponibilità
Parte terza. Capitolo 18. La valutazione dei titoli e delle partecipazioni
 Parte terza Capitolo 18 La valutazione dei titoli e delle partecipazioni Contabilità e bilancio 2/ed - Fabrizio Cerbioni, Lino Cinquini, Ugo Sòstero Titoli e partecipazioni - Che cosa sono I titoli sono
Parte terza Capitolo 18 La valutazione dei titoli e delle partecipazioni Contabilità e bilancio 2/ed - Fabrizio Cerbioni, Lino Cinquini, Ugo Sòstero Titoli e partecipazioni - Che cosa sono I titoli sono
AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE**
 Corso di Analisi di bilancio. A. A. 2012/2012 Ricerca personale AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE** DI A. ZAVETTIERI **Il Docente non interviene nell elaborazione delle Ricerche personali IMMOBILIZZAZIONI Nella
Corso di Analisi di bilancio. A. A. 2012/2012 Ricerca personale AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE** DI A. ZAVETTIERI **Il Docente non interviene nell elaborazione delle Ricerche personali IMMOBILIZZAZIONI Nella
Check-list sulle valutazioni
 956 CHECK LIST SULLE VALUTAZIONI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Check-list sulle valutazioni 9700 INDICE Introduzione... 9701 Come usare la Checklist sulle valutazioni... 9702 Sezione A - Attività A1 Immobili,
956 CHECK LIST SULLE VALUTAZIONI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Check-list sulle valutazioni 9700 INDICE Introduzione... 9701 Come usare la Checklist sulle valutazioni... 9702 Sezione A - Attività A1 Immobili,
Capitolo 16 Le poste in valuta
 Capitolo 16 Le poste in valuta Riferimenti: V. Antonelli, G. Liberatore (a cura di), Il bilancio d esercizio. Teoria e casi, Franco Angeli, Milano, capitolo 16; OIC 26, Operazioni in valuta estera, bozza
Capitolo 16 Le poste in valuta Riferimenti: V. Antonelli, G. Liberatore (a cura di), Il bilancio d esercizio. Teoria e casi, Franco Angeli, Milano, capitolo 16; OIC 26, Operazioni in valuta estera, bozza
Il Bilancio e i Principi Internazionali IAS-IFRS parte I
 Il Bilancio e i Principi Internazionali IAS-IFRS parte I Marika Arena - Economia e Organizzazione Aziendale B - A.A. 2009/2010 1 La contabilità generale La contabilità generale ha una valenza prevalentemente
Il Bilancio e i Principi Internazionali IAS-IFRS parte I Marika Arena - Economia e Organizzazione Aziendale B - A.A. 2009/2010 1 La contabilità generale La contabilità generale ha una valenza prevalentemente
Con riferimento ai principi contabili nazionali e internazionali, il candidato illustri i criteri di determinazione dell area di consolidamento e i
 Con riferimento ai principi contabili nazionali e internazionali, il candidato illustri i criteri di determinazione dell area di consolidamento e i metodi di consolidamento delle partecipazioni di controllo
Con riferimento ai principi contabili nazionali e internazionali, il candidato illustri i criteri di determinazione dell area di consolidamento e i metodi di consolidamento delle partecipazioni di controllo
Eni: Bilancio Consolidato e Progetto di Bilancio di Esercizio 2015
 Eni: Bilancio Consolidato e Progetto di Bilancio di 2015 Convocazione dell Assemblea degli Azionisti Bilancio consolidato e bilancio d'esercizio: confermati i risultati del preconsuntivo pubblicati il
Eni: Bilancio Consolidato e Progetto di Bilancio di 2015 Convocazione dell Assemblea degli Azionisti Bilancio consolidato e bilancio d'esercizio: confermati i risultati del preconsuntivo pubblicati il
Schiapparelli 1824 S.p.A.: Cda esamina il progetto di bilancio relativo all esercizio 2005
 Milano, 31 marzo 2006 Schiapparelli 1824 S.p.A.: Cda esamina il progetto di bilancio relativo all esercizio 2005 Il Valore della produzione consolidato è pari a 23.580 mila euro in aumento di 11.038 mila
Milano, 31 marzo 2006 Schiapparelli 1824 S.p.A.: Cda esamina il progetto di bilancio relativo all esercizio 2005 Il Valore della produzione consolidato è pari a 23.580 mila euro in aumento di 11.038 mila
Le procedure di consolidamento
 Antonino Borghi Le procedure di consolidamento 1 Riferimenti normativi Art. 147, co. 2, lettera del TUEL Verificare attraverso il bilancio consolidato l efficacia, l efficienza e l'economicità degli organismi
Antonino Borghi Le procedure di consolidamento 1 Riferimenti normativi Art. 147, co. 2, lettera del TUEL Verificare attraverso il bilancio consolidato l efficacia, l efficienza e l'economicità degli organismi
BILANCIO D ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO IL SOLE 24 ORE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2009 Prospetti contabili
 BILANCIO D ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO IL SOLE 24 ORE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2009 Prospetti contabili Situazione patrimoniale finanziaria SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA DELLA CAPOGRUPPO migliaia di
BILANCIO D ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO IL SOLE 24 ORE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2009 Prospetti contabili Situazione patrimoniale finanziaria SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA DELLA CAPOGRUPPO migliaia di
L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
 REGOLAMENTO IVASS N. 16 DEL 22 DICEMBRE 2015 REGOLAMENTO CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEI MODULI DI RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE
REGOLAMENTO IVASS N. 16 DEL 22 DICEMBRE 2015 REGOLAMENTO CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEI MODULI DI RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE
Strumenti finanziari IAS 39 (Integrazioni)
 Strumenti finanziari IAS 39 (Integrazioni) Corso di Principi Contabili e Informativa Finanziaria Prof.ssa Sabrina Pucci Facoltà di Economia Università degli Studi Roma Tre a.a. 2008-2009 prof.ssa Sabrina
Strumenti finanziari IAS 39 (Integrazioni) Corso di Principi Contabili e Informativa Finanziaria Prof.ssa Sabrina Pucci Facoltà di Economia Università degli Studi Roma Tre a.a. 2008-2009 prof.ssa Sabrina
ESERCIZI RELATIVI AL CAP. 17 IL BILANCIO CONSOLIDATO
 ESERCIZI RELATIVI AL CAP. 17 IL BILANCIO CONSOLIDATO A cura di Chiara Mancini 17.8.3.4. L attribuzione dell utile di pertinenza di terzi. Esercizi riepilogativi ESERCIZIO 17.8.3.4./1 Testo In data 01/01/X
ESERCIZI RELATIVI AL CAP. 17 IL BILANCIO CONSOLIDATO A cura di Chiara Mancini 17.8.3.4. L attribuzione dell utile di pertinenza di terzi. Esercizi riepilogativi ESERCIZIO 17.8.3.4./1 Testo In data 01/01/X
Parte I - RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - Operazioni in valuta dopo la riforma, di Michele Iori
 Parte I - RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - Operazioni in valuta dopo la riforma, di Michele Iori Autore: Michele Iori, il Sole 24 Ore Categoria Articolo: Società / Bilancio e principi contabili 1. Premessa
Parte I - RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - Operazioni in valuta dopo la riforma, di Michele Iori Autore: Michele Iori, il Sole 24 Ore Categoria Articolo: Società / Bilancio e principi contabili 1. Premessa
LE OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO
 LE OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO Profili di rilievo Forma e contenuto degli schemi di bilancio Data di chiusura dei bilanci da consolidare Omogeneità della moneta di conto Armonizzazione dei
LE OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO Profili di rilievo Forma e contenuto degli schemi di bilancio Data di chiusura dei bilanci da consolidare Omogeneità della moneta di conto Armonizzazione dei
Partecipazioni. Investimenti nel capitale di rischio di altre imprese. Criterio di classificazione in bilancio: DESTINAZIONE
 Applicazione n. 12 Partecipazioni Investimenti nel capitale di rischio di altre imprese Criterio di classificazione in bilancio: DESTINAZIONE Per il legislatore civilistico sono partecipazioni immobilizzate
Applicazione n. 12 Partecipazioni Investimenti nel capitale di rischio di altre imprese Criterio di classificazione in bilancio: DESTINAZIONE Per il legislatore civilistico sono partecipazioni immobilizzate
