Comandi di volo. Capitolo
|
|
|
- Vanessa Belli
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Capitolo 12 Comandi di volo
2 12.1 Introduzione I comandi di volo costituiscono una parte degli impianti di bordo essenziale per la controllabilità e manovrabilità della macchina. A seconda della categoria del velivolo, delle sue dimensioni e velocità sono possibili diverse tecniche per asservire il movimento delle superfici aerodinamiche di controllo ai comandi del pilota. Le soluzioni più comuni per alianti e piccoli velivoli dell aviazione generale sono basate solo su collegamenti meccanici diretti ottenuti con cavi o aste; il pilota, agendo sulla barra di comando (o sul volantino, o sulla pedaliera) in cabina, trasmette un movimento ad un cinematismo che arriva fino alla superficie di governo; normalmente la forza che il pilota deve applicare è funzione, oltre che delle dimensioni e altre caratteristiche del velivolo, della velocità di volo e dell angolo di deflessione della superficie aerodinamica. Quando allora non è possibile, attraverso queste soluzioni meccaniche, avere degli sforzi di barra sostenibili dal pilota, si deve ricorrere ad un potenziamento finale del comando, tipicamente utilizzando energia idraulica o e- lettrica. Una conseguenza della introduzione dei servomeccanismi nei comandi di volo è stata la possibilità di usare tecnologie di controllo attivo per la riduzione dei Fig Superfici di comando su velivolo da trasporto carichi di volo, la guida automatica, la stabilizzazione e la protezione da manovre fuori dall inviluppo di volo. Tecnologie più recenti si basano sulla trasmissione dalla cabina di un segnale elettrico, che viene opportunamente elaborato da un sistema di calcolatori e tradotto in comando di una superficie di governo (fly-by-wire). Il numero ed il tipo di superfici di governo dipende dalla categoria del velivolo. La fig.12.1 mostra una soluzione classica, riferita ad un velivolo da trasporto. Si possono distinguere anzitutto: - le superfici di governo primarie, per il controllo attorno ai tre assi: equilibratore, timone direzionale ed alettoni; - le superfici di governo secondarie: aerofreni, diruttori, ipersostentatori, alette di trimmaggio etc. Alcune configurazioni di velivoli moderni possiedono superfici di governo particolari: - elevons, lungo il bordo d uscita per il controllo di rollio (al posto degli alettoni) e beccheggio (al posto dell equilibratore) su configurazioni a delta senza impennaggio orizzontale; - flaperons, superfici indipendenti estese lungo tutta l apertura alare per il controllo del rollio (al posto degli alettoni) e dell incremento di portanza (al posto degli ipersostentatori di bordo d uscita); - tailerons, stabilizzatori indipendenti per il controllo di rollio (al posto degli alettoni) e beccheggio (al posto degli equilibratori); - ali a freccia variabile, per adattarsi a diverse condizioni di volo;
3 - canard, con superficie aerodinamica aggiuntiva a prua per un ulteriore controllo del beccheggio e stabilizzazione. I comandi primari sono ovviamente essenziali non solo per il compimento della missione, ma anche per la sicurezza; essi devono quindi essere caratterizzati da un elevata affidabilità ed inoltre essere in grado di mantenere prestazioni elevate anche con guasti al sistema, è quindi generalmente richiesta un certo grado di ridondanza nel sistema. I comandi secondari possono avere ridondanza inferiori quando un loro inutilizzo comporta solo restrizioni della missione senza pregiudizio della sicurezza ed è quindi accettabile una minore affidabilità Comandi diretti Come accennato è possibile un collegamento meccanico diretto tra cabina di pilotaggio e superficie di governo quando il momento di cerniera viene agevolmente contrastato dallo sforzo muscolare del pilota, considerando il meccanismo completo dei suoi attriti. Sono usati due tipi di trasmissione del comando: ad aste e a cavi. a b Fig Comando dell equilibratore: a) ad aste; b) a cavi Nel primo caso si utilizzano aste guidate lungo le varie regioni della struttura, con squadrette e bilancieri per cambiare la direzione e seguire un certo tracciato. La fig. 12.2a mostra un esempio di trasmissione ad aste per il controllo dell equilibratore. Il bilanciere è qui necessario per invertire il senso di trasmissione ed ottenere l accoppiamento classico tra il senso del movimento della barra di comando e quello dell equilibratore (barra avanti prua verso il basso). I principali problemi connessi alla progettazione di un comando ad aste sono la rigidezza, le frequenze e modi propri (soprattutto quelli flessionali) e l instabilità assiale. La rigidezza adeguata viene ottenuta, oltre che col dimensionamento, anche studiando un percorso per le
4 aste la cui lunghezza non cambi sensibilmente durante le normali deformazioni strutturali del velivolo. Uno studio dei modi di vibrare permette di evidenziare possibili fenomeni di risonanza, tipicamente con le frequenze dei motori e soprattutto con quelle dei rotori nell elicottero. Il carico di instabilità assiale è dato da: 2 π EI 2 P =, λ dove E è il modulo di Young del materiale, I il momento d inerzia della sezione e λ la lunghezza libera d inflessione; per non incorrere in problemi di instabilità occorre massimizzare il momento d inerzia rispetto al peso, e questo può essere ottenuto con sezioni a tubo circolare, e diminuendo la lunghezza delle aste con dei rompi tratta. Un sistema di trasmissione a cavi si differenzia dal precedente anzitutto per il fatto che è necessaria una doppia linea di trasmissione, poiché il cavo non resiste a carichi di compressione. Per modificare direzione e verso della trasmissione si utilizzano in questo caso delle pulegge. Sulle linee bisogna prevedere l impiego di tensionatori che compensino dilatazioni termiche e rilassamento dei trefoli. Spesso la soluzione a cavi è preferita rispetto a quella ad aste, per la maggiore possibilità di seguire tracciati anche complessi e raggiungere regioni remote della struttura. La fig. 12.2b mostra, per lo stesso caso precedente del controllo dell equilibratore, una soluzione a cavi. Con una trasmissione a cavi, essendo il circuito chiuso, possono esistere dei problemi di allentamento o indurimento del comando sia dovuti alla geometria delle aste di rinvio, sia per le diverse dilatazioni termiche della struttura rispetto a quelle dei cavi che sono in acciaio. Entrambe le soluzioni presentano vantaggi e svantaggi, nella maggioranza dei casi la soluzione adottata è mista, con aste e cavi nelle diverse zone. Per muovere la superficie di governo occorre compere un lavoro pari a: L c Mdα = A 0 dove M è il momento di cerniera e A l angolo massimo di rotazione. In realtà il pilota deve compiere un lavoro maggiore perché occorre tenere conto del lavoro di deformazione della catena di comando e del lavoro dovuto agli attriti: L p = Lc + Ld + La È possibile definire un rendimento: Lc η = L p che per sistemi complessi può assumere valori del 85 90%. Esistono dei limiti nella forza massima che il pilotà può esercitare; cambiando opportunamente i bracci di leva nella catena di comando si può ridurre lo sforzo di barra, ma esistono dei limiti anche nell escursione di barra possibile legati sempre ad evidenti limitazioni del pilota
5 Il comando diretto meccanico è quindi possibile solo fino a determinati valori del lavoro richiesto, se questo valore viene superato occorre potenziare il comando e questo può essere fatto con alette sfruttando forze aerodinamiche o con motori attraverso servocomandi Servocomandi idraulici Un servocomando idraulico è un classico servomeccanismo controreazionato in posizione nel quale l input è fornito dal comando del pilota attraverso una catena di comando classica o attraverso un segnale elettrico e l output è dato dalla posizione di un martinetto: dal confronto fra i due viene imposto lo spostamento del cursore di un distributore, la potenza viene fornita dall impianto idraulico (fig.12.3). Comando pilota Distributore Potenza idraulica Attuatore Posizione superficie Fig Servocomando idraulico Si possono avere servocomandi con comando e retroazione elettrici (fig. 12.4) o con collegamento meccanico in parallelo o in serie (fig 12.5). x x y Fig 12.4 Collegamento elettrico
6 Fig Collegamento meccanico parallelo e serie Nel servocomando meccanico con collegamento in parallelo distributore e martinetto sono due corpi separati; il segnale di ingresso agisce sul distributore attraverso una leva e lo spostamento del pistone del martinetto riporta il distributore nella posizione chiusa quando il pistone ha compiuto una corsa proporzionale all ingresso (fig. 12.6) dove il coefficiente di proporzionalità è dato dai bracci di leva. Fig Azionamento di un servocomando di tipo parallelo
7 Molto più comunemente si impiegano però servocomandi con comando in serie; il distributore ed il cilindro del martinetto sono un corpo unico e il pistone è vincolato alla struttura; il segnale di ingresso agisce sul cursore del distributore provocando lo spostamento del cilindro del martinetto, il corpo del distributore lo segue e quando la corsa del cilindro è pari allo spostamento imposto al cursore del distributore questo si ritrova nella posizione chiusa. x p R x y F y F y F Fig Azionamento di un servocomando di tipo serie Esiste un ritardo fra lo spostamento del cursore e quello del martinetto, ritardo funzione delle caratteristiche di frequenza del segnale di ingresso e della dinamica dell insieme servocomando superficie di comando; lo studio della stabilità del sistema e della sua risposta in frequenza è un aspetto molto importante nello sviluppo di un servocomando Con un servocomando la forza da applicare sulla barra è solo quella corrispondente agli attriti sulla linea di comando, cioè molto piccola; è necessario introdurre una forza che dia al pilota una sensibilità sul comando che sta applicando. Questo può essere fatto semplicemente con una molla che dà una forza proporzionale allo spostamento della barra, sistemi più sofisticati sono in grado di introdurre forze tenendo conto della velocità del velivolo o di altri fattori
8 I martinetti che fanno parte del servocomando sono normalmente a stelo passante in modo da avere aree di lavoro uguali su entrambi i lati, questo serve ad assicurare una simmetria di funzionamento ed è assolutamente indispensabile per poter eseguire manovre in caso si emergenza. In caso infatti di mancanza della potenza idraulica è possibile mettere le due camere in comunicazione fra loro (se le due camere hanno uguale sezione la portata uscente da una e quella entrante nell altra sono uguali e il pistone ed il cilindro possono avere un movimento relativo) e vincolare fra loro il cursore ed il corpo del distributore (Fig.12.8), in questo modo il comando può agire direttamente spostando il cilindro. Naturalmente in queste condizioni si riporta lo sforzo di barra a valori elevanti ed in alcuni casi si deve ridurre l inviluppo di volo, ma il velivolo resta pilotabile anche senza potenza idraulica. p R p Fig Dispositivi per intervento di emergenza 12.4 Fly-By-Wire Nei progetti recenti di velivoli si fa sempre più ricorso a dispositivi che permettono di elaborare, oltre ai comandi introdotti dal pilota, parametri misurati sul velivolo in modo da migliorare le qualità del volo. Esempi di sistemi di questo genere sono: autopiloti; dispositivi per il volo a bassa quota; attenuatori di raffica; aumentatori di stabilità; limitatori di incidenza. Dispositivi di questo genere sono nati già agli esordi dell'elettronica, ma hanno avuto notevole sviluppo ed incremento delle possibilità con l evoluzione dei calcolatori e delle tecnologie elettroniche digitali: è possibile integrare varie funzioni in un unico sistema basato su calcolatori; è possibile inoltre integrare tutte le funzioni in un calcolatore o utilizzare un certo numero di calcolatori, ognuno specializzato per un determinato compito e cooperante con gli altri
9 Sistemi così realizzati sono abbastanza complessi a causa delle ridondanze necessarie per raggiungere l'affidabilità richiesta. Le funzioni devolute ai calcolatori diventano in alcune macchine tante e tali da spingere ad eliminare completamente la catena meccanica di comando: il comando, o meglio la richiesta del pilota (demand) è trasformata in un segnale elettrico ed inviata ad un gruppo di calcolatori, insieme a vari parametri di volo misurati. I calcolatori esaminano la richiesta e trasmettono un segnale alla valvola di comando, azionando il martinetto, eventualmente con un adattamento alla condizione di volo. Questa tecnologia prende il nome di fly-by-wire, è nata negli anni 70 in ambito militare in versione analogica e, successivamente, esportata al civile e trasformata in digitale con la diffusione dei calcolatori digitali. Il primo velivolo civile ad adottare questa tecnologia è stato il Concorde, che per molto tempo è rimasto un caso isolato; adesso vediamo applicazioni in altri velivoli, come per e- sempio l Airbus delle serie 320, 330, 340, 380 e il Boeing 777. L A320 è stato inoltre il primo velivolo di linea ad eliminare i 2 tradizionali volantini di comando davanti ai piloti e sostituirli con due joystick a fianco dei piloti. Fig Rappresentazione schematica dell architettura fly-by-wire La fig rappresenta schematicamente l architettura di controllo fly-by-wire con sistema idraulico. I calcolatori generano un segnale basato sulla richiesta del pilota e adattato alle condizioni di volo; i dati di volo campionati e quindi utilizzati per l elaborazione del comando sono diversi a seconda della categoria di velivolo, ma generalmente includono i seguenti: velocità di beccheggio, rollio ed imbardata e accelerazioni lineari; angolo di incidenza e di deriva; velocità e quota; richieste di comando sulle superfici di controllo, sul carrello d atterraggio, sul regime motori etc. E' possibile dimostrare un'affidabilità del sistema pari o superiore a quella dei sistemi puramente meccanici. Questa affidabilità è ottenuta a costo di notevoli ridondanze a livello di componenti ed alimentazioni elettriche ed idrauliche: in genere il sistema è quadruplo
10 Per esempio il sistema di controllo di volo dell A320 è costituito da 7 computer ed è stato realizzato da 2 differenti aziende, che sono state obbligate ad utilizzare processori, linguaggi di programmazione ed algoritmi differenti l uno dall altro: differenziando hardware e software in parallelo per eseguire la stessa operazione, si riduce la possibilità che un comando errato venga eseguito, perché questo dovrebbe implicare un conflitto tra i calcolatori e l attivazione di un algoritmo di diagnosi. Sempre sull A320 esiste la possibilità, in caso di avaria completa dell impianto elettrico, di comandare meccanicamente il timone direzionale e l incidenza dello stabilizzatore: le prove di volo hanno dimostrato che è possibile un atterraggio utilizzando solo queste superfici, ma in realtà il dispositivo meccanico di emergenza ha lo scopo di dare tempo all equipaggio per tentare di riattivare l impianto. Il Tornado è invece un tipico esempio di applicazione di tecnologia FBW su velivolo a bassa stabilità. Esso infatti, pur non essendo totalmente instabile, è molto difficilmente manovrabile, soprattutto per il fatto che è a geometria variabile e quindi avrebbe risposte ai comandi completamente diverse a seconda della condizione di volo: questo richiederebbe al pilota un carico di lavoro inaccettabile. Il velivolo è quindi equipaggiato di sistemi di controllo ed aumento della stabilità attorno a tutti e tre gli assi ed un sistema di comando che rende le operazioni del pilota indipendenti dalle configurazioni del velivolo. Nei sistemi fly-by-wire, o comunque basati sull'impiego di calcolatori, esistono problemi hardware, ma soprattutto problemi di realizzazione e di certificazione del software, che oltretutto deve essere basato sulle equazioni di volo del velivolo. Il sistema viene quindi collaudato in modo molto estensivo, per ridurre al amassimo il rischio di errore. Attualmente il rischio di perdita totale del controllo del velivolo è pari a 2x10-6 per ogni ora di volo nel caso di un moderno velivolo militare; questo valore scende a 10-9 nel caso di un velivolo civile. I vantaggi di una tecnologia fly-by-wire possono essere molteplici: protezione dell inviluppo di volo (i calcolatori rifiutano o adattano richieste di controllo al di fuori dei fattori di carico previsti); aumento di stabilità e controllo in tutto l inviluppo di volo e possibilità di pilotare velivoli instabili; attenuazione degli effetti della turbolenza e delle raffiche, con riduzione dei carichi di fatica ed aumento del comfort dei passeggeri; controllo del volo con propulsori a spinta orientabile (velivoli a decollo verticale e convertiplani); riduzione della resistenza aerodinamica attraverso un trimmaggio adattativo; aumento della stabilità durante lo sgancio di serbatoi o armamenti; migliore interfacciabilità con sistemi automatici di controllo del volo; riduzione di peso; riduzione di manutenzione; riduzione del tempo di addestramento piloti. A bordo dei velivoli civili il modo operativo del sistema fly-by-wire cambia nelle 4 fasi di manovra a terra, decollo, volo e atterraggio. La transizione tra i modi è molto regolare ed impercettibile al pilota. Nel modo di controllo al suolo, il comando dello sterzo della ruota di prua è adattato alla velocità di rullaggio; dopo il distacco da terra la protezione dell inviluppo di volo viene gradualmente introdotta affinché il pilota non possa compiere manovre che superino il minimo e massimo fattore di carico, angolo di incidenza, stallo, velocità di volo, velocità di rollio ecc; infine, nella fase finale dell avvicinamento, il funzionamento del sistema
11 fly-by-wire passa gradualmente al modo atterraggio, il trimmaggio automatico è disattivato ed equazioni di volo modificate sono usate per il controllo del beccheggio. La fig mostra lo schema di controllo fly-by-wire per l Airbus 340. In questo caso sono usati 3 gruppi di calcolatori: un gruppo di 3 calcolatori per i comandi primari (FCPC), un gruppo di 2 per i secondari (FCSC) e un gruppo di due per i sistemi di aumento di portanza (SFCC). I computer dei comandi primari e secondari sono basati su diverso hardware; i computer dello stesso gruppo sono basati su diverso software. Un altra coppia di calcolatori si occupa dell acquisizione dati di volo. Nel disegno allegato vengono indicati i gruppi di calcolatori associati alle varie superfici di governo; l A340 ha 3 sistemi idraulici indipendenti, comunemente chiamati blu, verde e giallo; sia la rete idraulica che quella del controllo fly-by-wire hanno un architettura tale da ottenere un elevata ridondanza sul controllo del volo: gli alettoni interni ed esterni, gli equilibratori ed il timone sono controllati dai computer primari e secondari e potenziati dai tutti e tre gli impianti idraulici; i sistemi di aumento di portanza sono controllati dal gruppo di computer dedicati (SFCC) e complessivamente potenziati dai tre impianti idraulici; lo stabilizzatore, che ha ovviamente un importanza secondaria, è controllato da un solo gruppo di computer e potenziato da due impianti idraulici. Grazie a questa architettura un velivolo come l A340 può essere comandato, almeno nei comandi essenziali, anche a seguito di avaria di due impianti idraulici e due gruppi di calcolatori. Nell eventualità di perdita del terzo gruppo di computer o del terzo impianto idraulico, è previsto un controllo manuale d emergenza del timone direzionale degli equilibratori, al pari dell A320. Fig Schema fly-by-wire dell A340 Una tecnologia di tipo fly-by-wire è inevitabile per alcune categorie di velivoli come quelli mostrati in fig Il primo esempio è il bombardiere Northrop B-2, la cui struttura è progettata col principale requisito di ridurre la riflessione delle onde radar, e quindi di essere dif
12 ficilmente intercettato; ne risulta una forma aerodinamica priva delle classiche superfici di controllo, fortemente instabile. Nel secondo caso si vede il Bell-Boeing V-22, un convertiplano in grado di passare da una configurazione tipo elicottero, con rotori ad assi verticali, ad una di tipo velivolo ad ala fissa, con rotori ad assi orizzontali; la transizione tra le due configurazioni, in cui il sostentamento è dato in frazioni variabili dalla portanza alare e dalla spinta dei rotori, richiederebbe inusuali capacità di pilotaggio, ma è ben controllata da un sistema fly-bywire. Fig Velivolo instabile e velivolo a spinta orientabile 12.5 Attuatori: stato dell arte e sviluppi futuri Si è già detto che la tendenza attuale è quella di installare, laddove previsto un comando potenziato, servocomandi idraulici dove la valvola di comando viene azionata dal pilota, tramite un segnale meccanico od elettrico. Nella fig si mostra una valvola di comando pilotata elettricamente, per il controllo di un martinetto a 4 camere alimentato da due impianti idraulici indipendenti. Si può osservare che il sistema è tale per cui, in caso di avaria di un impianto, quest ultime viene escluso ed il controllo continua con l impianto ancora in funzione. La posizione dell attuatore viene trasformata in un segnale elettrico da un LVDT (linear variable displacement transducer) ed inviata ad un sommatore; la differenza tra il segnale e- lettrico del comando richiesto dal pilota ed il segnale dell LVDT costituisce l errore residuo; attraverso un controllo proporzionale integrativo derivativo (PID) si genera infine il segnale di corrente per il controllo del cursore della valvola. In realtà il sistema è un po più complesso, perché prima del PID ci sono un filtro ed un amplificatore, ed inoltre si utilizza spesso come retroazione anche la posizione del cursore della valvola. Fig Servocomando idraulico
13 I parametri più importanti per le prestazioni di un attuatore sono le forze massime, le velocità massime, la risposta in frequenza e la rigidezza dinamica. Le forze massime si riferiscono alle due condizioni di movimento e sono notoriamente funzione delle aree, della pressione idraulica e delle perdite di carico. Le velocità massime, pure definite nelle due direzioni di moto del pistone, sono funzione del carico e, di solito, vengono definite a carico nullo ed al 70% del carico massimo. La risposta in frequenza viene definita in termini di guadagno e sfasamento dello spostamento del pistone, sotto certe condizioni di carico. Infine la rigidezza dinamica, cui di solito si associa anche un fattore di smorzamento, è un dato importante per il calcolo dei modi propri. Attualmente sono in fase di studio due tipologie innovative di attuatori: attuatori elettromeccanici (EMA) ed attuatori elettro-idrostatici (EHA). Il primo è costituito da un motore elettrico a da una scatola di riduzione che movimenta lo stelo. Questo sistema è stato utilizzato per decenni per il controllo delle alette di trimmaggio, apertura portelli ed altri utilizzi che richiedono basse potenze, velocità e tempi di risposta; tuttavia è possibile uno sviluppo di questo metodo, ed una sua applicazione al controllo del volo, con l introduzione di motori elettrici ad alta tensione continua (270 VDC ), con relativi sistemi di controllo basati su interruttori allo stato solido e microprocessori. Gli studi attuali sono finalizzati a rendere gli attuatori elettromeccanici leggeri ed affidabili quanto i corrispondenti attuatori idraulici. Il secondo tipo di attuatore è invece costituito da un mini impianto idraulico integrato, comprensivo di pompa e serbatoio, per il movimento del martinetto, ed un motore elettrico ad alta tensione continua per l azionamento della pompa, attivato solo quando riceve il segnale di comando Comandi di volo degli elicotteri I velivoli ad ala rotante sono sistemi più complessi rispetto ai velivoli ad ala fissa: sono macchine asimmetriche, instabili e con una forte interazione tra i comandi di volo; questi ultimi inoltre sono completamente differenti dai comandi presenti su velivoli ad ala fissa. Un primo importante aspetto è il modo di trasmettere il movimento dai motori al rotore principale. Fatta eccezione per i piccoli elicotteri, che possono avere motori a pistoni, normalmente sono installati motori a turbina. Quasi tutta la potenza viene convertita in energia meccanica, includendo anche quella necessaria ad azionare l impianto idraulico ed elettrico. Per questo motivo il motore ha una doppia turbina, come mostrato in fig : la turbina del compressore, calettata sull asse e situata Fig Motore a turbina di un elicottero subito dopo la camera di combustione, ha lo scopo di trascinare il compressore stesso; la turbina di potenza, a valle della precedente
14 e non calettata sullo stesso albero, aziona il riduttore e quindi i rotori. Poiché questa turbina è libera dall albero principale, il motore ha un inerzia relativamente bassa e può cambiare regime senza transitori importanti; viceversa, alla turbina di potenza è associato un momento d inerzia molto elevato, e quindi lunghi transitori per passare da una velocità di rotazione ad un altra. Solitamente sono presenti almeno due motori, raramente uno solo; essi sono collocati sopra la cabina, in vicinanza della scatola di trasmissione, come mostrato in fig Il controllo del volo nell elicottero è ottenuto modificando la configurazione del rotore principale e di quello di coda. La forza di sostentamento è ottenuta dalle pale del rotore principale, solitamente in numero compreso tra 2 e 6: cambiando il loro Fig Collocazione motori e riduttore angolo di incidenza con la leva del passo collettivo, si modifica il loro coefficiente di portanza. Il controllo in direzione longitudinale e laterale è ottenuto inclinando il rotore principale nelle varie direzioni, operando sulla leva del passo ciclico. La fig A mostra i principali componenti del controllo rotore. Tre attuatori sono sufficienti per il controllo sia del passo collettivo che di quello ciclico. I attuatori vengono comandati, attraverso le loro valvole, dalla cabina di pilotaggio tramite aste, cavi o tecnologia flyby-wire. A seconda di come vengono azionati, essi sono in grado di spostare (passo collettivo) od inclinare (passo ciclico) il piatto oscillante inferiore, non rotante. Questo possiede un vincolo a pattino col piatto oscillante superiore, rotante, a cui trasmette il movimento di traslazione o inclinazione; quest ultimo controlla direttamente il calettamento delle singole pale del rotore principale, come chiarito dalla fig B. La variazione dell angolo di calettamento modifica la portanza della singola pala; il passo collettivo agisce simultaneamente su tutte le pale, generando su tutte e quindi sul velivolo una variazione di forza di sostentamento; il passo ciclico invece modifica l angolo di calettamento in modo tale da ottenere uno sbilanciamento della distribuzione di portanza ed un inclinazione del rotore, ovvero una componente di forza longitudinale. A B Fig Elementi del rotore e principio di funzionamento
15 La modifica del passo collettivo comporta una variazione del coefficiente di resistenza delle pale stesse e quindi della coppia sull asse del rotore principale; per evitare che il velivolo cambi rotta tale manovra dev essere compensata variando il calettamento delle pale del rotore di coda, tramite la pedaliera. Inoltre si verificherà un cambiamento della velocità di rotazione dei rotori, che andrà compensata col controllo della potenza motori, ottenuto da una manopola sulla leva del passo collettivo. Questi effetti incrociati dimostrano la complessità del pilotaggio dell elicottero, che è quindi basata su una continua coordinazione dei passi ciclico e collettivo, del rotore di coda e dei motori. La guida di un elicottero è più complicata di quella di un velivolo ad ala fissa, e questa differenza è accentuata durante le manovre ed il volo in condizioni di turbolenza. Per questo motivo gli elicotteri moderni sono equipaggiati con sistemi di controllo automatico della potenza motori, sistemi di stabilizzazione del volo e piloti automatici, in grado di ridurre gli effetti incrociati dei comandi e quindi il carico di lavoro del pilota Bibliografia Autori vari, Avionic Systems, curato da D.H.Middleton, Longman Scientific and Technical, 1989 I.Moir, A.Seabridge, Aircraft Systems, Longman Scientific and Technical,
Comandi di volo. Evoluzione
 Comandi di volo 1 Evoluzione 1. Superfici di governo articolate per permettere il controllo di base di rollio, beccheggio e imbardata, trasmissione meccanica. 2. Aumento del numero di superfici controllate
Comandi di volo 1 Evoluzione 1. Superfici di governo articolate per permettere il controllo di base di rollio, beccheggio e imbardata, trasmissione meccanica. 2. Aumento del numero di superfici controllate
Comandi di volo. Capitolo 12 - 12.1 -
 Capitolo 12 Comandi di volo - 12.1 - 12.1 Introduzione I comandi di volo costituiscono una parte degli impianti di bordo essenziale per la controllabilità e manovrabilità della macchina. A seconda della
Capitolo 12 Comandi di volo - 12.1 - 12.1 Introduzione I comandi di volo costituiscono una parte degli impianti di bordo essenziale per la controllabilità e manovrabilità della macchina. A seconda della
Prof. Luigi Puccinelli IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI. Comandi di volo
 Prof. Luigi Puccinelli IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI COMANDI DI VOLO 2 principali: determinano posizione delle superfici che controllano il moto del velivolo attorno ai suoi assi. secondari: comandano
Prof. Luigi Puccinelli IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI COMANDI DI VOLO 2 principali: determinano posizione delle superfici che controllano il moto del velivolo attorno ai suoi assi. secondari: comandano
I SISTEMI AUTOMATICI
 I SISTEMI AUTOMATICI GENERALITA I sistemi automatici trovano la più ampia diffusione in tutti i settori: dalle linee di produzione; ai mezzi di trasporto; alle applicazioni civili;... CARATTERISTICHE RICHIESTE
I SISTEMI AUTOMATICI GENERALITA I sistemi automatici trovano la più ampia diffusione in tutti i settori: dalle linee di produzione; ai mezzi di trasporto; alle applicazioni civili;... CARATTERISTICHE RICHIESTE
Attuatori. Gli attuatori costituiscono gli elementi che controllano e permettono il movimento delle parti
 Attuatori Gli attuatori costituiscono gli elementi che controllano e permettono il movimento delle parti meccaniche di una macchina automatica. Sono una componente della parte operativa di una macchina
Attuatori Gli attuatori costituiscono gli elementi che controllano e permettono il movimento delle parti meccaniche di una macchina automatica. Sono una componente della parte operativa di una macchina
UNIVERSITA DI PISA FACOLTA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE TESI DI LAUREA SPECIALISTICA
 UNIVERSITA DI PISA FACOLTA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE TESI DI LAUREA SPECIALISTICA Sviluppo di un modello della dinamica per un elicottero senza pilota (RUAV) e
UNIVERSITA DI PISA FACOLTA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE TESI DI LAUREA SPECIALISTICA Sviluppo di un modello della dinamica per un elicottero senza pilota (RUAV) e
OLEODINAMICA, OLEOIDRAULICA, IDRAULICA. Tecnologia affine alla pneumatica caratterizzata dai seguenti elementi:
 OLEODINAMICA, OLEOIDRAULICA, IDRAULICA Tecnologia affine alla pneumatica caratterizzata dai seguenti elementi: CARATTERISTICHE CIRCUITALI Gruppo di generazione di energia idraulica Gruppo di distribuzione
OLEODINAMICA, OLEOIDRAULICA, IDRAULICA Tecnologia affine alla pneumatica caratterizzata dai seguenti elementi: CARATTERISTICHE CIRCUITALI Gruppo di generazione di energia idraulica Gruppo di distribuzione
a.a. 2014/2015 Docente: Stefano Bifaretti
 a.a. 2014/2015 Docente: Stefano Bifaretti email: bifaretti@ing.uniroma2.it Gli schemi circuitali impiegati per la realizzazione dei convertitori statici sono molteplici. Infatti, la struttura del convertitore
a.a. 2014/2015 Docente: Stefano Bifaretti email: bifaretti@ing.uniroma2.it Gli schemi circuitali impiegati per la realizzazione dei convertitori statici sono molteplici. Infatti, la struttura del convertitore
TECNOLOGIE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ATTUATORI
 TECNOLOGIE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ENERGIA TERMICA ESPANSIONE DEFORMAZIONE ENERGIA FLUIDICA IDRAULICI A SEMI CONDUTTORI PNEUMATICI RELÈ MOTORI ENERGIA ELETTRICA ESPLOSIONE ELETTROLISI MOTORI A COMBUSTIONE
TECNOLOGIE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ENERGIA TERMICA ESPANSIONE DEFORMAZIONE ENERGIA FLUIDICA IDRAULICI A SEMI CONDUTTORI PNEUMATICI RELÈ MOTORI ENERGIA ELETTRICA ESPLOSIONE ELETTROLISI MOTORI A COMBUSTIONE
Impianti di propulsione navale
 Gli impianti di propulsione e generazione elettrica svolgono due funzioni essenziali per l operatività della nave. Il grado di integrazione fra tali impianti è variabile : a volte essi sono completamente
Gli impianti di propulsione e generazione elettrica svolgono due funzioni essenziali per l operatività della nave. Il grado di integrazione fra tali impianti è variabile : a volte essi sono completamente
IMPIANTO PNEUMATICO LA FINALITA DI TALE IMPIANTO E QUELLA DI FORNIRE ARIA A PRESSIONE E TEMPERATURA CONTROLLATE AD UNA SERIE DI UTENZE.
 IMPIANTO PNEUMATICO LA FINALITA DI TALE IMPIANTO E QUELLA DI FORNIRE ARIA A PRESSIONE E TEMPERATURA CONTROLLATE AD UNA SERIE DI UTENZE. QUESTE SONO RAGGIUNGIBILI CON UNA RETE DI DISTRIBUZIONE, COMPOSTA
IMPIANTO PNEUMATICO LA FINALITA DI TALE IMPIANTO E QUELLA DI FORNIRE ARIA A PRESSIONE E TEMPERATURA CONTROLLATE AD UNA SERIE DI UTENZE. QUESTE SONO RAGGIUNGIBILI CON UNA RETE DI DISTRIBUZIONE, COMPOSTA
Perché questa importante e sostanziale diversità da non confondere?
 Perché questa importante e sostanziale diversità da non confondere? Il C.G. è punto di applicazione di tutte le forze che agiscono sull aeromobile. (vds figura successiva) Il Punto di Bilanciamento Statico
Perché questa importante e sostanziale diversità da non confondere? Il C.G. è punto di applicazione di tutte le forze che agiscono sull aeromobile. (vds figura successiva) Il Punto di Bilanciamento Statico
Tipologie e caratteristiche strutturali. Parte 2
 Tipologie e caratteristiche strutturali Parte 2 Si è visto che i timoni presentano una specie di zona neutra intorno alla loro posizione media, cioè che in quella determinata zona, per piccole variazioni
Tipologie e caratteristiche strutturali Parte 2 Si è visto che i timoni presentano una specie di zona neutra intorno alla loro posizione media, cioè che in quella determinata zona, per piccole variazioni
Impianti di propulsione navale
 Motori diesel 2T Descrizione dei motori ME e RT-Flex Le caratteristiche ed i vantaggi dei motori a controllo completamente elettronico sono già state elencate i precedenza. In questo capitolo saranno illustrati
Motori diesel 2T Descrizione dei motori ME e RT-Flex Le caratteristiche ed i vantaggi dei motori a controllo completamente elettronico sono già state elencate i precedenza. In questo capitolo saranno illustrati
INTRODUZIONE AL CONTROLLO DIGITALE
 INTRODUZIONE AL CONTROLLO DIGITALE Prima della rivoluzione digitale l implementazione hardware degli elementi di controllo e dei trasduttori era basata sull uso di componenti idraulici, pneumatici e di
INTRODUZIONE AL CONTROLLO DIGITALE Prima della rivoluzione digitale l implementazione hardware degli elementi di controllo e dei trasduttori era basata sull uso di componenti idraulici, pneumatici e di
Impianto idraulico (2 parte)
 Prof. Luigi Puccinelli IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI (2 parte) POMPE 2 Cilindrata costante 1 senso di flusso 2 sensi di flusso Cilindrata variabile Compressore MARTINETTI 3 Semplice effetto Semplice
Prof. Luigi Puccinelli IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI (2 parte) POMPE 2 Cilindrata costante 1 senso di flusso 2 sensi di flusso Cilindrata variabile Compressore MARTINETTI 3 Semplice effetto Semplice
Pompa a pistoni assiali K3VL Serie B
 Descrizione generale La pompa a pistoni assiali a piastra oscillante K3VL è stata progettata e costruita per soddisfare le necessità di mercato dei settori: mobile, marino, industriale e dove è richiesta
Descrizione generale La pompa a pistoni assiali a piastra oscillante K3VL è stata progettata e costruita per soddisfare le necessità di mercato dei settori: mobile, marino, industriale e dove è richiesta
Studio e sperimentazione di un sistema di controllo per sistemi di terminazione del volo
 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale Studio e sperimentazione di un sistema di controllo per sistemi di
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale Studio e sperimentazione di un sistema di controllo per sistemi di
VIVERE IN UN CLIMA IDEALE VALVOLE EQUIPERCENTUALI VALVOLE DI REGOLAZIONE A GLOBO A 3 VIE GUIDA. Installazione
 VIVERE IN UN CLIMA IDEALE VALVOLE EQUIPERCENTUALI VALVOLE DI REGOLAZIONE A GLOBO A 3 VIE Installazione GUIDA GUIDA VALVOLE EQUIPERCENTUALI VALVOLE DI REGOLAZIONE A GLOBO A 3 VIE pag. 3 4 5 6 7 8 9 INDICE
VIVERE IN UN CLIMA IDEALE VALVOLE EQUIPERCENTUALI VALVOLE DI REGOLAZIONE A GLOBO A 3 VIE Installazione GUIDA GUIDA VALVOLE EQUIPERCENTUALI VALVOLE DI REGOLAZIONE A GLOBO A 3 VIE pag. 3 4 5 6 7 8 9 INDICE
Traslazioni. Debora Botturi ALTAIR. Debora Botturi. Laboratorio di Sistemi e Segnali
 Traslazioni ALTAIR http://metropolis.sci.univr.it Argomenti Velocitá ed accelerazione di una massa che trasla Esempio: massa che trasla con condizioni iniziali date Argomenti Argomenti Velocitá ed accelerazione
Traslazioni ALTAIR http://metropolis.sci.univr.it Argomenti Velocitá ed accelerazione di una massa che trasla Esempio: massa che trasla con condizioni iniziali date Argomenti Argomenti Velocitá ed accelerazione
Sicurezza e funzionalità: un unione non facile da realizzare Gli aspetti importanti da considerare in caso di integrazione di sensori Ex-i in un PLC
 Sicurezza e funzionalità: un unione non facile da realizzare Gli aspetti importanti da considerare in caso di integrazione di sensori Ex-i in un PLC La realizzazione di un classico loop di corrente per
Sicurezza e funzionalità: un unione non facile da realizzare Gli aspetti importanti da considerare in caso di integrazione di sensori Ex-i in un PLC La realizzazione di un classico loop di corrente per
In elettronica un filtro elettronico è un sistema o dispositivo che realizza
 Filtri V.Russo Cos è un Filtro? In elettronica un filtro elettronico è un sistema o dispositivo che realizza delle funzioni di trasformazione o elaborazione (processing) di segnali posti al suo ingresso.
Filtri V.Russo Cos è un Filtro? In elettronica un filtro elettronico è un sistema o dispositivo che realizza delle funzioni di trasformazione o elaborazione (processing) di segnali posti al suo ingresso.
SYLLABUS al. Manuale d istruzione Elicottero AS350 serie. (Version B-BA-B1-B2-B3-B3e) Issue 30.01.2015
 SYLLABUS al Manuale d istruzione Elicottero AS350 serie (Version B-BA-B1-B2-B3-B3e) Issue 30.01.2015 SYLLABUS 1 - INTRODUZIONE 1.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL ELICOTTERO 1.2 LA DOCUMENTAZIONE DELL
SYLLABUS al Manuale d istruzione Elicottero AS350 serie (Version B-BA-B1-B2-B3-B3e) Issue 30.01.2015 SYLLABUS 1 - INTRODUZIONE 1.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL ELICOTTERO 1.2 LA DOCUMENTAZIONE DELL
Il Moto nei Fluidi: Acqua e Aria. Il Volo Spaziale
 Il Moto nei Fluidi: Acqua e Aria Il Volo Spaziale Fluido Acqua Principio di Archimede 1. Il corpo tende a cadere fino a raggiungere il fondo se la forza di Archimede è minore del peso, F A < F p 2. Il
Il Moto nei Fluidi: Acqua e Aria Il Volo Spaziale Fluido Acqua Principio di Archimede 1. Il corpo tende a cadere fino a raggiungere il fondo se la forza di Archimede è minore del peso, F A < F p 2. Il
La colorazione standar della macchina è giallo RAL 1007 (NCS S1080-Y20R) e parti brunite nere.
 I bracci telescopici sono stati progettati e costruiti per essere installati su vie di corsa, per muoversi all interno di un area di lavoro, per annullare gli effetti generati dalla coppia di reazione
I bracci telescopici sono stati progettati e costruiti per essere installati su vie di corsa, per muoversi all interno di un area di lavoro, per annullare gli effetti generati dalla coppia di reazione
ASSOFLUID RACCOMANDAZIONE AFL.P0/2009 PROGRAMMA DELLA PNEUMATICA (P0) LIVELLO 0
 ASSOFLUID RACCOMANDAZIONE AFL.P0/2009 PROGRAMMA DELLA PNEUMATICA (P0) LIVELLO 0 ASSOFLUID RACCOMANDAZIONE AFL.P0/2009 PROGRAMMA DELLA PNEUMATICA (P0) LIVELLO 0 PREMESSA Questa raccomandazione, elaborata
ASSOFLUID RACCOMANDAZIONE AFL.P0/2009 PROGRAMMA DELLA PNEUMATICA (P0) LIVELLO 0 ASSOFLUID RACCOMANDAZIONE AFL.P0/2009 PROGRAMMA DELLA PNEUMATICA (P0) LIVELLO 0 PREMESSA Questa raccomandazione, elaborata
Impianto elettrico. Utenze
 Impianto elettrico 1 Utenze 2 Utenze e tipi di corrente Motori Risclad. Illuminaz. Avionica Scorta AC DC 3 Generalità Generatori AC e DC (Accumulatori) CSD, IDG etc Accumulatori Fusibili Relè Breakers
Impianto elettrico 1 Utenze 2 Utenze e tipi di corrente Motori Risclad. Illuminaz. Avionica Scorta AC DC 3 Generalità Generatori AC e DC (Accumulatori) CSD, IDG etc Accumulatori Fusibili Relè Breakers
I sensori, in quanto interfaccia tra l ambiente esterno e i sistemi di. elaborazione e gestione, hanno un profondo impatto su prodotti di larga
 CAPITOLO 1 INTRODUZIONE AI SENSORI IN FIBRA OTTICA 1.1 La sensoristica 1.1.1. Generalità I sensori, in quanto interfaccia tra l ambiente esterno e i sistemi di elaborazione e gestione, hanno un profondo
CAPITOLO 1 INTRODUZIONE AI SENSORI IN FIBRA OTTICA 1.1 La sensoristica 1.1.1. Generalità I sensori, in quanto interfaccia tra l ambiente esterno e i sistemi di elaborazione e gestione, hanno un profondo
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni METODO PER IL RENDERING DEI DIAGRAMMI DI IRRADIAZIONE VERTICALI BASATO SUI DATI PREVISTI DALLE SPECIFICHE DI FORMATO DEL CATASTO AGCOM 1. Premessa Per calcolare
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni METODO PER IL RENDERING DEI DIAGRAMMI DI IRRADIAZIONE VERTICALI BASATO SUI DATI PREVISTI DALLE SPECIFICHE DI FORMATO DEL CATASTO AGCOM 1. Premessa Per calcolare
CBS Meccanico. Indice. Panoramica del sistema Tipo con freno anteriore e posteriore a tamburo meccanico Tipo con freno anteriore a disco idraulico
 1/17 RISORSA Indice Panoramica del sistema Tipo con freno anteriore e posteriore a tamburo meccanico Tipo con freno anteriore a disco idraulico 2/17 Panoramica del sistema Il CBS meccanico montato su veicoli
1/17 RISORSA Indice Panoramica del sistema Tipo con freno anteriore e posteriore a tamburo meccanico Tipo con freno anteriore a disco idraulico 2/17 Panoramica del sistema Il CBS meccanico montato su veicoli
Il protocollo RS Introduzione. 1.2 Lo Standard RS-232
 1 Il protocollo RS232 1.1 Introduzione Come noto un dispositivo di interfaccia permette la comunicazione tra la struttura hardware di un calcolatore e uno o più dispositivi esterni. Uno degli obiettivi
1 Il protocollo RS232 1.1 Introduzione Come noto un dispositivo di interfaccia permette la comunicazione tra la struttura hardware di un calcolatore e uno o più dispositivi esterni. Uno degli obiettivi
Trasmissione di potenza
 Trasmissione di potenza Alberi Lo scopo di questi appunti è quello di introdurre alla comprensione della funzione degli alberi e alle loro regole di disegno e rappresentazione. Esercitarsi nella rappresentazione
Trasmissione di potenza Alberi Lo scopo di questi appunti è quello di introdurre alla comprensione della funzione degli alberi e alle loro regole di disegno e rappresentazione. Esercitarsi nella rappresentazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA STUDIO DI FATTIBILITA DEL BASAMENTO BOXER 6 CILINDRI PER IL MOTORE VD007
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale STUDIO DI FATTIBILITA DEL BASAMENTO BOXER 6 CILINDRI PER IL MOTORE VD007 Tesi
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale STUDIO DI FATTIBILITA DEL BASAMENTO BOXER 6 CILINDRI PER IL MOTORE VD007 Tesi
Rotazioni. Debora Botturi ALTAIR. Debora Botturi. Laboratorio di Sistemi e Segnali
 Rotazioni ALTAIR http://metropolis.sci.univr.it Argomenti Propietá di base della rotazione Argomenti Argomenti Propietá di base della rotazione Leggi base del moto Inerzia, molle, smorzatori, leve ed ingranaggi
Rotazioni ALTAIR http://metropolis.sci.univr.it Argomenti Propietá di base della rotazione Argomenti Argomenti Propietá di base della rotazione Leggi base del moto Inerzia, molle, smorzatori, leve ed ingranaggi
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ELABORATO FINALE DI LAUREA In Disegno Tecnico Industriale STUDIO DI FATTIBILITA DEL BASAMENTO BOXER 8 CILINDRI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ELABORATO FINALE DI LAUREA In Disegno Tecnico Industriale STUDIO DI FATTIBILITA DEL BASAMENTO BOXER 8 CILINDRI
SIMULAZIONE DELL AMMORTIZZATORE DEL CARRELLO DI ATTERRAGGIO DEL MACCHI 205 V
 Università degli studi di Bologna FACOLTÀ DI INGEGNERIA Corso di laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale SIMULAZIONE DELL AMMORTIZZATORE DEL CARRELLO DI ATTERRAGGIO DEL MACCHI 205 V
Università degli studi di Bologna FACOLTÀ DI INGEGNERIA Corso di laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale SIMULAZIONE DELL AMMORTIZZATORE DEL CARRELLO DI ATTERRAGGIO DEL MACCHI 205 V
8 - Dimensionamento del piano di coda
 8 - Dimensionamento del piano di coda 8.1 Piano di coda orizzontale Si è scelto un piano di coda orizzontale di tipo stabilizzatore equilibratore, di profilo NACA 0012 con un rapporto di rastremazione
8 - Dimensionamento del piano di coda 8.1 Piano di coda orizzontale Si è scelto un piano di coda orizzontale di tipo stabilizzatore equilibratore, di profilo NACA 0012 con un rapporto di rastremazione
Principi e Metodologie delle Costruzioni di Macchine
 Principi e Metodologie delle Costruzioni di Macchine Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica III anno A.A. 2010-2011 Docente: Domenico Gentile gentile@unicas.it 0776.2994336 Presentazione del corso PREREQUISITI
Principi e Metodologie delle Costruzioni di Macchine Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica III anno A.A. 2010-2011 Docente: Domenico Gentile gentile@unicas.it 0776.2994336 Presentazione del corso PREREQUISITI
Cilindri a semplice effetto
 Cilindri a semplice effetto Un cilindro a semplice effetto sviluppa la spinta in una sola direzione. Lo stelo si riposiziona per mezzo di una molla o per l'azione di una forza esterna. Il cilindro a semplice
Cilindri a semplice effetto Un cilindro a semplice effetto sviluppa la spinta in una sola direzione. Lo stelo si riposiziona per mezzo di una molla o per l'azione di una forza esterna. Il cilindro a semplice
Accordo Stato-regioni. Allegato IV GRU PER AUTOCARRO
 Accordo Stato-regioni 22 febbraio 2012 sulle attrezzature t di lavoro Allegato IV GRU PER AUTOCARRO Sono chiamate gru idrauliche perché i loro movimenti sono ottenuti per mezzo di cilindri ad azionamento
Accordo Stato-regioni 22 febbraio 2012 sulle attrezzature t di lavoro Allegato IV GRU PER AUTOCARRO Sono chiamate gru idrauliche perché i loro movimenti sono ottenuti per mezzo di cilindri ad azionamento
PRODUZIONE DI ENERGIA OLEODINAMICA
 PRODUZIONE DI ENERGIA OLEODINAMICA Comandi oleodinamici (o oleoidraulici) o semplicemente idraulici: 1. trasformazione di energia meccanica prelevata sull albero di un motore primo in energia idraulica
PRODUZIONE DI ENERGIA OLEODINAMICA Comandi oleodinamici (o oleoidraulici) o semplicemente idraulici: 1. trasformazione di energia meccanica prelevata sull albero di un motore primo in energia idraulica
Controllo ambientale. Scopo. Assicurare ambiente di cabina sicuro, salutare e confortevole, in tutte le condizioni di volo
 Controllo ambientale 1 Scopo Assicurare ambiente di cabina sicuro, salutare e confortevole, in tutte le condizioni di volo 2 Livello di complessità Per piccoli velivoli di bassa quota: sistema di ventilazione
Controllo ambientale 1 Scopo Assicurare ambiente di cabina sicuro, salutare e confortevole, in tutte le condizioni di volo 2 Livello di complessità Per piccoli velivoli di bassa quota: sistema di ventilazione
Analisi modale-principali attuatori
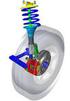 Analisi modale-principali attuatori La scelta del tipo di attuatore più adatto a sollecitare opportunamente la struttura (in funzione dell obiettivo della sperimentazione e delle caratteristiche stesse
Analisi modale-principali attuatori La scelta del tipo di attuatore più adatto a sollecitare opportunamente la struttura (in funzione dell obiettivo della sperimentazione e delle caratteristiche stesse
Impianti di propulsione navale
 Motori diesel 4T Interfacce con il sistema nave Ogni motore installato a bordo ha sostanzialmente quattro tipologie di interfacce con la nave, precisamente: Trasmissione potenza: collegamento meccanico
Motori diesel 4T Interfacce con il sistema nave Ogni motore installato a bordo ha sostanzialmente quattro tipologie di interfacce con la nave, precisamente: Trasmissione potenza: collegamento meccanico
STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DI UNA TESTATA MULTIVALVOLE PER MOTORE AD ALTISSIME PRESTAZIONI
 STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DI UNA TESTATA MULTIVALVOLE PER MOTORE AD ALTISSIME PRESTAZIONI Tesi di laurea di : Relatore : Juri Barbieri Prof. Ing. Luca Piancastelli Correlatori : Dott. Ing. Cristina Renzi
STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DI UNA TESTATA MULTIVALVOLE PER MOTORE AD ALTISSIME PRESTAZIONI Tesi di laurea di : Relatore : Juri Barbieri Prof. Ing. Luca Piancastelli Correlatori : Dott. Ing. Cristina Renzi
Summer School 2016 Elicotteri Pierangelo Masarati Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali
 Summer School 2016 Elicotteri Pierangelo Masarati Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali Istituzioni di Ingegneria Aerospaziale Giuseppe Quaranta Motivazione
Summer School 2016 Elicotteri Pierangelo Masarati Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali Istituzioni di Ingegneria Aerospaziale Giuseppe Quaranta Motivazione
MODULO PREREQUISITI OBIETTIVI CONTENUTI ORE
 1 ELETTRONICA DIGITALE Conoscenze di fisica del primo biennio biennio Nozioni di base di elettrotecnica ed elettronica analogica Uso di internet per ricerca materiali e cataloghi. Logica combinatoria Concetto
1 ELETTRONICA DIGITALE Conoscenze di fisica del primo biennio biennio Nozioni di base di elettrotecnica ed elettronica analogica Uso di internet per ricerca materiali e cataloghi. Logica combinatoria Concetto
Antilock Braking Sistem (ABS) Sistema di controllo della frenata
 Antilock Braking Sistem (ABS) Sistema di controllo della frenata Motivazioni FRENATA BRUSCA BLOCCAGGIO RUOTE SCARSA CAPACITÀ STERZANTE ELEVATO SPAZIO D ARRESTO Evitando il boccaggio delle ruote: si riduce
Antilock Braking Sistem (ABS) Sistema di controllo della frenata Motivazioni FRENATA BRUSCA BLOCCAGGIO RUOTE SCARSA CAPACITÀ STERZANTE ELEVATO SPAZIO D ARRESTO Evitando il boccaggio delle ruote: si riduce
Modello dinamico non lineare monodimensionale per la simulazione del pompaggio in un compressore assial-centrifugo INTRODUZIONE
 INTRODUZIONE L'impiego di programmi per la simulazione delle macchine è sempre più diffuso. Infatti, essi sono utilizzati sia in fase di progettazione di nuove macchine, sia per l'analisi dello stato di
INTRODUZIONE L'impiego di programmi per la simulazione delle macchine è sempre più diffuso. Infatti, essi sono utilizzati sia in fase di progettazione di nuove macchine, sia per l'analisi dello stato di
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale STUDIO DELL INFLUENZA DEL VENTO LATERALE SULLA DINAMICA DI AEROPLANI A BASSISSIMO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale STUDIO DELL INFLUENZA DEL VENTO LATERALE SULLA DINAMICA DI AEROPLANI A BASSISSIMO
Lezione 4: I motori, muscoli dei robot 1/02/2006 2
 Robotica Industriale Lezione 4: I motori, muscoli dei robot Prima di andare avanti: I motori appartengono alla classe degli attuatori: Dispositivi che, rispondendo a stimoli (elettrici) applicati al loro
Robotica Industriale Lezione 4: I motori, muscoli dei robot Prima di andare avanti: I motori appartengono alla classe degli attuatori: Dispositivi che, rispondendo a stimoli (elettrici) applicati al loro
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ELABORATO FINALE DI LAUREA In Laboratorio CAD L STUDIO E OTTIMIZZAZIONE DEL BASAMENTO DI UN MOTORE AERONAUTICO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ELABORATO FINALE DI LAUREA In Laboratorio CAD L STUDIO E OTTIMIZZAZIONE DEL BASAMENTO DI UN MOTORE AERONAUTICO
Fondamenti di Meccanica Esame del
 Politecnico di Milano Fondamenti di Meccanica Esame del 0.02.2009. In un piano verticale un asta omogenea AB, di lunghezza l e massa m, ha l estremo A vincolato a scorrere senza attrito su una guida verticale.
Politecnico di Milano Fondamenti di Meccanica Esame del 0.02.2009. In un piano verticale un asta omogenea AB, di lunghezza l e massa m, ha l estremo A vincolato a scorrere senza attrito su una guida verticale.
LEZIONE 1. IL PROGETTO STRUTTURALE Parte 2. La modellazione. Corso di TECNICA DELLE COSTRUZIONI Chiara CALDERINI A.A
 Corso di TECNICA DELLE COSTRUZIONI Chiara CALDERINI A.A. 2007-2008 Facoltà di Architettura Università degli Studi di Genova LEZIONE 1 IL PROGETTO STRUTTURALE Parte 2. La modellazione LA MODELLAZIONE INPUT
Corso di TECNICA DELLE COSTRUZIONI Chiara CALDERINI A.A. 2007-2008 Facoltà di Architettura Università degli Studi di Genova LEZIONE 1 IL PROGETTO STRUTTURALE Parte 2. La modellazione LA MODELLAZIONE INPUT
Descrizione caratteristiche cilindri elettrici serie ECC+
 Descrizione caratteristiche cilindri elettrici serie ECC+ Tipologie e potenzialità nuovo cilindro elettrico in cc 12/24V della famiglia EASY tipo ECC + Caratteristiche generali del sistema: Alimentazione
Descrizione caratteristiche cilindri elettrici serie ECC+ Tipologie e potenzialità nuovo cilindro elettrico in cc 12/24V della famiglia EASY tipo ECC + Caratteristiche generali del sistema: Alimentazione
INDICAZIONI TECNICHE TERMOCOPPIE
 INDICAZIONI TECNICHE TERMOCOPPIE 1. Principio di funzionamento 2. Metodi di misura con le termocoppie 3. Costruzione delle Termocoppie 4. Termocoppie ad isolamento tradizionale 5. Termocoppie ad isolamento
INDICAZIONI TECNICHE TERMOCOPPIE 1. Principio di funzionamento 2. Metodi di misura con le termocoppie 3. Costruzione delle Termocoppie 4. Termocoppie ad isolamento tradizionale 5. Termocoppie ad isolamento
Fondamenti di Automatica
 Fondamenti di Automatica Esempi applicativi Dott. Ing. Marcello Bonfè Dipartimento di Ingegneria - Università di Ferrara Tel. +39 0532 974839 E-mail: marcello.bonfe@unife.it pag. 1 Esempi applicativi TESTINA
Fondamenti di Automatica Esempi applicativi Dott. Ing. Marcello Bonfè Dipartimento di Ingegneria - Università di Ferrara Tel. +39 0532 974839 E-mail: marcello.bonfe@unife.it pag. 1 Esempi applicativi TESTINA
2. Connessioni. TAROT ZYX-S2 giroscopio tre assi Manuale utente
 TAROT ZYX-S2 giroscopio tre assi Manuale utente TAROT ZYX-S2 è un giroscopio 3 assi di nuova concezione molto preciso, con nuovi MEMS sensori di velocità angolare e microprocessore a 32 bit, nuovi algoritmi
TAROT ZYX-S2 giroscopio tre assi Manuale utente TAROT ZYX-S2 è un giroscopio 3 assi di nuova concezione molto preciso, con nuovi MEMS sensori di velocità angolare e microprocessore a 32 bit, nuovi algoritmi
Introduzione all Automatica. Automatica ROMA TRE Stefano Panzieri- 1
 Introduzione all Automatica Automatica ROMA TRE Stefano Panzieri- 1 Descrivere un sistema fisico La mia moto è un sistema? Capire il suo comportamento Cosa é l Automatica Quanti Km faccio con un litro?
Introduzione all Automatica Automatica ROMA TRE Stefano Panzieri- 1 Descrivere un sistema fisico La mia moto è un sistema? Capire il suo comportamento Cosa é l Automatica Quanti Km faccio con un litro?
ESERCIZIO 1 (Punti 9)
 UNIVERSITA DI PISA - ANNO ACCADEMICO 007-8 CORSO DI LAUREA IN ING. ELETTRICA (N.O.) CORSO DI MECCANICA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE VERIFICA INTERMEDIA DEL 15-06-009 ESERCIZIO 1 (Punti 9) Data
UNIVERSITA DI PISA - ANNO ACCADEMICO 007-8 CORSO DI LAUREA IN ING. ELETTRICA (N.O.) CORSO DI MECCANICA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE VERIFICA INTERMEDIA DEL 15-06-009 ESERCIZIO 1 (Punti 9) Data
I convertitori c.a.-c.a. possono essere suddivisi in tre categorie: convertitori a controllo di fase, cicloconvertitori, convertitori a matrice.
 Tra i vari tipi di convertitori monostadio, i convertitori c.a.-c.a. sono quelli che presentano il minore interesse applicativo, a causa delle notevoli limitazioni per quanto concerne sia la qualità della
Tra i vari tipi di convertitori monostadio, i convertitori c.a.-c.a. sono quelli che presentano il minore interesse applicativo, a causa delle notevoli limitazioni per quanto concerne sia la qualità della
Introduzione. Michelangelo Laterza Principi di Statica e di Dinamica delle Strutture
 Introduzione La meccanica è quella parte delle scienze applicate che studia le forze ed il moto. In questo campo è fondamentale la nozione di equilibrio, ovvero la condizione che si instaura quando le
Introduzione La meccanica è quella parte delle scienze applicate che studia le forze ed il moto. In questo campo è fondamentale la nozione di equilibrio, ovvero la condizione che si instaura quando le
Valvole di regolazione a globo a 2 e 3 vie Serie V2BM, V3BM
 Valvole di regolazione a globo a 2 e 3 vie Serie V2BM, V3BM Caratteristiche principali Disponibili nelle versioni a 2 e 3 vie Filettate da DN: 1/2-2 FF Caratteristica di regolazione equi percentuale Conforme
Valvole di regolazione a globo a 2 e 3 vie Serie V2BM, V3BM Caratteristiche principali Disponibili nelle versioni a 2 e 3 vie Filettate da DN: 1/2-2 FF Caratteristica di regolazione equi percentuale Conforme
M12 - Motori passo-passo.
 M12 - Motori passo-passo. I motori passo-passo convertono direttamente un'informazione numerica, costituita da impulsi elettrici di comando, in uno spostamento incrementale, costituito da un numero equivalente
M12 - Motori passo-passo. I motori passo-passo convertono direttamente un'informazione numerica, costituita da impulsi elettrici di comando, in uno spostamento incrementale, costituito da un numero equivalente
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DI UN AEROGENERATORE
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia Tesi di
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia Tesi di
Filtro attivo per la compensazione delle armoniche
 SEI SISTEMI S.R.L. Via Calamelli, 40-40026 IMOLA - BO Tel. 0542 640245 - Fax 0542 641018 E - mail: siei@sieisistemi.it Filtro attivo per la compensazione delle armoniche (SAF Shunt Active Filter) SEI SISTEMI
SEI SISTEMI S.R.L. Via Calamelli, 40-40026 IMOLA - BO Tel. 0542 640245 - Fax 0542 641018 E - mail: siei@sieisistemi.it Filtro attivo per la compensazione delle armoniche (SAF Shunt Active Filter) SEI SISTEMI
GITTATA MASSIMA DEGLI ELEMENTI ROTANTI... 2 CALCOLO DELLA GITTATA MASSIMA... 4
 GITTATA MASSIMA DEGLI ELEMENTI ROTANTI... 2 CALCOLO DELLA GITTATA MASSIMA... 4 1 GITTATA MASSIMA DEGLI ELEMENTI ROTANTI La tecnologia costruttiva degli aerogeneratori è alquanto sofisticata e di chiara
GITTATA MASSIMA DEGLI ELEMENTI ROTANTI... 2 CALCOLO DELLA GITTATA MASSIMA... 4 1 GITTATA MASSIMA DEGLI ELEMENTI ROTANTI La tecnologia costruttiva degli aerogeneratori è alquanto sofisticata e di chiara
BRACCI TELESCOPICI VERTICALI INFORMAZIONI GENERALI
 BRACCI TELESCOPICI VERTICALI I bracci telescopici sono stati progettati e costruiti per essere installati su vie di corsa, per muoversi all interno di un area di lavoro, per annullare gli effetti generati
BRACCI TELESCOPICI VERTICALI I bracci telescopici sono stati progettati e costruiti per essere installati su vie di corsa, per muoversi all interno di un area di lavoro, per annullare gli effetti generati
Progetto e sviluppo di un banco HIL per sistemi automobilistici di controllo attivo del rollio
 Progetto e sviluppo di un banco HIL per sistemi automobilistici di controllo del rollio Relatori: Prof. Nicolò D Alfio Prof. Mauro Velardocchia Candidati: Alessandro Fassio Roberto Fassio PAROLE CHIAVE:
Progetto e sviluppo di un banco HIL per sistemi automobilistici di controllo del rollio Relatori: Prof. Nicolò D Alfio Prof. Mauro Velardocchia Candidati: Alessandro Fassio Roberto Fassio PAROLE CHIAVE:
KNX Hotel Sistema di regolazione alberghiera Guida all installazione (per applicazioni con camere dotate di regolazione aggiuntiva di temperatura)
 KNX Hotel Guida all installazione KNX Hotel Sistema di regolazione alberghiera Guida all installazione (per applicazioni con camere dotate di regolazione aggiuntiva di temperatura) Building Technologies
KNX Hotel Guida all installazione KNX Hotel Sistema di regolazione alberghiera Guida all installazione (per applicazioni con camere dotate di regolazione aggiuntiva di temperatura) Building Technologies
Cuscinetti a strisciamento e a rotolamento
 Cuscinetti a strisciamento e a rotolamento La funzione dei cuscinetti a strisciamento e a rotolamento è quella di interporsi tra organi di macchina in rotazione reciproca. Questi elementi possono essere
Cuscinetti a strisciamento e a rotolamento La funzione dei cuscinetti a strisciamento e a rotolamento è quella di interporsi tra organi di macchina in rotazione reciproca. Questi elementi possono essere
Relè di alimentazione SPST,10 Pezzi,DC 5V Bobina 7A 240VAC 10A 125VAC/28VDC 5 pin JQC-3F
 Il relè è un dispositivo elettromeccanico costituito da un avvolgimento e da uno o più contatti meccanici, è utilizzato per operazione di interruzione e commutazione di circuiti elettrici. Normalmente
Il relè è un dispositivo elettromeccanico costituito da un avvolgimento e da uno o più contatti meccanici, è utilizzato per operazione di interruzione e commutazione di circuiti elettrici. Normalmente
Il motore a corrente continua
 Il motore a corrente continua 15 marzo 2015 Ing. chiara.foglietta@uniroma3.it Università degli Studi Roma TRE Agenda Il motore a corrente continua 2 Il motore elettrico a corrente continua è un componente
Il motore a corrente continua 15 marzo 2015 Ing. chiara.foglietta@uniroma3.it Università degli Studi Roma TRE Agenda Il motore a corrente continua 2 Il motore elettrico a corrente continua è un componente
Trasduttori. Argomenti: discussione di alcune tipologie di trasduttori: pressione accelerazione. Misure di pressione
 Trasduttori Argomenti: discussione di alcune tipologie di trasduttori: pressione accelerazione. 1 Misure di pressione 2 1 Manometro Tubi ad U (tipicamente utilizzati con lettura diretta da parte dell operatore,
Trasduttori Argomenti: discussione di alcune tipologie di trasduttori: pressione accelerazione. 1 Misure di pressione 2 1 Manometro Tubi ad U (tipicamente utilizzati con lettura diretta da parte dell operatore,
Il bilanciamento degli impianti idronici
 Il bilanciamento degli impianti idronici INTRODUZIONE Bilanciamento idronico L 80% degli edifici che abiteremo nel 2050 esiste già oggi. INTRODUZIONE Fattori di intervento Sostituzione del generatore di
Il bilanciamento degli impianti idronici INTRODUZIONE Bilanciamento idronico L 80% degli edifici che abiteremo nel 2050 esiste già oggi. INTRODUZIONE Fattori di intervento Sostituzione del generatore di
TESI DI LAUREA in DISEGNO ASSISTITO DAL CALCOLATORE. Studio di massima di un cinematismo per un sedile sportivo ammortizzato
 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA Dipartimento DIEM TESI DI LAUREA in DISEGNO ASSISTITO DAL CALCOLATORE Studio di massima di un cinematismo per un sedile
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA Dipartimento DIEM TESI DI LAUREA in DISEGNO ASSISTITO DAL CALCOLATORE Studio di massima di un cinematismo per un sedile
Collegamenti verticali meccanizzati: ascensori
 Collegamenti verticali meccanizzati: ascensori Definizioni Sistemi meccanizzati che permettono l interrelazione ed il collegamento tra spazi posizionati su differenti quote di uno o più edifici. Argomento
Collegamenti verticali meccanizzati: ascensori Definizioni Sistemi meccanizzati che permettono l interrelazione ed il collegamento tra spazi posizionati su differenti quote di uno o più edifici. Argomento
Capitolo 3 Cinematica e Dinamica
 Capitolo 3 Cinematica e Dinamica 3.1 Cinematica del Manovellismo Centrato Una volta aver calcolato dimensioni e masse caratteristiche del motore nel suo complessivo e di ogni singolo componente dello stesso,
Capitolo 3 Cinematica e Dinamica 3.1 Cinematica del Manovellismo Centrato Una volta aver calcolato dimensioni e masse caratteristiche del motore nel suo complessivo e di ogni singolo componente dello stesso,
regolazione delle macchine motrici e volano
 richiamo Nelle turbine a vapore la regolazione principale avviene correggendo l entalpia del vapore surriscaldato che entra in turbina: tale intervento è definito attemperamento e si effettua durante il
richiamo Nelle turbine a vapore la regolazione principale avviene correggendo l entalpia del vapore surriscaldato che entra in turbina: tale intervento è definito attemperamento e si effettua durante il
Prese di forza 9. Indice
 Indice PRESE DI FORZA Possibilità delle prese di forza Prese di forza azionate dal cambio Prese di forza indipendenti dalla frizione Prese di forza sul motore Presa di forza - Cambio automatico 5 PRESE
Indice PRESE DI FORZA Possibilità delle prese di forza Prese di forza azionate dal cambio Prese di forza indipendenti dalla frizione Prese di forza sul motore Presa di forza - Cambio automatico 5 PRESE
Ingegneria dei Sistemi Elettrici_6f
 Ingegneria dei Sistemi Elettrici_6f Guide d onda e cavità risonanti Sono state studiate le proprietà caratteristiche delle onde elettromagnetiche trasversali guidate da linee di trasmissione. Una delle
Ingegneria dei Sistemi Elettrici_6f Guide d onda e cavità risonanti Sono state studiate le proprietà caratteristiche delle onde elettromagnetiche trasversali guidate da linee di trasmissione. Una delle
AEROPLANI. LA FUSOLIERA 1a parte
 AEROPLANI LA FUSOLIERA 1a parte Funzioni Ospita i posti di pilotaggio, il carico utile ed eventualmente un motore o un reattore Collega l ala agli organi di stabilizzazione e governo della coda Casi particolari
AEROPLANI LA FUSOLIERA 1a parte Funzioni Ospita i posti di pilotaggio, il carico utile ed eventualmente un motore o un reattore Collega l ala agli organi di stabilizzazione e governo della coda Casi particolari
Telerilevamento: una panoramica sui sistemi
 Telerilevamento: una panoramica sui sistemi Il telerilevamento: cos è? Il telerilevamento è la scienza (o l arte) di ottenere informazioni riguardanti un oggetto, un area o un fenomeno utilizzando dati
Telerilevamento: una panoramica sui sistemi Il telerilevamento: cos è? Il telerilevamento è la scienza (o l arte) di ottenere informazioni riguardanti un oggetto, un area o un fenomeno utilizzando dati
BILANCIAMENTO DINAMICO DELLA PORTATA
 ilanciamento parte 4 FOUS TENIO ILANIAMENTO DINAMIO DELLA PORTATA Stabilizzatore automatico di portata - AUTOFLOW Gli impianti a portata variabile sono i più diffi cili da bilanciare in quanto le pressioni
ilanciamento parte 4 FOUS TENIO ILANIAMENTO DINAMIO DELLA PORTATA Stabilizzatore automatico di portata - AUTOFLOW Gli impianti a portata variabile sono i più diffi cili da bilanciare in quanto le pressioni
Impianto Pneumatico. Capitolo
 Capitolo 6 Impianto Pneumatico - 6. - 6. Introduzione In diversi casi è conveniente sfruttare energia proveniente da aria compressa; questo è soprattutto vero quando il velivolo possiede dei motori a turbina
Capitolo 6 Impianto Pneumatico - 6. - 6. Introduzione In diversi casi è conveniente sfruttare energia proveniente da aria compressa; questo è soprattutto vero quando il velivolo possiede dei motori a turbina
Ottimizzazione di un riduttore per convertiplani con inserzione di emergenza
 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE, NUCLEARI E AREONAUTICHE E DI METALLURGIA Ottimizzazione di
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE, NUCLEARI E AREONAUTICHE E DI METALLURGIA Ottimizzazione di
I n s e g n a m e n t o d i BIOMECCANICA
 A A 2 0 1 3-2014 U N I V E R S I TA D E G L I S T U D I DI R O M A T O R V E R G ATA F A C O LTA DI M E D I C I N A E C H I R U R G I A L A U R E A T R I E N N A L E I N S C I E N Z E M O T O R I E I n
A A 2 0 1 3-2014 U N I V E R S I TA D E G L I S T U D I DI R O M A T O R V E R G ATA F A C O LTA DI M E D I C I N A E C H I R U R G I A L A U R E A T R I E N N A L E I N S C I E N Z E M O T O R I E I n
TRACCE DI ESAME: Manovre in Volo e Stabilita Statica TRACCIA 1) Parte A) Siano date le seguenti caratteristiche di un velivolo:
 TRACCE DI ESAME: Manovre in Volo e Stabilita Statica TRACCIA 1) Parte A) W=850 Kg S w =14 m 2 C Lcrociera =.2 C LMAX =2.2 e supponendo un n max =4.5 Determinare: 1) Massimo angolo di rollio in virata 2)
TRACCE DI ESAME: Manovre in Volo e Stabilita Statica TRACCIA 1) Parte A) W=850 Kg S w =14 m 2 C Lcrociera =.2 C LMAX =2.2 e supponendo un n max =4.5 Determinare: 1) Massimo angolo di rollio in virata 2)
MANUALE ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEI MOTORI TUBOLARI ELETTRONICI
 MANUALE ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEI MOTORI TUBOLARI ELETTRONICI www.bruelmotion.com SICUREZZA NOTE IMPORTANTE: Per garantire la sicurezza è necessario effettuare una corretta installazione,
MANUALE ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEI MOTORI TUBOLARI ELETTRONICI www.bruelmotion.com SICUREZZA NOTE IMPORTANTE: Per garantire la sicurezza è necessario effettuare una corretta installazione,
AXSO Advanced Xolutions for Stability Onboard
 AXSO Advanced Xolutions for Stability Onboard Il sistema AXSO è stato studiato, realizzato e brevettato da Agency Impianti in collaborazione con alcune altre aziende specializzate in differenti settori.
AXSO Advanced Xolutions for Stability Onboard Il sistema AXSO è stato studiato, realizzato e brevettato da Agency Impianti in collaborazione con alcune altre aziende specializzate in differenti settori.
Calcolo dei calastrelli e delle diagonali
 1 Calcolo dei calastrelli e delle diagonali La funzione dei calastrelli e delle diagonali è quella di conferire un elevata rigidità all asta composta, con una notevole limitazione della sua inflessione
1 Calcolo dei calastrelli e delle diagonali La funzione dei calastrelli e delle diagonali è quella di conferire un elevata rigidità all asta composta, con una notevole limitazione della sua inflessione
L ENERGIA E LA QUANTITÀ DI MOTO
 L ENERGIA E LA QUANTITÀ DI MOTO Il lavoro In tutte le macchine vi sono forze che producono spostamenti. Il lavoro di una forza misura l effetto utile della combinazione di una forza con uno spostamento.
L ENERGIA E LA QUANTITÀ DI MOTO Il lavoro In tutte le macchine vi sono forze che producono spostamenti. Il lavoro di una forza misura l effetto utile della combinazione di una forza con uno spostamento.
Compito di Fisica Generale (Meccanica) 25/01/2011
 Compito di Fisica Generale (Meccanica) 25/01/2011 1) Un punto materiale di massa m è vincolato a muoversi su di una guida orizzontale. Il punto è attaccato ad una molla di costante elastica k. La guida
Compito di Fisica Generale (Meccanica) 25/01/2011 1) Un punto materiale di massa m è vincolato a muoversi su di una guida orizzontale. Il punto è attaccato ad una molla di costante elastica k. La guida
PLE DPI
 PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI INDICE Accordo Stato Regioni 22/02/2012: Attrezzature da lavoro 2.1 Categorie di PLE 2.2 Componenti strutturali 2.3 Dispositivi di comando e sicurezza 2.4 Controlli prima
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI INDICE Accordo Stato Regioni 22/02/2012: Attrezzature da lavoro 2.1 Categorie di PLE 2.2 Componenti strutturali 2.3 Dispositivi di comando e sicurezza 2.4 Controlli prima
MODULO BIMESTRALE N.1:Le Grandezze in Fisica
 CLASSE PRIMAFISICA MODULO BIMESTRALE N.1:Le Grandezze in Fisica Conoscere il concetto di grandezza, di misura, di unità di misura, di equivalenza e gli strumenti matematici per valutare le grandezze. ABILITA
CLASSE PRIMAFISICA MODULO BIMESTRALE N.1:Le Grandezze in Fisica Conoscere il concetto di grandezza, di misura, di unità di misura, di equivalenza e gli strumenti matematici per valutare le grandezze. ABILITA
REGOLATORI DI PORTATA
 Regolatori a Portata Costante Circolare Regolatori a Portata Costante Rettangolare Regolatore a Portata Variabile Circolare Regolatore a Portata Variabile Rettangolare condizionamento - riscaldamento -
Regolatori a Portata Costante Circolare Regolatori a Portata Costante Rettangolare Regolatore a Portata Variabile Circolare Regolatore a Portata Variabile Rettangolare condizionamento - riscaldamento -
* Aprifinestra per evacuatori di fumo di gradi dimensioni con angolo apertura 90 /100
 KIT COMPONENTI PER APERTURA AUTOMATICA EVACUATORI DI FUMO VERTICALI CON CERNIERA IN BASSO AMMORTIZZATORI CON MOLLA MECCANICA E SISTEMA DI BLOCCO TRAMITE ELETTROMAGNETE E RILEVATORE DI FUMO TEMPERATURA
KIT COMPONENTI PER APERTURA AUTOMATICA EVACUATORI DI FUMO VERTICALI CON CERNIERA IN BASSO AMMORTIZZATORI CON MOLLA MECCANICA E SISTEMA DI BLOCCO TRAMITE ELETTROMAGNETE E RILEVATORE DI FUMO TEMPERATURA
2. Si Discretizzano i carichi in CARICHI CONCENTRATI in modo da riprodurre gli andamenti delle azioni interne. Si opera in pi passi: 2a.
 1 Prove Statiche Permettono la verifica del comportamento elastico struttura allo scopo di validare il modello numerico Le prove prevedono: 1. Struttura completa (full-scale) Sottostruttura (Es. solo centina,
1 Prove Statiche Permettono la verifica del comportamento elastico struttura allo scopo di validare il modello numerico Le prove prevedono: 1. Struttura completa (full-scale) Sottostruttura (Es. solo centina,
CENTRALI FRIGORIFERE RISPARMIO ENERGETICO. Firenze, 17 maggio 2013
 CENTRALI FRIGORIFERE NUOVE TECNOLOGIE E RISPARMIO ENERGETICO Firenze, 17 maggio 2013 La portata d acqua variabile nei circuiti frigoriferi primari e secondari Diego Danieli Libero Professionista - Venezia
CENTRALI FRIGORIFERE NUOVE TECNOLOGIE E RISPARMIO ENERGETICO Firenze, 17 maggio 2013 La portata d acqua variabile nei circuiti frigoriferi primari e secondari Diego Danieli Libero Professionista - Venezia
La distribuzione pagina 2651
 2.1.13 La distribuzione pagina 2651 La distribuzione ha il compito di comandare il momento e la durata dell aspirazione della miscela ariacarburante e il momento e la durata dell espulsione dei gas di
2.1.13 La distribuzione pagina 2651 La distribuzione ha il compito di comandare il momento e la durata dell aspirazione della miscela ariacarburante e il momento e la durata dell espulsione dei gas di
