I risultati dello studio
|
|
|
- Silvio Alfano
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 I risultati dello studio Materiali e metodi Le stazioni di indagine Le stazioni di campionamento sono localizzate nella zona nord del F. Bacchiglione, più precisamente la Stazione 1 è situata in una delle risorgive che unendosi formano il F. Bacchiglioncello. La Stazione 2 è situata sul F. Bacchiglioncello, alcune centinaia di metri a valle dell impianto di troticoltura. La Stazione 3 è situata sul T. Timonchio poco più a monte della confluenza con il F: Bacchiglioncello; mentre la quarta ed ultima è situata a valle del Ponte di Vivaro (Figura 1). Figura 1 AQUAPROGRAM srl Via Borella Vicenza 27
2 Le coordinate geografiche (Datum di riferimento WGS 84) delle stazioni di campionamento sono riportati nella Tabella 1. Tabella 1 Stazione Latitudine Longitudine Stazione 1 45, , Stazione 2 45, , Stazione 3 45, , Stazione 4 45, , In tutte le stazioni sono state effettuati campionamenti con cadenza trimestrale per quanto riguarda l ittiofauna, la chimica, la microbiologia e l ecotossicologia. Le analisi delle macrofite acquatiche sono state effettuate esclusivamente ad aprile e ad agosto. Analisi chimico-fisiche e microbiologiche I campionamenti per le analisi chimico-fisiche sono stati eseguiti con cadenza trimestrale in tutte e quattro le stazioni di campionamento. Alcuni parametri sono stati rilevati direttamente in situ mentre altri in laboratorio. I parametri rilevati nel posto sono stati la temperatura superficiale e l ossigeno disciolto (sia in ppm che percentuale di saturazione); mentre la misura del ph, fosforo totale, conducibilità elettrica, azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, C.O.D. sono stati eseguiti in laboratorio seguendo i metodi analitici ufficiali. Più precisamente la analisi della conducibilità elettrica è stata eseguita utilizzando il metodo APAT/IRSA CNR 2030 (2003), per l analisi del ph il metodo APAT/IRSA CNR 2060 (2003) mentre per quella dell ammoniaca (come ione NH4+) è stato applicato il metodo APAT/IRSA CNR 4030A1/ 03 modificato (M. I. 62). Per l azoto nitrico (come N) si è utilizzato il metodo APAT/IRSA CNR 4050/ 03 modificato (M. I. 06). Per il fosforo totale è stato utilizzato il metodo APAT/IRSA CNR / 03 modificato (M. I. 08). Infine la misura del C.O.D. è stata rilevata utilizzando il metodo APAT/IRSA CNR 5130/ 03 modificato (M. I. 03). La misura della temperatura superficiale sono state eseguite in loco con sonda Delta OHM mod. HD Per la determinazione della concentrazione di ossigeno disciolto si è utilizzato il metodo amperometrico (ossimetro portatile Handy Gamma OxyGuard). AQUAPROGRAM srl Via Borella Vicenza 28
3 L unico parametro microbiologico rilevato è stato Escherichia coli, un importante indicatore di contaminazione fecale. Il campionamento è stato eseguito in tutte e quattro le stazioni di campionamento in quattro periodi dell anno. I campioni sono stati conservati durante il trasporto in idonei contenitori refrigerati. La misura degli E. coli è stata eseguita in laboratorio seguendo il metodo analitico per le acque dell ARPA (ISO ). La maggior parte di questi parametri corrisponde ai macrodescrittori che nell Allegato 1 del Decreto Legislativo n 152 del 1999 definiscono i Livelli di Inquinamento (L.I.M.) da utilizzare per la classificazione delle acque superficiali. I livelli a cui si fa riferimento sono 5, dove il primo livello (Livello 1) definisce una elevata qualità dell acqua e l ultimo (Livello 5) una pessima qualità. Il metodo di classificazione finale prevede il calcolo del 75 percentile sull insieme dei dati ottenuti in un certo periodo di monitoraggio. IBE In questo studio è stato utilizzato l'indice biologico I.B.E. (Ghetti, 1997) che costituisce il metodo di controllo biologico dei corsi d'acqua ufficialmente sancito dalla normativa specifica attualmente in vigore nel nostro paese (D.Lgs. 152/99), ma che comunque era già previsto. nel D.Lgs. 130/1992. L'I.B.E. deriva dal Trent Biotic Index (Woodiwiss, 1964), aggiornato come Extended Biotic Index E.B.I. (Woodiwiss, 1978). In Italia è stato introdotto, e tarato alle esigenze zoogeografiche locali grazie alle ricerche del Prof. Ghetti dell'università di Venezia; recentemente il metodo è stato rivisto e ricalibrato dallo stesso autore sulla base delle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche. L'Indice Biotico Esteso (I.B.E.), così come è stato ridefinito, prevede delle modificazioni rispetto al precedente che riguardano: declassamento del genere Leuctra, la definizione del livello tassonomico di determinazione per alcune Unità Sistematiche e il numero minimo di individui ritrovati per considerare l'ambiente colonizzato dal taxon. Al 1997 risale la stesura definitiva ed aggiornata del Manuale di Applicazione dell'indice Biotico Esteso, attualmente in uso da coloro che operano nel campo del monitoraggio biologico dei corsi d'acqua (Ghetti, 1997). Le valutazioni delle biocenosi bentoniche, risentendo di possibili variazioni ambientali, consentono di ottenere una zonazione dell'asta fluviale in funzione dello stato di qualità ambientale. Ciò è possibile attraverso un indice sintetico, riconducibile a cinque classi di qualità opportunamente trasferibili in cartografia. L'I.B.E. fornisce un giudizio complementare al controllo fisico, chimico e microbiologico. Mentre questi tipi di analisi individuano le singole cause e la dinamica del processo di alterazione dell'acqua e dei sedimenti (stima del rischio ambientale), il monitoraggio biologico, invece, verifica sinteticamente gli effetti di insieme prodotti dal complesso delle cause inquinanti (analisi degli AQUAPROGRAM srl Via Borella Vicenza 29
4 effetti reali). Esso permette così di valutare le capacità autodepurative in tratti di corsi d'acqua soggetti a carichi inquinanti continui o temporanei. Attraverso l'i.b.e. si possono classificare i corsi d'acqua lungo il profilo longitudinale, in cinque classi di qualità in modo da ottenere un quadro di insieme utile sia alla programmazione degli interventi risanatori, sia ad una corretta pianificazione del sistema di monitoraggio fisico, chimico ed igienistico; si può.così controllare nel tempo l'efficacia degli interventi risanatori stessi attraverso il recupero della qualità ambientale dei corpi idrici. L'I.B.E. si basa sull'analisi della struttura delle comunità di macroinvertebrati bentonici che colonizzano le differenti tipologie fluviali. Con organismi macroinvertebrati bentonici si intendono, convenzionalmente, quegli organismi che vengono trattenuti da un retino con 21 maglie per centimetro. La scelta di questi organismi come indicatori è legata alle seguenti ragioni: si tratta di organismi ubiquitari, relativamente facili da campionare e da identificare; numerose specie sono inoltre sensibili all'inquinamento ed esiste una conoscenza approfondita della loro autoecologia; hanno una durata di vita abbastanza lunga e possono quindi registrare gli eventi che si susseguono nell'ambiente che occupano; vivono poi preferibilmente sui substrati e non sono soggetti a migrazioni continue cosicché possono riflettere con immediatezza la qualità dell'acqua e del sedimento. I taxa considerati ed il livello di determinazione tassonomica richiesto dall'indice I.B.E., sono riportati nella Tabella 2. Per Unità Sistematica (U.S.) si intende il livello di determinazione sistematica definito dal metodo. Il livello si riferisce al genere o alla famiglia; è evitata pertanto una classificazione degli organismi fino al livello di specie, considerato limitante. per un'indagine con finalità pratiche anche se, talvolta, risulterebbe interessante per un'analisi più prettamente zoologica dell'ambiente considerato. Il calcolo dell'i.b.e. richiede che siano rigorosamente rispettati i limiti di definizione tassonomica per i vari gruppi, altrimenti la "ricchezza in taxa" delle comunità potrebbe variare a seconda del grado dì approfondìmento della classificazione. Il numero totale delle Unità Sistematiche di una determinata stazione, cioè la "ricchezza in taxa" della stazione stessa, non tiene conto delle Unità Sistematiche a cui appartengono organismi eventualmente trasportati a valle definiti "di drift", che rappresentano solo presenze occasionali o temporanee; essi risultano determinati dall'indicazione sul numero minimo di presenze che permettono di considerare l'organismo come appartenente in modo stabile alla comunità. AQUAPROGRAM srl Via Borella Vicenza 30
5 Tabella 2 Gruppi faunistici PLECOTTERI TRICOTTERI EFEMEROTTERI COLEOTTERI ODONATI DITTERI ETEROTTERI CROSTACEI GASTEROPODI BIVALVI TRICLADI IRUDINEI OLIGOCHETI Livelli di determinazione Tassonomica per definire le Unità Sistematiche in I.B.E. Genere Genere Genere Genere Genere Altri taxa da considerare nel calcolo dell I.B.E. Sialidae (MEGALOTTERI) Osmylidae (PLANIPENNI) Gordiidae (NEMATOMORFI) Prostoma (NEMERTINI) Tale numero minimo di presenze è definito dal protocollo del metodo ed è ricavabile dalle apposite tabelle riportate nel manuale di applicazione. Per il calcolo del valore dell indice si utilizza una tabella che permette di tradurre dati e considerazioni comprensibili solo agli specialisti, in un valore numerico. Si tratta di una tabella a doppia entrata (Tabella 3). L entrata orizzontale considera l aspetto di sensibilità agli inquinanti, mentre l entrata verticale tiene conto del grado di biodiversità e considera il numero totale di taxa che costituiscono la comunità. L'indice fornisce valori discreti, ma il metodo permette l'apprezzamento di livelli intermedi che riflettono situazioni di passaggio fra due condizioni. I valori intermedi di indice consentono così di fornire alla scala dell'i.b.e. una maggiore continuità, evitando stacchi eccessivi fra i valori di indice. I valori decrescenti dell'indice vanno intesi come un progressivo allontanamento da una condizione "ottimale o attesa", definita dalla composizione della comunità che, in condizioni di "buona efficienza dell'ecosistema", dovrebbe colonizzare quella determinata tipologia fluviale. La composizione "attesa" varia ovviamente a seconda dalla tipologia fluviale considerata. AQUAPROGRAM srl Via Borella Vicenza 31
6 Tabella 3 Numero totale delle Unità Sistematiche costituenti Gruppi Faunistici che determinano con la la comunità (secondo ingresso) loro presenza l'ingresso orizzontale in tabella (primo ingresso) più di una U.S * 14* Plecotteri presenti - (Leuctra ) una sola U.S * Efemerotteri presenti più di una U.S (escludere Baetidae, - Caenidae) una sola U.S Tricotteri presenti più di una U.S. (comprendere Baetidae - una sola U.S. e Caenida)e Gammaridi e/o Atiidi tutte le U.S. sopra e/o Palemonidi presenti assenti Asellidi e/o Nifhargidi tutte le U.S. sopra presenti assenti tutte le U.S. sopra Oligocheti o Chironomidi assenti Altri organismi tutte le U.S. sopra assenti Legenda: : nelle comunità in cui Leuctra è presente come unico taxon di Plecotteri e sono contemporaneamente assenti gli Efemerotteri (o presenti solo Baetidae e Caenidae), Leuctra deve essere considerata a livello dei Tricotteri per definire l'entrata orizzontale in tabella; : per la definizione dell'ingresso orizzontale in tabella le famiglie Baetidae e Caenidae vengono considerate a livello dei Tricotteri; -: giudizio dubbio, per errore di campionamento, per presenza di organismi di drift erroneamente considerati nel computo, per ambiente non colonizzato adeguatamente, per tipologie non valutabili con l I.B.E. (es. sorgenti, acque di scioglimento dei nevai, acque ferme, zone deltizie, salmastre); *: questi valori di indice vengono raggiunti raramente nelle acque correnti italiane per cui occorre prestare attenzione, sia nell'evitare la somma di biotipologie (incremento artificioso della ricchezza in taxa), sia nel valutare gli effetti prodotti dall'inquinamento trattandosi di ambienti con elevata ricchezza in taxa Mediante l utilizzo di un altra specifica tabella, il valore dell I.B.E., è stato convertito nella corrispondente classe di qualità. I valori di I.B.E. sono raggruppati in cinque Classi di Qualità (C.Q.), ciascuna individuata da un numero romano come indicato nella Tabella 4. AQUAPROGRAM srl Via Borella Vicenza 32
7 Tabella 4 Classi di qualità Valore di I.B.E. Giudizio di qualità Colore relativo alla Classe di qualità Classe I Classe II 8-9 Ambiente non alterato in modo sensibile Ambiente con moderati sintomi di alterazione azzurro verde Classe III 6-7 Ambiente alterato giallo Classe IV 4-5 Ambiente molto alterato arancione Classe V Ambiente fortemente degradato rosso Queste classi consentono la rappresentazione dei corsi d'acqua mediante cinque intervalli di giudizio, piuttosto ampi e quindi meno soggetti, rispetto all'indice numerico, agli errori ricorrenti in una valutazione così complessa. Anche per le Classi di Qualità possono venire espressi livelli di giudizio intermedi fra due Classi di Qualità. Inoltre le cinque Classi di Qualità possono essere facilmente visualizzate in cartografia mediante colori convenzionali (azzurro, verde, giallo, arancione, rosso) o altro simbolismo grafico. I valori intermedi fra le classi vengono rappresentati mediante tratteggio formato dai colori corrispondenti alle due classi. Questo artificio grafico consente di rappresentare direttamente in cartografia il giudizio sullo stato di qualità di un determinato tratto di corso d'acqua. Analisi ecotossicologiche Il settore dell ecotossicologia è stato sviluppato a partire dagli anni 90, in seguito alla necessità di adeguare le potenzialità analitiche del laboratorio alle nuove esigenze legislative (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152). Le matrici che possono essere indagate sono sia liquide che solide. In particolare modo vengono monitorati i reflui civili, gli scarichi industriali, le acque superficiali, oltre ai composti di sintesi ed ai sedimenti, sia di ambienti lacustri che fluviali. Per l esecuzione dei test di tossicità vengono utilizzati diversi organismi, i quali rappresentano i diversi livelli della catena alimentare: produttori, consumatori, decompositori; tra i quali l alga verde unicellurare Pseudokirchneriella subcapitata (ex Selenastrum capricornutum), il piccolo crostaceo d acqua dolce Daphnia magna, il rotifero Brachionus calyciflorus e i batteri bioluminescenti della specie Vibrio fischeri. AQUAPROGRAM srl Via Borella Vicenza 33
8 Nel presente studio sono stati utilizzati i test di ecotossicologia con la Daphnia magna, con Brachionus calyciflorus e con Vibrio fischeri. I test utilizzati sono: Test di tossicità acuta con Daphnia magna (metodo UNI EN ISO 6341:1999) L organismo utilizzato per il saggio è il crostaceo cladocero della specie Daphnia magna Straus, molto sensibile soprattutto all inquinamento da metalli pesanti (piombo, cadmio, zinco, rame ecc.). I neonati di meno di 24h vengono immessi nel campione da analizzare e dopo un periodo di tempo prestabilito si osserva la percentuale di individui sopravvissuti. I risultati possono sono espressi o come percentuale di individui morti/immobilizzati Il giudizio di accettabilità del campione in esame viene dato quando al termine delle 24 ore la somma degli organismi immobili risulta inferiore al 50%; se è pari o superiore al 50% il campione viene giudicato inaccettabile. Test di tossicità acuta con Brachionus calyciflorus (metodo ASTM E ) L organismo utilizzato per il saggio è il rotifero della specie Brachionus calyciflorus, molto sensibile all inquinamento. I neonati di meno di 24h vengono immessi nel campione da analizzare e dopo un periodo di tempo prestabilito (24h o 48h) si osserva la percentuale di individui sopravvissuti. I risultati possono sono espressi come percentuale di individui morti/immobilizzati. Il giudizio relativo ai campioni di cui sopra è stato formulato facendo riferimento ai criteri sotto riportati adottati dall ARPA del Piemonte e comunemente utilizzati per matrici ambientali quali acqua e suolo (rif.: Classi di Tossicità di Kenaga KENAGA E.E. Environ. Science and Tech ) Tabella 5 % di effetto del campione Giudizio di tossicità <= 20% Assenza di tossicità acuta >20% < 50% Debolmente tossico 50% Tossico Test di tossicità acuta con i batteri bioluminescenti della specie Vibrio fischeri (metodo APAT: 8030 Man ) Il test con batteri bioluminescenti sfrutta la naturale capacità di un gruppo di batteri marini appartenenti alla specie Vibrio fischeri di emettere luce se si trovano nelle condizioni ottimali. Attraverso uno specifico strumento, il luminometro, vengono effettuate delle misure AQUAPROGRAM srl Via Borella Vicenza 34
9 di luminescenza a dei tempi rispettivamente di 5, 15 e 30 minuti. La presenza di sostanze inibenti si manifesta mediante una riduzione della bioluminescenza proporzionale alla tossicità del campione in esame. Il limite allo scarico in acque superficiali è di 50% di inibizione. Analisi vegetazionale Le macrofite acquatiche sono un gruppo definito su base ecologico-funzionale e comprendono i vegetali macroscopicamente visibili presenti negli ambienti acquatici, palustri e di greto che caratterizzano gli ambiti fluviali. Oltre al loro importante ruolo ecologico, l uso delle macrofite come indicatrici della qualità delle acque correnti si basa sul fatto che alcune specie e gruppi di specie sono sensibili alle alterazioni dei corpi idrici e risentono in modo differente dell impatto antropico. Pertanto, l analisi della comunità di macrofite fornisce, sulla base delle variazioni dei popolamenti macrofitici presenti, indicazioni complessive sulla qualità dell acqua e sul livello di alterazione dei corpi idrici. Le macrofite sono una componente importante degli ecosistemi fluviali e possono essere utilizzate per rendere possibile il monitoraggio del loro stato ecologico. L utilizzo di questi organismi nel monitoraggio è richiesto da numerose norme europee e nazionali (Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e D.Lgs 152/2006, Direttiva sul Trattamento delle acque di scarico urbane 91/271/EEC, Direttiva Nitrati 91/676/EEC). Gli indici basati sull uso delle macrofite acquatiche danno indicazioni complessive sulla qualità dell acqua e sul livello di alterazione dei corpi idrici presenti. Gli indici utilizzati nel presente studio sono definiti indici a punteggio perché si fondano sull attribuzione di coefficienti numerici specifici ad un certo numero di taxa. Indice GIS (Groupement d Interet Scientifique, Haury et al., 1996) L indice GIS prevede l effettuazione di un inventario delle specie vegetali presenti tra maggio e ottobre su tratti fluviali di lunghezza minima di 50 m, possibilmente omogenei dal punto di vista delle condizioni di flusso e di ombreggiamento. Il rilievo viene fatto nella zona acquatica, ma è possibile effettuare dei campionamenti complementari anche nella zona sopra-acquatica. Le alghe vengono identificate a livello di genere, mentre la determinazione di briofite e piante vascolari viene richiesta fino a livello di specie. Per ogni taxon rinvenuto nel sito viene fatta anche una stima del grado di copertura. Le percentuali così ottenute vengono utilizzate per attribuire alle diverse macrofite dei coefficienti di copertura, seguendo la scala di abbondanza-dominanza, utilizzata negli studi fitosociologici (Braun-Blanquet 1964, Guinochet 1973). Oltre al coefficiente di abbondanza-dominanza il metodo prevede un punteggio (Cotes Spécifiques CSi) da assegnare ad ogni taxon indicatore sulla base di una tabella di riferimento. Tale punteggio va da un minimo di 0, assegnato a taxa che vivono in acque molto degradate con forte inquinamento organico, ad un massimo di 10, AQUAPROGRAM srl Via Borella Vicenza 35
10 per specie che colonizzano ambienti con buona qualità dell acqua, senza segni rilevabili di inquinamento. L indice GIS per la zona acquatica si calcola secondo la seguente formula: GIS = (Σ ADi CSi)/ Σ ADI Il valore dell indice GIS può variare tra 1 e 10 secondo un gradiente di sensibilità crescente. L indice GIS in origine (Haury et al., 1996) non permetteva una classificazione diretta del corso d acqua ma era utilizzato per fornire delle indicazioni sulla trofia dell ambiente acquatico (concentrazione di azoto ammoniacale e di ortofosfati nella stazione rilevata). Il GIS attualmente utilizzato fa riferimento ad una scala di trofia che consente una facile lettura dei dati rilevati, trasferendoli su una scala colorimetrica. Tabella 6: scala a 5 intervalli per l indice GIS. (ENEA, 2003) Valore GIS Livello trofico Colore 8,2 < GIS <= 10 Molto basso 6,4 < GIS <= 8,2 Basso 4,6 < GIS <= 6,4 Medio 2,8 < GIS <= 4,6 Elevato GIS <= 2,8 Molto elevato Indice IBMR (Indice Biologique Macrophytique en Riviere, AFNOR, 2003): Anche questo metodo prevede l osservazione in situ dei popolamenti macrofitici, con identificazione dei taxa ed una stima della copertura (coefficiente di copertura Ki), con eventuale prelievo dei campioni per una verifica tassonomica. Il metodo prevede l assegnazione, ad una lista di specie considerate significative, di un punteggio specifico di oligotrofia (Csi) che va da 1 a 20 e di un coefficiente di stenoecìa (Ei) che va da 1 a 3. Si calcola L IBMR secondo la seguente formula: IBMR = (Σ Ei Ki CSi) / Σ Ei Ki Una volta ottenuto il valore di IBMR, sulla base di questo dato è possibile classificare la relativa stazione, in termini di livello trofico dell acqua. AQUAPROGRAM srl Via Borella Vicenza 36
11 Tabella 7: categorie trofiche per la classificazione della stazione sulla base del valore IBMR, con relativo colore per la rappresentazione (da AFNOR, 2003) Valore IBMR Livello trofico Colore > 14 Molto basso 2 < IBMR <= 14 Basso 10 < IBMR <= 12 Medio 8 < IBMR <= 10 Elevato <= 8 Molto elevato Il rilievo della vegetazione macrofitica è quali-quantitativo a scala di stazione ed è stato effettuato su un tratto di 50 metri, in corrispondenza dei transetti di campionamento del macrobenthos, prendendo in considerazione le piante della zona acquatica (l alveo bagnato). La copertura totale della comunità è espressa in termini di copertura percentuale della comunità macrofitica rispetto alla superficie dell alveo bagnato. Analisi ittiofaunistiche I campionamenti di tipo quantitativo, necessari per poter effettuare delle stime di biomassa e densità ittica, hanno riguardato tutte e quattro le stazioni di campionamento. Operativamente i campionamenti della fauna ittica sono stati realizzati utilizzando degli elettrostorditori portatili di varia potenza ( V; A); sono stati campionati tratti di fiume con lunghezze variabili; la scelta della lunghezza del tratto da controllare veniva effettuata di volta in volta in funzione della variabilità ambientale presente e del tipo di materiale raccolto. A tutti gli animali catturati è stata rilevata la lunghezza alla forca caudale con la precisione di un millimetro ed il peso, con la precisione di un grammo. Inoltre su un sub-campione rappresentativo delle varie taglie si è provveduto al prelievo delle scaglie e alla determinazione dell'età per mezzo della lettura al microscopio. Alcuni sono stati trattenuti e portati in laboratorio per lo studio della fertilità. Le campagne di campionamento sono state in quattro periodi dell'anno (fine Aprile 2007, inizio Settembre 2007, metà Novembre 2008 e inizio marzo 2008) in modo da poter evidenziare eventuali cambiamenti popolazionali legati alle diverse esigenze e valenze ecologiche delle specie ittiche presenti (Pitcher and Hart, 1982). Stime della densità di popolazione sono state ottenute con il metodo dei passaggi ripetuti, Removal Method (Beverton e Holt, 1978; Penczak et al., 1981); in alcuni casi è stato effettuato un singolo passaggio e si è utilizzato il valore di p (coefficiente di catturabilità determinato come 1 - (C 2 /C 1 ) nel caso di due passaggi successivi) per ottenere la stima finale. AQUAPROGRAM srl Via Borella Vicenza 37
12 In laboratorio sono state quindi determinate, oltre all'età, anche gli accrescimenti in peso e lunghezza, la mortalità, la densità e la biomassa per classe di età e/o complessive e la produzione ittica, utilizzando le formulazioni riassunte in Ricker W.E. (1975) ed in Marconato A. et al. (La Carta Ittica della Provincia di Vicenza, 1990). Per età di un pesce propriamente detta, indicata generalmente in mesi o in anni, si intende il periodo di tempo trascorso tra la probabile data di nascita, derivata dalla conoscenza della biologia della specie, e la data della sua cattura (FAO, 1981). La classe d età indica, in anni, l età del pesce a partire dalla data di nascita stabilita arbitrariamente (FAO, 1981): così ad esempio la classe di età 0+ raggruppa gli esemplari che sono nel loro primo anno solare di vita (cioè da 0 a 12 mesi), la classe di età 1+ comprende i pesci che sono nel loro secondo anno solare di vita (da 12 mesi e un giorno a 24 mesi, e così via. Generalmente la classe di età si considera piena (classe di età 1, 2 ecc.) quando l animale viene catturato durante il periodo riproduttivo. Nei Teleostei la determinazione dell età viene di norma effettata mediante l interpretazione ed il conteggio delle zone di accrescimento presenti sulle parti dure del corpo (Cailliet, 1986; Bagenal, 1974; FAO, 1981). Nei pesci, infatti, l accrescimento e la mineralizzazione delle strutture calcificate (ossa, scaglie, otoliti) sono eventi ritmici e discontinui. Sono soprattutto le variazioni di temperatura che, influendo sul metabolismo dei pesci, provocano cambiamenti del ritmo di deposizione di tessuto osseo. Altri fattori determinanti sono la disponibilità di cibo e la riproduzione (Cailliet et al., 1986). In molti Teleostei delle zone temperate è dunque possibile riscontrare un modello di accrescimento a periodicità annuale. L analisi scalimetrica costituisce il metodo classico per lo studio dell accrescimento nelle popolazioni di varie specie ittiche (Berg e Grimaldi, 1967). La maggior parte delle specie presenti nell area di studio possiede scaglie cicloidi di media grandezza sulla cui superficie è evidenziata una serie di linee curve concentriche che durante la vita dell animale si accrescono in numero dal centro di ossificazione, denominato nucleo, verso la periferia. Vengono definiti circuli quei rilievi che si evidenziano sulla superficie della scaglia come linee scure concentriche, mentre per zona annuale la regione concentrica della scaglia corrispondente ad un intero anno di vita. Per banda si intende quella regione della scaglia, caratterizzata da una serie di circuli irregolari, che si è formata durante un certo periodo dell anno; è possibile dunque definire una banda estiva (summer band), caratterizzata da circuli più spaziati, ed una invernale (winter band), caratterizzata da circuli più ravvicinati. La linea, reale o teorica, che separa due successive zone annuali viene detta annulus. La lettura delle scaglie degli esemplari campionati è stata effettuata in laboratorio utilizzando un microscopio ottico; per questa operazione, le scaglie, opportunamente pulite dai residui di epidermide sono state messe in capsule Petri con acqua distillata. AQUAPROGRAM srl Via Borella Vicenza 38
13 Nei pesci l accrescimento, stimato a partire dai dati di lunghezza alle varie età, può essere espresso con funzioni diverse (Ricker, 1979); il modello di crescita più utilizzato è quello proposto da von Bertalanffy (1957): L = L t (1 e k ( t t0 ) ) Dove: L t è la lunghezza dell individuo all età t; L è la lunghezza asintotica dei pesci molto (infinitamente) vecchi; K è il coefficiente di curvatura, cioè quanto veloce è l approccio alla lunghezza infinita; t 0 è il momento in cui il pesce ha lunghezza zero. Gli ovari delle femmine di vairone e di barbo campionate sono stati analizzati in laboratorio ai fini del calcolo della fecondità assoluta e di quella relativa. La fecondità assoluta (F.A.) esprime il numero totale di uova per individuo, mentre quella relativa (F.R.) fornisce il valore del numero totale delle uova, espresso relativamente a kg di femmina: F.A. = Nt/P dove: Nt = numero totale di uova P = peso della femmina in kg I dati di fecondità vengono usati per calcolare il potenziale riproduttivo di una popolazione. Questo permette di stimare le dimensioni minime della popolazione adulta per sostenere il reclutamento di cui ha bisogno. Si possono anche usare (assieme alla sex ratio degli adulti) per stimare le dimensioni dello stock (Caillet et al., 1986). Il metodo utilizzato per il conteggio delle uova è quello gravimetrico (Caillet et al., 1986). Questo si basa sul prelievo di un sottocampione preso dalle gonadi, del quale viene determinato il peso tramite bilancia analitica (precisione ± g) e conteggiato il numero delle uova. Dalla proporzione tra il peso totale, il peso ed il numero di uova del sottocampione è stato possibile ricavare il numero totale delle uova: Nt = Po/(Ps/Ns) dove: Nt = numero totale di uova Po = peso delle ovaie Ps = peso del sottocampione delle ovaie Ns = numero di uova del sottocampione AQUAPROGRAM srl Via Borella Vicenza 39
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica
 Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI OSSERVAZIONE
 IL FIUME BREGGIA NEL TERRITORIO ITALIANO A. M. Brambilla, A. Dal Mas, C. Malacrida, B. Paleari, E. Pizzotti (ARPA Lombardia Dipartimento Provinciale di Como) 1. INTRODUZIONE La relazione intende presentare
IL FIUME BREGGIA NEL TERRITORIO ITALIANO A. M. Brambilla, A. Dal Mas, C. Malacrida, B. Paleari, E. Pizzotti (ARPA Lombardia Dipartimento Provinciale di Como) 1. INTRODUZIONE La relazione intende presentare
I RISULTATI WQI 1) BOD
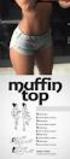 WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELLE ACQUE: COME INTERPRETARE I DATI
 MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELLE ACQUE: COME INTERPRETARE I DATI All interno del progetto denominato I Sentieri dell Acqua una delle attività effettuate è stata il monitoraggio della qualità acquatica
MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELLE ACQUE: COME INTERPRETARE I DATI All interno del progetto denominato I Sentieri dell Acqua una delle attività effettuate è stata il monitoraggio della qualità acquatica
Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci
 Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci Dott.. Ferdinando De Rosa, Presidente Ordine Regionale dei Chimici delle Marche Direttore Tecnico Scientifico ARPAM
Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci Dott.. Ferdinando De Rosa, Presidente Ordine Regionale dei Chimici delle Marche Direttore Tecnico Scientifico ARPAM
I Saggi Tossicologici di Laboratorio
 1 I Saggi Tossicologici di Laboratorio In Ecotossicologia é necessario estrapolare dai risultati degli esperimenti di laboratorio agli ecosistemi 1 Diversi modelli biologici vengono impiegati per misurare
1 I Saggi Tossicologici di Laboratorio In Ecotossicologia é necessario estrapolare dai risultati degli esperimenti di laboratorio agli ecosistemi 1 Diversi modelli biologici vengono impiegati per misurare
Applicazione dell Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) in alcuni corpi idrici del Friuli Venezia Giulia
 Applicazione dell Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) in alcuni corpi idrici del Friuli Venezia Giulia Pizzul E., D Aietti A., De Marco N., Orlandi C., Zanello A., Zorza R., Mattassi
Applicazione dell Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) in alcuni corpi idrici del Friuli Venezia Giulia Pizzul E., D Aietti A., De Marco N., Orlandi C., Zanello A., Zorza R., Mattassi
Istituto Comprensivo Sandro Pertini Ovada
 Istituto Comprensivo Sandro Pertini Ovada Materiale: Retini Pipette Vaschette Microscopi Vetrini a orologio Stivali in gomma Località del campionamento: Comune di Molare, Torrente Orba nei pressi della
Istituto Comprensivo Sandro Pertini Ovada Materiale: Retini Pipette Vaschette Microscopi Vetrini a orologio Stivali in gomma Località del campionamento: Comune di Molare, Torrente Orba nei pressi della
Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali
 Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - GALLERIA DI SICUREZZA - LOTTO 2 OPERE CIVILI LATO ITALIA
 TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - GALLERIA DI SICUREZZA - LOTTO 2 OPERE CIVILI LATO ITALIA MONITORAGGIO AMBIENTALE - FASE ANTE OPERAM Componente acque sotterranee Obiettivi specifici Descrizione dell area
TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - GALLERIA DI SICUREZZA - LOTTO 2 OPERE CIVILI LATO ITALIA MONITORAGGIO AMBIENTALE - FASE ANTE OPERAM Componente acque sotterranee Obiettivi specifici Descrizione dell area
Studio di Ingegneria Ferrari e Giraudo Corso Nizza 67/A 12100 CUNEO PREMESSA... 2 MONITORAGGIO IN FASE DI CANTIERE... 2
 Sommario PREMESSA... 2 MONITORAGGIO IN FASE DI CANTIERE... 2 MONITORAGGIO IN FASE DI ESERCIZIO... 4 MONITORAGGIO CHIMICO... 4 MONITORAGGIO BIOLOGICO... 5 MONITORAGGIO IDROMORFOLOGICO... 7 Piano di monitoraggio
Sommario PREMESSA... 2 MONITORAGGIO IN FASE DI CANTIERE... 2 MONITORAGGIO IN FASE DI ESERCIZIO... 4 MONITORAGGIO CHIMICO... 4 MONITORAGGIO BIOLOGICO... 5 MONITORAGGIO IDROMORFOLOGICO... 7 Piano di monitoraggio
I fiumi. La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia
 I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
SCUOLA 21 VERIFICA DI BIOLOGIA COGNOME CLASSE DATA NOME
 SCUOLA 21 VERIFICA DI BIOLOGIA COGNOME CLASSE DATA NOME 1 Completa con i termini mancanti. a) L...si occupa delle interazioni tra individui della stessa specie, tra individui di specie diverse e tra gli
SCUOLA 21 VERIFICA DI BIOLOGIA COGNOME CLASSE DATA NOME 1 Completa con i termini mancanti. a) L...si occupa delle interazioni tra individui della stessa specie, tra individui di specie diverse e tra gli
Zaupa S.! "# Boggero A. Rossaro B. Bettinetti R. Buscarinu P. Sesia E.
 Zaupa S.! "# Boggero A. Rossaro B. Bettinetti R. Buscarinu P. Sesia E. Il progetto finanziato per l implementazione della Direttiva 2000/60/CE ha lo scopo di definire lo stato ecologico e il potenziale
Zaupa S.! "# Boggero A. Rossaro B. Bettinetti R. Buscarinu P. Sesia E. Il progetto finanziato per l implementazione della Direttiva 2000/60/CE ha lo scopo di definire lo stato ecologico e il potenziale
Bologna, 11 dicembre Clara Bravi, Regione Lombardia - Pietro Genoni, ARPA Lombardia
 1 Il progetto di gestione - obiettivi Pianificazione ed attuazione delle operazioni di gestione del materiale sedimentato nell invaso (svaso, sfangamento, spurgo). Assicurare il mantenimento e ripristino
1 Il progetto di gestione - obiettivi Pianificazione ed attuazione delle operazioni di gestione del materiale sedimentato nell invaso (svaso, sfangamento, spurgo). Assicurare il mantenimento e ripristino
Esercizio 1.2. n BMI WKS
 Esercizio. E stato effettuata uno studio relativo all indice di massa corporea BMI ( peso kg /statura m) ed al test WKS (distanza percorsa per 6 minuti in m) in un campione di 0 individui femmina con problemi
Esercizio. E stato effettuata uno studio relativo all indice di massa corporea BMI ( peso kg /statura m) ed al test WKS (distanza percorsa per 6 minuti in m) in un campione di 0 individui femmina con problemi
Centrale di Pontelagoscuro: il sistema dei controlli delle acque del Po con sensori biologici
 Centrale di Pontelagoscuro: il sistema dei controlli delle acque del Po con sensori biologici Fernando Gelli Federica Savorelli Federico Brunelli Pier Luigi Trentini LA RICERCA Fin dal febbraio 2001, l
Centrale di Pontelagoscuro: il sistema dei controlli delle acque del Po con sensori biologici Fernando Gelli Federica Savorelli Federico Brunelli Pier Luigi Trentini LA RICERCA Fin dal febbraio 2001, l
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
 DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
MaX - Un applicazione software per il
 UTTS - Centro Ricerche Saluggia Dott. Riccardo Levizzari riccardo.levizzari@enea.it MaX - Un applicazione software per il calcolo dell indice IBMR ai fini della classificazione dello stato ecologico dei
UTTS - Centro Ricerche Saluggia Dott. Riccardo Levizzari riccardo.levizzari@enea.it MaX - Un applicazione software per il calcolo dell indice IBMR ai fini della classificazione dello stato ecologico dei
Il Monitoraggio Marino Costiero nelle Marche: norme e programmi d attuazioned
 Le MARCHE e la qualità del mare Il Monitoraggio Marino Costiero nelle Marche: norme e programmi d attuazioned WORKSHOP Ancona 18 Luglio 2006 Luigi Bolognini Servizio Ambiente e Difesa del Suolo PF Difesa
Le MARCHE e la qualità del mare Il Monitoraggio Marino Costiero nelle Marche: norme e programmi d attuazioned WORKSHOP Ancona 18 Luglio 2006 Luigi Bolognini Servizio Ambiente e Difesa del Suolo PF Difesa
IL MONITORAGGIO AMBIENTALE
 Valorizzare la qualità ambientale dei territori IL MONITORAGGIO AMBIENTALE Modulo A introduzione al monitoraggio il caso del monitoraggio in falda Istituto Istruzione Superiore A. Spinelli 2013-2014 monitoraggio
Valorizzare la qualità ambientale dei territori IL MONITORAGGIO AMBIENTALE Modulo A introduzione al monitoraggio il caso del monitoraggio in falda Istituto Istruzione Superiore A. Spinelli 2013-2014 monitoraggio
Sistemi di rappresentazione
 Sistemi di rappresentazione Uno dei problemi che i geografi devono affrontare è la scelta e l utilizzo di un linguaggio specifico e al tempo stesso facilmente comprensibile. Nel passato essi si basavano
Sistemi di rappresentazione Uno dei problemi che i geografi devono affrontare è la scelta e l utilizzo di un linguaggio specifico e al tempo stesso facilmente comprensibile. Nel passato essi si basavano
Università degli Studi di Napoli Federico II
 Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
Dighe ed ecologia delle acque
 HYDROS e SE Hydropower Gruppo SEL Dighe ed ecologia delle acque Bolzano, 15 maggio 2014 Vito Adami Laghi artificiali Dal punto di vista qualitativo, ecologico e funzionale, i laghi artificiali non possono
HYDROS e SE Hydropower Gruppo SEL Dighe ed ecologia delle acque Bolzano, 15 maggio 2014 Vito Adami Laghi artificiali Dal punto di vista qualitativo, ecologico e funzionale, i laghi artificiali non possono
UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI D ACQUA E STRUMENTO DI MONITORAGGIO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
 2 Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale Riqualificazione fluviale e gestione del territorio 6-7 novembre 2012, Bolzano UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI
2 Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale Riqualificazione fluviale e gestione del territorio 6-7 novembre 2012, Bolzano UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 19 GIUGNO 2006
 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 19 GIUGNO 2006 DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 20 ASSISTENZA SANITARIA DECRETO DIRIGENZIALE N. 20 del 17 maggio 2006 AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 19 GIUGNO 2006 DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 20 ASSISTENZA SANITARIA DECRETO DIRIGENZIALE N. 20 del 17 maggio 2006 AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Test di tossicità su Daphnia. Saggi su consumatori primari (acque dolci)
 Test di tossicità su Daphnia 1 Saggi su consumatori primari (acque dolci) Es. Daphnia magna Phylum: Artropoda Subphylum: Crustacea Classe: Branchiopoda Superordine: Sarsostraca Ordine: Cladocera Famiglia:
Test di tossicità su Daphnia 1 Saggi su consumatori primari (acque dolci) Es. Daphnia magna Phylum: Artropoda Subphylum: Crustacea Classe: Branchiopoda Superordine: Sarsostraca Ordine: Cladocera Famiglia:
Acque superficiali: Campionamento analisi chimiche Relatore: Dr. Ferdinando De Rosa
 Acque superficiali: Campionamento analisi chimiche Relatore: Dr. Ferdinando De Rosa salute e il tempo libero Riferimenti normativi D.Lgs 152 dell 11 maggio 1999 modificata e integrata con il D.Lgs 258
Acque superficiali: Campionamento analisi chimiche Relatore: Dr. Ferdinando De Rosa salute e il tempo libero Riferimenti normativi D.Lgs 152 dell 11 maggio 1999 modificata e integrata con il D.Lgs 258
I parametri di qualità chimica e microbiologica per la caratterizzazione delle acque
 Parte 3. I parametri di qualità chimica e microbiologica per la caratterizzazione delle acque Corso di Competitività e Sostenibilità A.A. 2014/2015 Massimo Raboni. PhD mraboni@liuc.it Parametri chimici
Parte 3. I parametri di qualità chimica e microbiologica per la caratterizzazione delle acque Corso di Competitività e Sostenibilità A.A. 2014/2015 Massimo Raboni. PhD mraboni@liuc.it Parametri chimici
L esperienza dell Osservatorio del Lago di Varese
 L esperienza dell Osservatorio del Lago di Varese Valeria Roella, ARPA Lombardia La salvaguardia dei corpi idrici dagli scarichi delle acque reflue Varese, 27 settembre 2016. Istituzione Osservatorio Lago
L esperienza dell Osservatorio del Lago di Varese Valeria Roella, ARPA Lombardia La salvaguardia dei corpi idrici dagli scarichi delle acque reflue Varese, 27 settembre 2016. Istituzione Osservatorio Lago
Indagine ecologica. 100 fontanili dall Adda al Ticino sistemi ambientali di connessione per la rete ecologica
 Laura Marziali Fabrizio Stefani Raffaella Balestrini Franco Salerno Istituto di Ricerca sulle Acque UOS Brugherio Via del Mulino 19, 20861 Brugherio (MB) 100 fontanili dall Adda al Ticino sistemi ambientali
Laura Marziali Fabrizio Stefani Raffaella Balestrini Franco Salerno Istituto di Ricerca sulle Acque UOS Brugherio Via del Mulino 19, 20861 Brugherio (MB) 100 fontanili dall Adda al Ticino sistemi ambientali
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI ASPETTI ECOLOGICI E NORMATIVA PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ACQUE CORRENTI: CONFRONTO TRA
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI ASPETTI ECOLOGICI E NORMATIVA PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ACQUE CORRENTI: CONFRONTO TRA
CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: scheda 24_POR
 a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine Lunghezza (km) 20,8 Capo dell Isolalato ovest Isola 0701101124 (1,7 Tino+3,2 Portovenere Punta Vagno * Palmaria +15,9 Palmaria costa)
a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine Lunghezza (km) 20,8 Capo dell Isolalato ovest Isola 0701101124 (1,7 Tino+3,2 Portovenere Punta Vagno * Palmaria +15,9 Palmaria costa)
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA STATISTICA MEDICA. Prof.ssa Donatella Siepi tel:
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA STATISTICA MEDICA Prof.ssa Donatella Siepi donatella.siepi@unipg.it tel: 075 5853525 2 LEZIONE Statistica descrittiva STATISTICA DESCRITTIVA Rilevazione dei dati Rappresentazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA STATISTICA MEDICA Prof.ssa Donatella Siepi donatella.siepi@unipg.it tel: 075 5853525 2 LEZIONE Statistica descrittiva STATISTICA DESCRITTIVA Rilevazione dei dati Rappresentazione
Studio scientifico delle interazioni tra gli organismi ed il loro ambiente (Haeckel)
 Principi di Ecologia Dipartimento di Biologia Animale-Università di Pavia Dott. Nicola Gilio Definizioni di ecologia Studio scientifico delle interazioni tra gli organismi ed il loro ambiente (Haeckel)
Principi di Ecologia Dipartimento di Biologia Animale-Università di Pavia Dott. Nicola Gilio Definizioni di ecologia Studio scientifico delle interazioni tra gli organismi ed il loro ambiente (Haeckel)
Inquadramento ittiofaunistico
 Dicembre 2014 CARATTERIZZAZIONE DELL ITTIOFAUNA E VERIFICA DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE NECESSARIE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PASSAGGIO PER PESCI SU UN OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TOSSIET (BACINO
Dicembre 2014 CARATTERIZZAZIONE DELL ITTIOFAUNA E VERIFICA DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE NECESSARIE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PASSAGGIO PER PESCI SU UN OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TOSSIET (BACINO
CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: scheda 19_ENT
 a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine Lunghezza (Km) 0701001019 Punta Chiappe Punta di Sestri * 26,9 * Il codice è costruito con i seguenti campi: Codice Istat Regione
a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine Lunghezza (Km) 0701001019 Punta Chiappe Punta di Sestri * 26,9 * Il codice è costruito con i seguenti campi: Codice Istat Regione
Corso per Guardie Giurate Volontarie sulla Pesca
 SERVIZIO FAUNISTICO Dott. Marco Aldrigo Corso per Guardie Giurate Volontarie sulla Pesca FONDAMENTI DI IDROBIOLOGIA E SPECIE ITTICHE ALLOCTONE Bergamo venerdì 27 gennaio 2012 IL CICLO DELLA MATERIA Batteri
SERVIZIO FAUNISTICO Dott. Marco Aldrigo Corso per Guardie Giurate Volontarie sulla Pesca FONDAMENTI DI IDROBIOLOGIA E SPECIE ITTICHE ALLOCTONE Bergamo venerdì 27 gennaio 2012 IL CICLO DELLA MATERIA Batteri
Avigliana - Giugno 2011
 Avigliana - Giugno 2011 RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLE ACQUE IPOLIMNICHE DEI LAGHI DI AVIGLIANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL ASPORTAZIONE DI FOSFORO DAL FONDO DAL LAGO GRANDE Fabrizio Merati*, Gilberto
Avigliana - Giugno 2011 RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLE ACQUE IPOLIMNICHE DEI LAGHI DI AVIGLIANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL ASPORTAZIONE DI FOSFORO DAL FONDO DAL LAGO GRANDE Fabrizio Merati*, Gilberto
Naples Shipping Week, 25 Giugno 2014, Tavola rotonda: «Il dragaggio dei porti e la destinazione dei sedimenti»
 Naples Shipping Week, 25 Giugno 2014, Tavola rotonda: «Il dragaggio dei porti e la destinazione dei sedimenti» Principi fondamentali per un dragaggio ambientalmente sostenibile: dalla caratterizzazione
Naples Shipping Week, 25 Giugno 2014, Tavola rotonda: «Il dragaggio dei porti e la destinazione dei sedimenti» Principi fondamentali per un dragaggio ambientalmente sostenibile: dalla caratterizzazione
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI
 SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
La solubilità del gesso e il rischio dell inquinamento dei solfati nelle falde
 La solubilità del gesso e il rischio dell inquinamento dei solfati nelle falde Eleonora Beccaloni Convegno sul tema: Il recupero dei rifiuti a base di gesso - II sessione Ferrara, 24 Settembre 2015 Il
La solubilità del gesso e il rischio dell inquinamento dei solfati nelle falde Eleonora Beccaloni Convegno sul tema: Il recupero dei rifiuti a base di gesso - II sessione Ferrara, 24 Settembre 2015 Il
4 th PAN-European FORUM Dredging in port and environmental sustainability Barletta, Italy
 4 th PAN-European FORUM Dredging in port and environmental sustainability Barletta, Italy Nancy ATTOLICO Servizio Infrastrutture - Ambiente Autorità Portuale del Levante www.aplevante.org - a.attolico@aplevante.org
4 th PAN-European FORUM Dredging in port and environmental sustainability Barletta, Italy Nancy ATTOLICO Servizio Infrastrutture - Ambiente Autorità Portuale del Levante www.aplevante.org - a.attolico@aplevante.org
Wew32q4e2. Monitoraggio Diga del Pertusillo
 Wew32q4e2 Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MAGGIO 2011 L attività di monitoraggio dell A.R.P.A.B. della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
Wew32q4e2 Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MAGGIO 2011 L attività di monitoraggio dell A.R.P.A.B. della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
LE METALLOTIONEINE COME BIOMARCATORI DELL INQUINAMENTO DA METALLI
 LE METALLOTIONEINE COME BIOMARCATORI DELL INQUINAMENTO DA METALLI Candidato: Giulia Russo Matricola: 245949 Relatrice: Prof.ssa Maria Marino Anno accademico: 2008/2009 Tavola periodica degli elementi METALLI
LE METALLOTIONEINE COME BIOMARCATORI DELL INQUINAMENTO DA METALLI Candidato: Giulia Russo Matricola: 245949 Relatrice: Prof.ssa Maria Marino Anno accademico: 2008/2009 Tavola periodica degli elementi METALLI
4. PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE Fase preliminare Definizione degli obiettivi
 Controllo di applicazione 71 4. PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE 4.1. Fase preliminare 4.1.1. Definizione degli obiettivi La valutazione della funzionalità fluviale attraverso l utilizzo di un indice globale
Controllo di applicazione 71 4. PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE 4.1. Fase preliminare 4.1.1. Definizione degli obiettivi La valutazione della funzionalità fluviale attraverso l utilizzo di un indice globale
LIFE. Dott. Marco Zanetti (biologo) Martedì 17 maggio Azione. . Applicazione dell Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) sul Fiume Sile.
 Bioprogramm S.C. LIFE 14/NAT/IT/000809 River functionality index as planning instrument for a good governance of Sile s ecosystem A1 Azione. Applicazione dell Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) sul
Bioprogramm S.C. LIFE 14/NAT/IT/000809 River functionality index as planning instrument for a good governance of Sile s ecosystem A1 Azione. Applicazione dell Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) sul
Caratteristiche dei sedimenti nei porti canale dell Emilia-Romagna
 Ravenna 26/09/2012 PROGETTO LIFE ENV/IT/426 COAST-BEST http://www.coast-best.eu Caratteristiche dei sedimenti nei porti canale dell Emilia-Romagna Action 2: Il prelievo dei campioni di sedimenti nei porti
Ravenna 26/09/2012 PROGETTO LIFE ENV/IT/426 COAST-BEST http://www.coast-best.eu Caratteristiche dei sedimenti nei porti canale dell Emilia-Romagna Action 2: Il prelievo dei campioni di sedimenti nei porti
Ciclo idrico e governo delle acque Titolo contratti Sottotitolo di fiume con particolare riguardo alle attività di monitoraggio e controllo
 Ciclo idrico e governo delle acque Il Titolo ruolo di ARPA Lombardia in materia di contratti Sottotitolo di fiume con particolare riguardo alle attività di monitoraggio e controllo Dr.ssa Paola Bossi Sede
Ciclo idrico e governo delle acque Il Titolo ruolo di ARPA Lombardia in materia di contratti Sottotitolo di fiume con particolare riguardo alle attività di monitoraggio e controllo Dr.ssa Paola Bossi Sede
CARATTERIZZAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE AREE DI DRAGAGGIO E DELLE SPIAGGIE
 Convegno STATO DEL LITORALE EMILIANO- ROMAGNOLO erosione e interventi di difesa Ravenna 30 novembre 2016 CARATTERIZZAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE AREE DI DRAGAGGIO E DELLE SPIAGGIE Carla Rita
Convegno STATO DEL LITORALE EMILIANO- ROMAGNOLO erosione e interventi di difesa Ravenna 30 novembre 2016 CARATTERIZZAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE AREE DI DRAGAGGIO E DELLE SPIAGGIE Carla Rita
ARPA Sezione di Rimini
 ARPA Sezione di Rimini Melo Rio Melo 211 B Ponte Via Venezia Riccione Bacino idrografico Corso d acqua Codice Tipo Localizzazione Pagina 76 Pagina 77 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Anche per
ARPA Sezione di Rimini Melo Rio Melo 211 B Ponte Via Venezia Riccione Bacino idrografico Corso d acqua Codice Tipo Localizzazione Pagina 76 Pagina 77 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Anche per
Indice. Approccio concettuale. Procedura operativa
 Introduzione... pag. 1 Parte A Approccio concettuale 1 Tipi di monitoraggio... pag. 13 1.1 Stato attuale... pag. 13 2 Monitoraggio operativo finalizzato... pag. 19 2.1 Obiettivi del monitoraggio... pag.
Introduzione... pag. 1 Parte A Approccio concettuale 1 Tipi di monitoraggio... pag. 13 1.1 Stato attuale... pag. 13 2 Monitoraggio operativo finalizzato... pag. 19 2.1 Obiettivi del monitoraggio... pag.
pluriparametrici di stima
 I procedimenti pluriparametrici di stima 01.IV.2011 Perché impiegare modelli pluriparametrici p del valore? Il caso più importante stime in contesti in cui è impossibile pervenire ad un campione di transazioni
I procedimenti pluriparametrici di stima 01.IV.2011 Perché impiegare modelli pluriparametrici p del valore? Il caso più importante stime in contesti in cui è impossibile pervenire ad un campione di transazioni
Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena
 STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
Programmazione con Foglio di Calcolo Cenni di Statistica Descrittiva
 Fondamenti di Informatica Ester Zumpano Programmazione con Foglio di Calcolo Cenni di Statistica Descrittiva Lezione 5 Statistica descrittiva La statistica descrittiva mette a disposizione il calcolo di
Fondamenti di Informatica Ester Zumpano Programmazione con Foglio di Calcolo Cenni di Statistica Descrittiva Lezione 5 Statistica descrittiva La statistica descrittiva mette a disposizione il calcolo di
L ECOTOSSICOLOGIA. Cosa ricerca l ecotossicologia?
 Cosa ricerca l ecotossicologia? L ECOTOSSICOLOGIA Che cosa è l ecotossicologia? L ecotossicologia valuta gli effetti tossici degli agenti chimici e fisici sugli organismi viventi, riuniti in comunità all
Cosa ricerca l ecotossicologia? L ECOTOSSICOLOGIA Che cosa è l ecotossicologia? L ecotossicologia valuta gli effetti tossici degli agenti chimici e fisici sugli organismi viventi, riuniti in comunità all
pluriparametrici di stima
 I procedimenti pluriparametrici di stima 29.X.2013 Perché impiegare modelli pluriparametrici p del valore? Il caso più importante stime in contesti in cui è impossibile pervenire ad un campione di transazioni
I procedimenti pluriparametrici di stima 29.X.2013 Perché impiegare modelli pluriparametrici p del valore? Il caso più importante stime in contesti in cui è impossibile pervenire ad un campione di transazioni
Estate Monitoraggio Fiume Arno. Bollettino n 8. Settimana luglio
 Estate 2016 Monitoraggio Fiume Arno Bollettino n 8 Settimana 25 31 luglio Introduzione Il monitoraggio in continuo del Fiume Arno operato da ARPAT a partire dal 2007 dispone oggi di serie consistenti e
Estate 2016 Monitoraggio Fiume Arno Bollettino n 8 Settimana 25 31 luglio Introduzione Il monitoraggio in continuo del Fiume Arno operato da ARPAT a partire dal 2007 dispone oggi di serie consistenti e
Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente.
 Report ARPAT Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente. Agosto 2014 Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto 1 Introduzione
Report ARPAT Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente. Agosto 2014 Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto 1 Introduzione
L Indice di Funzionalità Fluviale (IFF): applicazione al fiume Soligo
 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GEOMETRI A.A. 2004-05 Corso di Estimo ambientale, riqualificazione fluviale ed ingegneria naturalistica- II sezione: riqualificazione fluviale ed ingegneria naturalistica
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GEOMETRI A.A. 2004-05 Corso di Estimo ambientale, riqualificazione fluviale ed ingegneria naturalistica- II sezione: riqualificazione fluviale ed ingegneria naturalistica
Elementi idromorfologici: indice di alterazione del regime idrologico (IARI)
 Direttiva 2000/60/CE: Struttura delle reti e dei programmi di monitoraggio sui corsi d acqua Indici di classificazione dello stato di qualità Elementi idromorfologici: indice di alterazione del regime
Direttiva 2000/60/CE: Struttura delle reti e dei programmi di monitoraggio sui corsi d acqua Indici di classificazione dello stato di qualità Elementi idromorfologici: indice di alterazione del regime
MONITORAGGIO BIOLOGICO E CHIMICO
 MONITORAGGIO BIOLOGICO E CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E COSTIERE DR. TOMMASO PAGLIANI 1. INTRODUZIONE La qualità delle acque, specie quelle superficiali correnti, rappresenta indubbiamente lo specchio
MONITORAGGIO BIOLOGICO E CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E COSTIERE DR. TOMMASO PAGLIANI 1. INTRODUZIONE La qualità delle acque, specie quelle superficiali correnti, rappresenta indubbiamente lo specchio
Utilizzeremo un kit analitico per valutare la qualità dell acqua potabile delle nostre case, scuole e fontanelle cittadine.
 Acqua in brocca Ciao! Io sono LABBY e vi farò da guida per l analisi dell acqua del vostro rubinetto! Utilizzeremo un kit analitico per valutare la qualità dell acqua potabile delle nostre case, scuole
Acqua in brocca Ciao! Io sono LABBY e vi farò da guida per l analisi dell acqua del vostro rubinetto! Utilizzeremo un kit analitico per valutare la qualità dell acqua potabile delle nostre case, scuole
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI
 SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
ISTRUZIONE OPERATIVA CAMPIONAMENTO ALIMENTI
 Pagina 1 di 5 ISTRUZIONE OPERATIVA REVISIONE NUMERO DATA REDATTA DA DIR VERIFICATA DA RAQ APPROVATA DA AMM PARAGRAFO REVISIONATO NUMERO MOTIVO 00 15/01/09 Prima emissione 01 15/03/12 5 02 24/01/13 3 02
Pagina 1 di 5 ISTRUZIONE OPERATIVA REVISIONE NUMERO DATA REDATTA DA DIR VERIFICATA DA RAQ APPROVATA DA AMM PARAGRAFO REVISIONATO NUMERO MOTIVO 00 15/01/09 Prima emissione 01 15/03/12 5 02 24/01/13 3 02
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione
 La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
Stato di Qualità delle Comunità Biologiche del Fiume Lambro
 Stato di Qualità delle Comunità Biologiche del Fiume Lambro Valeria Mezzanotte Sergio Canobbio Laura Sartori Riccardo Cabrini Dipartimento di Scienze dell Ambiente e del Territorio Università degli Studi
Stato di Qualità delle Comunità Biologiche del Fiume Lambro Valeria Mezzanotte Sergio Canobbio Laura Sartori Riccardo Cabrini Dipartimento di Scienze dell Ambiente e del Territorio Università degli Studi
Convenzione per l esecuzione di campagne di. monitoraggio dell ittiofauna nell ambito del Progetto Life
 CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SULLE TECNOLOGIE E L IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI DELLE PICCOLE SPECIE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione per l esecuzione di campagne di monitoraggio
CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SULLE TECNOLOGIE E L IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI DELLE PICCOLE SPECIE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione per l esecuzione di campagne di monitoraggio
standardizzazione dei punteggi di un test
 DIAGNOSTICA PSICOLOGICA lezione! Paola Magnano paola.magnano@unikore.it standardizzazione dei punteggi di un test serve a dare significato ai punteggi che una persona ottiene ad un test, confrontando la
DIAGNOSTICA PSICOLOGICA lezione! Paola Magnano paola.magnano@unikore.it standardizzazione dei punteggi di un test serve a dare significato ai punteggi che una persona ottiene ad un test, confrontando la
Valutazione della sicurezza chimica delle sostanze: l impatto sull ambiente
 1 a Conferenza Nazionale sul regolamento REACH Valutazione della sicurezza chimica delle sostanze: l impatto sull ambiente Pietro Paris Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
1 a Conferenza Nazionale sul regolamento REACH Valutazione della sicurezza chimica delle sostanze: l impatto sull ambiente Pietro Paris Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
Statistica. Campione
 1 STATISTICA DESCRITTIVA Temi considerati 1) 2) Distribuzioni statistiche 3) Rappresentazioni grafiche 4) Misure di tendenza centrale 5) Medie ferme o basali 6) Medie lasche o di posizione 7) Dispersione
1 STATISTICA DESCRITTIVA Temi considerati 1) 2) Distribuzioni statistiche 3) Rappresentazioni grafiche 4) Misure di tendenza centrale 5) Medie ferme o basali 6) Medie lasche o di posizione 7) Dispersione
Torino, Ottobre 2011
 per i progetti di gestione degli invasi e per l esecuzione delle operazioni: contenuti ed esperienze di applicazione Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione
per i progetti di gestione degli invasi e per l esecuzione delle operazioni: contenuti ed esperienze di applicazione Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione
Errori di misura Teoria
 Errori di misura Teoria a misura operazione di misura di una grandezza fisica, anche se eseguita con uno strumento precisissimo e con tecniche e procedimenti accurati, è sempre affetta da errori. Gli errori
Errori di misura Teoria a misura operazione di misura di una grandezza fisica, anche se eseguita con uno strumento precisissimo e con tecniche e procedimenti accurati, è sempre affetta da errori. Gli errori
La biosfera e gli ecosistemi
 La biosfera e gli ecosistemi La biosfera: l insieme di tutti gli ecosistemi L ecologia studia le interazioni tra gli organismi viventi e il loro ambiente a vari livelli: ECOSISTEMA COMUNITA POPOLAZIONE
La biosfera e gli ecosistemi La biosfera: l insieme di tutti gli ecosistemi L ecologia studia le interazioni tra gli organismi viventi e il loro ambiente a vari livelli: ECOSISTEMA COMUNITA POPOLAZIONE
Il tuo quartiere sotto la lente di ingrandimento
 Il tuo quartiere sotto la lente di ingrandimento American Express in collaborazione con Experian, leader mondiale nell informazione commerciale e nella protezione dei dati di aziende e consumatori, nei
Il tuo quartiere sotto la lente di ingrandimento American Express in collaborazione con Experian, leader mondiale nell informazione commerciale e nella protezione dei dati di aziende e consumatori, nei
Laboratorio Analisi Acque e Suoli Azienda Agro-ecologica Carpaneta ( Bigarello Mantova )
 Dipartimento Sistemi agricoli Struttura Sviluppo dei centri agricoli Via Carpaneta, 7-46030 - Bigarello (MN) Tel. 0376.459.561; Fax. 0376.459.334; Laboratorio Analisi Acque e Suoli Azienda Agro-ecologica
Dipartimento Sistemi agricoli Struttura Sviluppo dei centri agricoli Via Carpaneta, 7-46030 - Bigarello (MN) Tel. 0376.459.561; Fax. 0376.459.334; Laboratorio Analisi Acque e Suoli Azienda Agro-ecologica
IMPIANTO DI RONCOBOTTO (Via Isola Ronchi Comune di Zocca)
 IMPIANTO DI RONCOBOTTO (Via Isola Ronchi Comune di Zocca) Discarica per rifiuti speciali non pericolosi con capacità superiore a 10 ton/giorno Impianto soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale Gestore:
IMPIANTO DI RONCOBOTTO (Via Isola Ronchi Comune di Zocca) Discarica per rifiuti speciali non pericolosi con capacità superiore a 10 ton/giorno Impianto soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale Gestore:
Monitoraggio I.B.E. del torrente Soligo e del torrente Lierza in comune di Pieve di Soligo (TV) MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ BIOLOGICA METODO I.B.E.
 Provincia di Treviso Comune di Pieve di Soligo Monitoraggio I.B.E. del torrente Soligo e del torrente Lierza in comune di Pieve di Soligo (TV) MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ BIOLOGICA METODO I.B.E. CODICE
Provincia di Treviso Comune di Pieve di Soligo Monitoraggio I.B.E. del torrente Soligo e del torrente Lierza in comune di Pieve di Soligo (TV) MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ BIOLOGICA METODO I.B.E. CODICE
 REACH: ANNUARIO DEI LABORATORI SELEZIONATI PER LE ANALISI E LE PROVE PREVISTE DAL REGOLAMENTO Marcella Murru Marcella.Murru@bracco.com Roma, 01 luglio 2009 2 La registrazione richiede la presentazione
REACH: ANNUARIO DEI LABORATORI SELEZIONATI PER LE ANALISI E LE PROVE PREVISTE DAL REGOLAMENTO Marcella Murru Marcella.Murru@bracco.com Roma, 01 luglio 2009 2 La registrazione richiede la presentazione
Relazione Conclusiva
 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS Direzione generale PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEGLI STAGNI DI S. GIOVANNI E DI MARCEDDI E DELLA ANTISTANTE FASCIA MARINO COSTIERA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS Direzione generale PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEGLI STAGNI DI S. GIOVANNI E DI MARCEDDI E DELLA ANTISTANTE FASCIA MARINO COSTIERA
L ADIGE. Foto 1 : Sorgente a Passo Resia e foce a Porto Fossone. Foto 2: Adige in situazioni di magra e di piena nel tratto di Pescantina. Pag. 12.
 L ADIGE Introduzione L Adige è il secondo fiume d Italia dopo il Po per lunghezza di corso, ed il terzo, dopo il Po ed il Tevere, per ampiezza di bacino imbrifero; è indubbiamente tra i primi, se non il
L ADIGE Introduzione L Adige è il secondo fiume d Italia dopo il Po per lunghezza di corso, ed il terzo, dopo il Po ed il Tevere, per ampiezza di bacino imbrifero; è indubbiamente tra i primi, se non il
Stima delle emissioni in atmosfera di ammoniaca derivanti dagli allevamenti zootecnici
 8 febbraio 2012 Stima delle emissioni in atmosfera di ammoniaca derivanti dagli allevamenti zootecnici Bagnolo, Cadelbosco di Sopra, Gualtieri, Novellara Sezione Provinciale di Reggio Emilia Servizio Sistemi
8 febbraio 2012 Stima delle emissioni in atmosfera di ammoniaca derivanti dagli allevamenti zootecnici Bagnolo, Cadelbosco di Sopra, Gualtieri, Novellara Sezione Provinciale di Reggio Emilia Servizio Sistemi
Interventi di Riqualificazione Fluviale su un tratto dimostrativo del Fiume Serchio Camporgiano (LU) Monitoraggio a tre anni dalla realizzazione
 Interventi di Riqualificazione Fluviale su un tratto dimostrativo del Fiume Serchio Camporgiano (LU) Monitoraggio a tre anni dalla realizzazione Laura Maria Bianchi, Geologo professionista Arianna Chines,
Interventi di Riqualificazione Fluviale su un tratto dimostrativo del Fiume Serchio Camporgiano (LU) Monitoraggio a tre anni dalla realizzazione Laura Maria Bianchi, Geologo professionista Arianna Chines,
la catena può essere analizzata in termini energetici
 la catena può essere analizzata in termini energetici PRODUTTORI: utilizzando la luce solare come fonte di energia sono grado di sintetizzare la materia organica partendo da sostanze inorganiche tramite
la catena può essere analizzata in termini energetici PRODUTTORI: utilizzando la luce solare come fonte di energia sono grado di sintetizzare la materia organica partendo da sostanze inorganiche tramite
Contenuti della sezione ACQUE
 Contenuti della sezione ACQUE La Qualità delle acque superficiali Azioni del Dipartimento di Como Punti di monitoraggio delle acque superficiali Descrittore: Stato ecologico dei corsi d acqua Descrittore:
Contenuti della sezione ACQUE La Qualità delle acque superficiali Azioni del Dipartimento di Como Punti di monitoraggio delle acque superficiali Descrittore: Stato ecologico dei corsi d acqua Descrittore:
Risultati Tratto Specie Individui peso medio d. s. Lunghezza media d. s. catturati (g) (cm) Abramide Blicca Carpa monte Carassio
 Ferrara, 22-07-2013 Università di Ferrara Provincia di Ferrara Sintesi dei principali risultati del monitoraggio estivo dei popolamenti ittici del Canale Circondariale nel tratto Comacchio-Anita, adibito
Ferrara, 22-07-2013 Università di Ferrara Provincia di Ferrara Sintesi dei principali risultati del monitoraggio estivo dei popolamenti ittici del Canale Circondariale nel tratto Comacchio-Anita, adibito
STUDIO PER L INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE PER LA PESCA DELLE VONGOLE FILIPPINE IN LAGUNA DI. Le Scadenze
 STUDIO PER L INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE PER LA PESCA DELLE VONGOLE FILIPPINE IN LAGUNA DI VENEZIA Le Scadenze Le Restituzioni Il Progetto Il Piano sperimentale PSLPSL PESCA PESCA ED ED INNOVAZIONE
STUDIO PER L INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE PER LA PESCA DELLE VONGOLE FILIPPINE IN LAGUNA DI VENEZIA Le Scadenze Le Restituzioni Il Progetto Il Piano sperimentale PSLPSL PESCA PESCA ED ED INNOVAZIONE
Monitoraggio. Incontro tematico per la partecipazione pubblica a supporto dell elaborazione elaborazione del PBI. Parma, 6 luglio 2011
 Monitoraggio Incontro tematico per la partecipazione pubblica a supporto dell elaborazione elaborazione del PBI Parma, 6 luglio 2011 via Giuseppe Garibaldi, 75-43121 Parma - tel. 0521 2761 www.adbpo.it
Monitoraggio Incontro tematico per la partecipazione pubblica a supporto dell elaborazione elaborazione del PBI Parma, 6 luglio 2011 via Giuseppe Garibaldi, 75-43121 Parma - tel. 0521 2761 www.adbpo.it
CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: scheda 22_MES
 a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine 0701101122 * Scoglio Nero-inizio zona B Area Protetta Cinque Terre * Il codice è costruito con i seguenti campi: Codice Istat Regione
a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine 0701101122 * Scoglio Nero-inizio zona B Area Protetta Cinque Terre * Il codice è costruito con i seguenti campi: Codice Istat Regione
La stima dei costi di produzione
 Università degli Studi di Trento Programmazione Costi e Contabilità lavori a.a. 2004-5 La stima dei costi di produzione Marco Masera, prof marco.masera@ing.unitn.it Procedimenti di stima I procedimenti
Università degli Studi di Trento Programmazione Costi e Contabilità lavori a.a. 2004-5 La stima dei costi di produzione Marco Masera, prof marco.masera@ing.unitn.it Procedimenti di stima I procedimenti
ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2014 Inquinamento delle risorse idriche Conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane (Depuratori)
 ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2014 Inquinamento delle risorse idriche Conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane (Depuratori) Nome indicatore DPSIR Fonte dati Conformità dei sistemi
ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2014 Inquinamento delle risorse idriche Conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane (Depuratori) Nome indicatore DPSIR Fonte dati Conformità dei sistemi
Umidità UNI ISO 1442:2010. Carne e prodotti a base di carne conservati N. di iodio LC/MP/N Rev.11 UNI EN ISO :2004
 DENOMINAZIONE DELLA PROVA METODO DI PROVA MATRICE Umidità UNI ISO 1442:2010 Carne e prodotti della carne Cloruri (come NaCl) LC/MP/N.6 2012 Rev.10 Carne e prodotti a base di carne conservati Attività dell
DENOMINAZIONE DELLA PROVA METODO DI PROVA MATRICE Umidità UNI ISO 1442:2010 Carne e prodotti della carne Cloruri (come NaCl) LC/MP/N.6 2012 Rev.10 Carne e prodotti a base di carne conservati Attività dell
Ecosistema acquatico: monitoraggio e controllo ambientale in attuazione del DM 367/2003
 Ecosistema acquatico: monitoraggio e controllo ambientale in attuazione del DM 367/2003 Luciano Giovannelli Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana D.Lgs 152/99: Obiettivi Mediante
Ecosistema acquatico: monitoraggio e controllo ambientale in attuazione del DM 367/2003 Luciano Giovannelli Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana D.Lgs 152/99: Obiettivi Mediante
AREE IMPORTANTI PER L AVIFAUNA NEL FIUME ARNO (PROV. DI FIRENZE): INDIVIDUAZIONE DELLE EMERGENZE E PROSPETTIVE DI TUTELA
 AREE IMPORTANTI PER L AVIFAUNA NEL FIUME ARNO (PROV. DI FIRENZE): INDIVIDUAZIONE DELLE EMERGENZE E PROSPETTIVE DI TUTELA MICHELE GIUNTI & PAOLO SPOSIMO * c/o Nemo srl, via Giotto 33 50121, Firenze 055/674223
AREE IMPORTANTI PER L AVIFAUNA NEL FIUME ARNO (PROV. DI FIRENZE): INDIVIDUAZIONE DELLE EMERGENZE E PROSPETTIVE DI TUTELA MICHELE GIUNTI & PAOLO SPOSIMO * c/o Nemo srl, via Giotto 33 50121, Firenze 055/674223
corso d acqua Un corso d acqua origina da una sorgente e termina con una foce,
 Corsi d acqua Un corso d acqua origina da una sorgente e termina con una foce, che può essere il mare o un titolo corso d acqua copertina più grande. Dalla sorgente alla foce sono riconoscibili tratti
Corsi d acqua Un corso d acqua origina da una sorgente e termina con una foce, che può essere il mare o un titolo corso d acqua copertina più grande. Dalla sorgente alla foce sono riconoscibili tratti
ORDINE DEI GEOLOGI DELL ORDINE DEI GEOL A TOSCANA
 ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 9 dicembre 2008 Elaborato a se stante, autonomo La relazione idrogeologica Mirata al tipo di progetto da supportare ma deve comunque sempre contenere informazioni sulla
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 9 dicembre 2008 Elaborato a se stante, autonomo La relazione idrogeologica Mirata al tipo di progetto da supportare ma deve comunque sempre contenere informazioni sulla
I CAMPIONAMENTI ITTICI: STRUMENTI E METODI
 Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale 5 Corso teorico-pratico di formazione: La fauna ittica dei corsi d acqua (Castelnuovo Garfagnana, 22-25 settembre 2009) I CAMPIONAMENTI ITTICI: STRUMENTI E
Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale 5 Corso teorico-pratico di formazione: La fauna ittica dei corsi d acqua (Castelnuovo Garfagnana, 22-25 settembre 2009) I CAMPIONAMENTI ITTICI: STRUMENTI E
Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena
 STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
La mobilità degli elementi chimici
 La mobilità degli elementi chimici Gli ioni contenuti nella parte sinistra del diagramma sono quelli che in soluzione si presentano sotto forma di cationi semplici. Gli ioni nella parte centrale del diagramma
La mobilità degli elementi chimici Gli ioni contenuti nella parte sinistra del diagramma sono quelli che in soluzione si presentano sotto forma di cationi semplici. Gli ioni nella parte centrale del diagramma
CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: scheda 06_AND
 a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine Lunghezza (Km) 0700800906 * Capo Berta Capo Mele (Confine - ) 22,9 * Il codice è costruito con i seguenti campi: Codice Istat Regione
a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine Lunghezza (Km) 0700800906 * Capo Berta Capo Mele (Confine - ) 22,9 * Il codice è costruito con i seguenti campi: Codice Istat Regione
