Eetti distorsivi delle imposte 1 (Economia Pubblica L-Z - Prof. Leonzio Rizzo)
|
|
|
- Faustina Cenci
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Eetti distorsivi delle imposte 1 (Economia Pubblica L-Z - Prof. Leonzio Rizzo) 1 Mercato perfettamente concorrenziale e Pareto-ottimalità Un mercato è perfettamente concorrenziale quando le imprese che operano in esso 1) producono un bene perfettamente omogeneo; 2) il bene venduto da un'impresa è un sostituto perfetto dei beni venduti da tutte le altre imprese, per tanto, il bene deve essere venduto ad un unico prezzo; 3) il mercato è popolato da un numero molto rilevante di imprese, teoricamente innito, ognuna delle quali produce una quota irrilevante dell'output complessivo. Conseguentemente, ogni impresa riterrà che le proprie decisioni non possano inuenzare il prezzo di mercato a cui il bene viene venduto: per le imprese è quindi razionale assumere il prezzo come un dato, ovvero le imprese sono price taker. 4) Nel lungo periodo i fattori della produzione sono perfettamente mobili e non vi sono barriere di nessuna sorta all'entrata e all'uscita di imprese nel mercato e quindi le tecnologie di produzione convergono ad una situazione in cui tutte le imprese presenti produrranno al costo marginale uguale al costo medio minimo, realizzando protti nulli. Nel breve periodo, invece, si assume che le tecnologie di produzione possano dierire, consentendo la presenza di imprese marginali il cui costo medio è uguale al costo marginale di produzione che uguaglia il prezzo di mercato e di imprese inframarginali, il cui costo medio è inferiore al costo marginale che uguaglia il prezzo di mercato e che quindi hanno protti positivi. Questo equilibrio di breve periodo è possibile perché ad esempio l'economia può essere sottoposta a shock da oerta (tecnologie innovative): in tal caso può succedere che alcune imprese adeguino la propria struttura di costo prima di altre, generando una dierenziazione nelle strutture di produzione che permette ad alcune imprese di ottenere protti maggiori di altre. Nel lungo periodo l'innovazione si dionde e i protti di tutte le imprese presenti sul mercato tendono a zero. 5) Le imprese e i consumatori hanno informazione perfetta ovvero hanno accesso senza costo a tutte le informazioni che sono rilevanti per le loro decisioni. In un mercato perfettamente concorrenziale i consumatori scelgono la quantità di beni da domandare e di input da orire, massimizzando la propria utilità e i produttori la quantità di beni da orire e di input da domandare, massimizzando il proprio protto. Tale attività genera le funzioni di domanda e di oerta di beni di consumo ed input produttivi, che in equilibrio si uguagliano, determinando il livello dei prezzi. Questi ultimi sono considerati come dati, da produttori e consumatori nel loro processo di massimizzazione. E' possibile dimostrare che in una situazione di concorrenza perfetta si raggiunge un equilibrio in cui non è possibile migliorare il pay-o di un produttore o consumatore, senza peggiorare quello di qualche altro produttore 1
2 o consumatore (primo teorema di economia del benessere ). 1) Il pay-o dei consumatori è misurato con il livello di utilità raggiunto, date le proprie scelte di consumo, vincolate al bilancio disponibile e 2) il pay-o dei produttori è dato dal protto ottenuto da ognuno, data la funzione di produzione che caratterizza la propria attività. 2 Strumenti di valutazione delle distorsioni dall'equilibrio di perfetta concorrenza L'introduzione di un'imposta, pagata dal consumataore, legata al consumo di un bene o all'oerta di un input, modica il rapporto relativo tra i prezzi, ottenuto con il meccanismo prima descritto e quindi le quantità oerte e consumate in equilibrio, causando una diminuzione del benessere sociale. In questo paragrafo descriviamo una strumentazione graca utile per quanticare l'impatto sul benessere dei consumatori e sui protti dei produttori dell'introduzione o incremento di un'imposta. Ci concentriamo su un'analisi di equilibrio parziale, ovvero su una singola industria che si suppone produca un bene omogeneo, gli attori dell'economia sono costituiti da consumatori e produttori di un bene, che esprimono domanda e oerta del bene in un mercato che considereremo in concorrenza perfetta. Rappresentiamo le curve di domanda ed oerta aggregata, utlizzando un sistema di assi cartesiani, ove sulle ascisse gurano le quantità e sulle ordinate i prezzi. Figura 1: 2
3 2.1 Surplus del consumatore La domanda D è il risultato dell'aggregazione delle quantità domandate da tutti consumatori e si ottiene sommando orizzontalmente le curve di domanda di tutti i consumatori. Ragioniamo per il momento con un solo consumatore fosse uno solo. Per ogni livello di prezzo il consumatore domanderà il bene no al punto cui il prezzo è uguale all'utilità marginale ricevuta dal consuno del bene. Il trapezio (Fig. 1) OQ'βγè il surplus lordo del consumatore. Quando il prezzo del bene di consumo è P', Q' è la domanda di consumo. Se con una certa approssimazione assumiamo la funzione di domanda come una rappresentazione della funzione dell'utilità marginale dovuta al consumo del bene, l'utilità complessiva ottenuta dal consumo di Q' è data dall'area prima denita surplus lordo del consumatore. I consumatori per fruire di tale surplus lordo pagano un somma che è denita dal prezzo di equilibrio per la quantità totale consumata, ovvero OQ'βP', quindi il surplus netto è individuato dall'area P' βγ. Il motivo per cui il surplus netto è positivo è dovuto al fatto che l'utilità marginale è decrescente all'aumentare del consumo: il consumo totale è frutto del consumo di più unità, tuttavia la valutazione che il consumatore dà delle unità consumate dopo la prima diminuisce sempre più. Il ragionamento appena fatto può essere ripetuto per tutti gli altri consumatori presenti sul mercato e sommando le quantità domandate da tutti i consumatori per ogni dato prezzo si ottiene la funzione di domanda aggregata che permette di calcolare il surplus dei consumatori. 2.2 Surplus del produttore L'oerta S, con un ragionamento del tutto simmetrico, è il risultato dell'aggregazione delle curve dei costi marginali dei produttori. In concorrenza, essendo price takers, essi ssano l'oerta al punto in cui il costo marginale è uguale al prezzo. Per la combinazione prezzo-quantità (P',Q' ), l'area OQ'βP' rappresenta il ricavo ottenuto producendo Q', ovvero il surplus lordo dei produttori (quantità venduta per il prezzo). L'area OQ' βα, rappresenta il costo totale che il produttore deve sopportare per realizzare l'oerta Q'. La funzione di oerta aggregata, S, si ottiene sommando orizzontalmente le funzioni di costo marginale di ogni impresa presente sul mercato. La dierenza tra l'area OQ'βP' e l'area OQ'βα, pari all'area αβp, è il cosiddetto surplus netto dei produttori. Tale surplus è positivo perché nel breve periodo esistono dei produttori il cui costo medio è inferiore al prezzo a cui il costo marginale è eguagliato nel caso che stiamo ipotizzando ci concorrenza perfetta. Al diminuire del prezzo dimiminuisce la quantità di equilibrio, ovvero l'impresa che prima era marginale (costo marginale uguale costo medio e quindi protti nulli) esce dal mercato e diventa marginale un'impresa che prima non lo era, il che implica che l'area di surplus netto del produttore (somma dei protti delle imprese inframarginali) si assottiglia. 2.3 Il benessere complessivo dell'economia In un mondo in cui esiste un solo bene, il primo teorema di economia del benessere può essere così riscritto: costo marginale dei produttori = prezzo = valutazione marginale dei consumatori. Poichè in questo universo esistono solo consumatori e produttori è naturale assumere come misura del benessere complessivo dell'economia la somma del 3
4 surplus netto dei consumatori e dei produttori, che in assenza di imposte è pari (Fig. 1) all'area αβγ ed è dovuto alle rendite dei consumatori per i quali la valutazione marginale dei beni acquistati è superiore al prezzo e alle rendite dei produttori per i quali il prezzo=costo marginale è superiore al costo medio. L'introduzione di un'imposta specica (accisa) sulla quantità domandata e quindi consumata di un bene induce una traslazione verso il basso della funzione di domanda in D' (il consumatore è disposto a pagare un prezzo al produttore per ogni quantità acquistata inferiore a quello che era disposto a pagare prima dell'introduzione dell'imposta per la stessa quantità acquistata) il nuovo punto di intersezione β determina una nuova quantità di equilibrio Q, il prezzo incassato dal produttore P e il prezzo pagato dal consumatore P+t: la dierenza tra il prezzo pagato dal consumatore e il prezzo incassato dal produttore è il cuneo scale. Dopo l'introduzione del cuneo scale il surplus netto del consumatore diventa γβ (P + t) e il surplus del produttore αβ P. Quindi si ottiene un gettito pari a OQ*t: infatti la nuova qunatità del bene di equilibrio è Q e su tale qunatità il governo applica l'imposta specica (accisa) t. Si noti che il gettito nella gura può essere anche visto come una quota del surplus precedente all'introduzione dell'imposta, ovvero P β β (P + t): infatti la lunghezza del segmento β β è pari a t (la distanza tra le due curve di domanda in presenza e assenza di imposta sul consumo) e la lunghezza del segmento P β coincide con la quantità di equilibrio dopo l'introduzione dell'imposta. Quindi l'introduzione dell'imposta ha causato una perdita di benessere pari a ββ β, che è la somma di una parte della perdita di surplus del consumatore pari a δββ e una parte della perdita di surplus del produttore pari a δββ. Infatti vi è un'altra parte di perdita di surplus del consumatore pari a P δβ (P + t), che, sommata all'altra parte di perdita di surplus del produttore pari a P β δp, coincide con il gettito dello stato. L'eetto visibile sull'economia dell'introduzione del cuneo scale è la diminuizione della quantità consumata in equilibrio da Q' a Q. 3 Il cuneo scale sul lavoro Si discute molto oggigiorno degli eetti depressivi del cuneo scale sull'occupazione: è quindi di interesse capire come tale cuneo possa essere identicato e quanticato. Applichiamo la stessa struttura logica di analisi precedentemente descritta. Si consideri un'economia con la seguente domanda di lavoro: l d = a b(w + τ) (1) e l'oerta di lavoro è data da: l s = c + dw (2) ove l s, l d, w e τ siano rispettivamente i logaritmi dell'oerta di lavoro, della domanda di lavoro e del salario reale netto e del cuneo scale: tale forma funzionale permette di interpretare (si può dimostrare) b come l'elasticità della domanda di lavoro al salario reale netto e d come l'elasticità dell'oerta di lavoro al salario reale netto. 4
5 Anche in questa sezione rappresentiamo la (1) e la (2), utilizzando uno schema di assi cartesiani, ove sulle ascisse gurano le ore lavorate (l) e sulle ordinate il salario (orario) reale (w ). Figura 2: Si noti che nel graco la curva di domanda e di oerta sono disegnate esprimendo il salario come funzione del lavoro e non come sono invece descritte nelle equazioni (1) e (2), dove il lavoro è espresso in funzione del salario. La descrizione del graco ci permette di interpretare la distanza tra la curva di domanda in assenza e in presenza di imposte con il valore dell'imposta stessa. Infatti utilizzando la (1): l d = a b(w + τ) si ottiene: bτ + l d a = bw w = a b τ 1 b ld In questo esempio supponiamo che le imposte sul lavoro siano prelevate interamente sull'impresa (si può dimostrare comunque che in un mercato di concorrenza perfetta è irrilevante chi legalmemte paga l'imposta per comprenderne gli eetti sulle variabili economiche di equilibrio). Poichè in equilibrio l s = l d, possiamo uguagliare la (1) e la (2) e quindi trovare il salario reale e il livello di occupazione di equilibrio: a b(w + τ) = c + dw 5
6 da cui: quindi: c + a bτ = dw + bw, (d + b)w = a + c bτ, quindi il salario di equilibrio risulta essere: w(τ) = a + c d + b bτ d + b sostituendo (3) in (2) si ottiene l'occupazione di equilibrio: ( a + c l(τ) = c + d d + b bτ ) d + b (3) (4) Si noti che in assenza di imposte, e quindi nella situazione di equilibrio di partenza, le coordinate del punto A (Fig. 3) risultano essere: w(0) = a + c d + b l(0) = c + d a + c d + b, l'introduzione dell'imposta (τ > 0) porta ad una traslazione verso il basso della funzione di domanda (1) e ad individuare il nuovo punto di equilibrio B le cui coordinate sono date da (3) e (4). Il punto B individua il nuovo livello di occupazione ed il salario reale che viene pagato al lavoratore. L'esborso per l'impresa è ovviamente maggiore poichè comprende anche l'imposta che deve versare all'erario e che è data dalla distanza tra la nuova e la vecchia curva di domanda. Quindi, data la nuova occupazione di equilibrio, l(τ), è possibile individuare il salario lordo intercettando il punto ad essa corrispondente sulla vecchia curva di domanda: w(τ) + τ = a + c d + b bτ d + b + τ = a + c d + b + dτ d + b Se teniamo presente che nel graco della Figura 3 è descritta la funzione di domanda e oerta di un particolare input di produzione che è il lavoro, possiamo utilizzare le categorie logiche discusse al paragrafo precedente per valutare l'impatto sul benessere di imprese e lavoratori di una variazione del cuneo scale. Il trapezio l(0)aeo rappresenta il ricavo che le imprese hanno dall'impiego di lavoro pari ad l(0), tuttavia tale lavoro va remunerato al prezzo di equilibrio pari a w(0), quindi il costo complessivo del lavoro per il comparto delle imprese è pari a l(0)aw(0)o, da cui il surplus netto del produttore risulta essere w(0)ae, che è positivo perchè esistono imprese con dierenti strutture produttive. 1 1 In particolare per l'impresa marginale, l'impiego di una unità marginale di lavoro ha una produttività marginale pari a w(0) che coincide con la produttività media, mentre le imprese inframarginali, che pagano un salario pari a w(0) inferiore alla produttività media, riescono a ricavare una rendita dal lavoro che impiegano nel processo produttivo. Se il salario aumenta l'impresa marginale precedente esce dal mercato e diventa marginale una che prima era inframarginale, poichè la sua produttività marginale ora coincide 6
7 Il trapezio DAl(0)O è la perdita di utilità che gli individui sopportano per riununciare al consumo del proprio tempo libero, impiegandolo nel lavoro. Poichè si suppone che l'utilità marginale dell'individuo sia descrescente rispetto al consumo di ore di tempo libero, se aumenta il numero di ore lavorate (ovvero dimiuisce il consumo di ore di tempo libero), la relativa disutilità marginale aumenta: questo è il motivo per cui la curva di oerta di lavoro (di disutilità marginale del lavoro) è crescente nel salario necessario a compensare la disutilità al margine provocata dall'incremento unitario di lavoro oerto. Le varie funzioni di oerta di lavoro individuali, se sommate orizzontalmente, permettono di ottenere l'oerta di lavoro aggregata. salario w(0), quindi il surplus del comparto lavoro è dato da w(0)al(0)o meno DAl(0)O. In equilibrio tutti i lavoratori ricevono un Se il salario di equilibrio diminuisce da w(0) a w(τ), alcuni lavoratori marginali per i quali la disutilità marginale del lavoro è molto elevata non saranno più disposti a lavorare o gli stessi lavoratori che invece continuano a lavorare potrebbero ridurre le ore di lavoro oerte. Nel passaggio da A a B, il surplus netto dei lavoratori si riduce a w(τ)bd e quello delle imprese a (w(τ)+τ)ce, il gettito per lo stato è dato da (w(τ) + τ)cb w(τ), ovvero il nuovo lìvello di occupazione di equilibrio l(τ) per l'imposta τ. I triangolo CAB è la perdita di benessere che non ha contropartita nel gettito dello stato valutato in termini di surplus di imprese e lavoratori. Calcoliamo quindi l'entità della perdita di benessere: AreaABC = [l(0) l(τ)] τ 2 = db τ 2 b + d 2 Possiamo aerrmare che la perdita di benessere è crescente con il quadrato dell'aliquota e con l'elasticita dell'oerta e della domanda di lavoro. La perdita di benessere dovuta all'introduzione del cuneo scale è originata dalla perdita di occupazione, che è proprio ciò che tanto preoccupa i policy-maker ai nostri giorni. E' possibile calcolare l'eetto del cuneo scale sull'occupazione in equilibrio: ovvero: l(0) l(τ) = db b + d τ l = db b + d τ (6) Essendo le variabili espresse in logaritmi, si può dimostrare che è possibile esprimere queste ultime tutte in termini di variazioni percentuali, senza cambiare i coecienti della relazione che lega le variabili logartmiche. La tabella 1 mette in evidenza come il costo del lavoro calcolato come la somma delle imposte sul reddito e dei contributi sociali pagati dai lavoratori e dalle imprese in Italia sia elevato (nel 2012 era pari a quasi il 48% del salario lordo), ma inferiore a quello di Francia Germania e Belgio. (5) Inoltre la letteratura empirica suggerisce che l'elasticità della domanda di lavoro (b) al salario reale sia circa 1 nel lungo periodo, ovvero le imprese si adeguano alla variazione dei salari, mentre quella dell'oerta di lavoro (d) è compresa tra 0,02 e 0,10. con la produttività media. 7
8 Tabella 1: 8
9 Siamo in ora grado di calcolare quanto l'esistenza del cuneo scale pari al 48% del salario (variazione del salario rispetto al salario in assenza di cuneo scale - imposte e contributi sul lavoro -), diminuisca l'occupazione rispetto all'occupazione in assenza di cuneo scale: 0, 02 1 l = 48 = 0, , 02 e 0, 10 1 l = 48 = 4, , 02 Nel caso in cui si ipotizzi l'elasticità della oerta (d) più bassa la variazione di occupazione è pari a poco meno dell'1%, mentre nel caso in cui si ipotizzi l'elasticità dell'oerta (d) più elevata la variazione di occupazione ammonta a poco più del 4%. Un taglio del cuneo scale di 12 punti porterebbe ad una variazione dell'occupazione tra lo 0,2 e l'1,1. I tagli del cuneo scale, essendo le elasticità di domanda ed oerta molto diverse determinano decrementi di surplus di dierente entità per imprese e lavoratori, infatti: surplusimp = AreaACF = [l(0) l(τ)] [w(τ) + τ w(0)] 1 2 = e = 1 db 2 b + d τ dτ b + d = ( τ ) 2 d 2 b b + d 2 surpluslavor = AreaABF = [l(0) l(τ)] [w(0) w(τ)] 1 2 = = 1 db 2 b + d τ bτ b + d = ( τ ) 2 b 2 d b + d 2, da cui: surplusimp < surpluslavor d 2 b > b 2 d b > d, ovvero la perdita di surplus del produttore dovuta ad un incremento del cuneo scale è minore di quella del lavoratore quando l'elasticità della domanda di lavoro e maggiore dell'elasticità dell'oerta come pare risultare dalle rilevazioni empiriche. 9
ESERCITAZIONE 4: Monopolio e concorrenza perfetta
 MIROEONOMIA LEA A.A. 003-00 ESERITAZIONE : Monopolio e concorrenza perfetta Esercizio : Monopolio (da una prova del 7//0) Un monopolista massimizza il suo profitto producendo la uantità Q*=. La curva di
MIROEONOMIA LEA A.A. 003-00 ESERITAZIONE : Monopolio e concorrenza perfetta Esercizio : Monopolio (da una prova del 7//0) Un monopolista massimizza il suo profitto producendo la uantità Q*=. La curva di
Esercitazione 4 EQUILIBRIO. Elena Crivellaro 1. Corso di Economia Politica 1, 2012. 1 Università of Padova
 Esercitazione 4 EQUILIBRIO Elena Crivellaro 1 1 Università of Padova Corso di Economia Politica 1, 2012 Elena Crivellaro (Università di Padova ) Esercitazione 4 Economia Politica 1 1 / 31 Concorrenza perfetta:
Esercitazione 4 EQUILIBRIO Elena Crivellaro 1 1 Università of Padova Corso di Economia Politica 1, 2012 Elena Crivellaro (Università di Padova ) Esercitazione 4 Economia Politica 1 1 / 31 Concorrenza perfetta:
Esercitazione 1 - Scienza delle Finanze. 1 Puro scambio e scatola di Edgeworth. Soluzione. Giuseppe Piroli
 Esercitazione 1 - Scienza delle Finanze Giuseppe Piroli Esercizio 1 - Puro scambio e scatola di Edgeworth Esercizio - Perdita netta di monopolio 1 Puro scambio e scatola di Edgeworth Si consideri un'economia
Esercitazione 1 - Scienza delle Finanze Giuseppe Piroli Esercizio 1 - Puro scambio e scatola di Edgeworth Esercizio - Perdita netta di monopolio 1 Puro scambio e scatola di Edgeworth Si consideri un'economia
a) Tracciare le curve del ricavo marginale e del costo marginale. b) Quale quantità deciderà di produrre?
 Domande 1. Supponete che un impresa possa vendere qualsiasi quantità desideri a 13 euro e che abbia i seguenti costi (CT) per vari livelli di produzione (Q): a) Tracciare le curve del ricavo marginale
Domande 1. Supponete che un impresa possa vendere qualsiasi quantità desideri a 13 euro e che abbia i seguenti costi (CT) per vari livelli di produzione (Q): a) Tracciare le curve del ricavo marginale
Beni pubblici (Economia Pubblica L-Z - Prof. Leonzio Rizzo)
 Beni pubblici (Economia Pubblica L-Z - Prof. Leonzio Rizzo) Il sistema economico nora considerato prevede l'esistenza di un solo tipo di beni: beni privati, i beni cioè che vengono solitamente prodotti
Beni pubblici (Economia Pubblica L-Z - Prof. Leonzio Rizzo) Il sistema economico nora considerato prevede l'esistenza di un solo tipo di beni: beni privati, i beni cioè che vengono solitamente prodotti
Corso di Recupero in Economia Politica: Esercizi
 Corso di Recupero in Economia Politica: Esercizi Jacopo Bonchi September 23, 2017 1 Esercitazione 1: Massimizzazione dell'utilità 1.1 Esercizi in classe Data la funzione di utilità: U(x, y) = 8xy ed il
Corso di Recupero in Economia Politica: Esercizi Jacopo Bonchi September 23, 2017 1 Esercitazione 1: Massimizzazione dell'utilità 1.1 Esercizi in classe Data la funzione di utilità: U(x, y) = 8xy ed il
6 + 2Q = 30 4Q. da cui: Q = 4 Sostituendo Q nella funzione di domanda (o nella funzione di offerta), si ottiene: p = 14
 Esercizio 4.1 L esercizio propone funzioni di domanda e offerta (in forma inversa) e richiede di calcolare il surplus sociale. Occorre innanzitutto calcolare prezzo e quantità di equilibrio, date dall
Esercizio 4.1 L esercizio propone funzioni di domanda e offerta (in forma inversa) e richiede di calcolare il surplus sociale. Occorre innanzitutto calcolare prezzo e quantità di equilibrio, date dall
Capitolo 11 Concorrenza perfetta. Robert H. Frank Microeconomia - 5 a Edizione Copyright The McGraw-Hill Companies, srl
 Capitolo 11 Concorrenza perfetta MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto contabile è
Capitolo 11 Concorrenza perfetta MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto contabile è
Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11)
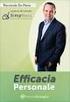 Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11) MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto economico
Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11) MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto economico
In che quantità verrà acquistato un bene?
 In che quantità verrà acquistato un bene? LEGGE DELLA DOMANDA Se il prezzo aumenta, la quantità domandata diminuisce Se il prezzo diminuisce, la quantità domandata aumenta L entità di tale aumento o diminuzione
In che quantità verrà acquistato un bene? LEGGE DELLA DOMANDA Se il prezzo aumenta, la quantità domandata diminuisce Se il prezzo diminuisce, la quantità domandata aumenta L entità di tale aumento o diminuzione
Imposte ed efficienza economica (2)
 Imposte ed efficienza economica (2) La valutazione dell inefficienza delle imposte a livello individuale ha evidenziato che la perdita di benessere dipende esclusivamente dall effetto di sostituzione.
Imposte ed efficienza economica (2) La valutazione dell inefficienza delle imposte a livello individuale ha evidenziato che la perdita di benessere dipende esclusivamente dall effetto di sostituzione.
ECONOMIA APPLICATA ALL INGEGNERIA (Docente: Prof. Ing. Donato Morea)
 ESERCIZIO n. 1 - La produzione ed i costi di produzione (1 ) Un impresa utilizza una tecnologia descritta dalla seguente funzione di produzione: I prezzi dei fattori lavoro e capitale sono, rispettivamente,
ESERCIZIO n. 1 - La produzione ed i costi di produzione (1 ) Un impresa utilizza una tecnologia descritta dalla seguente funzione di produzione: I prezzi dei fattori lavoro e capitale sono, rispettivamente,
Elementi di Economia a.a Facoltà di Scienze Politiche - CdL in Sociologia Esercitazione del 16 Marzo 2011
 Elementi di Economia a.a. 2010-2011 Facoltà di Scienze Politiche - CdL in Sociologia Esercitazione del 16 Marzo 2011 Domande a risposta multipla Fabio ha assunto Luca come assistente nella sua fabbrica
Elementi di Economia a.a. 2010-2011 Facoltà di Scienze Politiche - CdL in Sociologia Esercitazione del 16 Marzo 2011 Domande a risposta multipla Fabio ha assunto Luca come assistente nella sua fabbrica
Lezione 12 Costi marginali, salario e produttività marginale del lavoro. Curva di domanda e
 Corso di Economica Politica prof. S. Papa Lezione 12 Costi marginali, salario e produttività marginale del lavoro. Curva di domanda e offerta di lavoro Facoltà di Economia Università di Roma La Sapienza
Corso di Economica Politica prof. S. Papa Lezione 12 Costi marginali, salario e produttività marginale del lavoro. Curva di domanda e offerta di lavoro Facoltà di Economia Università di Roma La Sapienza
Analisi dell incidenza
 Analisi dell incidenza Incidenza delle imposte Imposte sul consumo (domanda) Imposte sulla produzione (offerta) Imposte sul reddito 1 Imposte sul consumo Imposta specifica: somma applicata ad ogni unità
Analisi dell incidenza Incidenza delle imposte Imposte sul consumo (domanda) Imposte sulla produzione (offerta) Imposte sul reddito 1 Imposte sul consumo Imposta specifica: somma applicata ad ogni unità
Esercizi di Microeconomia Avanzata
 Esercizi di Microeconomia Avanzata Oligopolio - Soluzioni May 7, 015 Esercizio 1 Si consideri un mercato caratterizzato dalla seguente funzione di domanda inversa: costo di produzione di ogni impresa che
Esercizi di Microeconomia Avanzata Oligopolio - Soluzioni May 7, 015 Esercizio 1 Si consideri un mercato caratterizzato dalla seguente funzione di domanda inversa: costo di produzione di ogni impresa che
CAPITOLO 9. La concorrenza perfetta
 CAPITOLO 9 La concorrenza perfetta 1 Mercati di concorrenza perfetta Un mercato di concorrenza perfetta è composto da imprese che producono beni identici e che vendono allo stesso prezzo. Il volume di
CAPITOLO 9 La concorrenza perfetta 1 Mercati di concorrenza perfetta Un mercato di concorrenza perfetta è composto da imprese che producono beni identici e che vendono allo stesso prezzo. Il volume di
Istituzioni di Economia a.a Le scelte del consumatore
 Istituzioni di Economia a.a. - Importante: - completare sempre i grafici indicando le variabili in ascissa e ordinata; - le definizioni si possono dare in termini discorsivi o in termini analitici Le scelte
Istituzioni di Economia a.a. - Importante: - completare sempre i grafici indicando le variabili in ascissa e ordinata; - le definizioni si possono dare in termini discorsivi o in termini analitici Le scelte
Esercizi svolti per l esame di Microeconomia
 Esercizi svolti per l esame di Microeconomia Università di Bari aa. 015-16 Es. 3.1 Concorrenza perfetta In un mercato in concorrenza perfetta in equilibrio di lungo periodo il prezzo è P = 00, la quantità
Esercizi svolti per l esame di Microeconomia Università di Bari aa. 015-16 Es. 3.1 Concorrenza perfetta In un mercato in concorrenza perfetta in equilibrio di lungo periodo il prezzo è P = 00, la quantità
Esame di Microeconomia CLEC - 14/06/2016. Versione A PARTE PRIMA
 Esame di Microeconomia CLEC - 14/06/2016 Versione A Corso AK - Peragine Corso LZ - Serlenga PARTE PRIMA NOME COGNOME MATRICOLA ISTRUZIONI L esame è composto da tre parti: 10 domande vero falso, 1 domanda
Esame di Microeconomia CLEC - 14/06/2016 Versione A Corso AK - Peragine Corso LZ - Serlenga PARTE PRIMA NOME COGNOME MATRICOLA ISTRUZIONI L esame è composto da tre parti: 10 domande vero falso, 1 domanda
Note sul monopolio 1) Il monopolista fronteggia la domanda del mercato: diventa cruciale il concetto di ricavo marginale
 Note sul monopolio 1) Il monopolista fronteggia la domanda del mercato: diventa cruciale il concetto di ricavo marginale In monopolio esiste una sola impresa che perciò fronteggia tutta la domanda di mercato.
Note sul monopolio 1) Il monopolista fronteggia la domanda del mercato: diventa cruciale il concetto di ricavo marginale In monopolio esiste una sola impresa che perciò fronteggia tutta la domanda di mercato.
Capitolo 9. La concorrenza perfetta. Soluzioni delle Domande di ripasso
 Capitolo 9 La concorrenza perfetta Soluzioni delle Domande di ripasso. La differenza tra profitto contabile e profitto economico è dovuta al modo in cui viene misurato il costo totale. Nel caso del profitto
Capitolo 9 La concorrenza perfetta Soluzioni delle Domande di ripasso. La differenza tra profitto contabile e profitto economico è dovuta al modo in cui viene misurato il costo totale. Nel caso del profitto
CAPITOLO 5 FORME DI MERCATO EAI PROF. PAOLO COLLACCHI - DOTT. RICCARDO CORATELLA 205
 CAPITOLO 5 FORME DI MERCATO EAI 2014-2015 - PROF. PAOLO COLLACCHI - DOTT. RICCARDO CORATELLA 205 RICAVO TOTALE, RICAVO MARGINALE E MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO Il ricavo totale è l'importo in denaro (
CAPITOLO 5 FORME DI MERCATO EAI 2014-2015 - PROF. PAOLO COLLACCHI - DOTT. RICCARDO CORATELLA 205 RICAVO TOTALE, RICAVO MARGINALE E MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO Il ricavo totale è l'importo in denaro (
Domande 1. La domanda e l offerta del bene 1 sono date rispettivamente da:
 Domande 1. La domanda e l offerta del bene 1 sono date rispettivamente da: DD SS 10 0,2 2 2 5 0,5 a) Calcolare la quantità e il prezzo di equilibrio sapendo che il reddito a disposizione del consumatore
Domande 1. La domanda e l offerta del bene 1 sono date rispettivamente da: DD SS 10 0,2 2 2 5 0,5 a) Calcolare la quantità e il prezzo di equilibrio sapendo che il reddito a disposizione del consumatore
Domanda individuale e di mercato
 Domanda individuale e di mercato Domanda individuale e di mercato Effetto reddito ed effetto sostituzione La domanda di mercato Il surplus del consumatore 1 La domanda individuale EFFETTO DELLE VARIAZIONI
Domanda individuale e di mercato Domanda individuale e di mercato Effetto reddito ed effetto sostituzione La domanda di mercato Il surplus del consumatore 1 La domanda individuale EFFETTO DELLE VARIAZIONI
p = p p = 440
 Esercizio 1.1 Dato che il reddito dei consumatori è pari a 600, la funzione di domanda può essere scritta: Q = 300 0.p Uguagliando domanda e offerta, otteniamo: 300 0.p = 50 + 0.3p p = 500 Se il reddito
Esercizio 1.1 Dato che il reddito dei consumatori è pari a 600, la funzione di domanda può essere scritta: Q = 300 0.p Uguagliando domanda e offerta, otteniamo: 300 0.p = 50 + 0.3p p = 500 Se il reddito
Temi di <Nome Insegnamento> Unità Didattica xx <Titolo Unità Didattica>
 Mx-Ux: diapositiva #1 Mx-Ux: diapositiva #2 Mx-Ux: diapositiva #3 Unità 4: Il valore economico delle risorse Parte I: I di mercato come misura del valore economico Valore
Mx-Ux: diapositiva #1 Mx-Ux: diapositiva #2 Mx-Ux: diapositiva #3 Unità 4: Il valore economico delle risorse Parte I: I di mercato come misura del valore economico Valore
Indice Sommario. pag. Indice delle figure TEORIA DEL CONSUMATORE Domande a risposta aperta
 Indice Sommario pag. Indice delle figure... 5 1. TEORIA DEL CONSUMATORE... 9 Domande a risposta aperta... 11 Problemi... 38 Domande a risposta multipla... 55 2. PRODUZIONE E COSTI... 59 Domande a risposta
Indice Sommario pag. Indice delle figure... 5 1. TEORIA DEL CONSUMATORE... 9 Domande a risposta aperta... 11 Problemi... 38 Domande a risposta multipla... 55 2. PRODUZIONE E COSTI... 59 Domande a risposta
ELASTICITA. Elasticità dell arco in una curva di domanda:
 ELASTICITA Elasticità dell arco in una curva di domanda: Δq / q E D = Δp / p ESERCIZIO Data la funzione di domanda p = - ½ q + 100, calcolare l elasticità per l arco BC, compreso tra i punti di coordinate:
ELASTICITA Elasticità dell arco in una curva di domanda: Δq / q E D = Δp / p ESERCIZIO Data la funzione di domanda p = - ½ q + 100, calcolare l elasticità per l arco BC, compreso tra i punti di coordinate:
Monopolio P, R R R RMe (domanda) Viki Nellas Esercizio 1
 onopolio Viki Nellas Esercizio La curva di domanda di un monopolista è 000. La funzione dei suoi costi totali è 7.5 + 00 + 00 a) Determinate le curve del ricavo medio e marginale di questa impresa e rappresentatele
onopolio Viki Nellas Esercizio La curva di domanda di un monopolista è 000. La funzione dei suoi costi totali è 7.5 + 00 + 00 a) Determinate le curve del ricavo medio e marginale di questa impresa e rappresentatele
Integrazioni al corso di Economia Politica (anno accademico ) Marianna Belloc
 Integrazioni al corso di Economia Politica (anno accademico 2013-2014) Marianna Belloc 1 L elasticità Come è già noto, la funzione di domanda di mercato indica la quantità che il mercato è disposto ad
Integrazioni al corso di Economia Politica (anno accademico 2013-2014) Marianna Belloc 1 L elasticità Come è già noto, la funzione di domanda di mercato indica la quantità che il mercato è disposto ad
ESERCITAZIONE 7: STRATEGIE DI PREZZO E EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE
 MICROECONOMI CLE.. 00-004 ssistente alla didattica: Elena rgentesi ESERCITZIONE 7: STRTEGIE I PREZZO E EQUILIRIO ECONOMICO GENERLE Esercizio : iscriminazione di prezzo del terzo tipo [Secondo parziale
MICROECONOMI CLE.. 00-004 ssistente alla didattica: Elena rgentesi ESERCITZIONE 7: STRTEGIE I PREZZO E EQUILIRIO ECONOMICO GENERLE Esercizio : iscriminazione di prezzo del terzo tipo [Secondo parziale
Mercati dei fattori produttivi (Frank, Capitolo 14)
 Mercati dei fattori produttivi (Frank, Capitolo 14) LA DOMANDA DI LAVORO DI BREVE PERIODO PER UN IMPRESA IN CONCORRENZA PERFETTA Si è visto in che modo la massimizzazione del profitto guidi le scelte dell
Mercati dei fattori produttivi (Frank, Capitolo 14) LA DOMANDA DI LAVORO DI BREVE PERIODO PER UN IMPRESA IN CONCORRENZA PERFETTA Si è visto in che modo la massimizzazione del profitto guidi le scelte dell
MERCATI, DOMANDA E OFFERTA. Barbara Martini
 MERCATI, DOMANDA E OFFERTA Barbara Martini Piano della lezione Economie pianificate vs economie di mercato Le caratteristiche e le determinanti della domanda e dell offerta La determinazione del prezzo
MERCATI, DOMANDA E OFFERTA Barbara Martini Piano della lezione Economie pianificate vs economie di mercato Le caratteristiche e le determinanti della domanda e dell offerta La determinazione del prezzo
ESERCITAZIONI DI ECONOMIA POLITICA (programma di MICROECONOMIA) seconda parte
 ESERCITAZIONI DI ECONOMIA POLITICA (programma di MICROECONOMIA) anno accademico 01 013 seconda parte Per domande, dubbi o chiarimenti scrivere a: gaetano.lisi@unicas.it 1 1. IMPORTANZA DEI COSTI (MEDI)
ESERCITAZIONI DI ECONOMIA POLITICA (programma di MICROECONOMIA) anno accademico 01 013 seconda parte Per domande, dubbi o chiarimenti scrivere a: gaetano.lisi@unicas.it 1 1. IMPORTANZA DEI COSTI (MEDI)
CONSUMO. 3. Il Saggio Marginale di Sostituzione (SMS)
 CONSUMO 1. Le Preferenze del Consumatore 2. Curve di Indifferenza 3. Il Saggio Marginale di Sostituzione (SMS) 4. La Funzione di Utilità Utilità Marginale e Utilità Marginale Decrescente Utilità Marginale
CONSUMO 1. Le Preferenze del Consumatore 2. Curve di Indifferenza 3. Il Saggio Marginale di Sostituzione (SMS) 4. La Funzione di Utilità Utilità Marginale e Utilità Marginale Decrescente Utilità Marginale
Offerta dell impresa e mercato di concorrenza perfetta
 Offerta dell impresa e mercato di concorrenza perfetta Caratteristiche della concorrenza perfetta La concorrenza perfetta è una forma di mercato dove: 1. Agisce un numero molto grande di produttori; 2.
Offerta dell impresa e mercato di concorrenza perfetta Caratteristiche della concorrenza perfetta La concorrenza perfetta è una forma di mercato dove: 1. Agisce un numero molto grande di produttori; 2.
Capitolo 4. Le forze di mercato della domanda e dell offerta
 Capitolo 4 Le forze di mercato della domanda e dell offerta Le forze di mercato della domanda e dell offerta La microeconomia moderna si occupa dell offerta, della domanda e dell equilibrio di mercato.
Capitolo 4 Le forze di mercato della domanda e dell offerta Le forze di mercato della domanda e dell offerta La microeconomia moderna si occupa dell offerta, della domanda e dell equilibrio di mercato.
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE FORESTALI E AMBIENTALI
 Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE FORESTALI E AMBIENTALI ISTITUZIONI DI ECONOMIA AGRARIA, FORESTALE E AMBIENTALE PRESENTAZIONE DEL CORSO Elena Pisani
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE FORESTALI E AMBIENTALI ISTITUZIONI DI ECONOMIA AGRARIA, FORESTALE E AMBIENTALE PRESENTAZIONE DEL CORSO Elena Pisani
1. Introduzione alle forme di mercato - Concorrenza perfetta
 1. Introduzione alle forme di mercato - Concorrenza perfetta Alessandra Michelangeli November 3, 2010 Alessandra Michelangeli () 1. Forme di mercato - Concorrenza perfetta November 3, 2010 1 / 16 Forme
1. Introduzione alle forme di mercato - Concorrenza perfetta Alessandra Michelangeli November 3, 2010 Alessandra Michelangeli () 1. Forme di mercato - Concorrenza perfetta November 3, 2010 1 / 16 Forme
Struttura di mercato: insieme di elementi che incidono sul comportamento e il rendimento delle imprese di mercato, quali numero di imprese e tipo di
 Struttura di mercato: insieme di elementi che incidono sul comportamento e il rendimento delle imprese di mercato, quali numero di imprese e tipo di bene venduto Concorrenzialità del mercato: dipende dalla
Struttura di mercato: insieme di elementi che incidono sul comportamento e il rendimento delle imprese di mercato, quali numero di imprese e tipo di bene venduto Concorrenzialità del mercato: dipende dalla
1 Esercizio. Funzione di Costo
 1 Esercizio. Funzione di osto Un impresa ha la seguente funzione di costo di breve periodo: e il seguente costo marginale: T = 1600 + q + 8q = q + 8 Si individui a) il costo fisso; b) il costo variabile
1 Esercizio. Funzione di osto Un impresa ha la seguente funzione di costo di breve periodo: e il seguente costo marginale: T = 1600 + q + 8q = q + 8 Si individui a) il costo fisso; b) il costo variabile
Esercitazione 10 marzo 2010 Cap. 6, 7, 8 Multiple Choice Cap. 6
 Esercitazione 10 marzo 2010 Cap. 6, 7, 8 Multiple Choice Cap. 6 1. La disponibilità a pagare di Peppe per l acquisto di un CD musicale è 12 euro. Questo significa che: a. 12 euro è il prezzo di mercato
Esercitazione 10 marzo 2010 Cap. 6, 7, 8 Multiple Choice Cap. 6 1. La disponibilità a pagare di Peppe per l acquisto di un CD musicale è 12 euro. Questo significa che: a. 12 euro è il prezzo di mercato
Le imprese nei mercati concorrenziali
 Le imprese nei mercati concorrenziali Le decisioni di prezzo e di produzione delle imprese sono influenzate dalla forma di mercato. Un caso estremo di mercato è quello della concorrenza perfetta. Tre condizioni:
Le imprese nei mercati concorrenziali Le decisioni di prezzo e di produzione delle imprese sono influenzate dalla forma di mercato. Un caso estremo di mercato è quello della concorrenza perfetta. Tre condizioni:
Mercato del lavoro in concorrenza imperfetta
 Mercato del lavoro in concorrenza imperfetta Monopsonio Sommario Monopolio dell impresa sul mercato del prodotto Sindacato monopolista e modelli di contrattazione su salari ed occupazione (right to manage;
Mercato del lavoro in concorrenza imperfetta Monopsonio Sommario Monopolio dell impresa sul mercato del prodotto Sindacato monopolista e modelli di contrattazione su salari ed occupazione (right to manage;
1 Ottima combinazione dei fattori produttivi. 2 Ottima combinazione dei fattori produttivi e curve di costo
 Esercizi svolti in classe Produzione e Concorrenza Perfetta 1 Ottima combinazione dei fattori produttivi Si consideri un impresa con la seguente funzione di produzione = L K e i prezzi dei fattori lavoro
Esercizi svolti in classe Produzione e Concorrenza Perfetta 1 Ottima combinazione dei fattori produttivi Si consideri un impresa con la seguente funzione di produzione = L K e i prezzi dei fattori lavoro
In una ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla e a una delle due domande a risposta aperta, e risolvere l esercizio.
 In una ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla e a una delle due domande a risposta aperta, e risolvere l esercizio. Domande a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione
In una ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla e a una delle due domande a risposta aperta, e risolvere l esercizio. Domande a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione
Esercitazioni di Economia politica Microeconomia
 5. IL LATO DELLA DOMANDA IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE Utilità, utilità marginale e regola della spesa razionale (richiami di teoria) L utilità è il grado di soddisfazione che gli individui traggono
5. IL LATO DELLA DOMANDA IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE Utilità, utilità marginale e regola della spesa razionale (richiami di teoria) L utilità è il grado di soddisfazione che gli individui traggono
Microeconomia (C.L. Economia e Legislazione di Impresa); A.A. 2010/2011 Prof. C. Perugini
 Microeconomia (C.L. Economia e Legislazione di Impresa); A.A. 2010/2011 Prof. C. Perugini Esercitazione n.8 1 Offerta dell impresa; concorrenza perfetta e monopolio; benessere Esercizio 1 Costi dell impresa
Microeconomia (C.L. Economia e Legislazione di Impresa); A.A. 2010/2011 Prof. C. Perugini Esercitazione n.8 1 Offerta dell impresa; concorrenza perfetta e monopolio; benessere Esercizio 1 Costi dell impresa
Microeconomia, Esercitazione 5. 1 Esercizi. 1.1 Monopolio/ Monopolio/2. A cura di Giuseppe Gori
 Microeconomia, Esercitazione 5. A cura di Giuseppe Gori (giuseppe.gori@unibo.it) Esercizi.. Monopolio/ Supponete che in un ipotetico mercato, curva di domanda, costi marginali dell impresa monopolista
Microeconomia, Esercitazione 5. A cura di Giuseppe Gori (giuseppe.gori@unibo.it) Esercizi.. Monopolio/ Supponete che in un ipotetico mercato, curva di domanda, costi marginali dell impresa monopolista
CONCORRENZA PERFETTA E MONOPOLIO. L impresa massimizza i profitti quando
 CONCORRENZA PERFETTA E MONOPOLIO Sono le due principali forme di di riferimento per valutare l efficienza e il potere di Modello di Concorrenza Perfetta ipotesi Struttura atomistica Prodotto omogeneo Liberta`
CONCORRENZA PERFETTA E MONOPOLIO Sono le due principali forme di di riferimento per valutare l efficienza e il potere di Modello di Concorrenza Perfetta ipotesi Struttura atomistica Prodotto omogeneo Liberta`
Economia del Lavoro 2010
 Economia del Lavoro 2010 Capitolo 3 La domanda di lavoro - 1 Le decisioni di assumere e licenziare delle imprese in ogni momento creano e distruggono molti posti di lavoro. Le imprese assumono lavoratori
Economia del Lavoro 2010 Capitolo 3 La domanda di lavoro - 1 Le decisioni di assumere e licenziare delle imprese in ogni momento creano e distruggono molti posti di lavoro. Le imprese assumono lavoratori
Economia Politica I Università Cattolica del Sacro Cuore 14 aprile 2015 PRIMA PROVA INTERMEDIA. Prof. Salvatore Piccolo
 Economia Politica I Università Cattolica del Sacro Cuore 14 aprile 1 PRIMA PROVA INTERMEDIA Prof. Salvatore Piccolo Istruzioni: La prova si compone di due parti, teoria ed esercizi. Avete un tempo massimo
Economia Politica I Università Cattolica del Sacro Cuore 14 aprile 1 PRIMA PROVA INTERMEDIA Prof. Salvatore Piccolo Istruzioni: La prova si compone di due parti, teoria ed esercizi. Avete un tempo massimo
Domanda e Offerta - Elasticità Dott. ssa Sabrina Pedrini
 Microeconomia, Esercitazione 1 (23/02/2017) Domanda e Offerta - Elasticità Dott. ssa Sabrina Pedrini Domande a risposta multipla 1) Siamo di fronte a un aumento (ossia uno spostamento verso destra) dell
Microeconomia, Esercitazione 1 (23/02/2017) Domanda e Offerta - Elasticità Dott. ssa Sabrina Pedrini Domande a risposta multipla 1) Siamo di fronte a un aumento (ossia uno spostamento verso destra) dell
Domanda e Offerta - Elasticità Dott. ssa Sabrina Pedrini
 Microeconomia, Esercitazione 1 (01/03/2016) Domanda e Offerta - Elasticità Dott. ssa Sabrina Pedrini Domande a risposta multipla 1) Siamo di fronte a un aumento (ossia uno spostamento verso destra) dell
Microeconomia, Esercitazione 1 (01/03/2016) Domanda e Offerta - Elasticità Dott. ssa Sabrina Pedrini Domande a risposta multipla 1) Siamo di fronte a un aumento (ossia uno spostamento verso destra) dell
I PROVA INTERMEDIA DOMANDE PER ESERCITAZIONE
 Nome Cognome Matr. 1) Se la domanda è ad elasticità unitaria rispetto al prezzo, quali sono le conseguenze di una diminuzione del prezzo del 5% sulla quantità domandata? La quantità domandata non varia
Nome Cognome Matr. 1) Se la domanda è ad elasticità unitaria rispetto al prezzo, quali sono le conseguenze di una diminuzione del prezzo del 5% sulla quantità domandata? La quantità domandata non varia
Prof.ssa Mariarosaria Agostino
 ECONOMIA APPLICATA Prof.ssa Mariarosaria Agostino Dispensa 10. Brevi note su: Domanda, Offerta, Equilibrio nei mercati concorrenziali. Esercizi di statica comparata. [Pindyck, Rubinfeld cap2 e cap 9, ed.
ECONOMIA APPLICATA Prof.ssa Mariarosaria Agostino Dispensa 10. Brevi note su: Domanda, Offerta, Equilibrio nei mercati concorrenziali. Esercizi di statica comparata. [Pindyck, Rubinfeld cap2 e cap 9, ed.
Esercitazione II. Capp. 6-10, 13-14
 Esercitazione II Capp. 6-10, 13-14 Domanda 1 All impresa perfettamente concorrenziale conviene sempre scegliere il livello di prodotto per il quale il prezzo uguaglia il costo marginale. Vero o Falso?
Esercitazione II Capp. 6-10, 13-14 Domanda 1 All impresa perfettamente concorrenziale conviene sempre scegliere il livello di prodotto per il quale il prezzo uguaglia il costo marginale. Vero o Falso?
Introduzione all Oligopolio
 SUN - Economia Politica - 1 a Cattedra 27 maggio 2012 Definizione di mercato Oligopolistico L oligopolio è una forma di mercato intermedia tra la libera concorrenza e il monopolio, in essa l offerta è
SUN - Economia Politica - 1 a Cattedra 27 maggio 2012 Definizione di mercato Oligopolistico L oligopolio è una forma di mercato intermedia tra la libera concorrenza e il monopolio, in essa l offerta è
OFFERTA DELL IMPRESA
 Economia, Corso di Laurea Magistrale in Ing. Elettrotecnica, A.A. 2013-2014. Prof. R. Sestini SCHEMA DELLE LEZIONI DELLA SETTIMA SETTIMANA OFFERTA DELL IMPRESA Ipotizziamo di essere in regime di concorrenza
Economia, Corso di Laurea Magistrale in Ing. Elettrotecnica, A.A. 2013-2014. Prof. R. Sestini SCHEMA DELLE LEZIONI DELLA SETTIMA SETTIMANA OFFERTA DELL IMPRESA Ipotizziamo di essere in regime di concorrenza
ESERCIZI DI MICROECONOMIA
 ESERCIZIO 1 - Equilibrio di mercato e spostamenti delle curve di domanda e di offerta La quantità domandata di un certo bene è descritta dalla funzione: p (D) mentre la quantità offerta è descritta dalla
ESERCIZIO 1 - Equilibrio di mercato e spostamenti delle curve di domanda e di offerta La quantità domandata di un certo bene è descritta dalla funzione: p (D) mentre la quantità offerta è descritta dalla
La teoria neoclassica dei mercati concorrenziali
 La teoria neoclassica dei mercati concorrenziali Nelle Economie capitaliste il Mercato è il luogo principe (anche se non l unico) dove prendono corpo le interazioni tra gli agenti economici del sistema.
La teoria neoclassica dei mercati concorrenziali Nelle Economie capitaliste il Mercato è il luogo principe (anche se non l unico) dove prendono corpo le interazioni tra gli agenti economici del sistema.
Domande ed Esercizi Corso di Istituzioni di Economia Politica
 Domande ed Esercizi Corso di Istituzioni di Economia Politica Simone D Alessandro Ottobre 2009 Indice 1 Teoria del Consumatore 1 1.1 Esercizi.............................. 1 2 Teoria della Produzione 3
Domande ed Esercizi Corso di Istituzioni di Economia Politica Simone D Alessandro Ottobre 2009 Indice 1 Teoria del Consumatore 1 1.1 Esercizi.............................. 1 2 Teoria della Produzione 3
Riassunto della Concorrenza Perfetta (LP=lungo periodo):
 Monopolio (Capitolo 10 del libro di testo di Micro) Riassunto della Concorrenza Perfetta (LP=lungo periodo): Elevato numero di acquirenti e di venditori entrambi price takers Prodotto omogeneo Informazione
Monopolio (Capitolo 10 del libro di testo di Micro) Riassunto della Concorrenza Perfetta (LP=lungo periodo): Elevato numero di acquirenti e di venditori entrambi price takers Prodotto omogeneo Informazione
P.A.S. Percorsi Abilitanti Speciali 2014 Facoltà di Giurisprudenza Ettore Peyron - Lezione N 1 C del CATEGORIE fondamentali della
 P.A.S. Percorsi Abilitanti Speciali 2014 Facoltà di Giurisprudenza Ettore Peyron - Lezione N 1 C del 24-4-2014 CATEGORIE fondamentali della MACROECONOMIA tratte dalla MICROECONOMIA Le LEGGI della DOMANDA
P.A.S. Percorsi Abilitanti Speciali 2014 Facoltà di Giurisprudenza Ettore Peyron - Lezione N 1 C del 24-4-2014 CATEGORIE fondamentali della MACROECONOMIA tratte dalla MICROECONOMIA Le LEGGI della DOMANDA
Mercati Concorrenziali
 DOMANDA E OFFERTA Mercati Concorrenziali Un mercato è un insieme di acquirenti e di venditori di un determinato bene. Un mercato concorrenziale è un mercato in cui vi siano numerosi acquirenti e venditori
DOMANDA E OFFERTA Mercati Concorrenziali Un mercato è un insieme di acquirenti e di venditori di un determinato bene. Un mercato concorrenziale è un mercato in cui vi siano numerosi acquirenti e venditori
ISTITUZIONI DI ECONOMIA (a.a ) PROVE D ESAME
 Giuseppe Garofalo Dipartimento di Economia pubblica Facoltà di Economia Università degli studi di Roma La Sapienza ISTITUZIONI DI ECONOMIA (a.a. 1999-2000) PROVE D ESAME Prova intermedia di Macro (4-3-2000)
Giuseppe Garofalo Dipartimento di Economia pubblica Facoltà di Economia Università degli studi di Roma La Sapienza ISTITUZIONI DI ECONOMIA (a.a. 1999-2000) PROVE D ESAME Prova intermedia di Macro (4-3-2000)
Esercitazione 3. Esercizio 1 - Salari relativi
 Esercitazione 3 Esercizio 1 - Salari relativi La tecnologia di produzione di formaggio e vino nei paesi A e B è sintetizzata dalla Tabella 9.1. Inoltre le dotazioni di fattore lavoro sono pari a L = L
Esercitazione 3 Esercizio 1 - Salari relativi La tecnologia di produzione di formaggio e vino nei paesi A e B è sintetizzata dalla Tabella 9.1. Inoltre le dotazioni di fattore lavoro sono pari a L = L
Elenco dei simboli più comunemente usati in economia politica
 Elenco dei simboli più comunemente usati in economia politica Simboli matematici m Coefficiente angolare di una retta generica Misura la pendenza della retta; se ha segno positivo la retta è crescente,
Elenco dei simboli più comunemente usati in economia politica Simboli matematici m Coefficiente angolare di una retta generica Misura la pendenza della retta; se ha segno positivo la retta è crescente,
Applicazione: I costi della tassazione
 Applicazione: I costi della zione Capitolo 8 I costi della zione Come le tasse influenzano il benessere degli agenti economici? 1 I costi della zione Non importa se una è imposta sui consumatori o sui
Applicazione: I costi della zione Capitolo 8 I costi della zione Come le tasse influenzano il benessere degli agenti economici? 1 I costi della zione Non importa se una è imposta sui consumatori o sui
In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio.
 In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. Domande a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. Domande a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
ECONOMIA APPLICATA ALL INGEGNERIA (Docente: Prof. Ing. Donato Morea)
 ESERCIZIO n. 1 - Scelte di consumo (scelta ottimale, variazione di prezzo, variazione di reddito) Un consumatore ha preferenze rappresentate dalla seguente funzione di utilità: a) Determinare la scelta
ESERCIZIO n. 1 - Scelte di consumo (scelta ottimale, variazione di prezzo, variazione di reddito) Un consumatore ha preferenze rappresentate dalla seguente funzione di utilità: a) Determinare la scelta
Esonero di Microeconomia CLEC / CLSS Università degli Studi di Bari Aldo Moro
 Esonero di Microeconomia CLEC / CLSS Università degli Studi di Bari Aldo Moro Versione A - Prof. Peragine Domande Vero Falso 1. Il saggio marginale di preferenza intertemporale è una misura della impazienza
Esonero di Microeconomia CLEC / CLSS Università degli Studi di Bari Aldo Moro Versione A - Prof. Peragine Domande Vero Falso 1. Il saggio marginale di preferenza intertemporale è una misura della impazienza
FATTORI PRODUTTIVI E DISTRIBUZIONI DEL REDDITO PROF. MATTIA LETTIERI
 FATTORI PRODUTTIVI E DISTRIBUZIONI DEL REDDITO PROF. MATTIA LETTIERI Indice 1 I PREZZI DEI FATTORI PRODUTTIVI -------------------------------------------------------------------------------- 3 2 LA MASSIMIZZAZIONE
FATTORI PRODUTTIVI E DISTRIBUZIONI DEL REDDITO PROF. MATTIA LETTIERI Indice 1 I PREZZI DEI FATTORI PRODUTTIVI -------------------------------------------------------------------------------- 3 2 LA MASSIMIZZAZIONE
ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI
 FACOLTA DI INGEGNERIA ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI ESERCIZI SVOLTI IN AULA A.A. 2010-2011 DOCENTE: Francesca Iacobone ASSISTENTE ALLA DIDATTICA: Andrea Maresca RICHIAMI DI TEORIA I richiami di teoria
FACOLTA DI INGEGNERIA ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI ESERCIZI SVOLTI IN AULA A.A. 2010-2011 DOCENTE: Francesca Iacobone ASSISTENTE ALLA DIDATTICA: Andrea Maresca RICHIAMI DI TEORIA I richiami di teoria
Corso di Recupero in Economia Politica
 Corso di Recupero in Economia Politica Jacopo Bonchi November 28, 207 IMPORTANTE Le soluzioni si trovano: sul sito del prof. Parello (https://sites.google.com/a/uniroma.it/economicamente/) in materiale
Corso di Recupero in Economia Politica Jacopo Bonchi November 28, 207 IMPORTANTE Le soluzioni si trovano: sul sito del prof. Parello (https://sites.google.com/a/uniroma.it/economicamente/) in materiale
SURPLUS, EFFICIENZA E PERDITA NETTA (brevi richiami di teoria)
 Esercitazioni di Economia olitica (Microeconomia) gaetano.lisi@unicas.it SURLUS, EFFIIENZA E ERITA NETTA (brevi richiami di teoria) Il surplus totale è la somma del surplus del compratore e del surplus
Esercitazioni di Economia olitica (Microeconomia) gaetano.lisi@unicas.it SURLUS, EFFIIENZA E ERITA NETTA (brevi richiami di teoria) Il surplus totale è la somma del surplus del compratore e del surplus
d) Per ogni unità venduta il monopolista perde la differenza tra prezzo (500) e costo medio (750). La perdita è quindi: ( ) * 250 =
 ESERCIZIO 1 Un'impresa opera in regime di monolio naturale. I suoi costi medi (CM) sono pari a: CM = 1000 q mentre la funzione di domanda del mercato è: p = 2000-6 q Lo stato impone al monopolista di comportarsi
ESERCIZIO 1 Un'impresa opera in regime di monolio naturale. I suoi costi medi (CM) sono pari a: CM = 1000 q mentre la funzione di domanda del mercato è: p = 2000-6 q Lo stato impone al monopolista di comportarsi
Economia Politica. Cap 8 Tassazione e benessere. Appunti delle lezioni Raffaele Paci
 Economia Politica Appunti delle lezioni Raffaele Paci testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 24, Zanichelli Cap 8 Tassazione e benessere Inquadramento generale Abbiamo visto come i
Economia Politica Appunti delle lezioni Raffaele Paci testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 24, Zanichelli Cap 8 Tassazione e benessere Inquadramento generale Abbiamo visto come i
Definizioni economia applicata all ingegneria
 Definizioni economia applicata all ingegneria October 28 2011 In questo documento assolutamente non ufficiale sono contenute le definizioni date durante le lezioni di economia applicata all ingegneria.
Definizioni economia applicata all ingegneria October 28 2011 In questo documento assolutamente non ufficiale sono contenute le definizioni date durante le lezioni di economia applicata all ingegneria.
concorrenza perfetta vs. monopolio
 Lezione di Giacomo Degli Antoni, 20-3- 13 concorrenza perfetta vs. monopolio (Cap. 3 e 4 Carlton - Perloff) Piano della lezione Caratteristiche principali della concorrenza perfetta Caratteristiche principali
Lezione di Giacomo Degli Antoni, 20-3- 13 concorrenza perfetta vs. monopolio (Cap. 3 e 4 Carlton - Perloff) Piano della lezione Caratteristiche principali della concorrenza perfetta Caratteristiche principali
Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 4
 Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 4 Premessa Studiando la curva di offerta e di domanda di un bene abbiamo visto che venditori e consumatori hanno la necessità di incontrarsi per vendere e
Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 4 Premessa Studiando la curva di offerta e di domanda di un bene abbiamo visto che venditori e consumatori hanno la necessità di incontrarsi per vendere e
Le scelte del consumatore
 Istituzioni di Economia a.a. - Importante: - completare sempre i grafici indicando le variabili in ascissa e ordinata; - le definizioni si possono dare in termini discorsivi o in termini analitici Le scelte
Istituzioni di Economia a.a. - Importante: - completare sempre i grafici indicando le variabili in ascissa e ordinata; - le definizioni si possono dare in termini discorsivi o in termini analitici Le scelte
Politica economica: Lezione 13
 Politica economica: Lezione 13 II canale: M - Z Crediti: 9 Corsi di laurea: Nuovo Ordinamento (DM. 270) Vecchio ordinamento (DM. 590) 1 Caratteristiche di un monopolio puro Un unico venditore: una sola
Politica economica: Lezione 13 II canale: M - Z Crediti: 9 Corsi di laurea: Nuovo Ordinamento (DM. 270) Vecchio ordinamento (DM. 590) 1 Caratteristiche di un monopolio puro Un unico venditore: una sola
Dato che la domanda è inclinata negativamente, il secondo termine è negativo, il che implica che il ricavo marginale è minore del prezzo.
 Capitolo 11 Il monopolio Soluzioni delle Domande di ripasso 1. Un mercato di monopolio è costituito da un unico venditore e da molteplici acquirenti. Poiché, per definizione, l impresa serve l intero mercato,
Capitolo 11 Il monopolio Soluzioni delle Domande di ripasso 1. Un mercato di monopolio è costituito da un unico venditore e da molteplici acquirenti. Poiché, per definizione, l impresa serve l intero mercato,
Esercizi per prendere maggiore confidenza con gli argomenti del corso
 Corso di ECONOMIA POLITICA L-36 (canale A-L) anno accademico 2016-2017 Esercizi per prendere maggiore confidenza con gli argomenti del corso 1) Supponete che la funzione di domanda di un determinato bene
Corso di ECONOMIA POLITICA L-36 (canale A-L) anno accademico 2016-2017 Esercizi per prendere maggiore confidenza con gli argomenti del corso 1) Supponete che la funzione di domanda di un determinato bene
CAPITOLO 2. PENSARE DA ECONOMISTI. 1 modello: flusso circolare del reddito (figura 2.1) PIANO DEL CORSO
 CAPITOLO 2. PENSARE DA ECONOMISTI Metodo scientifico, astrazione, ipotesi Scienze sociali, scienze esatte Modelli economici: 1 modello: flusso circolare del reddito (figura 2.1) Analisi positiva e analisi
CAPITOLO 2. PENSARE DA ECONOMISTI Metodo scientifico, astrazione, ipotesi Scienze sociali, scienze esatte Modelli economici: 1 modello: flusso circolare del reddito (figura 2.1) Analisi positiva e analisi
Effetti delle imposte nel mercato dei capitali. Economia dei tributi_polin 1
 Effetti delle imposte nel mercato dei capitali Economia dei tributi_polin 1 Mercato del capitale Curva di offerta di capitale (risparmio) Curva di domanda di capitale (investimento) Economia dei tributi_polin
Effetti delle imposte nel mercato dei capitali Economia dei tributi_polin 1 Mercato del capitale Curva di offerta di capitale (risparmio) Curva di domanda di capitale (investimento) Economia dei tributi_polin
Analisi dei mercati concorrenziali e valutazione delle politiche pubbliche. G. Pignataro Microeconomia SPOSI
 Analisi dei mercati concorrenziali e valutazione delle politiche pubbliche 1 Efficienza di un mercato concorrenziale Efficienza economica: Massimizzazione del surplus aggregato del consumatore e del produttore.
Analisi dei mercati concorrenziali e valutazione delle politiche pubbliche 1 Efficienza di un mercato concorrenziale Efficienza economica: Massimizzazione del surplus aggregato del consumatore e del produttore.
ESERCIZI - ECONOMIA PUBBLICA LZ 2016
 ESERCIZI - ECONOMIA PUBBLICA LZ 2016 Esercizio 1 (IVA) Si consideri la seguente situazione: - l'impresa A vende all'impresa B un bene intermedio, che ha prodotto utilizzando solo il fattore lavoro, al
ESERCIZI - ECONOMIA PUBBLICA LZ 2016 Esercizio 1 (IVA) Si consideri la seguente situazione: - l'impresa A vende all'impresa B un bene intermedio, che ha prodotto utilizzando solo il fattore lavoro, al
Capitolo 17: Aggregazione
 Capitolo 17: Aggregazione 17.1: Introduzione In questo capitolo introduciamo dei concetti strumentali all analisi contenuta nel prosieguo del testo. Studiamo la procedura di aggregazione delle funzioni
Capitolo 17: Aggregazione 17.1: Introduzione In questo capitolo introduciamo dei concetti strumentali all analisi contenuta nel prosieguo del testo. Studiamo la procedura di aggregazione delle funzioni
Forme di mercato e Massimizzazione del profitto con funzioni di ricavo
 Forme di mercato e Massimizzazione del profitto con funzioni di ricavo L importanza del regime di mercato Il comportamento e le decisioni di un impresa sono influenzati, oltre che da fattori interni all
Forme di mercato e Massimizzazione del profitto con funzioni di ricavo L importanza del regime di mercato Il comportamento e le decisioni di un impresa sono influenzati, oltre che da fattori interni all
LEZIONE 15 OFFERTA DELL IMPRESA IN CONCORRENZA PERFETTA
 LEZIONE 15 OFFERTA DELL IMPRESA IN CONCORRENZA PERFETTA Ipotesi del modello di concorrenza perfetta Curva di domanda per l impresa e domanda di mercato se impresa è price taker Decisioni: Quanto produrre?
LEZIONE 15 OFFERTA DELL IMPRESA IN CONCORRENZA PERFETTA Ipotesi del modello di concorrenza perfetta Curva di domanda per l impresa e domanda di mercato se impresa è price taker Decisioni: Quanto produrre?
EQUILIBRIO DI MERCATO, POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE
 EQUILIBRIO DI MERCATO, POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE CONTROLLO dei PREZZI Vi sono situazioni in cui il principio di efficienza si scontra con quello di equità. Considerazioni di tipo normativo possono
EQUILIBRIO DI MERCATO, POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE CONTROLLO dei PREZZI Vi sono situazioni in cui il principio di efficienza si scontra con quello di equità. Considerazioni di tipo normativo possono
SIMULAZIONE PROVA DI ECONOMIA POLITICA (PRIMA PARTE DEL PROGRAMMA: CAPP. 2,4,5,7,21) ANNO ACCADEMICO 2011/2012
 SIMULAZIONE PROVA DI ECONOMIA POLITICA (PRIMA PARTE DEL PROGRAMMA: CAPP. 2,4,5,7,21) ANNO ACCADEMICO 2011/2012 La prova d esame completa comprende 6 domande a risposta multipla più 4 esercizi articolati
SIMULAZIONE PROVA DI ECONOMIA POLITICA (PRIMA PARTE DEL PROGRAMMA: CAPP. 2,4,5,7,21) ANNO ACCADEMICO 2011/2012 La prova d esame completa comprende 6 domande a risposta multipla più 4 esercizi articolati
6 a Esercitazione: soluzioni
 6 a Esercitazione: soluzioni Corso di Microeconomia A K, a.a. 009 010 Monica Bonacina (monica.bonacina@unibocconi.it) Corso di Microeconomia L Z, a.a. 009 010 Stefania Migliavacca (stefania.migliavacca@enicorporateuniversity.eni.it)
6 a Esercitazione: soluzioni Corso di Microeconomia A K, a.a. 009 010 Monica Bonacina (monica.bonacina@unibocconi.it) Corso di Microeconomia L Z, a.a. 009 010 Stefania Migliavacca (stefania.migliavacca@enicorporateuniversity.eni.it)
ESERCIZIO n. 2. Soluzione
 Economia Internazionale e Politiche Commerciali a.a. 2013/14 ESERCIZIO n. 2 Krugman, Obstfeld e Melitz, Capitolo 4: Problemi n. 2, 3, 4, 5 e 6 (pp. 101 103) Problema 3 domanda d): Calcolate Discutete gli
Economia Internazionale e Politiche Commerciali a.a. 2013/14 ESERCIZIO n. 2 Krugman, Obstfeld e Melitz, Capitolo 4: Problemi n. 2, 3, 4, 5 e 6 (pp. 101 103) Problema 3 domanda d): Calcolate Discutete gli
Capitolo 7. La concorrenza perfetta
 Capitolo 7 La concorrenza perfetta La concorrenza perfetta è una delle possibili strutture di mercato Struttura di mercato: tutte le caratteristiche di un mercato che influenzano il comportamento degli
Capitolo 7 La concorrenza perfetta La concorrenza perfetta è una delle possibili strutture di mercato Struttura di mercato: tutte le caratteristiche di un mercato che influenzano il comportamento degli
In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio.
 In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. DOMANDE a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. DOMANDE a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
L ECONOMIA DEI MERCATI DEL LAVORO
 Economia Politica Appunti delle lezioni Raffaele Paci testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 24, Zanichelli Cap 18 I mercati dei fattori di produzione L ECONOMIA DEI MERCATI DEL LAVORO
Economia Politica Appunti delle lezioni Raffaele Paci testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 24, Zanichelli Cap 18 I mercati dei fattori di produzione L ECONOMIA DEI MERCATI DEL LAVORO
