Prof. Paola Cotticelli Linguistica storica - mutamento semantico - aa
|
|
|
- Sebastiano Piazza
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 2.4. Mutamento semantico La dimensione storica di una lingua diventa trasparente se osserviamo da vicino il lessico della lingua stessa. Partendo da una considerazione sincronica del lessico, vale a dire facendo un analisi delle parole italiane in uso, risulta la seguente composizione: Parti del lessico: a) vocaboli usati da parlanti e udenti che corrispondono a certe regole di fonologia, grammatica e formazione delle parole, che costituiscono il cosiddetto vocabolario comune, o di base, che comprende - il vocabolario fondamentale, - di alta frequenza, - di alta disponibilità o familiarità, - il vocabolario settoriale (le lingue tecniche, legate a professioni o saperi specifici) b) esotismi/prestiti grezzi/forestierismi crudi c) prestiti integrati d) neologismi. Anche il comunicare umano, il modo di esprimersi, è soggetto a variazioni che dipendono dalle circostanze, dalle situazioni, oltre che dalle facoltà linguistiche. Si parla allora di varianti nella lingua, che si distinguono nei seguenti tipi: - Diatopica: che dipende da fattori fonologici, lessicali e sintattico-grammaticali dell area geografica cui appartiene il parlante (romano, toscano, lombardo). - Diastratica: i parlanti di diversi strati sociali si esprimono in modo diverso, per articolazione, grammatica, sintassi, lessico. - Diafasica, che dipende dal tenore del discorso prodotto. Una relazione scientifica o una conversazione tra amici, un referto medico o una lettera d amore mostrano parti del lessico e strutture della sintassi diverse tra loro. - Diamesica: si riferisce alla diversità del mezzo tramite cui ci si esprime: la voce o lo scritto, da vicino e da lontano, in trasmissione televisiva etc., un modo formale e un modo informale. Tali variazioni sono ciascuna oggetto di studio di alcuni settori della linguistica: 1
2 - La geografia linguistica studia le varianti diatopiche; la sociolinguistica analizza le varianti diastratiche; la linguistica storica studia il cambiamento linguistico diacronico, cioè le variazioni o diversificazioni intervenute nel generarsi di una lingua dall altra e nell evolversi di una lingua nel tempo. Da un punto di vista diacronico, la scienza che si occupa dell evolversi delle forme dei vocaboli in una prospettiva storica è la Etimologia: cioè lo studio delle fasi e delle forme che una parola ha avuto attraverso il tempo, che si basa sui dati della fonologia, della grammatica e della semantica. Analizzando l origine e lo sviluppo delle parole di una lingua si possono stabilire le varie componenti del lessico complessivo di una lingua. Si prendano degli esempi dall italiano: 1. Vocaboli ereditati che l italiano e i dialetti italiani (i dialetti sono anch essi delle lingue, che presentano varianti perlopiù fonetiche e lessicali, ma anche a volte morfologiche) hanno ereditato dal latino e che mostrano rispetto alla forma latina diversità fonologiche a causa die mutamenti fonetici dal latino alle lingue romanze (mater: madre), e di significato per motivi storico-culturali (captivus: cattivo). 2. i vocaboli, pure di derivazione latina, ma che si sono insediati per via dotta e che hanno subito minor influsso dal mutamento fonetico in quanto entrati in italiano in periodo relativamente tardo. SI parla di prestiti dotti (maternus: materno; fluvialis: fluviale). 3. I prestiti adattati, o esotismi, cioè parole entrate in italiano da altre lingue: - da altre lingue romanze (francese, spagnolo) gioia: joie, disguido: descuido - dalle lingue germaniche, per lo più longobardo, gotico, franco: zanna:zahn - dall arabo: algebra, ragazzo - dal turco: giannizzero - dal greco antico, spesso per tramite del latino: tonno, filosofia, etc. 4. I prestiti non adattati dal punto di vista fonetico/grafico: overdose, senza derivati, ma sport con tanti derivati. 5. Formazioni endogene, cioè quei vocaboli che si sono formati, tramite le risorse morfologiche interne della lingua, sulla base di parole ereditate dal latino, da prestiti adattati e non adattati. 6. Calchi o prestiti semantici, tipo datore di lavoro: ted. Arbeitgeber. 2
3 Classificazione dei tipi di mutamento Cause del mutamento Lazzeroni (1990) presenta una classificazione di modelli di mutamento semantico basandosi sui criteri tracciati da Meillet e sui risultati della classificazione di Ullmann: Cause secondo Meillet sono: - linguistiche - storiche - sociali, alle quali Ullmann aggiunse: causa psicologica: derivanti da fattori emotivi e tabù (accidenti, Signore, bear, parbleu, ecc...); influenza straniera: prestiti e calchi; creazione di parole nuove: per denotare nuovi oggetti o nozioni (laser, regista, ecc...). Ullmann distingue la natura dei mutamenti semantici in due tipi: somiglianza fra i sensi: dà luogo alla metafora (gamba del tavolo, cane del fucile, voce calda, ecc...); contiguità dei sensi: dà luogo alla metonimia (passaggio romanzo di coxa a indicare la coscia anziché l'anca, come in origine, le guardie inglesi chiamate giubbe rosse, l'uso di denominare un prodotto dal luogo di produzione: gorgonzola, chianti); somiglianza fra i nomi: dà luogo all'etimologia popolare o paretimologia (veletta > vedetta); contiguità fra i nomi: dà luogo all'ellissi (quotidiano <> Le conseguenze del mutamento semantico vengono suddivise in due tipi e a loro volta, entrambi, in altri due sottotipi: mutamenti dell'area semantica: o o estensione del significato; restrizione del significato; 3
4 mutamenti nella valutazione: o o in senso migliorativo; in senso peggiorativo. Tale classificazione viene per altro criticata da Lazzeroni, in quanto carente di spessore teorico. Al proposito introduce il modello della semantica diacronica strutturale, modello creato dallo studioso Coseriu (studioso rumeno), che si occupa del mutamento semantico dal punto di vista dei suoi risvolti sulle strutture lessicali del contenuto. Il mutamento avviene non quando un vocabolo sostituisce un altro (caso della sostituzione di un vecchio significante con un nuovo significante, entrambi riferiti ad un unico significato). Strutturalmente si realizza un mutamento quando dei tratti semantici, vale a dire significativi sul piano del contenuto, e non del significante, vengono a modificarsi: lat. albus "bianco: candidus "brillante" >> it. "bianco", e così in fr. e rum Meccanismi del mutamento Estensione di significato: inglese dog come iperonimo deriva da un originario iponimo (tipo di razza di cane), confrontabile con ted. Dogge alano. In ted. l ipernomino è Hund, denominazione iperonima di origine indoeuropea per questo animale ed etimologicamente comparabile con lat. canis, gr. kuon, e con ingl. Hound, che nel sistema inglese ha funzione di iponimo di razza specifica. Sp. armario deposito di armi dal lat. medio armadio deposito per vestiti e altri oggetti. arma/armorum + suffisso arium > it Restringimento di significato Ingl. meat cibo > carne Ingl. hound cane > razza Ingl. girl bambina/o > ragazza 4
5 Metafora Inidca un mutamento basato su un confronto. Termini per uccidere in alcune lingue sono espressioni metaforiche e lessicalizzate: far fuori ; liquidare ; eliminare ; ingl. to terminate, terminator. Espressioni tipo sei un aquila oppure sei una volpe rappresentano metafore Metonimia Indica un mutamento di significato per contiguità. Espressioni quali: gamba del tavolo, collo della bottiglia, piede della montagna, fare una mano a carte, dare una mano di colore, ma anche il passaggio del significato dal concreto all astratto in verbi come lat. capere afferrare : it. capire; lat. pondero peso e penso, valuto : it. pesare; lat. pecunia bestiame e ricchezza da pecus bestiame ne sono buoni esempi Sineddoche Indica la parte per il tutto o il tutto per la parte (pars pro toto, totum pro parte) It. formaggio < Formaticus < caseus formaticus Sp. hermano fratello < lat. germanus < frater germanus degli stessi genitori Ted. merid. Fuß piede e gamba Degenerazione Tendenza allo sviluppo dell accezione negativa di un lemma: ingl. silly sciocco : ted. seelig beato ingl. knave ragazzino e delinquente : ted. Knabe ragazzino Miglioramento 5
6 lat. villa (rustica) > It. villa (>fr. ville città estensione di significato) Tabù Sostituzione di un lemma con un altro per ragioni religiose, sessuali, politiche in relazione ai diversi codici culturali: donna di servizio: spazzino : bidello: handicappato: cieco: dio : colf (collaboratrice famigliare, sigla) operatore ecologico operatore scolastico diversamente abile non vedente signore A volte si può trovare anche l eufemismo: Figlio di buona donna Iperbole Sostituzione del significato attraverso la sua esasperazione: un mare di bugie, un mare di lacrime, una tonnellata di lavoro Litote Sostituzione del significato attraverso la negazione del suo opposto: Il suo aspetto non è buono, (D.) Come stai? (R.) Non male Relazioni semantiche Le relazioni semantiche si possono descrivere mediante i tratti semantici: Sinonimi: espressioni che contengono esattamente gli stessi tratti semantici e le stesse caratteristiche. eteronimi /incompatibili: espressioni che condividono almeno un tratto con le stesse 6
7 caratteristiche ma che si distinguono per almeno un ulteriore tratto dagli altri. Iperonimi: contengono tutti i tratti essenziali dei loro iponimo. Iponimi: contengono tutti i tratti essenziali dei loro iperonimo e inoltre altri tratti per caratterizzarne le differenze. Complementari: espressioni che sembrano essere definite attraverso un solo tratto, laddove però a uno dei due valori viene attribuito "+" e all altro "-". Ad es. maschile = [-FEMMINILE]; "femminile" = [+FEMMINILE]. Antonimi: Tali espressioni possono essere descritte con tratti relativi, come ad es. [±MINIMO] e [±MASSIMO] oppure [SOPRA/SOTTO LA NORMA] Classificazione strutturale Secondo la Traugott, Vater e altri studiosi si possono delineare le seguenti tendenze all interno del mutamento che aiutano a illustrarne la natura: 1. Parole semanticamente vicine sviluppano significati vicini 2. Parole con significato spaziale hanno anche valore temporale: before, after, behind, in testa a, a capo di legate alle parti del corpo (metonimia) 3. Forme foneticamente vicine /simili sviluppano un passaggio di significato sit : set; lie : lay 4. Tendenza dal concreto all astratto Es. Ted. Haupt (< lat. caput) testa si sviluppa nell uso che si trova nei composti del tipo: Hauptbahnhof stazione centrale ; Hauptstadt capitale Vedere > sapere Sentire > capire Azioni concrete > azioni astratte (capere : capire) 5. Aggettivi relativi ai sensi mostrano sinestesie ingl. sharp: ted. scharf piccante ; tagliente ; bitter amaro ; triste, sweet dolce ; caro Formazione di neologismi La formazione di neologismi è il prodotto di diversi mutamenti lessicali e semantici di diversa natura. Essi testimoniano la capacità di rinnovamento di un sistema linguistico. 7
8 Di seguito si descrivono alcuni modelli tipologici della neoformazione delle parole: 1. Creazione dal nulla: il termine gas, derivato dalla pronuncia danese di una parola greca khaos; 2. Creazioni letterarie: il termine pandemonio, creato da Milton: pandemonium nel senso di capitale del male ; 3. Creazioni da nomi di persona: il termine inglese sandwich deriva dal nome di persona di Lord Sandwich e dalla sua passione per i panini! Oppure il termine gothic dai Goti, vandalismo dai Vandali, ecc. 4. Creazioni da nomi di luogo: il termine sherry deriva dal nome di luogo della sua produzione, Jerez, con pronuncia inglese e non spagnola. 5. Creazioni da nomi di marca di prodotti commerciali: Zewa > carta da cucina Tempo > fazzolettini di carta Coca Cola > bevanda 6. Creazioni di nomi da acronimi: DJ RAM ROM CD DVD UK 8
9 USA Yuppie (young people, dalla immagine acustica) Gestapo (Gemeinstaatspolizei polizia segreta di stato ) Polfer (polizia ferroviaria). 7. Creazioni da composti e da suffissoidi: Red-eye Auto-, bio-, trans-, super- -poli ( tangentopoli ). 8. Creazioni da riduzioni: bus < lat. omnibus (per tutti, ablativo plurale) bike < bicycle bicicletta, motocicletta schizo < schizofrenico 9
Indice. Premessa 11. Aprile, Marcello Dalle parole ai dizionari 2014. digitalisiert durch: IDS Basel Bern
 Indice Premessa 11 I. Leparole 13 1. Parole, lessemi, varianti 13 2. Parole e grammatica 14 3. Vocabolario comune e vocabolario di base: la disponibilitä all'uso 16 4. II lessico mentale 18 5. Rapporti
Indice Premessa 11 I. Leparole 13 1. Parole, lessemi, varianti 13 2. Parole e grammatica 14 3. Vocabolario comune e vocabolario di base: la disponibilitä all'uso 16 4. II lessico mentale 18 5. Rapporti
Semantica I L S I G N I F I C A T O D E L L E P A R O L E E D E L L E F R A S I
 Semantica I L S I G N I F I C A T O D E L L E P A R O L E E D E L L E F R A S I Cos è? Aspetti «interni» del linguaggio 2 i suoni linguistici la struttura delle parole la combinazione delle parole in gruppi
Semantica I L S I G N I F I C A T O D E L L E P A R O L E E D E L L E F R A S I Cos è? Aspetti «interni» del linguaggio 2 i suoni linguistici la struttura delle parole la combinazione delle parole in gruppi
GLOTTOLOGIA Giacomo Ferrari
 GLOTTOLOGIA Giacomo Ferrari ferrari@lett.unipmn.it Unità 1: Delimitazione del dominio scientifico GLOTTOLOGIA Il termine Glottologia è stato creato circa un secolo e mezzo fa come pseudo-derivato dal greco
GLOTTOLOGIA Giacomo Ferrari ferrari@lett.unipmn.it Unità 1: Delimitazione del dominio scientifico GLOTTOLOGIA Il termine Glottologia è stato creato circa un secolo e mezzo fa come pseudo-derivato dal greco
ITALIANO. Traguardi, obiettivi, nodi concettuali. Il lessico. ITALIANO- TRAGUARDI LESSICO
 Proposta di lettura e di interpretazione, secondo nodi concettuali, delle Indicazioni 2012 Maria Franchetti ITALIANO. Traguardi, obiettivi, nodi concettuali Il lessico. ITALIANO- TRAGUARDI LESSICO Piste
Proposta di lettura e di interpretazione, secondo nodi concettuali, delle Indicazioni 2012 Maria Franchetti ITALIANO. Traguardi, obiettivi, nodi concettuali Il lessico. ITALIANO- TRAGUARDI LESSICO Piste
Sociolinguistica A2 A.A.2005/06 ADA VALENTINI ESERCITAZIONI SULLE NOZIONI DI BASE Semantica, sintassi, tipologia, pragmatica
 Sociolinguistica A2 A.A.2005/06 ADA VALENTINI ESERCITAZIONI SULLE NOZIONI DI BASE Semantica, sintassi, tipologia, pragmatica 1. Dite quali rapporti semantici intercorrono tra le parole dei seguenti gruppi.
Sociolinguistica A2 A.A.2005/06 ADA VALENTINI ESERCITAZIONI SULLE NOZIONI DI BASE Semantica, sintassi, tipologia, pragmatica 1. Dite quali rapporti semantici intercorrono tra le parole dei seguenti gruppi.
Introduzione Il lessico. Introduzione. Introduzione. Linguistica generale, parte II a.a
 Introduzione Il lessico Lessico Linguistica generale, parte II a.a. 2007-2008 Rappr. Fonetica Sintassi Rappr. semantica Introduzione Introduzione Life s good - but not fair at all Lou Reed, Magic and Loss,
Introduzione Il lessico Lessico Linguistica generale, parte II a.a. 2007-2008 Rappr. Fonetica Sintassi Rappr. semantica Introduzione Introduzione Life s good - but not fair at all Lou Reed, Magic and Loss,
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica. La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio. L articolo
 Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009
 QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009 RIFERIMENTI NORMATIVI INDICAZIONI NAZIONALI 2003 (OSA) L. n 53/2003 e D. Lgs 59/2004 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO 2007 QUADRO DI RIFERIMENTO
QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009 RIFERIMENTI NORMATIVI INDICAZIONI NAZIONALI 2003 (OSA) L. n 53/2003 e D. Lgs 59/2004 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO 2007 QUADRO DI RIFERIMENTO
014 5 Pragmatica Lingue per scopi speciali. [014 8] Abbreviazioni e simboli Filosofia e teoria
![014 5 Pragmatica Lingue per scopi speciali. [014 8] Abbreviazioni e simboli Filosofia e teoria 014 5 Pragmatica Lingue per scopi speciali. [014 8] Abbreviazioni e simboli Filosofia e teoria](/thumbs/54/33772292.jpg) T4 T4 014 301 Filosofia e teoria 014 301 8 Scuole, teorie, metodologie 014 301 82 Linguistica formale Notazione 01 dalla Tavola 1 come di seguito modificata Da non usare per scuole e teorie semantiche;
T4 T4 014 301 Filosofia e teoria 014 301 8 Scuole, teorie, metodologie 014 301 82 Linguistica formale Notazione 01 dalla Tavola 1 come di seguito modificata Da non usare per scuole e teorie semantiche;
Premessa 11 [PARTE PRIMA I LE STRUTTURE DELL'ITALIANO D'OGGI
 Premessa 11 [PARTE PRIMA I LE STRUTTURE DELL'ITALIANO D'OGGI 1.1. Fonetica e fonologia 17 1.1.1. fonetica e fonologia, foni e fonemi 17 1.1.2. La produzione dei suoni 18 1.1.3. Le vocali 20 1.1.4. Le consonanti
Premessa 11 [PARTE PRIMA I LE STRUTTURE DELL'ITALIANO D'OGGI 1.1. Fonetica e fonologia 17 1.1.1. fonetica e fonologia, foni e fonemi 17 1.1.2. La produzione dei suoni 18 1.1.3. Le vocali 20 1.1.4. Le consonanti
Il codice linguistico
 Laboratorio Linguistico Il Testo narrativo Il codice linguistico www.nicolanapolitano.altervista.org App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM Le funzioni e la
Laboratorio Linguistico Il Testo narrativo Il codice linguistico www.nicolanapolitano.altervista.org App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM Le funzioni e la
Modulo: I. Mi presento Livello: Basso
 1. Saluti, Spelling ufficiale Imparare la distinzione dei saluti: in base all'ora e alla formalità. Imparare l'alfabeto ufficiale per lo spelling saluti, alfabeto spelling (nomi di città) - fogli esercizi
1. Saluti, Spelling ufficiale Imparare la distinzione dei saluti: in base all'ora e alla formalità. Imparare l'alfabeto ufficiale per lo spelling saluti, alfabeto spelling (nomi di città) - fogli esercizi
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
 BRUNO MIGLIORINI STORIA DELLA LINGUA ITALIANA Sansoni Editore INDICE DEI CAPITOLI 'REMESSA pp. vn-xi BIBLIOGRAFIA pp. xm-xvi - LA LATINITÀ D'ITALIA IN ETÀ IMPERIALE pp. 1-43 1. Da Augusto a Odoacre, p.
BRUNO MIGLIORINI STORIA DELLA LINGUA ITALIANA Sansoni Editore INDICE DEI CAPITOLI 'REMESSA pp. vn-xi BIBLIOGRAFIA pp. xm-xvi - LA LATINITÀ D'ITALIA IN ETÀ IMPERIALE pp. 1-43 1. Da Augusto a Odoacre, p.
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
Sommario. 1. Approccio logico-filosofico. 2. Approccio linguistico. 3. Pragmatica LEZIONE 7
 Sommario LEZIONE 7 1. Approccio logico-filosofico 2. Approccio linguistico 3. Pragmatica Concezione logico-filosofica referente (significato) significato (senso) segno Nota: fra parentesi la terminologia
Sommario LEZIONE 7 1. Approccio logico-filosofico 2. Approccio linguistico 3. Pragmatica Concezione logico-filosofica referente (significato) significato (senso) segno Nota: fra parentesi la terminologia
LICEO SCIENTIFICO GIORDANO BRUNO MESTRE - VENEZIA
 LICEO SCIENTIFICO GIORDANO BRUNO MESTRE - VENEZIA Anno scolastico 2010-2011 Classe 2^ C Materie: ITALIANO Docente: ONGARO GIANPIETRO Oggetto: PROGRAMMAZIONE ANNUALE La classe è composta di 24 alunni, palesa
LICEO SCIENTIFICO GIORDANO BRUNO MESTRE - VENEZIA Anno scolastico 2010-2011 Classe 2^ C Materie: ITALIANO Docente: ONGARO GIANPIETRO Oggetto: PROGRAMMAZIONE ANNUALE La classe è composta di 24 alunni, palesa
QUI SUIS-JE? CLASSE: 1^A Tempi:Ott/nov Anno Scolastico 2015/2016
 CLASSE: 1^A Tempi:Ott/nov Anno Scolastico 2015/2016 CONOSCENZE FONETICA: Grafemi e fonemi CAMPI: Relativi all identità e alle persone che si frequentano.. FUNZIONI: Salutare Chiedere e dire come va. Presentare
CLASSE: 1^A Tempi:Ott/nov Anno Scolastico 2015/2016 CONOSCENZE FONETICA: Grafemi e fonemi CAMPI: Relativi all identità e alle persone che si frequentano.. FUNZIONI: Salutare Chiedere e dire come va. Presentare
Criteri per la definizione della parola grammaticale
 Criteri per la definizione della parola grammaticale Una parola grammaticale (morfo-sintattica, non fonologica) è definita in base alla co-occorrenza dei seguenti criteri: a) COESIONE: si definisce parola
Criteri per la definizione della parola grammaticale Una parola grammaticale (morfo-sintattica, non fonologica) è definita in base alla co-occorrenza dei seguenti criteri: a) COESIONE: si definisce parola
Istituto Comprensivo di Pralboino Curricolo Verticale
 ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare. 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare
 1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare 3 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: leggere 4 Modulo operativo: Le abilità linguistiche:
1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare 3 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: leggere 4 Modulo operativo: Le abilità linguistiche:
Comunicazione Vs. Linguaggio
 Comunicazione Vs. Linguaggio Comunicazione: rete di scambi di informazioni e di relazioni sociali sirealizzaall internodiungruppo(naturasociale) ne costituisce la base dell interazione e delle relazioni
Comunicazione Vs. Linguaggio Comunicazione: rete di scambi di informazioni e di relazioni sociali sirealizzaall internodiungruppo(naturasociale) ne costituisce la base dell interazione e delle relazioni
PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA. Classe quarta
 PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA Classe quarta ASCOLTARE E PARLARE 1. Strategie essenziali dell'ascolto. 2. Processi di controllo da mettere in atto durante l'ascolto. 3. Interazioni fra testo e contesto.
PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA Classe quarta ASCOLTARE E PARLARE 1. Strategie essenziali dell'ascolto. 2. Processi di controllo da mettere in atto durante l'ascolto. 3. Interazioni fra testo e contesto.
Fondamenti di Linguistica Semantica e Lessico Lezione 4: Polisemia, Lessico e Dizionari
 Fondamenti di Linguistica Semantica e Lessico Lezione 4: Polisemia, Lessico e Dizionari Malvina Nissim malvina.nissim@unibo.it 3 Dicembre 2008 Metonimie o Lessicalizzazioni? Hoover Kleenex China Scottex
Fondamenti di Linguistica Semantica e Lessico Lezione 4: Polisemia, Lessico e Dizionari Malvina Nissim malvina.nissim@unibo.it 3 Dicembre 2008 Metonimie o Lessicalizzazioni? Hoover Kleenex China Scottex
AppuntiBicoccaAppuntiBicoccaAppu ntibicoccaappuntibicoccaappuntibic occaappuntibicoccaappuntibicoccaa ppuntibicoccaappuntibicoccaappunt
 AppuntiBicoccaAppuntiBicoccaAppu ntibicoccaappuntibicoccaappuntibic occaappuntibicoccaappuntibicoccaa ppuntibicoccaappuntibicoccaappunt Struttura delle parole ibicoccaappuntibicoccaappuntibicoc Riassunto
AppuntiBicoccaAppuntiBicoccaAppu ntibicoccaappuntibicoccaappuntibic occaappuntibicoccaappuntibicoccaa ppuntibicoccaappuntibicoccaappunt Struttura delle parole ibicoccaappuntibicoccaappuntibicoc Riassunto
Indice. Introduzione. Unità I. Unità 2. Unità Unità Unità Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica
 Indice Introduzione Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica Unità I 1.1. I1 latino lingua indoeuropea / 1.2. Le fasi della lingua latina / 11.1. L alfabeto latino / 11.2. La pronuncia del
Indice Introduzione Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica Unità I 1.1. I1 latino lingua indoeuropea / 1.2. Le fasi della lingua latina / 11.1. L alfabeto latino / 11.2. La pronuncia del
Proprietà del linguaggio: - Congenito: è una facoltà mentale che nasce con l organismo, è registrato nel suo patrimonio genetico e rimane a livello
 Proprietà del linguaggio: - Congenito: è una facoltà mentale che nasce con l organismo, è registrato nel suo patrimonio genetico e rimane a livello potenziale finché uno stimolo la fa emergere; - Inapprendibile:
Proprietà del linguaggio: - Congenito: è una facoltà mentale che nasce con l organismo, è registrato nel suo patrimonio genetico e rimane a livello potenziale finché uno stimolo la fa emergere; - Inapprendibile:
COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO IL LINGUAGGIO
 Referente Dott.ssa Renza Rosiglioni Corso Re Umberto I, n.5 Ivrea (To) renzarosiglioni@libero.it Cellulare 347 9662237 a cura di RENZA ROSIGLIONI & LARA MASOERO COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO IL LINGUAGGIO
Referente Dott.ssa Renza Rosiglioni Corso Re Umberto I, n.5 Ivrea (To) renzarosiglioni@libero.it Cellulare 347 9662237 a cura di RENZA ROSIGLIONI & LARA MASOERO COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO IL LINGUAGGIO
Istituto Comprensivo
 CURRICOLO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) Comprendere frasi semplici, brevi registrazioni trattanti argomenti con significati molto
CURRICOLO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) Comprendere frasi semplici, brevi registrazioni trattanti argomenti con significati molto
Linguistica Generale prof. dr. Giorgio Francesco Arcodia MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO
 Linguistica Generale prof. dr. Giorgio Francesco Arcodia MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO 1) Definire ed illustrare con esempi la nozione di ricorsività : 2) Identificare e descrivere i morfemi contenuti
Linguistica Generale prof. dr. Giorgio Francesco Arcodia MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO 1) Definire ed illustrare con esempi la nozione di ricorsività : 2) Identificare e descrivere i morfemi contenuti
Formazione del lessico
 Formazione del lessico 27 NEI LINGUAGGI SETTORIALI 1. Nuove creazioni Associazione di nuovo significante con nuovo significato In meccanica automobilistica Spinterogeno Punterie 28 Isabella Chiari 1 2.
Formazione del lessico 27 NEI LINGUAGGI SETTORIALI 1. Nuove creazioni Associazione di nuovo significante con nuovo significato In meccanica automobilistica Spinterogeno Punterie 28 Isabella Chiari 1 2.
Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria
 CURRICOLO DISCIPLINARE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Obiettivi di apprendimento
CURRICOLO DISCIPLINARE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Obiettivi di apprendimento
BAMBINO E BAMBINA sono i nomi che si usano per indicare QUALSIASI BAMBINO. SONO QUINDI CHIAMATI: NOMI COMUNI.
 BAMBINO E BAMBINA sono i nomi che si usano per indicare QUALSIASI BAMBINO. SONO QUINDI CHIAMATI: NOMI COMUNI. FABIO e ADRIANA sono invece i nomi che hanno ricevuto dai loro genitori: si chiamano NOMI PROPRI,
BAMBINO E BAMBINA sono i nomi che si usano per indicare QUALSIASI BAMBINO. SONO QUINDI CHIAMATI: NOMI COMUNI. FABIO e ADRIANA sono invece i nomi che hanno ricevuto dai loro genitori: si chiamano NOMI PROPRI,
VIII. Indice. Unità 2 La semantica 20
 Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
1 Introduzione e definizione
 INSEGNAMENTO DI DIDATTICA GENERALE I LEZIONE I INTRODUZIONE ALLA DIDATTICA PROF. ACHILLE M. NOTTI Indice 1 Introduzione e definizione --------------------------------------------------------------------------------3
INSEGNAMENTO DI DIDATTICA GENERALE I LEZIONE I INTRODUZIONE ALLA DIDATTICA PROF. ACHILLE M. NOTTI Indice 1 Introduzione e definizione --------------------------------------------------------------------------------3
I.C. "L.DA VINCI" LIMBIATE CURRICOLO IN VERTICALE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 GEOGRAFIA
 GEOGRAFIA (AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA) CONOSCENZE/ESPERIENZE Inteso come capacità di orientarsi all interno di un nuovo ambiente Osservare gli spazi circostanti Saper distinguere sopra-sotto,
GEOGRAFIA (AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA) CONOSCENZE/ESPERIENZE Inteso come capacità di orientarsi all interno di un nuovo ambiente Osservare gli spazi circostanti Saper distinguere sopra-sotto,
L ANELLO FORTE DI USSEGLIO Forum storico sul ruolo delle donne nella coesione sociale e famigliare di un villaggio alpino
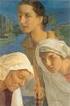 L ANELLO FORTE DI USSEGLIO Forum storico sul ruolo delle donne nella coesione sociale e famigliare di un villaggio alpino Riunione del 3 maggio 2014: LA MEMORIA DIMENTICATA Per iniziare: non sempre i grandi
L ANELLO FORTE DI USSEGLIO Forum storico sul ruolo delle donne nella coesione sociale e famigliare di un villaggio alpino Riunione del 3 maggio 2014: LA MEMORIA DIMENTICATA Per iniziare: non sempre i grandi
SCUOLA PRIMARIA - LINGUA INGLESE
 SCUOLA PRIMARIA - LINGUA INGLESE CLASSE PRIMA INGLESE - Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 1. Ascoltare e comprendere ed eseguire le consegne.
SCUOLA PRIMARIA - LINGUA INGLESE CLASSE PRIMA INGLESE - Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 1. Ascoltare e comprendere ed eseguire le consegne.
La struttura del segno linguistico
 Laboratorio di Scrittura creativa Il Testo narrativo La struttura del segno linguistico App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM La struttura del significante
Laboratorio di Scrittura creativa Il Testo narrativo La struttura del segno linguistico App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM La struttura del significante
LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE Classe LM-39
 TOTALE 0 CFU LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE Classe LM-39 (CDS 05409-1213 ordinamento 2012 - Regolamento 2013 ) I programmi degli insegnamenti, i relativi titolari e le modalità di
TOTALE 0 CFU LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE Classe LM-39 (CDS 05409-1213 ordinamento 2012 - Regolamento 2013 ) I programmi degli insegnamenti, i relativi titolari e le modalità di
CAPITOLO PRIMO MODELLI TEORICI DI RIFERIMENTO. La sociolinguistica è un ramo della linguistica che studia la variazione linguistica
 CAPITOLO PRIMO MODELLI TEORICI DI RIFERIMENTO 1.1. La sociolinguistica La sociolinguistica è un ramo della linguistica che studia la variazione linguistica secondo diversi livelli, tutti in qualche modo
CAPITOLO PRIMO MODELLI TEORICI DI RIFERIMENTO 1.1. La sociolinguistica La sociolinguistica è un ramo della linguistica che studia la variazione linguistica secondo diversi livelli, tutti in qualche modo
La tipologia e gli universali
 La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Latino Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Latino Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
Pistoia Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari
 Situazione iniziale della classe PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2014-2015 Prof. Susanna Battistini Materia: Spagnolo Classe I Sez. B TSS La classe è formata da 23 alunni di cui una
Situazione iniziale della classe PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2014-2015 Prof. Susanna Battistini Materia: Spagnolo Classe I Sez. B TSS La classe è formata da 23 alunni di cui una
Brevi note di filologia romanza (per gli studenti del 1 Liceo Classico) Giuliano Cianfrocca 2014
 * Brevi note di filologia romanza (per gli studenti del 1 Liceo Classico) 01 Concorrenza tra greco e latino L Impero romano, a partire dal I secolo d.c., si presenta come sostanzialmente bilingue, almeno
* Brevi note di filologia romanza (per gli studenti del 1 Liceo Classico) 01 Concorrenza tra greco e latino L Impero romano, a partire dal I secolo d.c., si presenta come sostanzialmente bilingue, almeno
PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO. Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto. Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia
 PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO Docenti Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto Insegnamento LINGUISTICA GENERALE Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia 1.1. Alfabeti e corrispondenza biunivoca;
PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO Docenti Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto Insegnamento LINGUISTICA GENERALE Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia 1.1. Alfabeti e corrispondenza biunivoca;
Classe 3 Curricolo di ITALIANO. Nuclei fondanti Abilità Conoscenze Ascoltare e Parlare
 Classe 3 Curricolo di ITALIANO Nuclei fondanti Abilità Conoscenze Ascoltare e Parlare -Prendere la parola negli scambi comunicativi, rispettando il proprio turno. -Comprendere le informazioni principali
Classe 3 Curricolo di ITALIANO Nuclei fondanti Abilità Conoscenze Ascoltare e Parlare -Prendere la parola negli scambi comunicativi, rispettando il proprio turno. -Comprendere le informazioni principali
Classe quinta Italiano
 Classe quinta Italiano SAPER ASCOLTARE E COMPRENDERE 1. Strategie essenziali dell ascolto finalizzato e dell ascolto attivo. 2. Modalità per prendere appunti mentre si ascolta. 3. Processi di controllo
Classe quinta Italiano SAPER ASCOLTARE E COMPRENDERE 1. Strategie essenziali dell ascolto finalizzato e dell ascolto attivo. 2. Modalità per prendere appunti mentre si ascolta. 3. Processi di controllo
Curricolo Inglese a.s
 Curricolo Inglese a.s. 2015-2016 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Curricolo Inglese a.s. 2015-2016 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
POTENZIAMENTO GRAMMATICA E LESSICO. Dott.ssa Renata Salvadorini IRCCS Stella Maris Calambrone - Pisa Con la partecipazione di:
 POTENZIAMENTO GRAMMATICA E LESSICO Dott.ssa Renata Salvadorini IRCCS Stella Maris Calambrone - Pisa Con la partecipazione di: LESSICO Il lessico o vocabolario è il complesso delle parole che appartengono
POTENZIAMENTO GRAMMATICA E LESSICO Dott.ssa Renata Salvadorini IRCCS Stella Maris Calambrone - Pisa Con la partecipazione di: LESSICO Il lessico o vocabolario è il complesso delle parole che appartengono
GEOGRAFIA Classe Prima Orientamento Linguaggio della geogeograficità territoriale
 Classe Prima Orientamento Linguaggio della geogeograficità Paesaggio Regione e sistema territoriale Settembre Prove d ingresso Prove d ingresso Prove d ingresso Prove d ingresso Ottobre Novembre L orientamento
Classe Prima Orientamento Linguaggio della geogeograficità Paesaggio Regione e sistema territoriale Settembre Prove d ingresso Prove d ingresso Prove d ingresso Prove d ingresso Ottobre Novembre L orientamento
PROGRAMMAZIONE DISCIPLNARE DI LATINO LICEO LINGUISTICO
 LICEO STATALE G. COMI - TRICASE a. s. 2015/2016 PROGRAMMAZIONE DISCIPLNARE DI LATINO LICEO LINGUISTICO per Unità di Apprendimento (UdA) bimestrali Classe I sez. AL indirizzo Linguistico Docente: Prof.ssa
LICEO STATALE G. COMI - TRICASE a. s. 2015/2016 PROGRAMMAZIONE DISCIPLNARE DI LATINO LICEO LINGUISTICO per Unità di Apprendimento (UdA) bimestrali Classe I sez. AL indirizzo Linguistico Docente: Prof.ssa
DAI CURRICOLI DISCIPLINARI AI PERCORSI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI
 50 DAI CURRICOLI DISCIPLINARI AI PERCORSI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI Elaborazione della figura strumentale per il curricolo e la valutazione ins. Dott.ssa Sabini Maria Rosaria 51 Indicatore Trasversale
50 DAI CURRICOLI DISCIPLINARI AI PERCORSI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI Elaborazione della figura strumentale per il curricolo e la valutazione ins. Dott.ssa Sabini Maria Rosaria 51 Indicatore Trasversale
ISTITUTO:Scuola Primaria CLASSE: 3 AMBITO LINGUISTICO ANTROPOLOGICO MATERIA: Italiano
 ISTITUTO:Scuola Primaria CLASSE: 3 AMBITO LINGUISTICO ANTROPOLOGICO MATERIA: Italiano - Produzioni orali su argomenti noti riguardanti contesti familiari, anche con il supporto di informazioni e spunti
ISTITUTO:Scuola Primaria CLASSE: 3 AMBITO LINGUISTICO ANTROPOLOGICO MATERIA: Italiano - Produzioni orali su argomenti noti riguardanti contesti familiari, anche con il supporto di informazioni e spunti
I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE
 I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE L alessia senza agrafia -Disturbo di lettura senza altri disturbi concomitanti -I pazienti scrivono senza essere capaci di leggere quello che hanno scritto Interpretazione
I SISTEMI DI LETTURA E LE DISLESSIE L alessia senza agrafia -Disturbo di lettura senza altri disturbi concomitanti -I pazienti scrivono senza essere capaci di leggere quello che hanno scritto Interpretazione
2 Affinità e differenze 15 La pronunzia 15 L alfabeto e la fonetica 16 Il lessico 16 La morfologia e la sintassi 17 I casi e le funzioni logiche 18
 XI verso il latino 1 Il latino per strada 2 2 Il latino e la sua storia 6 1 L antica lingua di Roma 6 Il latino e l italiano 6 Perché il latino si chiama così 7 Quando si parlò l antica lingua di Roma
XI verso il latino 1 Il latino per strada 2 2 Il latino e la sua storia 6 1 L antica lingua di Roma 6 Il latino e l italiano 6 Perché il latino si chiama così 7 Quando si parlò l antica lingua di Roma
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME. Competenze specifiche Abilità Conoscenze ABILITÀ MORFO-SINTATTICHE
 OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
LIVELLO A2 LIVELLO B1
 PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE Test informatizzato (durata 45 min): LIVELLO A2 2 cloze test (esercizi gap-fill di grammatica e lessico) livello A2 al fine di individuare i termini o la tipologia
PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE Test informatizzato (durata 45 min): LIVELLO A2 2 cloze test (esercizi gap-fill di grammatica e lessico) livello A2 al fine di individuare i termini o la tipologia
SCUOLA PRIMARIA ITALIANO (Classe 1ª)
 SCUOLA PRIMARIA ITALIANO (Classe 1ª) Leggere testi brevi e rispondere a semplici domande di comprensione. Ricostruire cronologicamente un semplice testo ascoltato. Eseguire semplici istruzioni, consegne
SCUOLA PRIMARIA ITALIANO (Classe 1ª) Leggere testi brevi e rispondere a semplici domande di comprensione. Ricostruire cronologicamente un semplice testo ascoltato. Eseguire semplici istruzioni, consegne
LA LINGUA PER STUDIARE
 LA LINGUA PER STUDIARE L'apprendimento della lingua astratta, della lingua delle discipline, rappresenta un salto qualitativo profondo, molto importante è una parte della competenza linguistica che va
LA LINGUA PER STUDIARE L'apprendimento della lingua astratta, della lingua delle discipline, rappresenta un salto qualitativo profondo, molto importante è una parte della competenza linguistica che va
PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE
 LICEO STATALE SANDRO PERTINI Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane (con Opzione Economico- Sociale) Liceo Musicale e Coreutico Sez. Musicale Via C. Battisti, 5-16145 Genova - Corso Magenta, 2 A
LICEO STATALE SANDRO PERTINI Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane (con Opzione Economico- Sociale) Liceo Musicale e Coreutico Sez. Musicale Via C. Battisti, 5-16145 Genova - Corso Magenta, 2 A
FRANCESE. Classe TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. SEZIONE A: Traguardi formativi e percorsi didattici
 FRANCESE Classe TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE LINGUA ORALE Ascoltare e comprendere un linguaggio di classe sempre più articolato Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni
FRANCESE Classe TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE SPECIFICHE LINGUA ORALE Ascoltare e comprendere un linguaggio di classe sempre più articolato Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni
Introduzione. L idea che le diverse lingue derivino tutte da un unica lingua originaria è molto antica
 Introduzione L idea che le diverse lingue derivino tutte da un unica lingua originaria è molto antica Il mito di Babele (Genesi, 11): la lingua primitiva dell umanità sarebbe stata una sola, l ebraico
Introduzione L idea che le diverse lingue derivino tutte da un unica lingua originaria è molto antica Il mito di Babele (Genesi, 11): la lingua primitiva dell umanità sarebbe stata una sola, l ebraico
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA STRANIERA SCUOLA PRIMARIA
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA STRANIERA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI FORMATIVI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA STRANIERA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI FORMATIVI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo
ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO INCISA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO
 ASCOLTARE E PARLARE ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO INCISA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classi QUARTE Primo quadrimestre Obiettivi Attività - Interagire in una conversazione formulando domande e dando
ASCOLTARE E PARLARE ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO INCISA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classi QUARTE Primo quadrimestre Obiettivi Attività - Interagire in una conversazione formulando domande e dando
Gian Luigi Beccaria, 1988
 Dalla nascita alla morte, ogni giorno, viviamo in un oceano di parole. Inconsapevoli, respiriamo la lingua come l aria e la produciamo come un atto fisiologico naturale. Eppure la parola è uno dei più
Dalla nascita alla morte, ogni giorno, viviamo in un oceano di parole. Inconsapevoli, respiriamo la lingua come l aria e la produciamo come un atto fisiologico naturale. Eppure la parola è uno dei più
OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, LATINO E GRECO AL GINNASIO
 DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, LATINO E GRECO AL GINNASIO ITALIANO CLASSE IV GINNASIALE 1. Leggere un testo in modo corretto ed espressivo. 2. Comprendere il senso globale di un testo narrativo poetico.
DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, LATINO E GRECO AL GINNASIO ITALIANO CLASSE IV GINNASIALE 1. Leggere un testo in modo corretto ed espressivo. 2. Comprendere il senso globale di un testo narrativo poetico.
DIARIO DI BORDO. Rilevazione delle competenze in italiano
 DIARIO DI BORDO Rilevazione delle competenze in italiano Anno scolastico. Diario di bordo di Scuola dell infanzia di Calendario delle Osservazioni Prima Osservazione (giorno e data).. Seconda Osservazione
DIARIO DI BORDO Rilevazione delle competenze in italiano Anno scolastico. Diario di bordo di Scuola dell infanzia di Calendario delle Osservazioni Prima Osservazione (giorno e data).. Seconda Osservazione
IL CACIO CON LE PERE di Musica Nuda Claudia Meneghetti, Università Ca Foscari. I verbi riflessivi. Elementi linguisticogrammaticali
 IL CACIO CON LE PERE di Musica Nuda Claudia Meneghetti, Università Ca Foscari La didattizzazione è presente anche nel sito www.itals.it Livello degli studenti Livello A1 Elementi lessicali Lessico del
IL CACIO CON LE PERE di Musica Nuda Claudia Meneghetti, Università Ca Foscari La didattizzazione è presente anche nel sito www.itals.it Livello degli studenti Livello A1 Elementi lessicali Lessico del
CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE. - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni
 CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE ITALIANO - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni - Potenziare l ascolto reciproco, il rispetto e
CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE ITALIANO - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni - Potenziare l ascolto reciproco, il rispetto e
LA GRAMMATICA PEDAGOGICA
 LA GRAMMATICA PEDAGOGICA Convegno Il primo passo Torino, 8 aprile 2014 Franca Bosc, Università degli Studi di Milano Nozioni di Lingua e Grammatica : Sistemi logico formali che offrono concettualizzazioni
LA GRAMMATICA PEDAGOGICA Convegno Il primo passo Torino, 8 aprile 2014 Franca Bosc, Università degli Studi di Milano Nozioni di Lingua e Grammatica : Sistemi logico formali che offrono concettualizzazioni
MA IL LATINO, DA DOVE DERIVA?
 MA IL LATINO, DA DOVE DERIVA? Per scoprirlo dobbiamo andare molto indietro nel tempo sul colle Palatino, a Roma, sono stati rinvenuti fondi di capanne risalenti circa al X sec. A.C.. L area poi occupata
MA IL LATINO, DA DOVE DERIVA? Per scoprirlo dobbiamo andare molto indietro nel tempo sul colle Palatino, a Roma, sono stati rinvenuti fondi di capanne risalenti circa al X sec. A.C.. L area poi occupata
CURRICOLO DI LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA Annoscolastico
 CLASSE I CURRICOLO DI LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA Annoscolastico2016-17 Leggere rispettando i suoni e Nucleo1: - Linguaggio inerente: i numeri, i colori, oggetti scolastici, la famiglia, animali domestici.
CLASSE I CURRICOLO DI LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA Annoscolastico2016-17 Leggere rispettando i suoni e Nucleo1: - Linguaggio inerente: i numeri, i colori, oggetti scolastici, la famiglia, animali domestici.
L italiano regionale. Lezione del 13 novembre 2014
 L italiano regionale Lezione del 13 novembre 2014 A proposito del dialetto tra i giovani, a p. 52 del libro di testo (Marcato) si legge: Il dialettalismo, in qualche caso, può non essere diretto nel senso
L italiano regionale Lezione del 13 novembre 2014 A proposito del dialetto tra i giovani, a p. 52 del libro di testo (Marcato) si legge: Il dialettalismo, in qualche caso, può non essere diretto nel senso
BFLR A Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA. edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto
 BFLR A 351667 Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto INDICE ABBREVIATURE 1. Principali abbreviature usate, p. 11 n INTRODUZIONE
BFLR A 351667 Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto INDICE ABBREVIATURE 1. Principali abbreviature usate, p. 11 n INTRODUZIONE
G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio A L C U N E I D E E B A S I L A R I 1
 G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio A L C U N E I D E E B A S I L A R I 1 La linguistica, il «linguaggio» e i «linguaggi» 2 Linguistica: Scienza cognitiva (cfr. lezioni introduttive) Lo studio
G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio A L C U N E I D E E B A S I L A R I 1 La linguistica, il «linguaggio» e i «linguaggi» 2 Linguistica: Scienza cognitiva (cfr. lezioni introduttive) Lo studio
NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE
 CURRICOLO DI LINGUA ITALIANA - CLASSE QUINTA NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE ASCOLTO E PARLATO Strategie essenziali dell ascolto finalizzato e dell ascolto attivo e relativi processi di
CURRICOLO DI LINGUA ITALIANA - CLASSE QUINTA NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE ASCOLTO E PARLATO Strategie essenziali dell ascolto finalizzato e dell ascolto attivo e relativi processi di
Psicologia della comunicazione Fondamenti. Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1
 Psicologia della comunicazione Fondamenti Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1 Psicologia della comunicazione Settore scientifico-disciplinare: Psicologia generale Campo di ricerca interdisciplinare
Psicologia della comunicazione Fondamenti Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1 Psicologia della comunicazione Settore scientifico-disciplinare: Psicologia generale Campo di ricerca interdisciplinare
ITALIANO classe quarta
 NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE ASCOLTO E PARLATO - SA ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE SU UN ARGOMENTO TRATTATO - SA PORRE DOMANDE PERTINENTI ALL ARGOMENTO E AL CONTESTO DURANTE O DOPO L ASCOLTO -
NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE ASCOLTO E PARLATO - SA ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE SU UN ARGOMENTO TRATTATO - SA PORRE DOMANDE PERTINENTI ALL ARGOMENTO E AL CONTESTO DURANTE O DOPO L ASCOLTO -
3. Una serata speciale 26
 3. Una serata speciale 26 1 Guarda i nomi scritti nella tabella Guarda i nomi scritti nella tabella: tutti hanno davanti (sono preceduti da) l articolo indeterminativo. L articolo indeterminativo maschile
3. Una serata speciale 26 1 Guarda i nomi scritti nella tabella Guarda i nomi scritti nella tabella: tutti hanno davanti (sono preceduti da) l articolo indeterminativo. L articolo indeterminativo maschile
SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO PIANI DI STUDIO LINGUE COMUNITARIE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 CLASSE PRIMA
 SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO PIANI DI STUDIO LINGUE COMUNITARIE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 CLASSE PRIMA COMPETENZA ABILITÀ' CONOSCENZE Comprendere e ricavare informazioni 1. dall'ascolto di dialoghi 2. dalla
SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO PIANI DI STUDIO LINGUE COMUNITARIE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 CLASSE PRIMA COMPETENZA ABILITÀ' CONOSCENZE Comprendere e ricavare informazioni 1. dall'ascolto di dialoghi 2. dalla
CLASSE PRIMA PROPOSTE DI LAVORO CONTENUTI COMPETENZE VERIFICHE. - Formule di saluto; - espressioni per chiedere e dire il proprio nome;
 CLASSE PRIMA NUCLEO TEMATICO - USO DELLA L.S. PROPOSTE DI LAVORO CONTENUTI COMPETENZE VERIFICHE NUCLEO FONDANTE ASCOLTO - prestare attenzione - riconoscere - interagire - Attività ludiche guidate dall'insegnante
CLASSE PRIMA NUCLEO TEMATICO - USO DELLA L.S. PROPOSTE DI LAVORO CONTENUTI COMPETENZE VERIFICHE NUCLEO FONDANTE ASCOLTO - prestare attenzione - riconoscere - interagire - Attività ludiche guidate dall'insegnante
Standard formativo minimo regionale
 Standard formativo minimo regionale Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze di base dei percorsi di Quarto anno di Tecnico professionale Comunicare in forma orale e scritta nella
Standard formativo minimo regionale Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze di base dei percorsi di Quarto anno di Tecnico professionale Comunicare in forma orale e scritta nella
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/ anno
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOLOGIA ROMANZA 9 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento MARIO PAGANO Email: mapagano@unict.it
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOLOGIA ROMANZA 9 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento MARIO PAGANO Email: mapagano@unict.it
PERCHÉ STUDIARE IL LATINO? Spunti di riflessione
 PERCHÉ STUDIARE IL LATINO? Spunti di riflessione IL LATINO: 1. potenzia e sviluppa le capacità logiche; 2. migliora la conoscenza dell italiano; 3. è la chiave per poter comprendere la modernità attraverso
PERCHÉ STUDIARE IL LATINO? Spunti di riflessione IL LATINO: 1. potenzia e sviluppa le capacità logiche; 2. migliora la conoscenza dell italiano; 3. è la chiave per poter comprendere la modernità attraverso
Programmazione didattica annuale classi prime Disciplina Lingua Inglese
 brevi e relativi ad ambiti familiari o di studio Espone studio contesti familiari e su argomenti noti testi scopo Comprensione orale: Mettere in relazione grafemi e fonemi, associando parole e frasi al
brevi e relativi ad ambiti familiari o di studio Espone studio contesti familiari e su argomenti noti testi scopo Comprensione orale: Mettere in relazione grafemi e fonemi, associando parole e frasi al
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Scuola dell Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1 grado San Giovanni Teatino (CH)
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Scuola dell Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1 grado San Giovanni Teatino (CH) CURRICOLO A.S. 2012-1013 CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE TRAGUARDI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Scuola dell Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1 grado San Giovanni Teatino (CH) CURRICOLO A.S. 2012-1013 CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE TRAGUARDI
La porta di ishtar e altri racconti
 Introduzione La porta di ishtar e altri racconti Le attività legate al testo, contenute sia nel volume di narrativa sia nella Guida, si articolano in tre sezioni principali. 1., in cui si sviluppano abilità
Introduzione La porta di ishtar e altri racconti Le attività legate al testo, contenute sia nel volume di narrativa sia nella Guida, si articolano in tre sezioni principali. 1., in cui si sviluppano abilità
Let s play English! Progetto di avviamento all apprendimento della lingua inglese per bambini dai 12 ai 36 mesi
 Let s play English! Progetto di avviamento all apprendimento della lingua inglese per bambini dai 12 ai 36 mesi Lisa Tognon Nido Integrato Sacro Cuore, Carpanedo di Albignasego, PADOVA Lisa Tognon Email:
Let s play English! Progetto di avviamento all apprendimento della lingua inglese per bambini dai 12 ai 36 mesi Lisa Tognon Nido Integrato Sacro Cuore, Carpanedo di Albignasego, PADOVA Lisa Tognon Email:
DIPARTIMENTO LETTERE CLASSICO LINGUISTICO DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico)
 Educazione linguistica: Educazione letteraria: Produzione scritta: DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico) morfologia: il verbo. Sintassi: gli elementi fondamentali di analisi della proposizione.
Educazione linguistica: Educazione letteraria: Produzione scritta: DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico) morfologia: il verbo. Sintassi: gli elementi fondamentali di analisi della proposizione.
Dalla grammatica alla riflessione sulla lingua. Didattica della lettura e della scrittura II
 Dalla grammatica alla riflessione sulla lingua Didattica della lettura e della scrittura II Grammatica De Mauro, Il dizionario della lingua italiana 1. Insieme delle convenzioni e delle norme di scrittura,
Dalla grammatica alla riflessione sulla lingua Didattica della lettura e della scrittura II Grammatica De Mauro, Il dizionario della lingua italiana 1. Insieme delle convenzioni e delle norme di scrittura,
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. Micro- obiettivi
 SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
Istituzioni di Linguistica (turno M-Z) MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO
 Istituzioni di Linguistica (turno M-Z) MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO 1) Definire ed illustrare con esempi la nozione di ricorsività : 2) Quanti morfemi sono contenuti nelle seguenti parole? cervo, stradale,
Istituzioni di Linguistica (turno M-Z) MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO 1) Definire ed illustrare con esempi la nozione di ricorsività : 2) Quanti morfemi sono contenuti nelle seguenti parole? cervo, stradale,
CURRICOLO VERTICALE DELLE DISCIPLINE IV CIRCOLO LINGUA INGLESE CLASSE PRIMA
 CURRICOLO VERTICALE DELLE DISCIPLINE IV CIRCOLO LINGUA INGLESE CLASSE PRIMA Listening Ascoltare semplici messaggi Formule di saluto Espressioni per chiedere e dire il nome Semplici istruzioni correlate
CURRICOLO VERTICALE DELLE DISCIPLINE IV CIRCOLO LINGUA INGLESE CLASSE PRIMA Listening Ascoltare semplici messaggi Formule di saluto Espressioni per chiedere e dire il nome Semplici istruzioni correlate
UNITA DI APPRENDIMENTO. La frase e brevi testi
 Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco" Via Visconti d Oleggio, 83 / 63900 Fermo tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112 CF: 90055090444 CM:APIC841002 sito web: www.iscfracassetticapodarco.gov.it e-mail:
Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco" Via Visconti d Oleggio, 83 / 63900 Fermo tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112 CF: 90055090444 CM:APIC841002 sito web: www.iscfracassetticapodarco.gov.it e-mail:
SCUOLA PRIMARIA SCIENZE (Classe 1ª)
 SCUOLA PRIMARIA SCIENZE (Classe 1ª) scientifico. all ambiente. Osservare e descrivere i cambiamenti della natura in rapporto al trascorrere delle stagioni. Analizzare oggetti e coglierne le principali
SCUOLA PRIMARIA SCIENZE (Classe 1ª) scientifico. all ambiente. Osservare e descrivere i cambiamenti della natura in rapporto al trascorrere delle stagioni. Analizzare oggetti e coglierne le principali
Gli abitanti d Europa
 Gli abitanti d Europa La popolazione POPOLO E POPOLAZIONE Un popolo è un gruppo di persone caratterizzate da: stesso modo di vivere stessa lingua e cultura. La popolazione è l insieme degli abitanti che
Gli abitanti d Europa La popolazione POPOLO E POPOLAZIONE Un popolo è un gruppo di persone caratterizzate da: stesso modo di vivere stessa lingua e cultura. La popolazione è l insieme degli abitanti che
Pragmatica e atti linguistici
 Pragmatica e atti linguistici Giovanni Manetti, Scienze della comunicazione, Siena c. Giovanni Manetti 1 Charles Morris 1. Sintattica 2. Semantica 3. Pragmatica c. Giovanni Manetti 2 Astratto/Concreto
Pragmatica e atti linguistici Giovanni Manetti, Scienze della comunicazione, Siena c. Giovanni Manetti 1 Charles Morris 1. Sintattica 2. Semantica 3. Pragmatica c. Giovanni Manetti 2 Astratto/Concreto
COMPETENZE DI ITALIANO DA PROVE INVALSI
 COMPETENZE DI ITALIANO DA PROVE INVALSI COMPETENZE DI ITALIANO TRATTE DAL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA DI ITALIANO DELL INVALSI AGGIORNATO AL 28 FEBBRAIO 2011. 1. LETTURA. PREMESSA: tipo di testo
COMPETENZE DI ITALIANO DA PROVE INVALSI COMPETENZE DI ITALIANO TRATTE DAL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA DI ITALIANO DELL INVALSI AGGIORNATO AL 28 FEBBRAIO 2011. 1. LETTURA. PREMESSA: tipo di testo
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO MATERIA: ITALIANO Prof.ssa Santomauro Teresa ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Classe I^ AS ELENCO DELLE UNITA DIDATTICHE/MODULI Num Titolo delle UNITA
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO MATERIA: ITALIANO Prof.ssa Santomauro Teresa ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Classe I^ AS ELENCO DELLE UNITA DIDATTICHE/MODULI Num Titolo delle UNITA
ICS Erasmo da Rotterdam Via Giovanni XXIII n CISLIANO Tel./Fax
 ICS Erasmo da Rotterdam Via Giovanni XXIII n.8 20080 CISLIANO www.albaciscuole.gov.it Tel./Fax02.9018574 info@albaciscuole.gov.it MAIL miic86900d@istruzione.it PEC: miic86900d@pec.istruzione.it C.F. 90015600159
ICS Erasmo da Rotterdam Via Giovanni XXIII n.8 20080 CISLIANO www.albaciscuole.gov.it Tel./Fax02.9018574 info@albaciscuole.gov.it MAIL miic86900d@istruzione.it PEC: miic86900d@pec.istruzione.it C.F. 90015600159
