Principi ed effetti della raffinazione sulla superficie
|
|
|
- Alfonsina Mauro
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 XI corso di tecnologia per tecnici cartari edizione 2003/2004 Principi ed effetti della raffinazione sulla superficie di Fornero Fabio Scuola Interregionale di Tecnologia per tecnici Cartari via don G. Minzoni, Verona - tel
2 INDICE Introduzione 1. Principi della raffinazione 2. Effetti della raffinazione sulle fibre 2.1 Taglio e accorciamento delle fibre 2.2 Fibrillazione interna 2.3 Fibrillazione esterna 2.4 Formazione di parti fini 2.5 Aumento della plasticità e flessibilità 2.6 Rigonfiamento e idratazione 3. Effetti della raffinazione sulle caratteristiche della carta 3.1 Resistenza alla trazione e alla lacerazione 3.2 Resistenza alla piegatura 3.3 Opacità e permeabilità all aria 3.4 Stabilità dimensionale e densità 4. Teorie della raffinazione 4.1 Specific edge load theory 4.2 The specific surface load theory (Lumianen) 4.3 Frequenza ed intensità 4.4 Teoria del fattore C (Kerekes) 4.5 Ipotesi della raffinazione a fiocchi 5. Tipi di raffinatore 5.1 Olandesi 5.2 Raffinatori conici 5.3 Raffinatori a dischi 6. Sistemi di raffinazione 7. Effetti delle condizioni di raffinazione 7.1 Effetti sulla consistenza 7.2 Effetto del grado di raffinazione 7.3 Effetto dell energia specifica 7.4 Effetto dell intensità di raffinazione 7.5 Influenza del ph 7.6 Influenza delle lamature 8. Controlli sulla raffinazione 9. Conclusioni - INDICE -
3 INTRODUZIONE La fibra cellulosica per essere idonea a formare il foglio di carta deve subire un trattamento meccanico in presenza di acqua, tale da modificarne parzialmente la struttura e renderla idonea a formare un foglio avente le caratteristiche desiderate. Senza questo processo la carta formata avrebbe caratteristiche fisiche e visive totalmente insoddisfacenti presentando una speratura inaccettabile, maggiore volume, superficie irregolare, struttura aperta e soprattutto resistenze meccaniche bassissime. Si comprende quindi quanto sia importante la raffinazione nella fabbricazione cartaria e quanto influisca sulle caratteristiche finali del prodotto che vogliamo ottenere. Nei prossimi capitoli verrà affrontato l argomento dando prima rilievo alle variazioni strutturali generate sulle fibre e in seguito descrivendo i processi meccanici, teorici e le variabili che entrano in gioco nei sistemi di cartiera. 1
4 1. I PRINCIPI DELLA RAFFINAZIONE La raffinazione delle materie fibrose si realizza mediante due fasi principali: un azione di taglio, in quanto la fibra può essere divisa in più parti trasversalmente dalle lame del raffinatore ed un azione molto più complessa subita dalla fibra quando viene sfregata tra le barre e schiacciata. In un primo tempo la parete primaria incomincia a distaccarsi, i piccoli interstizi e- sistenti fra i fasci di molecole cellulosiche si allargano e se ne formano altri. Siccome fino a questo punto l aspetto esterno della fibra non cambia, si può parlare di una sfibrillatura interna. Successivamente, con il procedere della raffinazione, si manifestano cambiamenti anche nell aspetto esterno. Infatti, mentre il processo di sfibrillatura interna continua, compaiono, sulla superficie della fibra, sottili filamenti che si staccano dalla parete e che prendono il nome di fibrille. Per questo stadio si potrà parlare di una sfibrillatura esterna. Di questo e di altri effetti sulla fibra se ne parlerà più dettagliatamente nel prossimo capitolo. Il metodo di raffinazione più comune consiste nel trattare le fibre con lame metalliche in presenza di acqua. Nel rivestimento dei dischi le scanalature tra le barre aiutano il flusso fibroso ad attraversare i dischi dei raffinatori. Nella prima fase di raffinazione i fiocchi fibrosi si concentrano soprattutto vicino al bordo principale delle lame (leading edge). Quando le barre del rotore e quelle dello statore si avvicinano (fig.1 A) i fiocchi ricevono un forte colpo facendo sì che la maggior parte di acqua venga compressa fuori dai fiocchi. In questa fase le fibre troppo corte o con scarso potere flocculante si staccano dal fiocco e fluiscono lungo le scanalature. Solo le fibre che rimangono in fiocco, infatti, vengono compresse tra le barre e subiscono il processo di raffinazione. Fig. 1 Refining mechanism 2
5 In questa fase infatti entrambe i bordi delle barre di statore e rotore scorrono lungo il fiocco e lo pressano contro la superficie liscia delle barre (edge to surface stage) e- sercitando così una forte azione meccanica di impatto e una importante azione di sfregamento tra le fibre del fiocco. Nella raffinazione a bassa consistenza la distanza tra le barre (gap clearance) di rotore e statore è di circa 100 µm che corrisponde allo spessore di circa 2-5 fibre integre e fibre collassate. La fase seguente (fig.1-b) è rappresentata dal passaggio delle fibre tra le due superfici lisce delle barre e dipende dalla larghezza e dall angolo di intersezione delle barre. Quando le barre del rotore si muovono lungo quelle dello statore si crea, nelle scanalature (grooves), un vortice abbastanza forte tale da aiutare le fibre ad essere accolte nel migliore dei modi tra le due superfici. Naturalmente se le scanalature sono troppo strette viene meno l azione rotativa del vortice aumentando così il rischio di far scorrere i fiocchi senza che essi subiscano alcuna azione di raffinazione. Fig. 2 Vortice tra le scanalature 3
6 2. EFFETTI DELLA RAFFINAZIONE SULLE FIBRE Importanza capitale per la raffinazione delle cellulose hanno le emicellulose in esse contenute. Queste infatti, in contatto con l acqua, rigonfiano molto più della cellulosa vera e propria e siccome sono incorporate nella parete della fibra a contatto immediato con le molecole di cellulosa, durante la raffinazione si hanno due effetti principali: in primo luogo i fasci di molecole cellulosiche si allontanano più facilmente gli uni dagli altri rendendo più rapida e agevole la sfibrillatura interna della fibra; in secondo luogo la fibra diventa più plastica e flessibile, il che aumenta il numero di punti di contatto fra fibra e fibra e fra fibrilla e fibrilla. L esperienza dimostra che le cellulose nobili che sono molto povere di emicellulose, si raffinano con difficoltà e forniscono fogli a resistenza molto bassa, mentre le paste al solfito di alcune latifoglie, per esempio, che sono molto ricche di emicellulose, si comportano nel modo esattamente contrario: raffinazione molto rapida e fogli resistenti. La raffinazione essendo soprattutto un processo meccanico produce una modificazione nella struttura fisica delle fibre. Come già accennato, il primo effetto corrisponde ad un distacco della parete primaria ed alla formazione di interstizi fra i fasci molecolari, mentre proseguendo l operazione si origina il rigonfiamento delle zone interne, cioè della parete secondaria della fibra stessa. Il rigonfiamento provoca un ammorbidimento delle pareti e un indebolimento delle forze di coesione. In una fase ulteriore della raffinazione ha inizio lo sfibrillamento, preceduto dal distacco della parete primaria. Le fibrille che si formano sono paragonabili ad uno sfrangiamento e costituiscono una minuta peluria sporgente dalle estremità e dall intero corpo della fibra. Dal punto di vista chimico, la raffinazione pare che non provochi grandi variazioni; modifica invece lo stato colloidale della fibra nel senso che attiva il rigonfiamento determinato dalla presenza d acqua. Il rigonfiamento o idratazione è indispensabile per la raffinazione, non avviene infatti raffinazione in assenza d acqua o in presenza di liquidi non polari. La raffinazione molto spinta provoca la caduta dei valori di viscosità delle soluzioni cuproammoniacali di cellulosa, segno evidente di una demolizione della macromolecola cellulosica, ma la variazione del peso molecolare è un azione fisica più che chimica. 4
7 Gli effetti principali della raffinazione sono quindi: Taglio e accorciamento delle fibre Produzione di fini e rimozione di intere parti di parete fibrosa Variazioni interne alla struttura della fibra con formazione di fibrille interne Fibrillazione esterna Schiacciamento e perdita di spessore Dissolvimento di materiale colloidale contenuto nella struttura fibrosa Creazione di nodi e di superfici lisce dovute a microcompressioni delle pareti Ridistribuzione dell emicellulosa dalla parte interna a quella esterna delle fibre Abrasione della superficie a livello molecolare con trasformazione gelatinosa della stessa 2.1 TAGLIO E ACCORCIAMENTO DELLE FIBRE La raffinazione, essendo un trattamento meccanico che per sua natura non è selettivo nelle sue modalità di azione sulla fibra, determina inevitabilmente accorciamenti più o meno spinti delle fibre. Se si prescinde da alcuni aspetti favorevoli connessi col miglioramento della speratura del foglio, questi effetti devono considerarsi complessivamente negativi nei riguardi delle proprietà meccaniche del foglio. Quindi è da considerarsi una pratica infruttifera in quanto sarebbe meglio riformulare gli impasti immettendo cellulose a fibre corte ed eliminando così il costo derivante dall azione di taglio, che assorbe una notevole quantità di energia e comporta un consumo più elevato del mezzo raffinante. Quando la raffinazione dell impasto viene condotta in modo da avere un minimo di taglio ed un massimo di sfibrillatura si dice che la pasta è grassa (il nome deriva dalla sensazione di scivolosità che si prova immergendo la mano nella pasta così raffinata, sensazione dovuta alla presenza delle fibrille sulla superficie delle fibre). Al contrario una pasta poco raffinata o raffinata con prevalente azione di taglio, sarà detta magra. La proprietà caratteristica di una pasta grassa è quella di lasciar scolare l acqua con difficoltà poiché le fibrille hanno la tendenza a trattenere l acqua o ad o- struire le maglie della tela rendendone difficile il drenaggio. 5
8 2.2 FIBRILLAZIONE INTERNA Si tratta dell effetto più importante che la raffinazione provoca sulla fibra: esso comprende tutte quelle modifiche che avvengono nell interno della parete fibrosa determinando 1 allentamento, 1 apertura e lo snervamento della sua struttura fisica. Quando la fibra in sospensione acquosa viene sottoposta all azione del raffinatore, essa subisce una serie ripetuta di sollecitazioni meccaniche di flessione e di schiacciamento che si ripercuotono sulla struttura fisica della parete fibrosa. Si verifica così una rottura dei legami idrogeno esistenti nell interno della parete fibrosa che vengono sostituiti con legami idrogeno tra fibra e acqua. Questo significa che avviene una separazione tra le microfibrille, tra le fibrille e tra gli strati lamellari in cui è strutturata la parete della fibra. Il risultato è un allentamento e un apertura della struttura che consente alla fibra di rigonfiare per 1 aumentata capacità di imbibirsi d acqua: la fibra perde quindi la sua rigidità originaria, diventa più flessibile, plastica e conformabile creando i presupposti per la formazione di aree molto ampie su cui possono stabilirsi legami tra fibra e fibra. È indubbio che questo è l effetto più importante della raffinazione perché è quello dal quale dipende principalmente l ottenimento di un foglio compatto e robusto. 2.3 FIBRILLAZIONE ESTERNA Il trattamento di fibrillazione, condotto meccanicamente durante 1 operazione di raffinazione, ha lo scopo di incrementare i legami tra le fibre e quindi la resistenza del supporto cartaceo. Generalmente la parete primaria della fibra è resa quasi cristallina durante le operazioni chimiche di estrazione o più ancora durante le operazioni di imbianchimento. L efficacia della raffinazione sarà più sensibile e significativa se una grande quantità di fibre verrà privata della parete primaria; in caso contrario esse si idrateranno e si sfibrilleranno con molta difficoltà impedendo la formazione di legami interfibra. L acqua penetra nello strato S2 e forma dei gel con i materiali cellulosici a più basso peso molecolare (emicellulose). Questi ultimi rigonfiano e la membrana S2 fuoriesce dagli spazi in precedenza lasciati dalla S1 che, essendo la meno elastica delle tre membrane, forma delle specie di rigidi collari che strozzano la crescita della S2 e de- 6
9 terminano la formazione di rigonfiamenti. Questi palloni sono punti di debolezza delle fibre che possono portare allo sfaldamento completo e alla sua rottura. Durante queste fasi le microfibrille escono dal contesto fibroso conferendogli un aspetto "peloso" (teorie del baco peloso o del maccherone bollito) ed inoltre le interazioni fibra-acqua così come pure le interazioni fibra-fibra si rafforzano aumentando in modo importante la superficie specifica. 2.4 FORMAZIONE DI PARTI FINI In qualunque modo venga condotta la raffinazione porta alla formazione di una certa aliquota di frammenti (parti fini) che si liberano dalle fibre. Questi sono costituiti principalmente da frammenti della parete primaria e di strato esterno della parete secondaria della fibra che vengono strappate dall azione di sfregamento delle barre del raffinatore, oltre che da frammenti fibrosi che si formano con l accorciamento delle fibre. Questi fini sono i responsabili di quasi tutti gli inconvenienti classici della continua: doppio viso, difficoltà di drenaggio, imbrattamento tele, feltri e sezioni aspiranti, ecc. Tuttavia con una corretta gestione dell azione di ritenzione si può notare come alcune caratteristiche fisiche della carta, quali scoppio ed opacità, vengono modificate positivamente dalla loro presenza. 2.5 AUMENTO DELLA PLASTICITÀ E FLESSIBILITÀ L acqua che è entrata nelle fibre sia per tensione superficiale che per effetto dei legami chimico-fisici in un certo qual modo dilata la struttura della fibra amorfa minandone la resistenza tra le varie molecole ed in più esercita una specie di lubrificazione che permette lo scorrimento tra fibrilla e fibrilla. 2.6 RIGONFIAMENTO E IDRATAZIONE Non sono sinonimi, il primo è una conseguenza dell idratazione. Il sistema cellulosa-acqua può essere considerato un gel. Quindi come per il gel il suo grado di rigon- 7
10 fiamento sarà proporzionale al rapporto grammi di acqua e grammi di materiale secco sotto specifiche condizioni. Questo valore è il punto di saturazione delle fibre cioè il peso di acqua che satura le pareti e che può essere eliminato solo per essiccamento a caldo e non per drenaggio o aspirazione. Come conseguenza dei suddetti effetti le fibre si presentano schiacciate e flessibili e quindi con una superficie di contatto decisamente più elevata. Il foglio che ne deriva avrà un aumento della resistenza alla trazione, allo scoppio e di quella interna tra le fibre, una maggior capacità di trattenere acqua al suo interno e una maggior rigidità. La resistenza alla lacerazione invece aumenta leggermente all inizio, ma decresce con una prolungata raffinazione. Diminuisce la permeabilità all aria, il volume, l opacità e di poco anche il grado di bianco. I principali effetti della raffinazione sono visibili nella fig.3 che rappresenta il confronto tra una pasta chimica non raffinata ed una sottoposta ad una raffinazione di 340 kwh/t a più stadi e con una consistenza del 4.2% (con t si intende tonnellata di pasta secca). Fig. 3 Raffronto tra pasta chimica raffinata e non 8
11 3. EFFETTI DELLA RAFFINAZIONE SULLE CARATTERISTICHE DELLA CARTA Il foglio ottenuto da fibre non raffinate si presenta con proprietà meccaniche scadenti, soffice, con superficie molto aperta e irregolare e con speratura non accettabile. La raffinazione migliora nel contesto fibroso le proprietà meccaniche come la lunghezza di rottura e la resistenza allo scoppio, diminuisce la porosità conferendo una struttura più chiusa alle fibre, migliora la speratura, la ritenzione delle cariche, la resa dei coloranti e dei collanti. Naturalmente la raffinazione deve essere effettuata e condotta in funzione all impiego a cui è destinata la carta, un abbassamento infatti di opacità non è desiderato in una carta da stampa oppure una struttura chiusa non è adatta per carte da filtro o carte assorbenti. La raffinazione, influendo pesantemente sulla struttura delle fibre, abbassa la stabilità della carta e il suo spessore, da ciò deriva che la raffinazione deve essere ben controllata per non superare il punto desiderato, si dice infatti che è meglio raffinare un po meno che troppo. La formazione di parti fini e la capacità delle fibre di conformarsi tra loro, fanno sì che gli spazi interfibra siano sempre in minor numero, per cui il foglio acquista compattezza e quindi densità apparente più elevata. Modificando le procedure di raffinazione è possibile produrre carte simili a partire da cellulose che hanno caratteristiche iniziali abbastanza diverse. 3.1 RESISTENZA ALLA TRAZIONE E ALLA LACERAZIONE In seguito alla raffinazione il foglio risulta più omogeneo e più legato poiché la fibrillazione interna determina una migliore e più diffusa formazione di legame tra le fibre e le parti fini favorendo una maggior compattezza del foglio. Le sollecitazioni applicate nella prova di lacerazione sono distribuite su di un area più piccola, in ragione della diminuzione dello spessore del foglio, per cui il carico specifico assume valori più elevati e la concentrazione della sollecitazione porta ad un cedimento localizzato sui carichi minori. Inoltre occorre tener conto dell accorciamento subito dalle fibre che 9
12 provoca una riduzione della resistenza alla lacerazione. Questi aspetti possono variare di entità da una pasta all altra e tra pasta a fibra lunga e pasta a fibra corta. Nel caso delle prime, all aumentare della raffinazione, si osserva un continuo ed immediato calo di resistenza, mentre nelle seconde si verificano all inizio della raffinazione anche aumenti graduali fino a pervenire ad un massimo oltre al quale la resistenza torna a scendere. Effetti opposti invece si hanno sulla resistenza alla trazione (tensile index) che aumenta con l aumentare della raffinazione proprio per la maggior forza di coesione delle fibre e la maggior compattezza del foglio appena descritti. Di conseguenza anche la resistenza allo scoppio trova giovamento dall aumento della raffinazione. I grafici seguenti dimostrano quanto detto: Energia specifica e indice di lacerazione 10
13 Energia specifica e tensile Energia specifica e legame interno 11
14 Energia specifica e indice di scoppio 3.2 RESISTENZA ALLA PIEGATURA Questa caratteristica della carta aumenta col progredire della raffinazione fino a pervenire a un massimo nel caso di raffinazioni molto spinte. La maggior omogeneità del foglio, che si consegue con la raffinazione, ha effetti positivi sulla resistenza alla piegatura, al contrario di quanto avviene per la lacerazione. La fibrillazione interna ed esterna è senza dubbio la causa di tali effetti sul prodotto finito che viene modificato anche dalla presenza di fini e da una bassa azione di taglio del raffinatore. 3.3 OPACITÀ E PERMEABILITÀ ALL ARIA L opacità di un materiale solido e omogeneo è determinata dalla sua capacità di assorbire la luce incidente su di esso. La carta deve la sua opacità al grande numero di aree di contatto tra materiale fibroso ed aria che, avendo indici di rifrazione diversi, 12
15 provocano una notevole diffusione della luce incidente. La forma e le dimensioni delle fibre, rappresentano gli elementi principali che influenzano l opacità del foglio di carta. È noto che, rispetto alle paste a fibra lunga, quelle a fibra corta danno carte più opache in ragione del numero molto maggiore di superfici per unità di massa che sono capaci di rifrangere la luce. L opacità, con l aumentare della raffinazione, diminuisce essendo questa determinata dalla quantità di superfici e di particelle rifrattive e di corpuscoli che diffondono la luce all interno, la raffinazione con l adattamento delle fibre e la diminuzione delle superfici otticamente rifrattive, rende il foglio più compatto, meno opaco e meno luminoso. Questo fenomeno è meno sensibile nella raffinazione di paste meccaniche che talvolta, addirittura, aumentano con la raffinazione la propria capacità di assorbenza della luce in quanto prima della raffinazione presentano fibre ancora lignificate. Una conseguenza dell aumento di compattezza del nastro fibroso in seguito alla raffinazione determina chiaramente un aumento di densità e di chiusura del foglio con una diminuzione della permeabilità all aria e della porosità. Energia specifica e rifrazione della luce 13
16 Energia specifica e opacità Energia specifica e luminosità 14
17 Energia specifica e permeabilità all aria 3.4 STABILITÀ DIMENSIONALE E DENSITÀ Un foglio di carta è per sua natura dimensionalmente instabile, in quanto si espande o si contrae all aumentare o al diminuire del suo contenuto di umidità, che a sua volta dipende dall umidità dell ambiente circostante. Al progredire della raffinazione diminuisce nettamente la proprietà di un foglio alla stabilità. Le variazioni dimensionali del foglio sono dovute al contrarsi o all espandersi delle fibre singole, poiché, con l umidità, la fibra rigonfia assai più di quanto non si allunghi. Il fenomeno della stabilità dimensionale risulta molto più evidente nella direzione trasversale del foglio in ragione dell orientamento preferenziale delle fibre in direzione longitudinale all atto della sua formazione sulla macchina continua. Un altro aspetto di grande importanza per la stabilità dimensionale del foglio è rappresentato dalla struttura della fibra e in particolare da una caratteristica morfologica così importante come lo spessore della parete cellulare. Fibre con parete cellulare sottile daranno fogli densi e quindi meno stabili; fibre con parete cellulare spessa non as- 15
18 sumeranno un aspetto nastriforme e quindi daranno fogli meno densi e meno sensibili alle umidità ambientali. La seguente immagine mostra l aumento della densità con l aumentare della raffinazione: un grammo di carta occupa infatti meno volume con l aumento dell energia specifica. Energia specifica e densità 16
19 4. TEORIE DELLA RAFFINAZIONE I risultati di una buona raffinazione possono dipendere da molti fattori come indicato nella fig.4. I fattori dipendenti dalla specificità delle fibre (fiber-based factors) come il tipo di legno originario e la sua lavorazione influiscono sì sulla qualità ma determinano soprattutto l adeguato trattamento a seconda delle esigenze delle cartiere. Tocca infatti al sistema di raffinazione di queste ultime ottimizzare il processo per garantire il miglior risultato finale. Molte teorie sono state sviluppate nel tempo proprio per determinare i più adatti sistemi e controlli sotto determinate condizioni lavorative. Fig. 4 Fattori che condizionano la raffinazione 17
20 L utilizzo delle teorie di raffinazione, che altro non sono se non descrizioni matematiche di processo, risalgono a più di cento anni fa quando nel 1887 Jagenberg introdusse termini come edge lenght per second (lunghezza lame per secondo) e beating area (area di raffinazione), termini ancora in uso ancora oggi. Una importante caratteristica di queste teorie è che possono essere applicate indipendentemente dalle dimensioni dei raffinatori e dal tipo (conici o a dischi). Dal momento che i raffinatori ad alta consistenza operano a velocità superiore, con una maggiore distanza tra i dischi e con vapore nell impasto, le seguenti teorie vengono applicate solo per la raffinazione a medio-bassa consistenza che presenta condizioni più stabili e risultati più precisi. Il fattore comune che caratterizza le teorie di raffinazione a bassa consistenza è rappresentato dalla possibilità di scomporre la potenza totale applicata in potenza netta (ossia quella effettivamente applicata al trattamento delle fibre) e potenza senza carico (no load power). La potenza netta è facilmente calcolabile sottraendo dalla potenza totale quella senza carico mentre per quantificare quest ultima si misura la potenza dei raffinatori in marcia con gap tra i dischi minimo e con flusso di acqua. La potenza senza carico aumenta in funzione della velocità e del diametro del rotore così come dimostrato dal seguente schema che prende ad esempio prove effettuate con raffinatori conici e a doppio disco. La fig.5 mostra invece le curve di potenza a velocità variabili riferite ad un raffinatore conico JC-01. Si può notare come l area compresa tra la linea della potenza totale e quella a vuoto identifichi la massima potenza netta a varie velocità. 18
21 Fig. 5 Effetto della rotazione sulla potenza 4.1 SPECIFIC EDGE LOAD THEORY Questa teoria è una delle più conosciute e può essere considerata come una caratterizzazione a doppio parametro della raffinazione. Essa ci indica infatti quanto le fibre sono trattate e quanto intensamente vengono raffinate. La quantità della raffinazione viene definita Specific Refining Energy (SRE) e si esprime in kwh/t mentre l intensità di raffinazione indicata come Specific Edge Load (SEL) è espressa in J/m. SRE = SEL = Pt Pn = Pe F C Pt Pn = Pe Zr Zst l n = L n = Ls Pt è la potenza totale applicata (kw) Pn è la potenza a vuoto (kw) Pe è la potenza netta di raffinazione (kw) F è il flusso (l/min) 19
22 C è la consistenza dell impasto (%) Zr, Zst sono il numero delle lame di rotore e statore l è la lunghezza complessiva delle lame (km) L è la lunghezza dell angolo di taglio al giro (km/rev) n è la velocità di rotazione (1/s) Ls è la velocità di taglio delle lame (km/s) Fig. 6 Calcolo della lunghezza di taglio (CEL) La lunghezza di taglio (Cutting Edge Lenght) viene calcolata come indicato dalla fig.6 e non tiene conto del tipo di raffinatore (conico o a dischi). Le lame in entrambe i casi sono leggermente inclinate (18 ) evitando così di fare lavorare parallelamente due barre opposte di rotore e statore. La teoria della SEL ci dice solamente la quantità di energia applicata per metro di lamatura e non tiene conto di molti altri parametri quali la larghezza delle lame, la distanza tra le stesse, il loro stato di usura, il modo in cui le fibre fluiscono tra le due superfici opposte (tipo di impatto), tutte variabili che definiscono in quale modo l energia viene applicata. 20
23 4.2 THE SPECIFIC SURFACE LOAD THEORY (LUMIAINEN) Lumiainen sviluppò la precedente teoria dando una maggior importanza all energia trasferita alle fibre nella fase di schiacciamento tra le superfici delle lame analizzando il numero degli impatti (IN), il carico specifico sulla superficie (SSL) e ridefinendo così la SRE theory come l energia di impatto per kg di massa secca. Dal punto di vista matematico la formula venne così riscritta da Lumiainen: SRE = IN SSL IL dove IL (larghezza delle barre) e SSL rappresentano la natura della raffinazione mentre IN l intensità della raffinazione. Il numero degli impatti IN (km/kg) che le fibre subiscono nel passaggio attraverso il raffinatore si ottiene dividendo la velocità di taglio Ls (km/s) per la portata di messa secca M (kg/s) Ls IN = SSL = M Wr + Wst 1 IL = 2 cos( α / 2) SEL IL La specific surface load SSL (J/m 2 ) si ottiene dalla divisione tra specific edge load SEL già analizzata in precedenza e la larghezza delle barre calcolabile con la formula sopra citata dove Wr e Wst stanno per larghezza barre rispettivamente di rotore e statore e α si riferisce all angolo di intersezione descritto nella figura seguente: Fig. 7 Definizione di lunghezza di impatto IL 21
24 La teoria della specific surface load (SSL) sembra funzionare abbastanza bene quando le barre sono sufficientemente strette da permettere ai fiocchi fibrosi che ricevono l impatto di raffinazione di coprire l intera larghezza della superficie della lama. Non va peraltro dimenticato che barre troppo strette aumentano la possibilità di taglio delle fibre. La teoria della specific edge load (SEL) dà ottimi risultati invece con lame più larghe e da ciò si comprende come, nella scelta del tipo di lamatura e del raffinatore, si debbano prendere in considerazione entrambe le teorie. 4.3 FREQUENZA ED INTENSITÀ Alla fine degli anni 60 Danforth sviluppò due indipendenti espressioni per descrivere la raffinazione, N numero degli impatti (frequenza) e S severità di raffinazione (intensità) descritte dalle seguenti equazioni: ( HPa HPn) At Lr Ls ( RPM ) C S = K2 N = K1 D ( RPM ) Lr Ls C X R Queste teorie vedono la potenza espressa in cavalli (HPa e HPn), considerano l area di raffinazione (At), la lunghezza delle barre (Lr Ls), il diametro dei dischi (D), i giri del rotore (RPM), la consistenza (C), la lunghezza di contatto tra lame opposte (X), la percentuale di attraversamento (R) e le costanti K appropriate. Proprio l utilizzo di queste costanti non sempre di facile identificazione a seconda dei casi fa si che queste teorie vengano poco applicate. 4.4 TEORIA DEL FATTORE C (KEREKES) Il punto di partenza di questa teoria è lo stesso di quelle precedentemente descritte e cioè l effettiva energia di raffinazione è direttamente legata al numero degli impatti e alla loro intensità: E = N I 22
25 Successivamente Kerekes sviluppò la teoria del C-factor che rappresenta la capacità del raffinatore di applicare l energia sulle fibre che lo attraversano. Ne deriva che il numero degli impatti e l intensità è così calcolata: N = F Cfactor ( PulpMassFlow) Il calcolo del fattore C viene effettuato in modo diverso a seconda che si tratti di raffinatori a dischi o conici, tiene infatti conto della geometria delle lame, della velocità di rotazione, della consistenza della massa fibrosa, della lunghezza delle fibre e della loro densità. C-factor per raffinatori a dischi: C = 2 3 8π GDρC ln ω(1 + 2tanϕ)( R 3ω ( l + D) 3 2 R 3 1 ) C-factor per raffinatori conici: C = 8π 2 GDρC ln 3 ω(1+ 2 tanϕ) LR L 2 R 1 sinθ +(L 3 / 3)sin 2 θ [ ] ω(l + D) Nomenclatura: N numero di impatti per kg massa (kg 1 ) n numero di lame di rotore e statore F flusso impasto (kg/s) ω velocità di rotazione (giri/s) I energia d impatto (J) φ angolo tra lame e raggio disco P potenza netta (W) R 1 raggio interno della zona di raff. G larghezza delle scanalature (m) R 2 raggio esterno (m) D profondità delle scanalature (m) w densità delle fibre (kg/m) p densità dell acqua (kg/m 3 ) θ angolo del raff. conico C consistenza impasto L lunghezza zona di raffinazione (m) L lunghezza delle fibre (m) 23
26 Questa teoria è senza dubbio la più rigorosa ed esaustiva grazie a tutte le variabili che tiene in considerazione ma proprio per la sua complessità viene utilizzata solo nel momento della scelta del tipo di lamatura e di raffinatore nel caso di costruzione di un nuovo impianto o di ammodernamento di uno preesistente. 4.5 IPOTESI DELLA RAFFINAZIONE A FIOCCHI Questa ipotesi conferma l opinione comune che le fibre non sono raffinate singolarmente ma a fiocchi. La consistenza dell impasto fin qui considerata è compresa tra il 2% e il 6% e pertanto le fibre non sono in grado di potersi muovere in modo indipendente. Esse formano dei fiocchi che si sfaldano in modo continuativo sotto l azione di taglio delle lame. Lo spessore di un fiocco può arrivare anche a 5 mm mentre la distanza tra i dischi è di circa µm, ne consegue che secondo questa ipotesi solo parte delle fibre subiscono un violento impatto tra le lame mentre le altre scorrono lungo le scanalature dove la sola turbolenza può creare lo sfregamento fibroso necessario per la raffinazione. Basato su questo concetto è stato costruito, in laboratorio, un disco con una unità di dispersione centrale che permette alle fibre di essere trattate singolarmente con lame appositamente studiate. Nonostante gli incoraggianti risultati ancora non ci sono progetti di sviluppo per la produzione su larga scala di questi dischi. 24
27 5. TIPI DI RAFFINATORE Se, una volta, con le sole Olandesi le variabili per la raffinazione potevano essere il tempo e la consistenza dell impasto, ora con i moderni raffinatori si possono lavorare e trasformare le cellulose nel modo più appropriato per il raggiungimento del risultato finale voluto. La scelta infatti del tipo di raffinatore, delle dimensioni, delle guarniture, ecc.. ci permettono di lavorare al meglio paste chimiche di fibre lunghe o di fibre corte; dalla lavorazione delle conifere si hanno infatti fibre più dure e resistenti alla raffinazione che richiedono quindi guarniture più grossolane e carichi di lavoro maggiore mentre le fibre delle latifoglie sono più morbide e necessitano di raffinazione più leggera. 5.1 OLANDESI Le Olandesi furono le prime macchine per la raffinazione, funzionavano in modo discontinuo ed erano costituite da una vasca e da un tamburo rotante rivestito da lame (fig.8). La loro azione produceva una raffinazione gentile e un trattamento uniforme sulle fibre. Le ultime olandesi vengono ora utilizzate solo in particolari cartiere per il taglio delle lunghe fibre di cotone prima dell invio al gruppo di raffinazione vero e proprio. La cellulosa generalmente era introdotta in essa già spappolata con una concentrazione variabile dal 4% al 7 % a seconda del modello di macchina e del tipo di raffinazione che si voleva ottenere. Si diceva che la carta veniva fatta nell olandese: era qui infatti che la cellulosa poteva essere lavorata in vari modi per ottenere risultati sensibilmente diversi. Nella lavorazione classica, dopo la raffinazione, si compivano nell olandese stessa le operazioni di coloritura e di collatura, spesso vi si facevano anche le aggiunte di carica e di altri additivi, si può dire che qui si preparava l impasto. Le olandesi avevano una capacità variabile da 200 a 800 kg di fibra secca, pari a litri in sospensione. Occorrevano generalmente più olandesi per servire una sola macchina continua. Terminata la preparazione dell impasto il contenuto delle olandesi era scaricato in un grande tino che poteva accogliere il contenuto di 4 o 6 olandesi. La ragione di 25
28 quest operazione è evidente, il mescolatore infatti, oltre a servire da polmone, permetteva di attenuare le eventuali differenze tra i diversi impasti preparati nelle varie olandesi. Fig. 8 Struttura di una olandese 5.2 RAFFINATORI CONICI Sono i primi raffinatori nati con lo scopo di raffinare in continuo un flusso di cellulosa o di impasto. La loro comparsa non è recente, in passato furono usati però solo per integrare il lavoro delle olandesi. Sono composti di un rotore conico orizzontale sulla cui superficie sono riportate, lungo le generatrici del cono, lame metalliche più o meno simili a quelle dei rotori cilindrici delle olandesi. Il rotore gira in una carcassa anch essa conica ed avente lame che sporgono dalla superficie interna; le lame del rotore e quelle dello statore si sfiorano. Spostamenti orizzontali del rotore lungo l asse in un senso o nell altro provocano l avvicinamento o l allontanamento delle lame. La pasta entra per mezzo di una tubazione dal lato corrispondente al vertice del cono. L effetto centrifugo della rotazione fa funzionare da pompa il raffinatore stesso. Strozzando la valvola a valle del raffinatore si dosa la velocità di passaggio della pasta e si regola la velocità della raffinazione. 26
29 I primi raffinatori conici furono i Jordan ad angolo stretto (fig. 9), essi montano infatti coni di circa 10 di angolo con guarniture abbastanza grossolane e sono per questo considerati raffinatori a forte azione di taglio. Nonostante ciò se usati con guarniture a barre strette danno ottimi risultati con ogni tipo di fibra. La difficoltà nella sostituzione delle guarniture, a causa della loro struttura con entrata dell impasto centrale, ha fatto sì che questi raffinatori venissero man mano sostituiti con i più funzionali ad angolo medio che vedremo tra poco. Un altro tipo di raffinatore conico è il modello Claflin ad ampio angolo, la sua struttura è simile al Jordan ma monta dischi da 30 (fig. 10). Fig. 9 Raffinatore Jordan Fig. 10 Raffinatore Claflin 27
30 Gli ultimi nati in ordine di tempo e quelli più largamente utilizzati per paste a bassa consistenza sono i raffinatori ad angolo medio (fig.11) caratterizzati da coni a circa 20 e soprattutto da una meccanica che permetta un facile accesso alla zona delle guarniture con minori perdite di tempo in caso di manutenzione. Fig. 11 Raffinatore Conflo (consistenza 2% - 6%) 1) Ingresso pasta da raffinare 2) Uscita pasta raffinata 3) Guarniture 4) Tenuta albero 5) Supporto cuscinetti 6) Dispositivo di carico 7) Giunto a denti 8) Ispezione trappola 9) Flussostato acqua di tenuta 10) Centralina per la lubrificazione I raffinatori Conflo comprendono sei differenti misure, i più piccoli lavorano fino a 110 kw mentre i più grandi arrivano fino a 3500 kw; la distanza tra i dischi di rotore e statore è regolato elettromeccanicamente. 28
31 Lo schema seguente indica alcuni dati relativi ai raffinatori Conflo riferiti a paste chimiche di conifere e di latifoglie. 5.3 RAFFINATORI A DISCHI Il principio di questi raffinatori è simile a quelli conici, nel centro della zona compresa fra i dischi si manda la pasta che, per la forza centrifuga prodotta dalla rotazione di uno o di tutti e due i dischi, tende a portarsi verso la periferia, subendo l azione di sfregamento prodotto dalle nervature dei dischi che si muovono in senso contrario. Questi raffinatori sono suddivisi in tre tipi: a disco singolo, a doppio disco e multidisco. I raffinatori a disco singolo vengono ora utilizzati solo per le paste ad alta consistenza perché la loro efficienza con basse densità non è ritenuta soddisfacente per le attuali esigenze di cartiera. Quelli a più dischi, con guarniture fini e basse intensità di raffinazione, vengono u- tilizzati solitamente per la post-raffinazione delle paste meccaniche. I raffinatori più utilizzati sono quelli a doppio disco e i modelli più conosciuti sono i Voith Sulzer (fig. 12) e i Beloit (fig. 13). I primi sono disponibili in cinque diverse misure a seconda delle esigenze, i dischi vanno infatti da un diametro minimo di 467 mm ad un massimo di 1473 mm e le potenze variano da 200 kw a 3000 kw. Lo schema seguente indica alcuni dati di lavoro sui due tipi di fibre: 29
32 Fig. 12 Voith Sulzer a doppio disco Il raffinatore a doppio disco Beloit ha dischi da 406 mm fino ad arrivare ai 1168 mm con potenze comprese tra 260 kw e 1900 kw, qui di seguito il solito schema di funzionamento con fibre lunghe e corte: Fig. 13 Beloit a doppio disco 30
33 6. SISTEMI DI RAFFINAZIONE La scelta del giusto sistema di raffinazione tiene conto del prodotto che si vuole ottenere, della cellulosa da utilizzare e della capacità pianificata dell impianto. Per arrivare al dimensionamento e al tipo di impianto però bisogna valutare la consistenza dell impasto (da questo deriva la dimensione delle tine di stoccaggio), il tipo di guarniture, l energia netta da applicare, il numero raccomandato di stadi di raffinazione per passare poi alla dimensione ed il tipo del raffinatore, alla velocità di rotazione dei dischi ed al consumo energetico. Altri indicatori fondamentali per stabilire il giusto sistema sono il tipo di fibre da raffinare, la loro lunghezza e dimensione, il trattamento di imbianchimento subito, la viscosità e la grossolanità dell impasto. La necessità di controllare tutti questi parametri fa si che i più importanti costruttori, prima dell installazione in loco, si affidino ad impianti pilota utili per verificare i migliori prodotti per le esigenze del cliente. Molto spesso vengono utilizzate linee separate per tipologia di fibra; fibre corte e lunghe dovrebbero infatti essere lavorate separatamente a causa della loro differente necessità di trattamento (fig. 14). In altre cartiere, soprattutto a causa degli elevati costi, le fibre vengono raffinate indifferentemente dal tipo in un unico processo con l accortezza di trovare le giuste impostazioni di compromesso per non danneggiare una o l altra fibra (fig. 15). Fig.14 Sistema separato 31
34 Fig.15 Sistema combinato Nelle cartiere che producono cartoncino multistrato i sistemi di raffinazione sono più complessi a causa dei differenti tipi di pasta utilizzata, dalle fibre bianchite e non alle paste chemimeccaniche (fig. 16) Fig.16 Sistema per cartoncino m.strato 32
35 7. EFFETTI DELLE CONDIZIONI DI RAFFINAZIONE Per una buona raffinazione non è certo sufficiente avere a disposizione delle buone macchine se poi la costanza di risultato non è garantita da controlli di processo adeguati. Variabili quali la consistenza, la temperatura, il ph e la pressione sono condizioni di processo che vengono controllate durante la raffinazione; i parametri meccanici legati al tipo di raffinatore, alle lamature, alla velocità e la direzione della rotazione sono decisi invece in fase di scelta di processo, ne deriva così che l unica variabile meccanica modificabile in fase operativa è la distanza tra i dischi (gap) che determina l energia di raffinazione. Nei prossimi capitoli verranno presi in esame tali variabili e, attraverso dati di laboratorio, verranno visualizzati grafici di più immediata comprensione. 7.1 EFFETTI DELLA CONSISTENZA Le diverse consistenze di lavoro solitamente caratterizzano il tipo di prodotto finito che si vuole ottenere. La raffinazione a media consistenza è indicata per le fibre riciclate che hanno quindi già subito un processo di raffinazione; l impasto viene pompato in un raffinatore a disco singolo ad una consistenza di circa il 15%, il risultato che ne deriva è una delicata fibrillazione interna che diminuisce con l aumentare della consistenza. Un utilizzo pratico che implica la raffinazione ad alta consistenza si ha nella produzione di carta per sacchi (fig. 17) quali quelli per il cemento o le polveri in generale che richiedono grande resistenza ma con alta permeabilità all aria, viene combinata infatti una raffinazione ad una consistenza di circa 30%-35% con una a bassa consistenza. Come dimostra la fig.18 l alta consistenza non ha grossi effetti sulle fibre se non un accorciamento delle stesse e una lieve diminuzione della densità apparente, si formano però piccole fibrille con micro nodi utili per la caratteristica di permeabilità all aria sopra citata. La conseguente raffinazione a bassa consistenza sviluppa poi le qualità meccaniche necessarie alle finalità del sacco cartaceo. 33
36 Fig.17 Sistema per carta kraft per sacchi La raffinazione a bassa consistenza è senz altro quella che permette un risultato qualitativo migliore sulle paste chimiche vergini ed è la condizione operativa utilizzata per le prove delle pagine seguenti. La consistenza non può essere considerata una variabile indipendente, il tipo di lamatura, infatti, ha influenza su di essa: una lamatura grossolana con scanalature ampie richiede consistenze più alte rispetto ad una più fine con scanalature strette. Fig.18 Effetti dopo raffinazione ad alta e bassa consistenza 34
37 Tipicamente nei sistemi a bassa consistenza questa varia dal 3% al 5%, le fibre delle conifere solitamente vengono lavorate ad una consistenza leggermente superiore rispetto a quelle delle latifoglie. La raffinazione di queste ultime ad una consistenza inferiore al 3% provoca l aumento dell azione di taglio mentre le fibre più resistenti delle conifere si comportano diversamente, a causa della diminuzione della flocculazione: le fibre passano infatti con più facilità nelle scanalature senza subire raffinazione. Un aumento della consistenza ostacola la formazione dei vortici nelle scanalature necessari per un buon passaggio delle fibre tra le lame ed aumenta la flocculazione che richiede l utilizzo di guarnizioni più grossolane. La fig.19 mostra gli effetti della consistenza sull intensità massima di raffinazione applicabile senza incorrere nel rischio di contatto tra dischi. Fig.19 Intensità di raffinazione e consistenza 7.2 EFFETTO DEL GRADO DI RAFFINAZIONE Un altro importante fattore di cui tener conto è il grado di raffinazione (espresso in gradi Shopper Riegler - SR) in entrata al singolo raffinatore; l impasto passa infatti da uno stage all altro sempre più raffinato condizionando così l intensità di raffinazione (J/m 2 ) dello stage successivo; così come la raffinazione diminuisce la resistenza delle 35
38 fibre all azione meccanica, l intensità di raffinazione scende col proseguimento del processo. Fig.20 Influenza intensità raffinazione 7.3 EFFETTO DELL ENERGIA SPECIFICA L energia di raffinazione (kwh/t) indica la quantità di energia trasferita dai raffinatori alle fibre ed è la principale variabile che viene utilizzata per il controllo diretto del grado di raffinazione. L impostazione dei giusti parametri è importante non solo per il risultato che si vuole ottenere ma anche per il costo economico, in termini di consumi elettrici, certo non indifferente. A seconda del tipo di fibra da trattare si possono utilizzare uno o più raffinatori con energie che variano da 25 a 200 kwh/t per singolo passaggio. 36
39 Sebbene le teorie più utilizzate non tengano conto dell energia per singolo passaggio, il suo controllo è molto importante perché più è elevata l energia nel singolo stage e minore sarà la resistenza meccanica finale. I seguenti grafici dimostrano proprio quanto detto; per le prove è stato utilizzato un impasto di cellulosa ECF di pino scandinavo con una consistenza del 4%, un raffinatore Conflo JC-01 Valmet, guarniture con barre larghe 4.5 mm, velocità di rotazione di 1000 giri/min, intensità di 830 J/m 2 ed un energia nella prima serie di test di 75 kwh/t per passaggio e di 150 kwh/t nella seconda. Fig.21 Grado di raffinazione ed energia netta Fig.22 Resistenza alla trazione ed energia di raff. 37
40 Fig.23 Resistenza alla trazione e grado di raff. Fig.24 Resistenza alla trazione e resistenza alla lacerazione La minor energia specifica utilizzata per ogni singolo stage produce anche una maggiore resistenza alla trazione a parità di grado di raffinazione come dimostra la figura
41 Anche la figura 24, mettendo a confronto la resistenza alla trazione e quella alla lacerazione, dimostra i migliori risultati ottenuti con la minor energia per singola passata. Il trattamento più robusto provoca sulle fibre un aumento dell azione di taglio con conseguente diminuzione della resistenza alla trazione (fig. 25). Fig.25 Lunghezza delle fibre e res. trazione 7.4 EFFETTO DELL INTENSITÀ DI RAFFINAZIONE L ottimizzazione dell intensità di raffinazione per le paste chimiche dipende dalla resistenza delle fibre al trattamento meccanico, alle dimensioni e alle caratteristiche fisiche e all abilità delle stesse a creare il fiocco. Quando si lavorano le fibre lunghe di conifera una raffinazione troppo morbida può avere uno scarso effetto mentre una troppo robusta aumenta l azione di taglio e la capacità di trattenere acqua. I seguenti grafici si riferiscono a prove effettuate con cellulosa di conifera ECF canadese applicando ad un Conflo JC-1 una energia specifica per singolo passaggio di circa 75 kwh/t. La miscela, nelle due condizioni di lavoro a confronto, è caratterizzata prima da un flusso di 500 L/min, consistenza di 3,8% e una intensità di raffinazione di 2.0 J/m (423 J/m 2 ), poi da una flusso aumentato a 950 L/min, consistenza del 4% e intensità di 4.0 J/m (845 J/m 2 ). 39
42 All inizio il grado di raffinazione e l energia specifica crescono in modo proporzionale, poi, nella condizione di intensità maggiore (4.0 J/m), a parità di energia specifica si ha un maggiore grado di raffinazione (fig. 26). Fig.26 Energia spec. e grado di raffinazione Per raggiungere un dato grado di resistenza alla trazione un intensità di raffinazione più alta richiede una minor richiesta di energia specifica (fig.27) con un incremento però dell azione di taglio (fig.28). Fig. 27 Res. trazione ed energia specifica 40
43 Fig.28 Lunghezza fibre e resistenza alla trazione Le prove appena viste dimostrano come questo tipo di cellulosa (conifere canadesi) sia solo leggermente influenzata dalle variazioni di intensità di raffinazione. La figura seguente mostra l influenza dell intensità appena citata sul consumo del raffinatore a 1000 giri/min (fig.29). Fig.29 Intensità raffinazione su Conflo JC-01 Per dimostrare le differenze di comportamento tra diverse cellulose verranno prese in esame le prove effettuate prima con un impasto di fibre lunghe sud americane (Cile) e successivamente con una cellulosa di fibre corte di eucalipto portoghese. 41
44 Nel primo caso la miscela di conifera presenta una consistenza del 4.1% e viene raffinata con guarnizioni leggermente più grossolane rispetto al caso precedente, con un energia specifica per stadio di 95 kwh/t, flusso di 375 L/min ed intensità di 2.0 J/m (423 J/m 2 ). Questi dati vengono messi a confronto con le prove a condizioni diverse e cioè: consistenza del 3.9%, flusso 720 L/min e intensità di 4.0 J/m (845 J/m 2 ). Le prove effettuate con conifere dimostrano che una bassa energia specifica non è in grado di lavorare adeguatamente le fibre (fig.30). Fig Energia spec. e grado di raffinazione (conifera) Fig.31 Energia spec. e resist alla trazione (conifera) 42
45 È chiaro che, prendendo in esame la fig. 31, le condizioni con intensità di raffinazione maggiore ci permettono di avere migliori resistenze a parità di energia applicata mentre quelle con l applicazione di 2.0 J/m non ci danno resistenze meccaniche soddisfacenti. Raffinando una cellulosa di fibre corte con una bassa intensità si ottengono certamente i migliori risultati a scapito però di una maggiore aumento di energia specifica. L aumento di intensità rischia infatti di rompere le fibre facendole scorrere lungo le scanalature delle lame impedendone ogni trattamento di raffinazione. I grafici seguenti mostrano gli effetti dell intensità di raffinazione su una cellulosa di eucalipto portoghese. In questa serie di prove l energia netta applicata per ogni singola passata è di circa 50 kwh/t. Le due condizioni di lavoro sono: flusso di 605 l/m, consistenza del 4,3% ed intensità di 195 J/m 2 nel primo caso e flusso di 1515 l/m, consistenza sempre di 4,3% e aumento intensità a 490 J/m 2. Fig.32 Influenza energia netta sul grado di raff. (eucalipto) 43
46 Fig.33 Influenza energia totale sul tensile (eucalipto) Fig.34 Influenza intensità sul tensile e sulla lacerazione Questi grafici dimostrano chiaramente come una raffinazione più delicata (intensità di raffinazione minore) a parità di energia applicata riesca a dare risultati eccellenti dal punto di vista del grado di raffinazione, della resistenza alla trazione e alla lacerazione. 44
47 Bisogna tuttavia notare che il decremento di intensità, con lo stesso tipo di lamature, corrisponde alla diminuzione di energia netta con la conseguente necessità di adeguare il numero ed il tipo di raffinatori da utilizzare. Per quanto riguarda la lunghezza delle fibre è da notare come un intensità di raffinazione minore influisca meno sull azione di taglio migliorando, a parità di energia applicata, il tensile index (fig. 35). Fig.35 Lunghezza fibre e tensile 7.5 INFLUENZA DEL PH Il Ph influisce sulla penetrazione dell acqua nelle fibre. Si raccomanda solitamente di lavorare in condizioni di ph neutro, un ph sotto 5 impedirebbe infatti una buona idratazione delle fibre aumentando l azione di taglio dei raffinatori e l aumento di fini mentre un Ph sopra 10 rende le fibre viscose ( saponose ) limitandone il passaggio tra le lame e facilitando il loro flusso tra le scanalature senza ricevere raffinazione. Nella pratica però difficilmente di interviene direttamente sul controllo del Ph in quanto questo è determinato dalle acque bianche utilizzate nel ciclo che hanno un Ph oscillante ma generalmente basico. 45
48 7.6 INFLUENZA DELLE LAMATURE Nei raffinatori di piccole dimensioni il rotore è composto da un disco unico mentre in quelli di maggiori dimensioni la superficie dei dischi è composta da più segmenti. In entrambe i casi i dischi, siano essi conici o no, sono composti da barre metalliche separate da scanalature più o meno profonde. I parametri che identificano le guarniture dei dischi sono: la larghezza delle barre e delle scanalature, l altezza delle barre e l angolo di posizionamento di queste rispetto alla direzione radiale. Dal momento che in condizioni di parallelismo tra le barre di rotore e statore si a- vrebbe una eccessiva rumorosità ed una forte azione di taglio, si preferisce intersecare le barre in modo da avere un angolo di circa 20 per le fibre corte e 35 per quelle lunghe. La scelta del tipo di guarnitura deve essere quindi fatto in base al tipo di fibra che si vuol trattare, ai target che si vogliono raggiungere e alle condizioni di raffinazione. Le fibre lunghe e resistenti delle conifere necessitano di barre e scanalature larghe, al contrario le fibre corte delle latifoglie vengono lavorate con barre e scanalature più strette. La figura seguente mostra le misure in base al tipo di fibra. Le guarniture possono essere d acciaio, di nichel, di cromo o di ceramica (per basse densità) ed il trattamento a caldo prima della finitura ne determina le caratteristiche. Per ottenere il massimo dai dischi occorre ovviamente che gli spigoli delle barre mantengano la forma originale, l eccessiva usura smussa gli angoli con conseguente aumento del consumo di energia (per esperienza personale posso affermare che la sostituzione di lamature usurate ha portato ad un risparmio energetico con conflo JC-05 di circa il 30%) e decremento dello sviluppo della fibra. 46
49 Dischi di un raffinatore Conflo 47
50 8. CONTROLLI SULLA RAFFINAZIONE La raffinazione è ottenuta dal controllo della distanza tra le lame di statore e rotore ed il segnale per il controllo automatico o manuale può provenire dal motore principale, dall energia specifica, dal flusso, dalla consistenza, dalla scolantezza o dalla permeabilità all aria della carta. Il metodo più semplice per il controllo del carico è quello manuale con la regolazione del gap tramite un pulsante o un potenziometro; è evidente però che una variazione di flusso o di consistenza comporta una variazione di carico con una irregolarità nella raffinazione. Il metodo automatico più semplice risulta invece quello legato alla regolazione del carico ad un determinato set-point con lo svantaggio di una non costante distribuzione dell energia netta nel caso di variazioni delle condizioni dell impasto. Il metodo migliore e più utilizzato è quello che si basa sulla regolazione dell energia specifica: il sistema misura la consistenza e il flusso in entrata ai raffinatori determinandone la massa secca e applicando il carico necessario a raggiungere l energia specifica impostata misurata in kwh/t di massa secca. I recenti sistemi permettono di controllare l energia specifica su ogni singolo raffinatore (la seguente figura rappresenta il sistema di raffinazione della linea 9 della Burgo di Verzuolo). 48
51 Sistema di raffinazione linea 9 Talvolta per il carico vengono anche utilizzati i segnali derivanti dalle misure online relative al grado di scolantezza, alla temperatura o alla permeabilità all aria della carta. È chiaro che la precisione della misura in questi casi è fondamentale onde evitare brusche variazioni di carico che comprometterebbero non solo la costanza della raffinazione ma rischierebbero anche il danneggiamento dei dischi. La figura seguente mostra un recente sistema di raffinazione con tre raffinatori Conflo; da notare la linea di ricircolo essenziale per la costanza del flusso alla tina di macchina. 49
I FATTORI CHE INFLUENZANO LA QUALITA DELLA STAMPA
 La qualità di stampa è determinata da: carta inchiostro forma della stampante macchina da stampa È opportuno distinguere tre differenti aspetti della stampabilità della carta: - la macchinabilità ; - l
La qualità di stampa è determinata da: carta inchiostro forma della stampante macchina da stampa È opportuno distinguere tre differenti aspetti della stampabilità della carta: - la macchinabilità ; - l
CORRELAZIONI TRA PROPRIETA DELLA CARTA TISSUE E PARAMETRI CHIMICO-FISICI DEL PROCESSO
 CORRELAZIONI TRA PROPRIETA DELLA CARTA TISSUE E PARAMETRI CHIMICO-FISICI DEL PROCESSO EFFETTUARE ANALISI CHIMICO- FISICHE SULL IMPASTO FIBROSO TENERE SOTTO CONTROLLO LA QUALITA DELLA CARTA SCOPO: CERCARE
CORRELAZIONI TRA PROPRIETA DELLA CARTA TISSUE E PARAMETRI CHIMICO-FISICI DEL PROCESSO EFFETTUARE ANALISI CHIMICO- FISICHE SULL IMPASTO FIBROSO TENERE SOTTO CONTROLLO LA QUALITA DELLA CARTA SCOPO: CERCARE
XVIII corso di Tecnologia per Tecnici Cartari edizione 2010/2011. Scuola Interregionale di tecnologia per tecnici Cartari
 XVIII corso di Tecnologia per Tecnici Cartari edizione 2010/2011 Le lamature Finebar di Santarelli Maila Scuola Interregionale di tecnologia per tecnici Cartari Istituto Salesiano «San Zeno» - Via Don
XVIII corso di Tecnologia per Tecnici Cartari edizione 2010/2011 Le lamature Finebar di Santarelli Maila Scuola Interregionale di tecnologia per tecnici Cartari Istituto Salesiano «San Zeno» - Via Don
Sollecitazioni delle strutture
 Sollecitazioni delle strutture I pilastri e i muri portanti sono tipicamente sollecitati a compressione Le travi e i solai sono sollecitati a flessione L indeformabilità di questi elementi costruttivi
Sollecitazioni delle strutture I pilastri e i muri portanti sono tipicamente sollecitati a compressione Le travi e i solai sono sollecitati a flessione L indeformabilità di questi elementi costruttivi
Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica. Docente: Dr. Giorgio Pia
 Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica Docente: Dr. Giorgio Pia L Idratazione 2C 3 S + 6H = C 3 S 2 H 3 + 3Ca(OH) 2 2C 2 S + 4H = C 3 S 2 H 3 + Ca(OH) 2 L Idratazione 2C 3 S + 6H = C
Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica Docente: Dr. Giorgio Pia L Idratazione 2C 3 S + 6H = C 3 S 2 H 3 + 3Ca(OH) 2 2C 2 S + 4H = C 3 S 2 H 3 + Ca(OH) 2 L Idratazione 2C 3 S + 6H = C
Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV Prof. Dott. Bernhard Elsener
 Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV ESERCIZIO 4.1 E dato il diagramma di stato del sistema Pb-Sn (figura 1). Figura 1 Diagramma di stato Pb-Sn 1. Determinare le fasi
Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV ESERCIZIO 4.1 E dato il diagramma di stato del sistema Pb-Sn (figura 1). Figura 1 Diagramma di stato Pb-Sn 1. Determinare le fasi
iglidur J200: Per scorrimento su alluminio anodizzato Eccellente resistenza all abrasione su perni in alluminio anodizzato
 iglidur : Per scorrimento su alluminio anodizzato Eccellente resistenza all abrasione su perni in alluminio anodizzato Bassi coefficienti d attrito Bassa usura anche in ambienti sporchi Per carichi medio-bassi
iglidur : Per scorrimento su alluminio anodizzato Eccellente resistenza all abrasione su perni in alluminio anodizzato Bassi coefficienti d attrito Bassa usura anche in ambienti sporchi Per carichi medio-bassi
MATERIALI STRUTTURALI PER L EDILIZIA: ACCIAIO, LATERIZIO E VETRO STRUTTURALE
 MATERIALI PER L EDILIZIA Prof. L. Coppola MATERIALI STRUTTURALI PER L EDILIZIA: ACCIAIO, LATERIZIO E VETRO STRUTTURALE Coffetti Denny PhD Candidate Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate Università
MATERIALI PER L EDILIZIA Prof. L. Coppola MATERIALI STRUTTURALI PER L EDILIZIA: ACCIAIO, LATERIZIO E VETRO STRUTTURALE Coffetti Denny PhD Candidate Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate Università
1. Introduzione 1.1 Scopo della tesi
 1. Introduzione 1.1 Scopo della tesi Fluidizzare un letto di particelle solide con un gas è un ottima tecnica per assicurare il mescolamento delle particelle ed il contatto intimo tra le due fasi. Di conseguenza,
1. Introduzione 1.1 Scopo della tesi Fluidizzare un letto di particelle solide con un gas è un ottima tecnica per assicurare il mescolamento delle particelle ed il contatto intimo tra le due fasi. Di conseguenza,
La smussatura di ingranaggi con grande modulo
 La smussatura di ingranaggi con grande modulo I metodi di smussatura normalmente usati per ingranaggi di modulo fino a 6-8 mm prodotti in lotti non troppo piccoli, usano utensili che lavorano per compressione
La smussatura di ingranaggi con grande modulo I metodi di smussatura normalmente usati per ingranaggi di modulo fino a 6-8 mm prodotti in lotti non troppo piccoli, usano utensili che lavorano per compressione
Corso di Chimica Generale CL Biotecnologie
 Corso di Chimica Generale CL Biotecnologie STATI DELLA MATERIA Prof. Manuel Sergi MATERIA ALLO STATO GASSOSO MOLECOLE AD ALTA ENERGIA CINETICA GRANDE DISTANZA TRA LE MOLECOLE LEGAMI INTERMOLECOLARI DEBOLI
Corso di Chimica Generale CL Biotecnologie STATI DELLA MATERIA Prof. Manuel Sergi MATERIA ALLO STATO GASSOSO MOLECOLE AD ALTA ENERGIA CINETICA GRANDE DISTANZA TRA LE MOLECOLE LEGAMI INTERMOLECOLARI DEBOLI
a) determinare le fasi presenti, la loro quantità (percentuale) e la loro composizione in una lega Pb30% - Sn a 300, 200 e 184, 180 e 20 C.
 ESERCIZIO 1 E dato il diagramma di stato del sistema Pb-Sn (figura). a) determinare le fasi presenti, la loro quantità (percentuale) e la loro composizione in una lega Pb30% - Sn a 300, 200 e 184, 180
ESERCIZIO 1 E dato il diagramma di stato del sistema Pb-Sn (figura). a) determinare le fasi presenti, la loro quantità (percentuale) e la loro composizione in una lega Pb30% - Sn a 300, 200 e 184, 180
Effetti del fuoco (incendio) sul calcestruzzo armato
 Effetti del fuoco (incendio) sul calcestruzzo armato Effetti generali dell incendio a) Distribuzione della temperatura nelle strutture. Una distribuzione di temperatura non uniforme con differenze di dilatazione
Effetti del fuoco (incendio) sul calcestruzzo armato Effetti generali dell incendio a) Distribuzione della temperatura nelle strutture. Una distribuzione di temperatura non uniforme con differenze di dilatazione
Zone a rischio di esplosione e incendio: le falegnamerie
 Dicembre 2016 Zone a rischio di esplosione e incendio: le falegnamerie Le falegnamerie sono impianti di lavorazione del legno, solitamente rappresentati da capannoni industriali, nei quali una serie di
Dicembre 2016 Zone a rischio di esplosione e incendio: le falegnamerie Le falegnamerie sono impianti di lavorazione del legno, solitamente rappresentati da capannoni industriali, nei quali una serie di
Caratteristiche di materiali
 Caratteristiche di materiali Caratteristiche macroscopiche Lavorazione Microstruttura Formula chimica Legami chimici Struttura atomica Meccaniche Materiale Fisiche Elettriche Megnetiche Termiche Meccaniche
Caratteristiche di materiali Caratteristiche macroscopiche Lavorazione Microstruttura Formula chimica Legami chimici Struttura atomica Meccaniche Materiale Fisiche Elettriche Megnetiche Termiche Meccaniche
Lezione del 27/05/2010 ora 10:30-13:30 Andrea Carbognani matricola Alice Lomonaco matricola Roberto Alciati matricola
 Lezione del 27/05/2010 ora 10:30-13:30 Andrea Carbognani matricola 219587 Alice Lomonaco matricola 219414 Roberto Alciati matricola 219475 Sommario 1 Essiccatore a tamburo rotante... 1 1.1 Introduzione...
Lezione del 27/05/2010 ora 10:30-13:30 Andrea Carbognani matricola 219587 Alice Lomonaco matricola 219414 Roberto Alciati matricola 219475 Sommario 1 Essiccatore a tamburo rotante... 1 1.1 Introduzione...
POMPE A PALETTE Introduzione
 POMPE A PALETTE Introduzione Architettura Caratteristiche di Funzionamento Calcolo della Cilindrata Bilanciamento Idraulico Pompe a Palette 1 SCHEMA BASE Il rotore è un tamburo circolare che ruota all
POMPE A PALETTE Introduzione Architettura Caratteristiche di Funzionamento Calcolo della Cilindrata Bilanciamento Idraulico Pompe a Palette 1 SCHEMA BASE Il rotore è un tamburo circolare che ruota all
LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DELLA CARTA
 La produzione della cellulosa La cellulosa è composta da legno proveniente da alberi quali betulla, pioppo, faggio, eucalipto, pino o abete (questi ultimi due, hanno fibre più robuste e consistenti). Ai
La produzione della cellulosa La cellulosa è composta da legno proveniente da alberi quali betulla, pioppo, faggio, eucalipto, pino o abete (questi ultimi due, hanno fibre più robuste e consistenti). Ai
Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV Prof. Dott. Bernhard Elsener
 Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV ESERCIZIO 4.1 E dato il diagramma di stato del sistema Pb-Sn (figura 1). Figura 1 Diagramma di stato Pb-Sn 1. Determinare le fasi
Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV ESERCIZIO 4.1 E dato il diagramma di stato del sistema Pb-Sn (figura 1). Figura 1 Diagramma di stato Pb-Sn 1. Determinare le fasi
iglidur J200 Per scorrimenti su alluminio anodizzato iglidur J200 Tel Fax
 J200 Per scorrimenti su alluminio anodizzato Eccellente resistenza all abrasione su perni in alluminio anodizzato Bassi coefficienti d attrito Ottima durata anche in ambienti sporchi Esente da manutenzione
J200 Per scorrimenti su alluminio anodizzato Eccellente resistenza all abrasione su perni in alluminio anodizzato Bassi coefficienti d attrito Ottima durata anche in ambienti sporchi Esente da manutenzione
I Materiali Compositi
 PERCHE IN FORMA DI FIBRE? L utilizzo delle fibre è dovuto al fatto che molti materiali risultano essere più resistenti e rigidi sotto forma di fibra (con una dimensione molto maggiore dell altra) che non
PERCHE IN FORMA DI FIBRE? L utilizzo delle fibre è dovuto al fatto che molti materiali risultano essere più resistenti e rigidi sotto forma di fibra (con una dimensione molto maggiore dell altra) che non
Corso di Laurea in Ingegneria Edile
 Dip. di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale Università Federico II di Napoli Corso di Laurea in Ingegneria Edile Corso di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata (Prof.
Dip. di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale Università Federico II di Napoli Corso di Laurea in Ingegneria Edile Corso di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata (Prof.
ESERCITAZIONE SUL CRITERIO
 TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AEROSPAZIALI ESERCITAZIONE SUL CRITERIO DI JUVINALL Prof. Claudio Scarponi Ing. Carlo Andreotti Ing. Carlo Andreotti 1 IL CRITERIO DI JUVINALL La formulazione del criterio
TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AEROSPAZIALI ESERCITAZIONE SUL CRITERIO DI JUVINALL Prof. Claudio Scarponi Ing. Carlo Andreotti Ing. Carlo Andreotti 1 IL CRITERIO DI JUVINALL La formulazione del criterio
IL TAGLIO ORBITALE DELLE VITI SENZA FINE UNA TECNOLOGIA ECOSOSTENIBILE
 IL TAGLIO ORBITALE DELLE VITI SENZA FINE UNA TECNOLOGIA ECOSOSTENIBILE Marco Benincasa (Benincasa Meccanica) Giampaolo Giacomozzi (Varvel SpA) Massimiliano Turci (Studio Tecnico Turci) Riduttori a vite
IL TAGLIO ORBITALE DELLE VITI SENZA FINE UNA TECNOLOGIA ECOSOSTENIBILE Marco Benincasa (Benincasa Meccanica) Giampaolo Giacomozzi (Varvel SpA) Massimiliano Turci (Studio Tecnico Turci) Riduttori a vite
I differenti materiali differiscono per le caratteristiche meccaniche e fisiche.
 MATERIALI COMPOSITI I differenti materiali differiscono per le caratteristiche meccaniche e fisiche. I METALLI hanno forma cristallina e forti legami molecolari (legame metallico), che danno loro resistenza
MATERIALI COMPOSITI I differenti materiali differiscono per le caratteristiche meccaniche e fisiche. I METALLI hanno forma cristallina e forti legami molecolari (legame metallico), che danno loro resistenza
CAPITOLO 6 L ATTRITO INTRODUZIONE 6.1 L ATTRITO TRA DUE CORPI
 62 CAPITOLO 6 L ATTRITO INTRODUZIONE In questo capitolo viene data una descrizione del fenomeno fisico dell attrito a livello macroscopico e microscopico e sono illustrati diversi comportamenti che tengono
62 CAPITOLO 6 L ATTRITO INTRODUZIONE In questo capitolo viene data una descrizione del fenomeno fisico dell attrito a livello macroscopico e microscopico e sono illustrati diversi comportamenti che tengono
ESTRATTO MOLLA AD ELEVATA ELASTICITÀ IN MATERIA PLASTICA.
 ESTRATTO MOLLA AD ELEVATA ELASTICITÀ IN MATERIA PLASTICA vittorio.scialla@strumentiperleaziende.com Molla ad elevata elasticità (A), realizzata in materia plastica, costituita da due elementi a forma di
ESTRATTO MOLLA AD ELEVATA ELASTICITÀ IN MATERIA PLASTICA vittorio.scialla@strumentiperleaziende.com Molla ad elevata elasticità (A), realizzata in materia plastica, costituita da due elementi a forma di
NYLON-CARBON DUREZZA & TRAZIONE
 NYLON-CARBON DUREZZA & TRAZIONE D R. F L A V I A N A C A L I G N A NO D R. M A S S I M O L O R U S S O D R. I G N A Z I O R O P P O L O N Y LO N - C A R BON PROVE DI DUREZZA E DI TRAZIONE INTRODUZIONE
NYLON-CARBON DUREZZA & TRAZIONE D R. F L A V I A N A C A L I G N A NO D R. M A S S I M O L O R U S S O D R. I G N A Z I O R O P P O L O N Y LO N - C A R BON PROVE DI DUREZZA E DI TRAZIONE INTRODUZIONE
FATICA. FATICA: curva di Wohler
 FATICA Flessione rotante CURVA DI WOHLER 1 FATICA: curva di Wohler 2 1 FATICA: curva di Wohler 3 FATICA: curva di Wohler an f b f N f 1 1 m m f K N f f a 1 b 4 2 FATICA: curva di Wohler la curva viene
FATICA Flessione rotante CURVA DI WOHLER 1 FATICA: curva di Wohler 2 1 FATICA: curva di Wohler 3 FATICA: curva di Wohler an f b f N f 1 1 m m f K N f f a 1 b 4 2 FATICA: curva di Wohler la curva viene
La terra come materiale da costruzione - Principi. Strade ferrovie aeroporti
 La terra come materiale da costruzione - Principi Strade ferrovie aeroporti La terra come materiale da costruzione è caratterizzato da: 1. Composizione trifase (solido, liquido, aeriforme) 2. Assetto granulare
La terra come materiale da costruzione - Principi Strade ferrovie aeroporti La terra come materiale da costruzione è caratterizzato da: 1. Composizione trifase (solido, liquido, aeriforme) 2. Assetto granulare
ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO - 4 DURATA DEL TAGLIENTE
 LAVORAZIONI PER SEPARAZIONE ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO - 4 DURATA DEL TAGLIENTE Vittore Carassiti - INFN FE 1 INTRODUZIONE La velocità di taglio e gli altri parametri di lavorazione Alla velocità di taglio
LAVORAZIONI PER SEPARAZIONE ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO - 4 DURATA DEL TAGLIENTE Vittore Carassiti - INFN FE 1 INTRODUZIONE La velocità di taglio e gli altri parametri di lavorazione Alla velocità di taglio
MISCELAZIONE DI SISTEMI LIQUIDI E SEMISOLIDI
 MISCELAZIONE DI SISTEMI LIQUIDI E SEMISOLIDI CORSO DI IMPIANTI DELL INDUSTRIA FARMACEUTICA ANNO ACCADEMICO 2007-2008 2008 MISCELAZIONE DI SISTEMI LIQUIDI QUANDO SI MESCOLANO SISTEMI LIQUIDI CHE DANNO MISCELE
MISCELAZIONE DI SISTEMI LIQUIDI E SEMISOLIDI CORSO DI IMPIANTI DELL INDUSTRIA FARMACEUTICA ANNO ACCADEMICO 2007-2008 2008 MISCELAZIONE DI SISTEMI LIQUIDI QUANDO SI MESCOLANO SISTEMI LIQUIDI CHE DANNO MISCELE
Sussidi didattici per il corso di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI. Prof. Ing. Francesco Zanghì ELEMENTI DI IDRAULICA AGGIORNAMENTO 26/11/2013
 Sussidi didattici per il corso di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI Prof. Ing. Francesco Zanghì ELEMENTI DI IDRAULICA AGGIORNAMENTO 26/11/2013 L'idraulica è la scienza che studia l'utilizzazione dei
Sussidi didattici per il corso di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI Prof. Ing. Francesco Zanghì ELEMENTI DI IDRAULICA AGGIORNAMENTO 26/11/2013 L'idraulica è la scienza che studia l'utilizzazione dei
LAVORAZIONE DEI POLIMERI I processi per trasformare granuli e pastiglie in prodotti finiti sono numerosi.
 LAVORAZIONE DEI POLIMERI I processi per trasformare granuli e pastiglie in prodotti finiti sono numerosi. Generalmente i polimeri non vengono trasformati allo stato puro, ma miscelati con additivi che
LAVORAZIONE DEI POLIMERI I processi per trasformare granuli e pastiglie in prodotti finiti sono numerosi. Generalmente i polimeri non vengono trasformati allo stato puro, ma miscelati con additivi che
14. Transizioni di Fase_a.a. 2009/2010 TRANSIZIONI DI FASE
 TRANSIZIONI DI FASE Fase: qualsiasi parte di un sistema omogenea, di composizione chimica costante e in un determinato stato fisico. Una fase può avere le stesse variabili intensive (P, T etc) ma ha diverse
TRANSIZIONI DI FASE Fase: qualsiasi parte di un sistema omogenea, di composizione chimica costante e in un determinato stato fisico. Una fase può avere le stesse variabili intensive (P, T etc) ma ha diverse
Umidità e materiali igroscopici U CA
 II. Umidità e materiali igroscopici U CA Contenuto d acqua U CA U CA m m H 2 O SEC 100 m H2 O m SEC massa d acqua presente nel materiale massa anidra del materiale note: 1. Dal contenuto d acqua U CA di
II. Umidità e materiali igroscopici U CA Contenuto d acqua U CA U CA m m H 2 O SEC 100 m H2 O m SEC massa d acqua presente nel materiale massa anidra del materiale note: 1. Dal contenuto d acqua U CA di
La sinterizzazione rappresenta il processo che porta dalle polveri ad un compatto in genere più denso, meno poroso e più resistente (è il passaggio
 La sinterizzazione rappresenta il processo che porta dalle polveri ad un compatto in genere più denso, meno poroso e più resistente (è il passaggio da una situazione incoerente ad una coerente). Si parla
La sinterizzazione rappresenta il processo che porta dalle polveri ad un compatto in genere più denso, meno poroso e più resistente (è il passaggio da una situazione incoerente ad una coerente). Si parla
Attrito statico e attrito dinamico
 Forza di attrito La presenza delle forze di attrito fa parte dell esperienza quotidiana. Se si tenta di far scorrere un corpo su una superficie, si sviluppa una resistenza allo scorrimento detta forza
Forza di attrito La presenza delle forze di attrito fa parte dell esperienza quotidiana. Se si tenta di far scorrere un corpo su una superficie, si sviluppa una resistenza allo scorrimento detta forza
Corso di Componenti e Impianti Termotecnici RETI DI DISTRIBUZIONE PERDITE DI CARICO CONTINUE
 RETI DI DISTRIBUZIONE PERDITE DI CARICO CONTINUE 1 PERDITE DI CARICO CONTINUE Sono le perdite di carico (o di pressione) che un fluido, in moto attraverso un condotto, subisce a causa delle resistenze
RETI DI DISTRIBUZIONE PERDITE DI CARICO CONTINUE 1 PERDITE DI CARICO CONTINUE Sono le perdite di carico (o di pressione) che un fluido, in moto attraverso un condotto, subisce a causa delle resistenze
LA COLATA CENTRIFUGA
 LA COLATA CENTRIFUGA Rientra nella categoria dei processi fusori per colata sotto pressione: Colata centrifuga Pressofusione La colata avviene introducendo il metallo liquido nella forma con l ausilio
LA COLATA CENTRIFUGA Rientra nella categoria dei processi fusori per colata sotto pressione: Colata centrifuga Pressofusione La colata avviene introducendo il metallo liquido nella forma con l ausilio
TECNICHE CENTRIFUGATIVE PRINCIPI DI BASE DELLA SEDIMENTAZIONE TIPI DI CENTRIFUGHE ULTRACENTRIFUGA ANALITICA
 TECNICHE CENTRIFUGATIVE PRINCIPI DI BASE DELLA SEDIMENTAZIONE TIPI DI CENTRIFUGHE ULTRACENTRIFUGA ANALITICA TIPI DI CENTRIFUGHE CENTRIFUGHE PREPARATIVE Consentono la separazione, isolamento e purificazione
TECNICHE CENTRIFUGATIVE PRINCIPI DI BASE DELLA SEDIMENTAZIONE TIPI DI CENTRIFUGHE ULTRACENTRIFUGA ANALITICA TIPI DI CENTRIFUGHE CENTRIFUGHE PREPARATIVE Consentono la separazione, isolamento e purificazione
Proprietà meccaniche. Proprietà dei materiali
 Proprietà meccaniche Proprietà dei materiali Proprietà meccaniche Tutti i materiali sono soggetti a sollecitazioni (forze) di varia natura che ne determinano deformazioni macroscopiche. Spesso le proprietà
Proprietà meccaniche Proprietà dei materiali Proprietà meccaniche Tutti i materiali sono soggetti a sollecitazioni (forze) di varia natura che ne determinano deformazioni macroscopiche. Spesso le proprietà
PANNELLO-SISTEMA REFLEX
 Settembre 04 S Y S T E M S 1A05 REFLEX PANNELLO-SISTEMA REFLEX DESCRIZIONE IMPIEGO Composto da una lastra superficiale per la diffusione del calore in lega speciale di alluminio dello spessore di 0,3 mm,
Settembre 04 S Y S T E M S 1A05 REFLEX PANNELLO-SISTEMA REFLEX DESCRIZIONE IMPIEGO Composto da una lastra superficiale per la diffusione del calore in lega speciale di alluminio dello spessore di 0,3 mm,
CAPITOLO 7: ESEMPI PRATICI: 7.1 Esempi di dinamica.
 CAPITOLO 7: ESEMPI PRATICI: 7.1 Esempi di dinamica. Questo capitolo vuole fornire una serie di esempi pratici dei concetti illustrati nei capitoli precedenti con qualche approfondimento. Vediamo subito
CAPITOLO 7: ESEMPI PRATICI: 7.1 Esempi di dinamica. Questo capitolo vuole fornire una serie di esempi pratici dei concetti illustrati nei capitoli precedenti con qualche approfondimento. Vediamo subito
Angoli caratteristici delle frese a lame riportate
 Angoli caratteristici delle frese a lame riportate Le frese a lame riportate sono costituite da un corpo in acciaio su cui sono fissate, in apposite sedi, le lame di acciaio rapido o di metallo duro che
Angoli caratteristici delle frese a lame riportate Le frese a lame riportate sono costituite da un corpo in acciaio su cui sono fissate, in apposite sedi, le lame di acciaio rapido o di metallo duro che
Università della Calabria
 Università della Calabria Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Dipartimento di Ingegneria Meccanica TESI DI LAUREA Progettazione di un accesso ottico per una pompa a palette per
Università della Calabria Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Dipartimento di Ingegneria Meccanica TESI DI LAUREA Progettazione di un accesso ottico per una pompa a palette per
TECNOLOGIA DELL ARCHITETTURA 2009/10 PROF. SERGIO RINALDI
 SISTEMI STRUTTURALI PRINCIPALI NELLA STORIA DELL ARCHITETTURA Esiste una stretta relazione tra il sistema strutturale e i materiali scelti per la costruzione sistema a telaio sistema trilitico sistema
SISTEMI STRUTTURALI PRINCIPALI NELLA STORIA DELL ARCHITETTURA Esiste una stretta relazione tra il sistema strutturale e i materiali scelti per la costruzione sistema a telaio sistema trilitico sistema
Sistemi radianti a pavimento a basso spessore e bassa inerzia: tipologie e caratteristiche
 Sistemi radianti a pavimento a basso spessore e bassa inerzia: Ing. Clara Peretti Segretario Generale Consorzio Q-RAD Febbraio 2017 Figura 1. Sistemi radianti a basso spessore I sistemi radianti a pavimento
Sistemi radianti a pavimento a basso spessore e bassa inerzia: Ing. Clara Peretti Segretario Generale Consorzio Q-RAD Febbraio 2017 Figura 1. Sistemi radianti a basso spessore I sistemi radianti a pavimento
Comportamento meccanico dei materiali
 Comportamento meccanico dei materiali Riferimento: capitolo 2 del Kalpakjian Importante per comprendere il comportamento dei materiali durante le lavorazioni Introduzione Tensione e compressione Torsione
Comportamento meccanico dei materiali Riferimento: capitolo 2 del Kalpakjian Importante per comprendere il comportamento dei materiali durante le lavorazioni Introduzione Tensione e compressione Torsione
Pompe per liquidi abrasivi Flygt serie H
 Pompe per liquidi abrasivi Flygt serie H 58 Quando il gioco si fa duro... La rimozione dei fanghi è una componente essenziale delle operazioni quotidiane di un gran numero di industrie, quali cave, miniere,
Pompe per liquidi abrasivi Flygt serie H 58 Quando il gioco si fa duro... La rimozione dei fanghi è una componente essenziale delle operazioni quotidiane di un gran numero di industrie, quali cave, miniere,
La Trasmissione Dell Energia Meccanica
 La Trasmissione Dell Energia Meccanica La trasmissione del moto I sistemi meccanici sono dispositivi costituiti da più componenti in grado di trasmettere energia cinetica. Alcuni sono anche in grado di
La Trasmissione Dell Energia Meccanica La trasmissione del moto I sistemi meccanici sono dispositivi costituiti da più componenti in grado di trasmettere energia cinetica. Alcuni sono anche in grado di
Esercitazione 2 Ciclo a vapore a recupero
 Esercitazione 2 Ciclo a vapore a recupero Lo scopo di questa esercitazione è la progettazione di un ciclo a recupero: l impianto è composto da un ciclo a vapore ad un livello di pressione che utilizza
Esercitazione 2 Ciclo a vapore a recupero Lo scopo di questa esercitazione è la progettazione di un ciclo a recupero: l impianto è composto da un ciclo a vapore ad un livello di pressione che utilizza
1.Pressione di un Gas
 1.Pressione di un Gas Un gas è formato da molecole che si muovono in modo disordinato, urtandosi fra loro e urtando contro le pareti del recipiente che le contiene. Durante gli urti, le molecole esercitano
1.Pressione di un Gas Un gas è formato da molecole che si muovono in modo disordinato, urtandosi fra loro e urtando contro le pareti del recipiente che le contiene. Durante gli urti, le molecole esercitano
4 SOLLECITAZIONI INDOTTE. 4.1 Generalità
 4 SOLLECITAZIONI INDOTTE 4.1 Generalità Le azioni viste inducono uno stato pensionale interno alla struttura e all edificio che dipende dalla modalità con cui le azioni si esplicano. Le sollecitazioni
4 SOLLECITAZIONI INDOTTE 4.1 Generalità Le azioni viste inducono uno stato pensionale interno alla struttura e all edificio che dipende dalla modalità con cui le azioni si esplicano. Le sollecitazioni
Il processo di raffinazione
 XVII corso di Tecnologia per Tecnici Cartari edizione 2009/2010 Il processo di raffinazione di De Amicis Pierluigi Scuola Interregionale di tecnologia per tecnici Cartari Istituto Salesiano «San Zeno»
XVII corso di Tecnologia per Tecnici Cartari edizione 2009/2010 Il processo di raffinazione di De Amicis Pierluigi Scuola Interregionale di tecnologia per tecnici Cartari Istituto Salesiano «San Zeno»
Lezione 15 Geometrie lineari di confinamento magnetico
 Lezione 15 Geometrie lineari di confinamento magnetico G. Bosia Universita di Torino G. Bosia Introduzione alla fisica del plasma Lezione 15 1 Disuniformità con gradiente in direzione del campo ( ) Una
Lezione 15 Geometrie lineari di confinamento magnetico G. Bosia Universita di Torino G. Bosia Introduzione alla fisica del plasma Lezione 15 1 Disuniformità con gradiente in direzione del campo ( ) Una
ZEPPA G. Università degli Studi di Torino
 Appunti del corso di Istituzioni di tecnologia alimentare Parte 2 Macinatura -Vagliatura ZEPPA G. Università degli Studi di Torino Riduzione delle dimensioni Operazioni puramente meccaniche che determinano
Appunti del corso di Istituzioni di tecnologia alimentare Parte 2 Macinatura -Vagliatura ZEPPA G. Università degli Studi di Torino Riduzione delle dimensioni Operazioni puramente meccaniche che determinano
LA BIGA. Scritto il marzo, 2017 by papuzzakia
 LA BIGA Scritto il marzo, 2017 by papuzzakia La biga è un preimpasto molto usato in panificazione. La sua caratteristica è quella di un essere molto duro con una percentuale di acqua generalmente intorno
LA BIGA Scritto il marzo, 2017 by papuzzakia La biga è un preimpasto molto usato in panificazione. La sua caratteristica è quella di un essere molto duro con una percentuale di acqua generalmente intorno
Trasmissioni con cinghie. della trasmissione
 Tecnologia della trasmissione Trasmissioni con cinghie 1 2 Trasmissioni con cinghie Cinghie piane ad anello continuo 6.4.1 ESBAND Cinghie termosaldabili per il 6.4.4 trasporto in PUR Cinghie tonde ad anello
Tecnologia della trasmissione Trasmissioni con cinghie 1 2 Trasmissioni con cinghie Cinghie piane ad anello continuo 6.4.1 ESBAND Cinghie termosaldabili per il 6.4.4 trasporto in PUR Cinghie tonde ad anello
Statica ed equilibrio dei corpi
 Statica ed equilibrio dei corpi Avendo stabilito le leggi che regolano il moto dei corpi è possibile dedurre le leggi che regolano il loro equilibrio in condizioni statiche, cioè in assenza di movimento.
Statica ed equilibrio dei corpi Avendo stabilito le leggi che regolano il moto dei corpi è possibile dedurre le leggi che regolano il loro equilibrio in condizioni statiche, cioè in assenza di movimento.
La carta è costituito da materie prime fibrose prevalentemente vegetali, unite per feltrazione ed essiccate, inoltre questo prodotto può essere arricc
 La carta è costituito da materie prime fibrose prevalentemente vegetali, unite per feltrazione ed essiccate, inoltre questo prodotto può essere arricchito da collanti, cariche minerali, coloranti ed additivi
La carta è costituito da materie prime fibrose prevalentemente vegetali, unite per feltrazione ed essiccate, inoltre questo prodotto può essere arricchito da collanti, cariche minerali, coloranti ed additivi
Caratteristiche di materiali
 Caratteristiche di materiali Caratteristiche macroscopiche Lavorazione Microstruttura Formula chimica Legami chimici Struttura atomica Meccaniche Materiale Fisiche Elettriche Megnetiche Termiche Meccaniche
Caratteristiche di materiali Caratteristiche macroscopiche Lavorazione Microstruttura Formula chimica Legami chimici Struttura atomica Meccaniche Materiale Fisiche Elettriche Megnetiche Termiche Meccaniche
BULLONI AD ALTA RESISTENZA GIUNZIONI AD ATTRITO
 LEZIONI N E 3 ULLONI D LT RESISTENZ GIUNZIONI D TTRITO I) Giunzioni ad attrito soggette a forze di taglio Si considerano ad alta resistenza i bulloni di classe 8.8 e 10.9. Essi sono caratterizzati dai
LEZIONI N E 3 ULLONI D LT RESISTENZ GIUNZIONI D TTRITO I) Giunzioni ad attrito soggette a forze di taglio Si considerano ad alta resistenza i bulloni di classe 8.8 e 10.9. Essi sono caratterizzati dai
Amplificatori in classe A con accoppiamento capacitivo
 Ottobre 00 Amplificatori in classe A con accoppiamento capacitivo amplificatore in classe A di Fig. presenta lo svantaggio che il carico è percorso sia dalla componente di segnale, variabile nel tempo,
Ottobre 00 Amplificatori in classe A con accoppiamento capacitivo amplificatore in classe A di Fig. presenta lo svantaggio che il carico è percorso sia dalla componente di segnale, variabile nel tempo,
ANALISI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI RAFFINAZIONE
 ANALISI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI RAFFINAZIONE Bargiacchi Fabio Georgia Pacific Italia, Via Enrico Fermi, 13 Castelnuovo di Garfagnana (LU) SOMMARIO La raffinazione è una delle operazioni della
ANALISI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI RAFFINAZIONE Bargiacchi Fabio Georgia Pacific Italia, Via Enrico Fermi, 13 Castelnuovo di Garfagnana (LU) SOMMARIO La raffinazione è una delle operazioni della
Trasmissione con cinghie
 Trasmissione con cinghie La flessibilità e la leggerezza delle cinghie sono sfruttate per trasmissioni tra alberi distanti tra loro e comunque disposti. I tipi di cinghie adoperati oggi sono le cinghie
Trasmissione con cinghie La flessibilità e la leggerezza delle cinghie sono sfruttate per trasmissioni tra alberi distanti tra loro e comunque disposti. I tipi di cinghie adoperati oggi sono le cinghie
Le fibre tessili naturali sono quelle esistenti in natura, le tecnofibre - più comunemente conosciute come fibre chimiche - invece sono quelle
 Le fibre tessili. La fibra tessile è l'insieme dei prodotti fibrosi che, per la loro struttura, lunghezza, resistenza ed elasticità, hanno la proprietà di unirsi, attraverso la filatura, in fili sottili,
Le fibre tessili. La fibra tessile è l'insieme dei prodotti fibrosi che, per la loro struttura, lunghezza, resistenza ed elasticità, hanno la proprietà di unirsi, attraverso la filatura, in fili sottili,
MACCHINA PELLETTIZZATRICE. My Pellet!
 MACCHINA PELLETTIZZATRICE My Pellet! N-PICO vuol dire pellet a portata di tutti. N-PICO è stata appositamente progettata e sviluppata per la piccola e domestica produzione di pellet, tale da permettere
MACCHINA PELLETTIZZATRICE My Pellet! N-PICO vuol dire pellet a portata di tutti. N-PICO è stata appositamente progettata e sviluppata per la piccola e domestica produzione di pellet, tale da permettere
Il cono d affilatura nelle punte elicoidali. Riprendendo la figura N 1 della descrizione generale, si possono dare le seguenti definizioni:
 Il cono d affilatura nelle punte elicoidali Riprendendo la figura N 1 della descrizione generale, si possono dare le seguenti definizioni: Fig.N 1- Alcuni angoli caratteristici della punta elicoidale ε
Il cono d affilatura nelle punte elicoidali Riprendendo la figura N 1 della descrizione generale, si possono dare le seguenti definizioni: Fig.N 1- Alcuni angoli caratteristici della punta elicoidale ε
Concetti di base. Sistemi ideali Sistemi reali SOLIDI CORPI LIQUIDI/GASSOSI (FLUIDI) SOLIDI DEFORMAZIONE ELASTICA
 Reologia Concetti di base CORPI SOLIDI LIQUIDI/GASSOSI (FLUIDI) Sistemi ideali Sistemi reali SOLIDI DEFORMAZIONE ELASTICA FLUIDI DEFORM. IRREVERSIBILI (SCORRIMENTO) SOLIDI DEFORMAZIONI PERMANENTI FLUIDI
Reologia Concetti di base CORPI SOLIDI LIQUIDI/GASSOSI (FLUIDI) Sistemi ideali Sistemi reali SOLIDI DEFORMAZIONE ELASTICA FLUIDI DEFORM. IRREVERSIBILI (SCORRIMENTO) SOLIDI DEFORMAZIONI PERMANENTI FLUIDI
TERMODINAMICA. Studia le trasformazioni dei sistemi in relazione agli scambi di calore e lavoro. GENERALITÀ SUI SISTEMI TERMODINAMICI
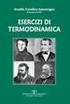 TERMODINAMICA Termodinamica: scienza che studia le proprietà e il comportamento dei sistemi, la loro evoluzione e interazione con l'ambiente esterno che li circonda. Studia le trasformazioni dei sistemi
TERMODINAMICA Termodinamica: scienza che studia le proprietà e il comportamento dei sistemi, la loro evoluzione e interazione con l'ambiente esterno che li circonda. Studia le trasformazioni dei sistemi
Lo stato liquido. Un liquido non ha una forma propria, ma ha la forma del recipiente che lo contiene; ha però volume proprio e non è comprimibile.
 I liquidi Lo stato liquido Lo stato liquido rappresenta una condizione intermedia tra stato aeriforme e stato solido, tra lo stato di massimo disordine e quello di perfetto ordine Un liquido non ha una
I liquidi Lo stato liquido Lo stato liquido rappresenta una condizione intermedia tra stato aeriforme e stato solido, tra lo stato di massimo disordine e quello di perfetto ordine Un liquido non ha una
FATTORI DI INFLUENZA PROVA DI RESILIENZA
 L'importanza della prova di resilienza è ormai da tutti riconosciuta, ma occorre tenere presente che i valori che se ne ricavano non hanno di per sé alcun significato assoluto, in quanto essi risentono
L'importanza della prova di resilienza è ormai da tutti riconosciuta, ma occorre tenere presente che i valori che se ne ricavano non hanno di per sé alcun significato assoluto, in quanto essi risentono
Macchina a regime periodico
 Macchina a regime periodico rev. 1.2 J m J v τ, η t r φ motore l m F x, ẋ, ẍ (P.M.E.) p m p a Figura 1: Schema dell impianto di pompaggio Della pompa volumetrica a stantuffo a singolo effetto rappresentata
Macchina a regime periodico rev. 1.2 J m J v τ, η t r φ motore l m F x, ẋ, ẍ (P.M.E.) p m p a Figura 1: Schema dell impianto di pompaggio Della pompa volumetrica a stantuffo a singolo effetto rappresentata
La cordonatura e la piegatura degli astucci: criticità nella cartotecnica
 La cordonatura e la piegatura degli astucci: criticità nella cartotecnica Dipl. Ing. Lukas Pescoller Traduzione a cura di Andrea De Rossi Creasy è distribuito in Italia da: www. tecnologiegrafiche.com
La cordonatura e la piegatura degli astucci: criticità nella cartotecnica Dipl. Ing. Lukas Pescoller Traduzione a cura di Andrea De Rossi Creasy è distribuito in Italia da: www. tecnologiegrafiche.com
17/03/2014. Le prove meccaniche distruttive. Tipologie di deformazione. Sistemi di Produzione D. Antonelli, G. Murari C.L.U.T.
 Le prove meccaniche distruttive Le prove meccaniche distruttive Sistemi di Produzione D. Antonelli, G. Murari C.L.U.T. Editrice, 2008 capitolo 3 Tecnologia meccanica S. Kalpakjian, S. R. Schmid Pearson
Le prove meccaniche distruttive Le prove meccaniche distruttive Sistemi di Produzione D. Antonelli, G. Murari C.L.U.T. Editrice, 2008 capitolo 3 Tecnologia meccanica S. Kalpakjian, S. R. Schmid Pearson
Settore Ricerca & Sviluppo
 La Cismondi S.r.l. è stata iscritta nell albo dei laboratori altamente qualificati dal Ministero dell Università e della Ricerca scientifica con Decreto n. 2326. Settore Ricerca & Sviluppo DATI del COMMITTENTE
La Cismondi S.r.l. è stata iscritta nell albo dei laboratori altamente qualificati dal Ministero dell Università e della Ricerca scientifica con Decreto n. 2326. Settore Ricerca & Sviluppo DATI del COMMITTENTE
DEBEM MB POMPE CENTRIFUGHE ORIZZONTALI.
 MB POMPE CENTRIFUGHE ORIZZONTALI Le pompe centrifughe orizzontali in resina fabbricate da Debem sono pompe ad alto rendimento azionate da motore elettrico in presa diretta (max 3 giri/min) per il trasferimento
MB POMPE CENTRIFUGHE ORIZZONTALI Le pompe centrifughe orizzontali in resina fabbricate da Debem sono pompe ad alto rendimento azionate da motore elettrico in presa diretta (max 3 giri/min) per il trasferimento
FRESATURA. fresatura. La geometria delle frese varia secondo il loro campo di applicazione. Frese a diamante
 FRESATURA Il materiale utilizzato per la costruzione delle frese è formato da una miscela di tungsteno 92-94% e cobalto 6-8% polverizzato in grana ultrafine e pressato. La percentuale di cobalto detrmina
FRESATURA Il materiale utilizzato per la costruzione delle frese è formato da una miscela di tungsteno 92-94% e cobalto 6-8% polverizzato in grana ultrafine e pressato. La percentuale di cobalto detrmina
L Unità didattica in breve
 L Unità didattica in breve Una macchina semplice è un dispositivo utilizzato per equilibrare o vincere una forza resistente (resistenza) mediante una forza motrice (po tenza) avente caratteristiche diverse.
L Unità didattica in breve Una macchina semplice è un dispositivo utilizzato per equilibrare o vincere una forza resistente (resistenza) mediante una forza motrice (po tenza) avente caratteristiche diverse.
Unità didattica 3. Terza unità didattica (Fisica) 1. Corso integrato di Matematica e Fisica per il Corso di Farmacia
 Unità didattica 3 Elasticità dei materiali Deformazione di un solido..2 Legge di Hooke.. 3 Forza elastica.. 4 Deformazione elastica di una molla... 5 Accumulo di energia attraverso la deformazione elastica..6
Unità didattica 3 Elasticità dei materiali Deformazione di un solido..2 Legge di Hooke.. 3 Forza elastica.. 4 Deformazione elastica di una molla... 5 Accumulo di energia attraverso la deformazione elastica..6
CARATTERISTICHE TECNICHE
 11 AQUAFIRE Lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato. Anisotropo. Utilizzo Civile ed industriale. Caratteristiche Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato,
11 AQUAFIRE Lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato. Anisotropo. Utilizzo Civile ed industriale. Caratteristiche Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato,
PROGETTO DI RICERCA SPERIMENTALE RELATIVA ALL IMPIEGO DEL GASBETON IN ZONA SISMICA
 PROGETTO DI RICERCA SPERIMENTALE RELATIVA ALL IMPIEGO DEL GASBETON IN ZONA SISMICA PREMESSA L Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 regolamenta in modo organico
PROGETTO DI RICERCA SPERIMENTALE RELATIVA ALL IMPIEGO DEL GASBETON IN ZONA SISMICA PREMESSA L Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 regolamenta in modo organico
Utensili rullatori. Tecnologia della rullatura. Vantaggi della rullatura DREX -TOOLS UTENSILI RULLATORI
 Utensili rullatori La DREX -TOOLS vanta sin dal 1980 una solida esperienza nel settore della rullatura. L azienda, con il supporto di personale tecnico di vasta esperienza, ha creato una nuova linea di
Utensili rullatori La DREX -TOOLS vanta sin dal 1980 una solida esperienza nel settore della rullatura. L azienda, con il supporto di personale tecnico di vasta esperienza, ha creato una nuova linea di
Università del Salento Facoltà di Ingegneria Costruzione di Macchine
 Università del Salento Facoltà di Ingegneria Costruzione di Macchine Lezione 3 Prova di trazione a cura del prof. ing. Vito Dattoma e dell ing. Riccardo Nobile 1 Prove di caratterizzazione meccanica Prova
Università del Salento Facoltà di Ingegneria Costruzione di Macchine Lezione 3 Prova di trazione a cura del prof. ing. Vito Dattoma e dell ing. Riccardo Nobile 1 Prove di caratterizzazione meccanica Prova
Umidificazione (2) Raffreddamento con evaporazione
 Umidificazione (2) Raffreddamento con evaporazione Termodinamica dell Aria Umida - 27 Nel secondo caso, parte dell acqua spruzzata nella corrente evapora, sottraendo all aria calore sensibile ed abbassandone
Umidificazione (2) Raffreddamento con evaporazione Termodinamica dell Aria Umida - 27 Nel secondo caso, parte dell acqua spruzzata nella corrente evapora, sottraendo all aria calore sensibile ed abbassandone
Capitolo Descrizione tecnica del sensore MAF a filo caldo
 Capitolo 2 2.1 Descrizione tecnica del sensore MAF a filo caldo Come anticipato nel paragrafo 1.3.3, verrà ora analizzato in maniera più approfondita il principio di funzionamento del sensore MAF, con
Capitolo 2 2.1 Descrizione tecnica del sensore MAF a filo caldo Come anticipato nel paragrafo 1.3.3, verrà ora analizzato in maniera più approfondita il principio di funzionamento del sensore MAF, con
Turbomacchine Impiegate in Aeronautica
 Lezione 11 1 Turbomacchine Impiegate in Aeronautica Ci si occuperà ora in maggior dettaglio delle turbomacchine più diffuse nel campo aeronautico. Esse sono: Tra i compressori Compressore radiale centrifugo
Lezione 11 1 Turbomacchine Impiegate in Aeronautica Ci si occuperà ora in maggior dettaglio delle turbomacchine più diffuse nel campo aeronautico. Esse sono: Tra i compressori Compressore radiale centrifugo
Tecnologie dei vetri e dei
 Tecnologie dei vetri e dei polimeri organici PROPRIETA DEI VETRI Per i processi di formatura è importante conoscere il comportamento viscositàtemperatura del vetro. La lavorabilità del vetro dipende dalla
Tecnologie dei vetri e dei polimeri organici PROPRIETA DEI VETRI Per i processi di formatura è importante conoscere il comportamento viscositàtemperatura del vetro. La lavorabilità del vetro dipende dalla
Passaggi di stato. P = costante
 Passaggi di stato P costante Diagramma isobaro di riscaldamento, relativo ai passaggi di stato Solido Liquido vapore. Si noti che la diversa lunghezza dei tratti FG e EV vuol mettere in evidenza, qualitativamente,
Passaggi di stato P costante Diagramma isobaro di riscaldamento, relativo ai passaggi di stato Solido Liquido vapore. Si noti che la diversa lunghezza dei tratti FG e EV vuol mettere in evidenza, qualitativamente,
Esercitazione sullo schema IS-LM 1
 Esercitazione sullo schema IS-LM 1 Esercizio 1. Sia dato il sistema economico caratterizzato dalle seguenti equazioni che definiscono il mercato dei beni e della moneta: C = C 0 cyd = 290 + 0,8Yd I = I
Esercitazione sullo schema IS-LM 1 Esercizio 1. Sia dato il sistema economico caratterizzato dalle seguenti equazioni che definiscono il mercato dei beni e della moneta: C = C 0 cyd = 290 + 0,8Yd I = I
Lezione Il calcestruzzo armato I
 Lezione Il calcestruzzo armato I Sommario Il calcestruzzo armato Il comportamento a compressione Il comportamento a trazione Il calcestruzzo armato Il cemento armato Il calcestruzzo armato Il calcestruzzo
Lezione Il calcestruzzo armato I Sommario Il calcestruzzo armato Il comportamento a compressione Il comportamento a trazione Il calcestruzzo armato Il cemento armato Il calcestruzzo armato Il calcestruzzo
Transistore bipolare a giunzione (BJT)
 ransistore bipolare a giunzione (J) Parte 1 www.die.ing.unibo.it/pers/mastri/didattica.htm (versione del 22-5-2012) ransistore bipolare a giunzione (J) l transistore bipolare a giunzione è un dispositivo
ransistore bipolare a giunzione (J) Parte 1 www.die.ing.unibo.it/pers/mastri/didattica.htm (versione del 22-5-2012) ransistore bipolare a giunzione (J) l transistore bipolare a giunzione è un dispositivo
Lame d aria ionizzanti con soffiatore Typhoon
 INDICE 1 Lame d aria ionizzanti con soffiatore Typhoon Indice 1 Lame d aria ionizzanti con soffiatore Typhoon 2 1.1 Principale....................................... 2 1.2 Benefici........................................
INDICE 1 Lame d aria ionizzanti con soffiatore Typhoon Indice 1 Lame d aria ionizzanti con soffiatore Typhoon 2 1.1 Principale....................................... 2 1.2 Benefici........................................
Economia del Lavoro 2010
 Economia del Lavoro 2010 Capitolo 3 La domanda di lavoro - La decisione di occupazione nel breve periodo 1 La domanda di lavoro La decisione di occupazione di b.p. Breve periodo è un tempo sufficientemente
Economia del Lavoro 2010 Capitolo 3 La domanda di lavoro - La decisione di occupazione nel breve periodo 1 La domanda di lavoro La decisione di occupazione di b.p. Breve periodo è un tempo sufficientemente
Prima classificazione fondazioni
 Prima classificazione fondazioni Una struttura trasferisce al terreno attraverso le fondazioni il proprio peso, il peso di ciò che contiene oltre a tutte le forze verticali e laterali che agiscono su di
Prima classificazione fondazioni Una struttura trasferisce al terreno attraverso le fondazioni il proprio peso, il peso di ciò che contiene oltre a tutte le forze verticali e laterali che agiscono su di
SCHEDA PER IL DOCENTE DESCRIZIONE DELL ITINERARIO DI LABORATORIO
 SCHEDA PER IL DOCENTE DESCRIZIONE DELL ITINERARIO DI LABORATORIO I Titolo della scheda Un itinerario di Laboratorio: LA DENSITÀ Esperienze di laboratorio per la misura della densità di una sostanza solida
SCHEDA PER IL DOCENTE DESCRIZIONE DELL ITINERARIO DI LABORATORIO I Titolo della scheda Un itinerario di Laboratorio: LA DENSITÀ Esperienze di laboratorio per la misura della densità di una sostanza solida
Make your own pellet!
 MACCHINA PELLETTIZZATRICE Make your own pellet! N-MICRO vuol dire Easy Pellet. N-MICRO è stata appositamente progettata e sviluppata per la piccola e domestica produzione di pellet, tale da permettere
MACCHINA PELLETTIZZATRICE Make your own pellet! N-MICRO vuol dire Easy Pellet. N-MICRO è stata appositamente progettata e sviluppata per la piccola e domestica produzione di pellet, tale da permettere
Progettazione e realizzazione di un albero per un gruppo di sovralimentazione per uso aeronautico
 Progettazione e realizzazione di un albero per un gruppo di sovralimentazione per uso aeronautico Questo lavoro si inserisce nel progetto di un sistema di sovralimentazione ad altissimo rapporto di compressione
Progettazione e realizzazione di un albero per un gruppo di sovralimentazione per uso aeronautico Questo lavoro si inserisce nel progetto di un sistema di sovralimentazione ad altissimo rapporto di compressione
Principi di Estensimetria. parte 1
 Principi di Estensimetria parte 1 Generalità Un estensimetro elettrico è un dispositivo che misura una variazione di lunghezza traducendola in una deformazione. Tale misura avviene attraverso una misura
Principi di Estensimetria parte 1 Generalità Un estensimetro elettrico è un dispositivo che misura una variazione di lunghezza traducendola in una deformazione. Tale misura avviene attraverso una misura
