DIFFERENZA DI CAPTAZIONE TRA DUE SELETTORI PER POLVERI DI LEGNO: PRIMI RISULTATI
|
|
|
- Bianca Rostagno
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Vol. 4, n. 3, DIFFERENZA DI CAPTAZIONE TRA DUE SELETTORI PER POLVERI DI LEGNO: PRIMI RISULTATI Antonella Campopiano*, Angelo Olori*, Fulvio Basili*, Deborah Ramires*, Aneta Maria Zakrzewska** * Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), Dipartimento Igiene del Lavoro, Laboratorio Polveri e Fibre, Monte Porzio Catone (Roma) ** Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) Centro Ricerche Lamezia Terme, Laboratorio Polveri e Fibre, Lamezia Terme (CZ) (Parole chiave: polvere di legno, caratterizzazione dimensionale, frazione inalabile, IOM, microscopia elettronica) SINTESI CONTESTO - La classificazione di cancerogenicità delle polveri di legno per l'uomo da parte dell Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ed il valore limite di soglia ponderato sul periodo di otto ore lavorative pari a 5 mg/m 3 stabilito dalla normativa nazionale ha posto il problema di valutare il rischio polveri in tutti quegli ambienti dove viene lavorato il legno. OBIETTIVI - L obiettivo è quello di caratterizzare dimensionalmente le particelle di legno captate da due selettori utilizzati per il prelievo della frazione inalabile: lo IOM (Institute Occupational Medicine, Edimburgo, Scozia) ed il selettore a geometria conica conosciuto in Italia con il nome di conetto. La scelta delle due teste di campionamento, sopra citate, è stata dettata principalmente dal fatto che il selettore conico italiano, utilizzato in passato per il campionamento delle polveri totali, è il più diffuso presso i Servizi di Prevenzione e presso i laboratori di analisi in genere, mentre lo IOM è stato ideato appositamente per la captazione della frazione inalabile. METODI - I due dispositivi sono stati posizionati contemporaneamente nella zona respiratoria di uno stesso lavoratore. Inoltre è stato collocato, sempre sullo stesso lavoratore, un altro selettore IOM, non collegato alla pompa personale, con la funzione di campionatore passivo ed in grado di captare le particelle proiettile che vengono generate durante le lavorazioni. Per il conteggio del particolato raccolto sui filtri di campionamento è stato utilizzato un microscopio elettronico a scansione (SEM) completo di spettrometria a dispersione di energia BOW PO/base indexing: CIS: Legno e prodotti del legno [CIS: Few]; Macchine per la lavorazione del legno [CIS: Hpo]; Industria del legno [CIS: Xeh]; Metodi di campionamento [CIS: Qea] EUOSHA OSH: Polvere di legno [33721E]; Macchinario per la lavorazione del legno [OSH: 45321C]; Raccolta di campioni [OSH: 13281E]; Rischi derivanti da impianti, macchinari e attrezzature di lavoro [OSH: 41681B] ATECO: Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio [ATECO: 20] 47
2 dei raggi X (EDAX, INCA ENERGY 400, Oxford Instruments, Abington, UK). Ogni particella individuata con il SEM è stata caratterizzata dimensionalmente misurandone il diametro medio. RISULTATI - Dall analisi al SEM si è potuto constatare che la dimensione media delle particelle più grandi captate dal conetto non ha superato i 1 µm mentre quella delle particelle captate dallo IOM ha raggiunto i 3 µm. L osservazione dei filtri inseriti negli IOM passivi ha evidenziato che effettivamente si depositano particelle con diametri medi molto maggiori di 0 µm anche se la percentuale calcolata è risultata molto bassa (mediamente intorno all 1%). Questo non significa che il loro contributo gravimetrico sia trascurabile: infatti il peso delle particelle con diametro maggiore di 0 µm presenti sui filtri passivi è del 95% rispetto al totale. INTRODUZIONE Nel 1987 l Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato come cancerogene per l uomo o possibili cancerogene le seguenti lavorazioni riguardanti le polveri di legno: la fabbricazione di mobili e le lavorazioni da ebanista, gruppo 1 (cancerogeni per l uomo); le lavorazioni di falegnameria e carpenteria, gruppo 2 B (possibili cancerogeni per l uomo). L industria del legname e delle segherie è stata classificata come gruppo 3 (non classificabili in relazione alla cancerogenicità per l uomo). Nel 1995 la stessa IARC, in base all'osservazione di un marcato incremento dell incidenza delle neoplasie a livello delle fosse nasali e dei seni paranasali tra i lavoratori esposti prevalentemente a polveri di legno duro, ha valutato sufficiente l'evidenza di cancerogenicità delle polveri di legno per l'uomo e quindi le ha inserite nel gruppo 1 [1]. Nel 1999 l Unione europea ha stabilito un valore limite di esposizione a polveri di legno duro pari a 5 mg/m 3 ponderato sul periodo di otto ore lavorative da adottare in presenza di qualsiasi miscela di polveri di legno contenenti legni duri. A tale limite si sono conformati gli Stati membri dell Unione europea e l Italia ha recepito la Direttiva europea 1999/38/CE del 29 aprile 1999 con il D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66 specificando che la valutazione di conformità a 5 mg/m 3 deve essere effettuata tramite il campionamento personale della frazione inalabile [2]. La Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi (ACGIH) [3] indicava negli anni passati il limite di 5 mg/m 3 per le polveri di legno tenero e di 1 mg/m 3 per le polveri di legno duro classificando quest ultimo in categoria A1 (cancerogeno riconosciuto per l uomo). Attualmente l ACGIH [4] non distingue più le polveri di legno tenero da quelle di legno duro, ma considera solo le specie non allergeniche stabilendo il limite di esposizione pari ad 1 mg/m 3 con la sola eccezione del cedro rosso considerato tra i legni più pericolosi per la salute dell uomo e per il quale viene proposto il limite di 0,5 mg/m 3. Molti Stati membri dell Unione europea non fanno distinzione tra legno duro e tenero fornendo un valore limite riferito alla sola frazione inalabile. È importante infine rammentare che il Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) della Commissione europea ha effettuato una revisione della letteratura scientifica disponibile con lo scopo di stabilire un limite di esposizione a polveri di legno basato sugli effetti sulla salute. Le raccomandazioni dello SCOEL pubblicate nel 2002 e nel 2003 forniscono una valutazione quantitativa del rischio ed indicano chiaramente che esposizioni professionali a polveri di legno superiori a 0,5 mg/m 3 inducono effetti polmonari e andrebbero pertanto evitate [5, 6]. È necessario precisare che il valore dello SCOEL, proveniente da un elaborazione delle esposizioni esistenti nel passato, è riferito alle polveri totali poiché solo recentemente si è 48
3 introdotto il concetto di inalabilità. Il fattore di correlazione per convertire l esposizione a polvere totale in inalabile varia tra 2 e 3. Il limite di 0,5 mg/m 3 è pari quindi al limite di esposizione occupazionale di 1-1,5 mg/m 3 [6], valore che non si discosta molto da quello stabilito dall ACGIH. La frazione inalabile a cui fa riferimento la Direttiva europea 1999/38/CE è stata definita dalla norma UNI-EN 481/1994 come la frazione in massa delle particelle aerodisperse totali che viene inalata attraverso il naso e la bocca (particelle aventi per il % un taglio dimensionale di 0 µm) [7]. Quindi per la loro captazione è necessario utilizzare quei selettori che soddisfano le richieste della norma UNI EN 481. In letteratura numerosi studi [8-17] sull efficienza del campionamento hanno dimostrato che la maggior parte dei selettori hanno difficoltà ad incontrare la curva definita dalla convenzione ACGIH-ISO-CEN per il campionamento della frazione inalabile quando la velocità del vento è elevata, come negli ambienti esterni, o quando sono prodotte particelle proiettile in particolari operazioni lavorative, come accade per le polveri di legno; queste situazioni possono portare rispettivamente a sottostimare o a sovrastimare la frazione inalabile. Uno studio europeo [18] ha sperimentato una serie di selettori che venivano impiegati per il campionamento della frazione inalabile tra cui l Istitute Occupational Medicine (IOM), sviluppato dall Istituto di Medicina del Lavoro di Edimburgo, il selettore a geometria conica CIS (Conical Inhalable Sampler) ed il seven-hole, sviluppato anch esso dall Istituto di Medicina del Lavoro di Edimburgo. Sono stati studiati i diversi selettori in un tunnel del vento a velocità del vento che variava da 0,5 m/s a 4 m/s e per particelle aventi dimensioni da 6 µm a 0 µm. I risultati hanno mostrato che l efficienza dei selettori era influenzata fortemente dalla velocità del vento [19] e poiché questa negli ambienti indoor è mediamente intorno a 0,1 m/s [20], le prestazioni dei selettori sono state valutate a velocità del vento molto basse. Lo IOM risulta essere il più adatto per prelevare la polvere inalabile sia in ambienti esterni, dove le velocità del vento sono alte [18, 19], che in ambienti indoor [20]. L Agenzia per la Salute e la Sicurezza del Regno Unito (HSE) nei metodi per la determinazione delle sostanze pericolose consiglia come selettore per la frazione inalabile lo IOM, il CIS ed il seven hole [21]. Essi operano aspirando le particelle aerodisperse attraverso un orifizio posto nella loro parte frontale, che poi vengono depositate sul filtro inserito all interno del selettore. La principale distinzione fisica è dovuta alle dimensioni ed alla configurazione dell orifizio. In Italia si è utilizzato per lungo tempo un selettore conosciuto con il nome di conetto, avente una geometria conica leggermente diversa da quella del CIS, vista la sua ampia disponibilità presso tutti i servizi di prevenzione. Il diametro dell apertura del selettore CIS è pari a 8 mm mentre quello del conetto è di 7,8 mm; entrambi lavorano ad un flusso di 3,5 L/min. Il selettore IOM è costituito da un corpo di campionamento e da un sistema a cassetta. Il dispositivo a cassetta consente di trattenere le particelle non solo sul filtro ma anche sulle pareti del dispositivo stesso, simulando la funzionalità del setto nasale. Per la quantificazione del peso delle particelle raccolte, il dispositivo a cassetta con il filtro assemblato deve essere pesato prima e dopo il prelievo. La geometria d ingresso dell aria aspirata ha un diametro di 15 mm ed il flusso di utilizzo è pari a 2 L/min. I risultati di alcune indagini ambientali effettuate in aziende artigiane dove si lavora il legno, hanno evidenziato che il selettore IOM e quello a geometria conica presentano delle differenze nella quantità di polvere raccolta. Tale differenza sembra essere compensata dalla polvere depositata sul filtro posto in un selettore IOM passivo [22]. La definizione di legno duro, riportata nella monografia IARC Wood dust and formaldehyde [1], è dovuta alla classificazione botanica che opera la distinzione in due grandi classi: quella delle Angiosperme, in cui sono compresi gli alberi che perdono le foglie in inverno (latifoglie) e quella delle Gimnosperme, in cui sono compresi gli alberi sempreverdi (conifere). Differenza di captazione tra due selettori per polveri di legno: primi risultati 49
4 Il legno duro è ottenuto dalle Angiosperme, mentre il legno dolce è ottenuto dalle Gimnosperme. I legni duri sono solitamente più densi a causa delle caratteristiche anatomico-strutturali di maggiore complessità, ma ciò non è sempre vero e la densità può variare notevolmente anche all interno di una stessa categoria. Ad esempio il legno douglas, nonostante sia classificato come legno dolce, ha caratteristiche di durezza superiori a quelle del legno di betulla che è un legno duro, oppure il legno di balsa (uno dei più leggeri) è botanicamente classificato come legno duro. Le lavorazioni su legno duro comportano la formazione di percentuali più elevate di polveri fini rispetto a quelle effettuate su legno dolce, a causa delle caratteristiche anatomiche di questi legni, in cui il taglio determina una maggiore frantumazione cellulare per la presenza di diversi tipi di cellule tra di loro saldamente collegate. La lavorazione del legno prevede l utilizzo di numerose sostanze, che possono avere un impatto sulla salute degli esposti; basti pensare ai diluenti, alle vernici, alle lacche ed alle colle usate nella lavorazione di manufatti in legno che emettono formaldeide, benzene, isocianati ecc. Ad esempio la formaldeide, usata nella produzione di truciolati e compensati, può liberarsi come tale o essere assorbita su particelle di legno che ne favoriscono trasporto ed azione sull apparato respiratorio (cancro polmonare). In questo lavoro viene riportata una caratterizzazione dimensionale delle particelle di legno captate dal selettore IOM passivo per verificare la presenza o meno di particelle con dimensioni maggiori di 0 µm. 1. MATERIALI E METODI Sono stati effettuati alcuni campionamenti personali su lavoratori che operano nel settore del legno. Ciascun lavoratore ha indossato tre selettori: uno IOM collegato ad un campionatore personale (modello Airchek 2000, SKC Inc., Eighty Four, PA, USA) con flusso di aspirazione pari a 2 L/min; un secondo IOM, non collegato alla pompa personale, con la funzione di campionatore passivo in grado di captare le particelle proiettile generate durante le lavorazioni; un conetto in acciaio inox da 25 mm di diametro, avente un apertura di 7,8 mm, collegato ad una pompa personale (modello 224 PCXR8, SKC Inc., Eighty Four, PA, USA) per garantire un flusso di aspirazione più elevato pari a 3,5 L/min. Le linee di campionamento sono state precedentemente calibrate con l ausilio di un calibratore primario (modello DryCal DC-Lite, BIOS International Corporation, Butler, NJ, USA). I prelievi sono stati realizzati utilizzando filtri in polivinilcloruro (PVC), così come descritto nel metodo NIOSH [23] con un diametro pari a 25 mm e porosità 5 µm. La quantità di polvere raccolta sulle membrane è stata determinata mediante una doppia pesata con bilancia Sartorius MC1 (portata: 2 g; unità di formato u f : 0,01 mg) dotata di dispositivo di abbattimento delle cariche elettrostatiche. Prima di ogni pesata i filtri sono stati sempre condizionati mantenendoli nella stanza della bilancia per due ore. Nel caso dello IOM, il sistema a cassetta in cui era stata inserita la membrana è stato pesato prima e dopo il campionamento. In base alla quantità di polvere depositata sul filtro, sono state scelte cinque membrane provenienti dai campionamenti passivi: A3, B3, C3, I3, M3 ed una terna proveniente dal campionamento effettuato su un singolo operatore: IOM, conetto e IOM passivo. I filtri selezionati sono stati preparati per l osservazione al microscopio elettronico a scansione (SEM, modello LEO 440, LEO Electron Microscopy Ltd, Cambridge, UK) completo di
5 spettrometria a dispersione di energia dei raggi X (EDAX, INCA ENERGY 400, Oxford Instruments, Abington, UK). Su ogni filtro è stato misurato il diametro verticale ed orizzontale di trecento particelle ed è stato applicato il test di normalità alle distribuzioni dei diametri ottenute. 2. RISULTATI Le particelle raccolte sui filtri di campionamento presentano una forma allungata e disomogenea. Alcuni esempi di immagini al SEM di tali particelle sono mostrati in Figura 1, 2 e 3 per i filtri di captazione rispettivamente dello IOM passivo, dello IOM e del conetto relativi ad uno stesso campionamento. In alcuni casi, sui filtri passivi, la misura del diametro maggiore raggiunge dimensioni pari a 700 µm. Per ogni particella è stato calcolato il diametro medio ottenuto dalle due lunghezze misurate. Alcuni dei principali parametri statistici delle distribuzioni dei diametri delle particelle raccolte dagli IOM passivi sono presentati in Tabella 1; quelli relativi alla terna di campionamento posizionata su uno stesso operatore sono riportati in Tabella 2. Figura 1 - Immagine SEM di particelle depositate sulla membrana in PVC inserita nello IOM passivo Differenza La ricerca sulla di captazione salute e sicurezza tra due selettori del lavoro: per ilpolveri contesto di legno: europeo primi e i finanziamenti risultati 51
6 Figura 2 - Immagine SEM di una particella di legno depositata su membrana in PVC dello IOM Figura 3 - Immagine SEM di una particella di forma allungata captata dal selettore conetto 52
7 Tabella 1 - Parametri statistici delle distribuzioni dei diametri delle particelle depositate sui filtri IOM passivi Parametri statistici A3 B3 C3 I3 M3 media aritmetica (µm) 13,0 11,6 14,8 8,3 8,2 mediana (µm) 7,3 2,9 9,3 5,4 4,2 media geometrica (µm) 7,2 3,8 8,3 5,9 4,8 deviazione aritmetica standard (µm) 18,7 32,0 24,5 8,4 13,2 deviazione geometrica standard (µm) 2,9 3,6 2,8 2,2 2,6 coefficiente di variazione 1,4 2,7 1,6 1,0 1,6 valore minimo (µm) 0,9 0,4 0,9 1,2 0,8 valore massimo (µm) 191,5 3,0 283,5 57,5 143,8 Tabella 2 - Parametri statistici delle distribuzioni dei diametri delle particelle raccolte dalla terna di campionamento: IOM, conetto e IOM passivo Parametri statistici IOM conetto IOM passivo media aritmetica (µm) 6,5 3,7 11,6 mediana (µm) 2,2 1,7 2,9 media geometrica (µm) 2,2 1,9 3,8 deviazione aritmetica standard (µm) 22,8,7 32,0 deviazione geometrica standard (µm) 3,8 2,8 3,6 valore minimo (µm) 0,2 0,2 0,4 valore massimo (µm) 300,6 146,7 3,0 coefficiente di variazione 3,5 2,9 2,7 asimmetria,0,9 7,1 curtosi 111,7 133,1 62,3 asimmetria (distribuzione ln d) 0,3 0,5 0,9 curtosi (distribuzione ln d) 0,3 0,8 0,6 La percentuale di particelle aventi un diametro maggiore di 0 µm è molto bassa, pari mediamente all 1% e raggiunge il 3% solo su un filtro proveniente dal campionamento effettuato su un operatore durante il taglio, tramite seghe doppie, di grossi pezzi di legname. Le operazioni di piallatura e di rettificatura (filtri I3 e M3) generano mediamente dimensioni più piccole rispetto a quelle generate dall operazione di segagione (filtri A3, B3 e C3). Nella Tabella 2 sono mostrati i valori corrispondenti all asimmetria ed alla curtosi delle distribuzioni dei diametri delle particelle e dei loro logaritmi naturali. I due parametri, fornendo informazioni sulla simmetria della curva rispetto alla media e sulla forma delle code, permettono di effettuare una prima valutazione su quanto la distribuzione dei dati sia prossima o meno ad una gaussiana. Per una distribuzione normale, i valori di asimmetria e di curtosi hanno valore nullo. Differenza di captazione tra due selettori per polveri di legno: primi risultati 53
8 Le distribuzioni dimensionali delle particelle presenti sui filtri passivi sono riportate nella Figura 4. Figura 4 - Distribuzione dimensionale delle particelle depositate negli IOM passivi Fn (%) A3 B3 C3 I3 M3 0 5,0,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0,0 d medio (µm) Note: Le distribuzioni sono riportate fino alla classe dimensionale di µm per poter meglio discriminare ogni singola classe. La Figura 4 mostra le cinque distribuzioni fino alla classe dimensionale di µm per poter meglio discriminare ogni singola classe. La Figura 5 mostra invece le distribuzioni dimensionali delle particelle captate dalla terna di campionamento selezionata. Tali distribuzioni sono riportate fino ad un diametro medio pari a 15 µm per poter meglio discriminare ogni singola classe, mentre le code della distribuzione sono riportate nella Figura 6. Figura 5 - Distribuzione dimensionale delle particelle fino ad un diametro medio di 15 µm captate dalla terna di campionamento IOM, conetto e IOM passivo Fn (%) IOM conetto passivo 2 0 0,5 2,0 3,5 5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0 d medio (µm) 54
9 Figura 6 - Distribuzione dimensionale delle particelle aventi diametro medio oltre 15 µm captate dalla terna di campionamento IOM, conetto e IOM passivo 4 Fn (%) d medio (µm) È stato applicato alle distribuzioni dei logaritmi dei diametri medi relativi a tutti i filtri osservati al SEM il test di normalità di Kolmogorov-Smirnov che ha fornito i valori della distanza tra la distribuzione sotto analisi e quella ideale con la relativa significatività p. Tali valori sono riportati nella Tabella 3. Tabella 3 - Risultati del test di normalità di Kolmogorov-Smirnov applicato ai filtri passivi Filtri IOM passivi Distanza K-S p Superamento test A3 0,061 0,009 negativo B3 0,119 < 0,001 negativo C3 0,068 0,002 negativo I3 0,049 0,077 al limite M3 0,090 < 0,001 negativo Per tutti i filtri passivi, il test ha evidenziato differenze significative dalla distribuzione gaussiana; ciò mostra che le distribuzioni delle particelle depositate su questi filtri non possono essere descritte da distribuzioni lognormali. Nel caso dei due filtri di campionamento, come riportato nella Tabella 4, si verifica che le particelle catturate durante l aspirazione mostrano una distribuzione lognormale, infatti il test di Kolmogorov-Smirnov risulta essere positivo per il filtro proveniente dallo IOM ed al limite di accettabilità per quello proveniente dal conetto. Differenza di captazione tra due selettori per polveri di legno: primi risultati 55
10 Tabella 4 - Risultati del test di normalità di Kolmogorov-Smirnov applicato ai filtri di campionamento Filtri di campionamento Distanza K-S p Superamento test IOM 0,034 > 0,200 positivo conetto 0,052 0,076 al limite I relativi grafici di normalità (Figure 7-13) visualizzano in maniera chiara lo scostamento delle distribuzioni dei diametri medi delle particelle da un andamento gaussiano. Dalla letteratura si evidenzia che le code delle distribuzioni hanno un peso importante ed influiscono in maniera determinante sui valori di tali parametri statistici. Figura 7 - Grafico di normalità del campione A3 99 Frequenza cumulata vvalore residuo 56
11 Figura 8 - Grafico di normalità del campione B3 99,9 99 Frequenza cumulata vvalore residuo Figura 9 - Grafico di normalità del campione C3 99,9 99 Frequenza cumulata Differenza di captazione tra due selettori per polveri di legno: primi risultati Valore residuo 57
12 Figura - Grafico di normalità del campione I Frequenza cumulata Valore residuo Figura 11 - Grafico di normalità del campione passivo M3 99,9 Frequenza cumulata Valore residuo 58
13 Figura 12 - Grafico di normalità del campione IOM 99,9 99 Frequenza cumulata Valore residuo Figura 13 - Grafico di normalità del campione conetto 99,99 99,9 99 Frequenza cumulata Differenza di captazione tra due selettori per polveri di legno: primi risultati Valore residuo 59
14 3. CONCLUSIONI È stato discusso in un precedente studio [22] che i valori di concentrazione delle polveri ottenuti utilizzando il selettore IOM sono risultati sempre maggiori di quelli ottenuti con l impiego del selettore conetto. Le diversità di captazione da parte dei due selettori vengono attribuite alle differenze presenti nella geometria d ingresso dello IOM rispetto a quella del conetto [22, 24]. Le maggiori dimensioni dell apertura d ingresso dello IOM consentirebbero la captazione delle particelle di grandi dimensioni proiettate durante le lavorazioni del legno. È stato osservato, infatti, che lo IOM (passivo) collocato nella zona respiratoria del lavoratore, pur non essendo collegato alla pompa di aspirazione, era comunque in grado di catturare delle particelle. Sottraendo tale contributo alla quantità prelevata dallo IOM (attivo) collegato alla pompa di aspirazione, si otteneva un valore di concentrazione che si avvicinava a quello ottenuto utilizzando il conetto. In Italia sono stati usati in passato e sono usati ancora oggi selettori con ingresso conico (conetto) con diametri dell orifizio d ingresso variabili tra 6 mm e mm. Tali selettori operano ad un flusso tale da avere una velocità d ingresso della polvere di circa 1,25 m/s; quello utilizzato per i nostri scopi funziona ad un flusso pari a 3,5 L/min. Le prove per valutare le prestazioni dei selettori inalabili rispetto alla convenzione ACGIH-ISO-CEN di riferimento hanno mostrato risultati non troppo soddisfacenti e nel caso del prelievo delle polveri di legno, il problema principale riguarda proprio l efficienza di campionamento nei riguardi delle particelle con diametro aerodinamico maggiore di 0 µm. I dati sperimentali su cui sono basate le nuove convenzioni si riferiscono infatti a particelle con diametro aerodinamico minore di 0 µm. Negli ambienti lavorativi del settore del legno sono presenti diverse macchine in grado di generare e proiettare particelle grossolane e frammenti, che possono raggiungere la zona in cui è posizionato il campionatore. Dall analisi al SEM si è potuto constatare che la dimensione media geometrica delle particelle più grandi captate dal conetto non superava i 1 µm, mentre quella delle particelle captate dallo IOM raggiungeva i 3 µm, che in termini di diametro aerodinamico significa rispettivamente una dimensione media che supera i 0 µm ed i 300 µm, presupponendo per entrambi una densità della particella di legno pari a 0,75 g/cm 3. L osservazione dei filtri inseriti negli IOM passivi ha evidenziato che effettivamente si depositano particelle con diametri medi molto maggiori di 0 µm anche se la percentuale calcolata è risultata molto bassa (mediamente intorno all 1%). Questo non significa che il loro contributo gravimetrico sia trascurabile: infatti il peso delle particelle con diametro maggiore di 0 µm presenti sui filtri passivi è del 95% rispetto al totale. Nel caso dello IOM, i risultati fin qui riportati sono sottostimati poiché sono state conteggiate solo le particelle raccolte sul filtro di campionamento, trascurando il contributo della frazione di particelle depositata all interno della cassetta di prelievo. Quest ultima informazione sarà oggetto di ulteriori indagini. Da questo studio emerge la maggiore tendenza a raccogliere particelle ultralarghe del campionatore IOM rispetto alle cassette a faccia chiusa; sarebbe utile verificare la possibilità di ricavare fattori di conversione medi tra i due selettori, da applicare successivamente alle misure provenienti dai campionamenti personali. L ingresso di particelle ultralarghe, comunque, può essere minimizzata riducendo le dimensioni dell orifizio d ingresso. È noto, inoltre, in letteratura, che le particelle e le fibre aerodisperse possono essere descritte in maniera soddisfacente da distribuzioni logaritmiche [25, 26] e che le code delle distribuzioni influiscono in maniera determinante sui valori dei parametri statistici. Spesso si ricorre ad elaborazioni statistiche più specifiche per evitare distorsioni nella valutazione dei dati e per correlare meglio le distribuzioni teoriche [27]. In questo lavoro si è osservato che le 60
15 particelle proiettili (quelle particelle generate casualmente durante particolari lavorazioni) non seguono una distribuzione lognormale. Ciò è dovuto al fatto che la loro deposizione su filtro non avviene in seguito ad una aspirazione omogenea dell aria, ma ad un deposito casuale delle particelle con una forte predominanza di quelle con grandi dimensioni. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 1. International Agency for Research on Cancer (IARC). Wood dust and formaldehyde. Lyon: IARC;1995. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans n Italia. Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 66. Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione da agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 70, 24 marzo American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). TLVs and BEIs Based on Documentation of the threshold limit values for chemical substances and physical agents. Cincinnati (OHIO):ACGIH ; American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). TLVs and BEIs Based on Documentation of the threshold limit values for chemical substances and physical agents. Cincinnati (OHIO): ACGIH; Scientific Committee on Occupational Exposure Limits. SCOEL. Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Wood Dust. SCOEL/SUM/2B Ann Occup Hyg 2006; (6): Scientific Committee on Occupational Exposure Limits. SCOEL. Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits: risk assessment for wood dust. SCOEL/SUM/2 final Ann Occup Hyg 2006; (6): Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI. Atmosfera nell ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse. UNI-EN 481; Aizenberg V, Choe K, Grinshpun SA, Willeke K, Baron PA. Evaluation of personal aerosol samplers challenged with large particles. J Aerosol Sci 2001; 32: Kennedy NJ, Tatyan, Hinds WC. Comparison of a simplified and full-size mannequin for the evaluation of inhalable sampler performance. Aerosol Sci Technol 2001; 35: Kenny LC, Aitken RJ, Baldwin PEJ, Beaumont GC, Maynard AD. The sampling efficiency of personal inhalable aerosol samplers in low air movement environments. J Aerosol Sci. 1999; 30 (5): Predicala BZ, Maghirang RG. Field comparison of inhalable and total dust samplers for assessing airborne dust in swine confinement barns. Appl Occup Environ Hyg 2003; 18: Tatum VL, Ray AE, Rovell-Rixx DC. The performance of personal inhalable dust samplers in wood-products industry facilities. Appl Occup Environ Hyg 2001; 16 (7): Clinkenbeard RE, England EC, Johnson DL, Esmen NA, Hall TA. A field comparison of the IOM inhalable aerosol sampler and a modified 37-mm cassette. Appl Occup Environ Hyg 2002;17 (9): Demange M, Görner P, Elcabache JM, Wrobel R. Field comparison of 37-mm closed-face cassettes and IOM samplers. Appl Occup Environ Hyg 2002; 17 (3): Lidén G, Melin B, Lidblom A, Lindberg K, Norén JO. Personal Sampling in parallel with open-face filter cassettes and IOM samplers for inhalable dust-implications for occupational exposure limits. Appl Occup Environ Hyg 2000; 15 (3): Differenza di captazione tra due selettori per polveri di legno: primi risultati 61
16 16. Mark D, Vincent JH. A new personal sampler for airborne total dust in workplaces. Ann Occup Hyg 1986; 30: Mark D, Vincent JH. A new personal sampler for airborne total dust in workplaces. Ann Occup Hyg 1986; 38: Kenny LC, Aitken RJ, Chalmers C, Fabries JF, Gonzalez-Fernandez E, Kromhout H, Liden G, Mark D, Riediger G, Prodi V. A collaborative European study of personal inhalable aerosol sampler performance. Ann Occup Hyg 1997; 41(2): Baldwin PEJ, Maynard AD. A survey of windspeeds in indoor workplace. Ann Occup Hyg 1998; 42(5): Aitken RJ, Baldwin PEJ, Beaumont GC, Kenny LC, Maynard AD. Aerosol inhalability in very low wind. J Aerosol Sci 1999; 30(5): HSE. General methods for sampling and gravim etric analysis of respirable and inhalable dust: MDHS In: Methods for the determination of hazardous substances. Health and Safety Executive. London Campopiano A, Ramires D, Spagnoli G, Arcaro F, Bosco MG, Pandolfi P, Fioravanti F. Primi risultati del confronto tra due selettori utilizzati per la captazione di polveri di legno. Giornale degli Igienisti Industriali 2006; 31 (2): National Institute for Occupational Safety and Heakth (NIOSH): NIOSH Manual of Analytical Methods, 4th ed. Cincinnati (OHIO). Particulates Not Otherwise Regulated, Total: Method 00; Marconi A. Campionamento delle frazioni dimensionali di rilevanza sanitaria per le polveri di legno. Giornale degli Igienisti Industriali 2002; 27 (2): Holst E, Schneider T. Fibre size characterization and size analysis using general and bivariate log-normal distributions. J Aerosol Sci 1985; 16: Schneider T, Holst E, Skotte J. Size distributions of airborne fibres generated from manmade mineral fibre products. Ann Occup Hyg 1983; 27: Fogel P, Hanton DY, De Meringo A, Morscheidt C. The reliability of the dimensional measurements of man-made vitreous fibers used for biopersistence assays: a statistical approach. Aerosol Sci Technol 1999; 30:
IL RISCHIO CANCEROGENO
 Indagine nel Comparto del Legno 2017 IL RISCHIO CANCEROGENO Liviano Vianello SPISAL ULSS 16 D.L.gs 81/2008 Allegato XLII ESPOSIZIONE A POLVERE DI LEGNO DURO In linea generale i LEGNI DURI sono rappresentati
Indagine nel Comparto del Legno 2017 IL RISCHIO CANCEROGENO Liviano Vianello SPISAL ULSS 16 D.L.gs 81/2008 Allegato XLII ESPOSIZIONE A POLVERE DI LEGNO DURO In linea generale i LEGNI DURI sono rappresentati
Indicazioni operative per La Misurazione dei fumi e dei gas durante la attività di saldatura
 Indicazioni operative per La Misurazione dei fumi e dei gas durante la attività di saldatura Scheda n 1 Giugno 2010 1 Norme di riferimento: UNI EN 10882-1:2002: Campionamento delle particelle in sospensione
Indicazioni operative per La Misurazione dei fumi e dei gas durante la attività di saldatura Scheda n 1 Giugno 2010 1 Norme di riferimento: UNI EN 10882-1:2002: Campionamento delle particelle in sospensione
Zone a rischio di esplosione e incendio: le falegnamerie
 Dicembre 2016 Zone a rischio di esplosione e incendio: le falegnamerie Le falegnamerie sono impianti di lavorazione del legno, solitamente rappresentati da capannoni industriali, nei quali una serie di
Dicembre 2016 Zone a rischio di esplosione e incendio: le falegnamerie Le falegnamerie sono impianti di lavorazione del legno, solitamente rappresentati da capannoni industriali, nei quali una serie di
Indicazioni operative per La Misurazione della frazione inalabile e dei solventi durante le attività di verniciatura
 Indicazioni operative per La Misurazione della frazione inalabile e dei solventi durante le attività di verniciatura Scheda n 2 Giugno 2010 1 Documentazione di riferimento: Norma UNI EN 689/97: Guida alla
Indicazioni operative per La Misurazione della frazione inalabile e dei solventi durante le attività di verniciatura Scheda n 2 Giugno 2010 1 Documentazione di riferimento: Norma UNI EN 689/97: Guida alla
Incontro tecnico sulla valutazione del Rischio da Agenti Chimici e Cancerogeni
 Vicenza 6 e 15 dicembre 2005 Caserma dei Vigili del Fuoco Incontro tecnico sulla valutazione del Rischio da Agenti Chimici e Cancerogeni Franco Zanin, Pierantonio Zanon, Francesca Lievore *SPISAL ULSS
Vicenza 6 e 15 dicembre 2005 Caserma dei Vigili del Fuoco Incontro tecnico sulla valutazione del Rischio da Agenti Chimici e Cancerogeni Franco Zanin, Pierantonio Zanon, Francesca Lievore *SPISAL ULSS
Polveri di legno: salute e sicurezza
 Polveri di legno: salute e sicurezza VOLUME DEGLI ATTI Edizioni CIMAL Como, 16 maggio 2008 Copyright 2008 Edizioni CIMAL Divisione editoriale di Gruppo CIMAL s.r.l. Tutti i diritti sono riservati a norma
Polveri di legno: salute e sicurezza VOLUME DEGLI ATTI Edizioni CIMAL Como, 16 maggio 2008 Copyright 2008 Edizioni CIMAL Divisione editoriale di Gruppo CIMAL s.r.l. Tutti i diritti sono riservati a norma
Funzionalità degli impianti HVAC e indagini ambientali
 Funzionalità degli impianti HVAC e indagini ambientali 20 febbraio 2010 Stefano Massera Patrizia Anzidei CONTARP INAIL Direzione Generale Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione 1 In Cenni
Funzionalità degli impianti HVAC e indagini ambientali 20 febbraio 2010 Stefano Massera Patrizia Anzidei CONTARP INAIL Direzione Generale Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione 1 In Cenni
LAVORAZIONI CHE ESPONGONO A POLVERI DI LEGNO DURO INDICE
 LAVORAZIONI CHE ESPONGONO A POLVERI DI LEGNO DURO a cura di Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome INDICE LINEE GUIDA SULL APPLICAZIONE DEL
LAVORAZIONI CHE ESPONGONO A POLVERI DI LEGNO DURO a cura di Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome INDICE LINEE GUIDA SULL APPLICAZIONE DEL
VALUTAZIONE DI UNA MODIFICA DELL ATTUALE SISTEMA DI CAMPIONAMENTO DI POLVERI DI LEGNO DURO
 VALUTAZIONE DI UNA MODIFICA DELL ATTUALE SISTEMA DI CAMPIONAMENTO DI POLVERI DI LEGNO DURO Alessandro Bacaloni 1, Leonardo Cornacchia 2 1 Dipartimento di Chimica, Sapienza Università di Roma 2 Dipartimento
VALUTAZIONE DI UNA MODIFICA DELL ATTUALE SISTEMA DI CAMPIONAMENTO DI POLVERI DI LEGNO DURO Alessandro Bacaloni 1, Leonardo Cornacchia 2 1 Dipartimento di Chimica, Sapienza Università di Roma 2 Dipartimento
LANA DI ROCCIA E LANA DI VETRO
 LANA DI ROCCIA E LANA DI VETRO COPERTINA LOGO FIVRA CORRETTA CLASSIFICAZIONE E SMALTIMENTO Costituita nel 2003 e socia di EURIMA (European Insulation Manufactures Association), FIVRA vanta tra i propri
LANA DI ROCCIA E LANA DI VETRO COPERTINA LOGO FIVRA CORRETTA CLASSIFICAZIONE E SMALTIMENTO Costituita nel 2003 e socia di EURIMA (European Insulation Manufactures Association), FIVRA vanta tra i propri
La polvere nella potatura meccanica
 Sicurezza La polvere nella potatura meccanica Luciano Caruso Roberta Bonsignore Giampaolo Schillaci L aumento della produttività grazie ai progressi della meccanizzazione comporta un incremento della polverosità
Sicurezza La polvere nella potatura meccanica Luciano Caruso Roberta Bonsignore Giampaolo Schillaci L aumento della produttività grazie ai progressi della meccanizzazione comporta un incremento della polverosità
3.23 Il rischio silice in agricoltura: la raccolta delle nocciole
 3.23 Il rischio silice in agricoltura: la raccolta delle nocciole M. De Rossi (1), R. Puleggi (2), F. Cavariani (1) (1) (2) Laboratorio di Igiene Industriale ASL Viterbo - Civita Castellana (VT) Università
3.23 Il rischio silice in agricoltura: la raccolta delle nocciole M. De Rossi (1), R. Puleggi (2), F. Cavariani (1) (1) (2) Laboratorio di Igiene Industriale ASL Viterbo - Civita Castellana (VT) Università
Dipartimento Provinciale di Treviso DELL ARIA NELLA PROVINCIA DI TREVISO. Comune di Asolo
 Dipartimento Provinciale di IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA NELLA PROVINCIA DI TREVISO Comune di Periodi di indagine: 18 Febbraio 5 Marzo 2003 (semestre freddo) 21-26 Marzo 2006 (semestre freddo)
Dipartimento Provinciale di IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA NELLA PROVINCIA DI TREVISO Comune di Periodi di indagine: 18 Febbraio 5 Marzo 2003 (semestre freddo) 21-26 Marzo 2006 (semestre freddo)
NORMA UNI EN 689/97 ESPOSIZIONE
 Assessorato politiche per la salute Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Servizio Sanità Pubblica CORSO DI FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO in materia di Gestione del Rischio derivante da Materiali Contenenti
Assessorato politiche per la salute Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Servizio Sanità Pubblica CORSO DI FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO in materia di Gestione del Rischio derivante da Materiali Contenenti
L igiene del lavoro quale rilevante prevenzione nella pubblica amministrazione RISCHIO OZONO DA APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE
 L igiene del lavoro quale rilevante prevenzione nella pubblica amministrazione RISCHIO OZONO DA APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE Renato Cabella ISPESL Dipartimento Igiene del Lavoro La qualità dell
L igiene del lavoro quale rilevante prevenzione nella pubblica amministrazione RISCHIO OZONO DA APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE Renato Cabella ISPESL Dipartimento Igiene del Lavoro La qualità dell
Prime valutazioni analitiche sul contenuto di silice cristallina respirabile in sabbie di mare e di fiume
 Agenzia Regionale per la Prevenzione e l Ambiente dell Emilia-Romagna Prime valutazioni analitiche sul contenuto di silice cristallina respirabile in sabbie di mare e di fiume Giovanni Pecchini, Rosanna
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l Ambiente dell Emilia-Romagna Prime valutazioni analitiche sul contenuto di silice cristallina respirabile in sabbie di mare e di fiume Giovanni Pecchini, Rosanna
Aspetti metodologici
 GRUPPO ESP SIZIONE SILICE emilia romagna Valutazione del rischio da esposizione a S.L.C. a cura di Bruno MARCHESINI Aspetti metodologici Sassuolo, 7 maggio 2009 DIPARTIMENTI DI SANITÀ PUBBLICA AZIENDE
GRUPPO ESP SIZIONE SILICE emilia romagna Valutazione del rischio da esposizione a S.L.C. a cura di Bruno MARCHESINI Aspetti metodologici Sassuolo, 7 maggio 2009 DIPARTIMENTI DI SANITÀ PUBBLICA AZIENDE
Esposizione a SLC nel settore della produzione del cemento
 Esposizione a SLC nel settore della produzione del cemento A. Bergamaschi MONITORAGGIO SILICE ITALIA: RISULTATI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE Viterbo, 27-28 28 ottobre 2008 TENORI IN QUARZO NEI CAMPIONI MASSIVI
Esposizione a SLC nel settore della produzione del cemento A. Bergamaschi MONITORAGGIO SILICE ITALIA: RISULTATI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE Viterbo, 27-28 28 ottobre 2008 TENORI IN QUARZO NEI CAMPIONI MASSIVI
Eleonora Beccaloni. Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria
 Eleonora Beccaloni Istituto Superiore di Sanità Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria Gestione integrata del rischio in un sito di interesse nazionale Brescia-22 Settembre 2014 Contesto
Eleonora Beccaloni Istituto Superiore di Sanità Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria Gestione integrata del rischio in un sito di interesse nazionale Brescia-22 Settembre 2014 Contesto
Monitoraggio sperimentale effettuato con campionatore ad alto volume. Attività svolta nel 2008
 Monitoraggio sperimentale effettuato con campionatore ad alto volume Attività svolta nel 2008 Obiettivo attività: L attività oggetto della seguente presentazione è stata svolta da questa Agenzia su incarico
Monitoraggio sperimentale effettuato con campionatore ad alto volume Attività svolta nel 2008 Obiettivo attività: L attività oggetto della seguente presentazione è stata svolta da questa Agenzia su incarico
Personal exposure to hardwood dust in the Udine chair district: preliminary evaluations.
 www.ijohey.it - Italian Journal of Occupational and Environmental Hygiene Personal exposure to hardwood dust in the Udine chair district: preliminary evaluations. Esposizioni personali a polveri di legno
www.ijohey.it - Italian Journal of Occupational and Environmental Hygiene Personal exposure to hardwood dust in the Udine chair district: preliminary evaluations. Esposizioni personali a polveri di legno
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI. A cura di: Danilo Monarca
 CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI A cura di: Danilo Monarca DEFINIZIONI
CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI A cura di: Danilo Monarca DEFINIZIONI
POLVERI CONTENENTI SLC NELLO SCAVO E DEMOLIZIONI
 POLVERI CONTENENTI SLC NELLO SCAVO E DEMOLIZIONI Monitoraggio e strategie di riduzione delle emissioni DM Cavallo, A Cattaneo, PA Bertazzi SETTORE DEMOLIZIONI Attività edilizie con il massimo potere disperdente
POLVERI CONTENENTI SLC NELLO SCAVO E DEMOLIZIONI Monitoraggio e strategie di riduzione delle emissioni DM Cavallo, A Cattaneo, PA Bertazzi SETTORE DEMOLIZIONI Attività edilizie con il massimo potere disperdente
Valori Limite nella Legislazione Italiana
 Valori Limite nella Legislazione Italiana D.Lgs 277/91: primi valori limite per amianto, piombo, rumore. (importante passo avanti ma rigidità normativa) D.Lgs 66/00: polveri di legno duro, cloruro di vinile
Valori Limite nella Legislazione Italiana D.Lgs 277/91: primi valori limite per amianto, piombo, rumore. (importante passo avanti ma rigidità normativa) D.Lgs 66/00: polveri di legno duro, cloruro di vinile
AZIENDA: SEDE LEGALE DATORE DI LAVORO: SEDE UNITA' PRODUTTIVA: ATTIVITÀ SVOLTA O ESERCITATA: MEDICO COMPETENTE: PRIMO SOCCORSO PREVENZIONE INCENDI
 AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI PER LE LAVORAZIONI CHE ESPONGONO ALLE POLVERI DI LEGNO DURO PREVISTA DALL ART. 4 COMMA 11 E ART. 63 COMMA 1 DEL DECRETO
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI PER LE LAVORAZIONI CHE ESPONGONO ALLE POLVERI DI LEGNO DURO PREVISTA DALL ART. 4 COMMA 11 E ART. 63 COMMA 1 DEL DECRETO
Strategie di Valutazione e Prevenzione del Rischio d Esposizione a FAV: esperienze in ambito industriale
 LE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE: aspetti ambientali e sanitari Monfalcone - 20 aprile 2017 Strategie di Valutazione e Prevenzione del Rischio d Esposizione a FAV: esperienze in ambito industriale Danilo Cottica
LE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE: aspetti ambientali e sanitari Monfalcone - 20 aprile 2017 Strategie di Valutazione e Prevenzione del Rischio d Esposizione a FAV: esperienze in ambito industriale Danilo Cottica
Valutazione dei rischi di igiene
 Valutazione dei rischi di igiene Fattori di rischio professionali Classificazione (1) Rischi per la sicurezza: Elettricità, macchinari, ecc. Rischi per la salute fattori inquinanti connessi con la produzione:
Valutazione dei rischi di igiene Fattori di rischio professionali Classificazione (1) Rischi per la sicurezza: Elettricità, macchinari, ecc. Rischi per la salute fattori inquinanti connessi con la produzione:
Analisi fluidodinamica CFD su dispositivi a colonna d acqua oscillante OWC - Fase 2: Confronto tra risultati numerici e risultati sperimentali
 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Analisi fluidodinamica CFD su dispositivi a colonna d acqua oscillante OWC -
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Analisi fluidodinamica CFD su dispositivi a colonna d acqua oscillante OWC -
METODI SPERIMENTALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE IN MATERIALI MASSIVI
 METODI SPERIMENTALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE IN MATERIALI MASSIVI Un esempio di contributo all applicazione dei criteri CLP delle sostanze e delle miscele pericolose
METODI SPERIMENTALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE IN MATERIALI MASSIVI Un esempio di contributo all applicazione dei criteri CLP delle sostanze e delle miscele pericolose
LA GESTIONE DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE Le esperienze di Arpa Piemonte. Direttore Generale Arpa Piemonte ing. Angelo Robotto
 LA GESTIONE DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE Le esperienze di Arpa Piemonte Direttore Generale Arpa Piemonte ing. Angelo Robotto La normativa di riferimento La Direttiva 67/548 CE regolamenta l emissione
LA GESTIONE DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE Le esperienze di Arpa Piemonte Direttore Generale Arpa Piemonte ing. Angelo Robotto La normativa di riferimento La Direttiva 67/548 CE regolamenta l emissione
Le misure di igiene industriale per la prevenzione: esperienze di lavoro di CONTARP INAIL Marche in sinergia con l'asur MARCHE"
 Le misure di igiene industriale per la prevenzione: esperienze di lavoro di CONTARP INAIL Marche in sinergia con l'asur MARCHE" INAIL-Direzione Regionale Marche Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e
Le misure di igiene industriale per la prevenzione: esperienze di lavoro di CONTARP INAIL Marche in sinergia con l'asur MARCHE" INAIL-Direzione Regionale Marche Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e
METODICHE DI ANALISI PER AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) Parte introduttiva: il laboratorio accreditato e certificato
 METODICHE DI ANALISI PER AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) Parte introduttiva: il laboratorio accreditato e certificato Lunedì 12 dicembre 2016 AC Hotel Vicenza S.S. Padana Superiore verso Verona,
METODICHE DI ANALISI PER AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) Parte introduttiva: il laboratorio accreditato e certificato Lunedì 12 dicembre 2016 AC Hotel Vicenza S.S. Padana Superiore verso Verona,
Teoria e tecniche dei test. Concetti di base
 Teoria e tecniche dei test Lezione 2 2013/14 ALCUNE NOZIONI STATITICHE DI BASE Concetti di base Campione e popolazione (1) La popolazione è l insieme di individui o oggetti che si vogliono studiare. Questi
Teoria e tecniche dei test Lezione 2 2013/14 ALCUNE NOZIONI STATITICHE DI BASE Concetti di base Campione e popolazione (1) La popolazione è l insieme di individui o oggetti che si vogliono studiare. Questi
Dipartimento di CHIMICA Via P.Giuria 5, Torino, Italy
 Dipartimento di CHIMICA Via P.Giuria 5, 10125 Torino, Italy Tel.: 011-705218 Fax: 011-70715 E-mail: valter.maurino@unito.it Spett.le Att.ne GIOLLI SRL Via Enzo Ferrari, sn 1030, Calcinelli di Saltara (PU)
Dipartimento di CHIMICA Via P.Giuria 5, 10125 Torino, Italy Tel.: 011-705218 Fax: 011-70715 E-mail: valter.maurino@unito.it Spett.le Att.ne GIOLLI SRL Via Enzo Ferrari, sn 1030, Calcinelli di Saltara (PU)
INCONTRO INFORMATIVO CON I MEDICI COMPETENTI SPISAL
 INCONTRO INFORMATIVO CON I MEDICI COMPETENTI SPISAL provincia Belluno Belluno 16 febbraio 2017 Qualche novità sull approccio ai cancerogeni professionali - formaldeide Nuove Check list regionali per Rischio
INCONTRO INFORMATIVO CON I MEDICI COMPETENTI SPISAL provincia Belluno Belluno 16 febbraio 2017 Qualche novità sull approccio ai cancerogeni professionali - formaldeide Nuove Check list regionali per Rischio
Ufficio Aria Dipartimento Provinciale
 CAMPAGNA DI MONITORAGGIO E METALLI P.zza VITTORIO EMANUELE - POTENZA - ANNO 15 1 Gestione, Manutenzione ed Elaborazione a cura di: Ufficio Aria, Dip. prov. Potenza P.I. Giuseppe Taddonio P.I. Rocco Marino
CAMPAGNA DI MONITORAGGIO E METALLI P.zza VITTORIO EMANUELE - POTENZA - ANNO 15 1 Gestione, Manutenzione ed Elaborazione a cura di: Ufficio Aria, Dip. prov. Potenza P.I. Giuseppe Taddonio P.I. Rocco Marino
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO
 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE TESI DI LAUREA Analisi dei dati di due campagne
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE TESI DI LAUREA Analisi dei dati di due campagne
VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA
 Associazione Italiana di Acustica 38 Convegno Nazionale Rimini, 08-10 giugno 2011 VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA Paolo
Associazione Italiana di Acustica 38 Convegno Nazionale Rimini, 08-10 giugno 2011 VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA Paolo
Analisi di emissioni gassose convogliate di una caldaia alimentata con differenti tipologie di gasolio
 Qualità dell aria e combustibili: rispetto dell ambiente, tutela della concorrenza, sostenibilità economica Verona Fiere 12 Ottobre 2016 Analisi di emissioni gassose convogliate di una caldaia alimentata
Qualità dell aria e combustibili: rispetto dell ambiente, tutela della concorrenza, sostenibilità economica Verona Fiere 12 Ottobre 2016 Analisi di emissioni gassose convogliate di una caldaia alimentata
ASPETTI ASSICURATIVI LEGATI ALL ESPOSIZIONE IN FONDERIA
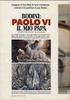 PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO D INTESA SULLE BUONE PRATICHE PER L UTILIZZO DELLA SILICE LIBERA CRISTALLINA NELL INDUSTRIA DELLA FONDERIA CON FORMATURA IN TERRA Auditorium Confindustria Ceramica Sassuolo
PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO D INTESA SULLE BUONE PRATICHE PER L UTILIZZO DELLA SILICE LIBERA CRISTALLINA NELL INDUSTRIA DELLA FONDERIA CON FORMATURA IN TERRA Auditorium Confindustria Ceramica Sassuolo
Determinazione dell azoto totale e ammoniacale in spettrofotometria: modalità di calibrazione e confrontabilità nel tempo
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN BIOTECNOLOGIE Determinazione dell azoto totale e ammoniacale in spettrofotometria: modalità di calibrazione e confrontabilità nel tempo Relatore:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN BIOTECNOLOGIE Determinazione dell azoto totale e ammoniacale in spettrofotometria: modalità di calibrazione e confrontabilità nel tempo Relatore:
CONTROLLI PERIODICI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
 CONTROLLI PERIODICI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Falegnameria Fratelli Rubicondo s.r.l. Via Pianodardine Zona industriale Avellino A cura di tecnico competente Data: 19/06/2017 Dott. Chim. Giuseppe Mazza
CONTROLLI PERIODICI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Falegnameria Fratelli Rubicondo s.r.l. Via Pianodardine Zona industriale Avellino A cura di tecnico competente Data: 19/06/2017 Dott. Chim. Giuseppe Mazza
Percezione e valutazione del rischio da sollevamento, trasporto, traino e spinta
 Trieste, 28 settembre 2011 Percezione e valutazione del rischio da sollevamento, trasporto, traino e spinta INAIL F.V.G. CONTARP Maria Angela Gogliettino D. Lgs.. 81/2008 (mod. 106/2009) Art. 15, c. 1
Trieste, 28 settembre 2011 Percezione e valutazione del rischio da sollevamento, trasporto, traino e spinta INAIL F.V.G. CONTARP Maria Angela Gogliettino D. Lgs.. 81/2008 (mod. 106/2009) Art. 15, c. 1
CONCENTRAZIONE DI MONOSSIDO DI CARBONIO NELL ARIA AMBIENTE
 CONCENTRAZIONE DI MONOSSIDO DI CARBONIO NELL ARIA AMBIENTE Il monossido di carbonio è un inquinante da traffico caratteristico delle aree urbane a circolazione congestionata. CLASSIFICAZIONE TEMA SOTTOTEMA
CONCENTRAZIONE DI MONOSSIDO DI CARBONIO NELL ARIA AMBIENTE Il monossido di carbonio è un inquinante da traffico caratteristico delle aree urbane a circolazione congestionata. CLASSIFICAZIONE TEMA SOTTOTEMA
DETERMINAZIONE DEI DIAMETRI E CONTROLLO FRA LABORATORI
 Gruppo Interregionale Fibre Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro C.T.I.P.L.L. CLASSIFICAZIONE DI MMVFs DETERMINAZIONE DEI DIAMETRI E CONTROLLO FRA LABORATORI Studio
Gruppo Interregionale Fibre Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro C.T.I.P.L.L. CLASSIFICAZIONE DI MMVFs DETERMINAZIONE DEI DIAMETRI E CONTROLLO FRA LABORATORI Studio
CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLA GALLERIA DEL VENTO DALLARA. G.V. Iungo, G. Lombardi
 CARATTERIAIONE DEL FLSSO DELLA GALLERIA DEL VENTO DALLARA G.V. Iungo, G. Lombardi DDIA 2008-3 Marzo 2008 Indice Pagina 1 Misure d anemometro a filo caldo e di Pitot statico 2 1.1 Set-up 2 1.2 Analisi dei
CARATTERIAIONE DEL FLSSO DELLA GALLERIA DEL VENTO DALLARA G.V. Iungo, G. Lombardi DDIA 2008-3 Marzo 2008 Indice Pagina 1 Misure d anemometro a filo caldo e di Pitot statico 2 1.1 Set-up 2 1.2 Analisi dei
COMUNE DI NOVARA ASSESSORATO PER L AMBIENTE INDAGINE SULL INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI -IPA
 COMUNE DI NOVARA ASSESSORATO PER L AMBIENTE INDAGINE SULL INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI -IPA BENZENE, TOLUENE, XILENE - BTX POLVERI CON DIMENSIONE 10 mm - PM10 AGOSTO 1997
COMUNE DI NOVARA ASSESSORATO PER L AMBIENTE INDAGINE SULL INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI -IPA BENZENE, TOLUENE, XILENE - BTX POLVERI CON DIMENSIONE 10 mm - PM10 AGOSTO 1997
Le misure di prevenzione
 Prevenzione del rischio cancerogeno Piano mirato di prevenzione Applicazione del vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività di saldatura di acciai inox
Prevenzione del rischio cancerogeno Piano mirato di prevenzione Applicazione del vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività di saldatura di acciai inox
PRINCIPI E METODI DI MISURA DEI PRINCIPALI INQUINANTI ATMOSFERICI
 PRINCIPI E METODI DI MISURA DEI PRINCIPALI INQUINANTI ATMOSFERICI PARTICOLATO PM10 E PM2.5 I sistema di riferimento per la misura del particolato atmosferico in aria ambiente è il sistema gravimetrico.
PRINCIPI E METODI DI MISURA DEI PRINCIPALI INQUINANTI ATMOSFERICI PARTICOLATO PM10 E PM2.5 I sistema di riferimento per la misura del particolato atmosferico in aria ambiente è il sistema gravimetrico.
La variabilità. Dott. Cazzaniga Paolo. Dip. di Scienze Umane e Sociali
 Dip. di Scienze Umane e Sociali paolo.cazzaniga@unibg.it Introduzione [1/2] Gli indici di variabilità consentono di riassumere le principali caratteristiche di una distribuzione (assieme alle medie) Le
Dip. di Scienze Umane e Sociali paolo.cazzaniga@unibg.it Introduzione [1/2] Gli indici di variabilità consentono di riassumere le principali caratteristiche di una distribuzione (assieme alle medie) Le
Proficiency Testing per i laboratori che effettuano analisi di silice cristallina mediante DRX
 Convegno Network Italiano Silice: dieci anni dopo Il sistema di Prevenzione del rischio in Italia Proficiency Testing per i laboratori che effettuano analisi di silice cristallina mediante DRX E. Incocciati,
Convegno Network Italiano Silice: dieci anni dopo Il sistema di Prevenzione del rischio in Italia Proficiency Testing per i laboratori che effettuano analisi di silice cristallina mediante DRX E. Incocciati,
Pietro Apostoli, Simona Catalani, Jacopo Fostinelli
 STIMA INTEGRATA DELL'ESPOSIZIONE A XENOBIOTICI NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI E GENERALI: QUALCHE UTILE SPUNTO DALLA NOSTRA ESPERIENZA NELLO STUDIO DI METALLI ED IPA NELLA METALLURGIA FERROSA E NON? Pietro
STIMA INTEGRATA DELL'ESPOSIZIONE A XENOBIOTICI NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI E GENERALI: QUALCHE UTILE SPUNTO DALLA NOSTRA ESPERIENZA NELLO STUDIO DI METALLI ED IPA NELLA METALLURGIA FERROSA E NON? Pietro
La Regione Lombardia e il NIS (Network Italiano Silice) Ing. Domenico Savoca
 La Regione e il NIS (Network Italiano Silice) Ing. Domenico Savoca Dirigente Struttura Cave e Miniere Regione Partenza nel 2002 Motivazioni: 1.Coerenza con le evidenze scientifiche emergenti a seguito
La Regione e il NIS (Network Italiano Silice) Ing. Domenico Savoca Dirigente Struttura Cave e Miniere Regione Partenza nel 2002 Motivazioni: 1.Coerenza con le evidenze scientifiche emergenti a seguito
Prodotto: Sabbia silicea
 pag.1 di 9 Prodotto: Sabbia silicea pag.2 di 9 INDICE 1. IDENTIFICAZIONE PRODOTTO E FORNITORE pag. 3 2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUI COMPONENTI pag. 3 3. INDICAZIONE DEI PERICOLI. pag. 4 4. MISURE DI
pag.1 di 9 Prodotto: Sabbia silicea pag.2 di 9 INDICE 1. IDENTIFICAZIONE PRODOTTO E FORNITORE pag. 3 2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUI COMPONENTI pag. 3 3. INDICAZIONE DEI PERICOLI. pag. 4 4. MISURE DI
RISCHIO MALATTIA PROFESSIONALE ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
 FASE 1 Individuazione dei VALORI LIMITE D ESPOSIZIONE PROFESSIONALE in base ai dati più attendibili ricavati dall esperienza in campo industriale, ai risultati di ricerche sperimentali sull uomo e sugli
FASE 1 Individuazione dei VALORI LIMITE D ESPOSIZIONE PROFESSIONALE in base ai dati più attendibili ricavati dall esperienza in campo industriale, ai risultati di ricerche sperimentali sull uomo e sugli
Misura in camera olfattometrica
 Misura in camera olfattometrica Udine, 18 maggio 2012 Dott. Alberto Tonino UNI EN 13725 standard per la misurazione delle unità di odore ou E /m 3 = quantità di odorante in un m 3 di gas neutro che provoca
Misura in camera olfattometrica Udine, 18 maggio 2012 Dott. Alberto Tonino UNI EN 13725 standard per la misurazione delle unità di odore ou E /m 3 = quantità di odorante in un m 3 di gas neutro che provoca
TLV, procedure di campionamento e analisi di inquinanti atmosferici
 Università degli Studi di Padova Laurea Magistrale in Chimica Chimica Analitica e Ambiente TLV, procedure di campionamento e analisi di inquinanti atmosferici Andrea Tapparo Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Padova Laurea Magistrale in Chimica Chimica Analitica e Ambiente TLV, procedure di campionamento e analisi di inquinanti atmosferici Andrea Tapparo Università degli Studi di Padova
STRATEGIE DI MONITORAGGIO DEI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) IN AMBIENTE INDOOR a cura del Gruppo di Studio Nazionale sull Inquinamento Indoor dell
 STRATEGIE DI MONITORAGGIO DEI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) IN AMBIENTE INDOOR a cura del Gruppo di Studio Nazionale sull Inquinamento Indoor dell ISS Rapporto Istisan, 2013 1 INDICE Introduzione...
STRATEGIE DI MONITORAGGIO DEI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) IN AMBIENTE INDOOR a cura del Gruppo di Studio Nazionale sull Inquinamento Indoor dell ISS Rapporto Istisan, 2013 1 INDICE Introduzione...
15LA16753 del 14/12/2015
 Rapporto di prova n : 15LA16753 del 14/12/2015 Dati relativi al campione Spett. Chimeko Srl Via Valeri, 16 20017 Passirana di Rho (MI) Oggetto della prova: Polimeri Descrizione: Mix di poliolefine Data
Rapporto di prova n : 15LA16753 del 14/12/2015 Dati relativi al campione Spett. Chimeko Srl Via Valeri, 16 20017 Passirana di Rho (MI) Oggetto della prova: Polimeri Descrizione: Mix di poliolefine Data
Direttore A.R.P.A.B Ing. Raffaele Vita
 POTENZA P.zza VITTORIO EMANUELE CAMPAGNA MONITORAGGIO PM10 E METALLI IN TRACCIA ANNO 2011 1 Gestione Manutenzione ed Elaborazione a cura di : Ufficio Aria Dip. Prov. Potenza P.I. Giuseppe Taddonio P.I.
POTENZA P.zza VITTORIO EMANUELE CAMPAGNA MONITORAGGIO PM10 E METALLI IN TRACCIA ANNO 2011 1 Gestione Manutenzione ed Elaborazione a cura di : Ufficio Aria Dip. Prov. Potenza P.I. Giuseppe Taddonio P.I.
- Cos è la silice cristallina? - Gli effetti sulla salute - Lavori e materiali pericolosi - Misure di prevenzione
 - Cos è la silice cristallina? - Gli effetti sulla salute - Lavori e materiali pericolosi - Misure di prevenzione Laboratorio Igiene Industriale ASL VT - Dipartimento di Prevenzione Centro Regionale Amianto
- Cos è la silice cristallina? - Gli effetti sulla salute - Lavori e materiali pericolosi - Misure di prevenzione Laboratorio Igiene Industriale ASL VT - Dipartimento di Prevenzione Centro Regionale Amianto
Misure ambientali del progetto CCM Indoor-School: inquinamento chimico indoor e outdoor
 Inquinamento atmosferico interno e salute nelle scuole italiane Roma 23/02/2015 Misure ambientali del progetto CCM Indoor-School: inquinamento chimico indoor e outdoor Gaetano Settimo Reparto Igiene dell
Inquinamento atmosferico interno e salute nelle scuole italiane Roma 23/02/2015 Misure ambientali del progetto CCM Indoor-School: inquinamento chimico indoor e outdoor Gaetano Settimo Reparto Igiene dell
Caratterizzazione chimica del PM2,5 ed analisi dimensionale di particolato fine in un luogo di lavoro
 Caratterizzazione chimica del PM2,5 ed analisi dimensionale di particolato fine in un luogo di lavoro Piera Ielpo 1,2, P. Fermo 3, V. Ancona 2, A. Candeliere 3, A. Piazzalunga 3, R. Dario, V. Di Lecce
Caratterizzazione chimica del PM2,5 ed analisi dimensionale di particolato fine in un luogo di lavoro Piera Ielpo 1,2, P. Fermo 3, V. Ancona 2, A. Candeliere 3, A. Piazzalunga 3, R. Dario, V. Di Lecce
Valutazione di Emulsioni Acqua-DMA in un Motore Marino Ausiliario
 Valutazione di Emulsioni Acqua-DMA in un Motore Marino Ausiliario Impianti Tecnici Industriali Obiettivo della Prova Misurare i consumi dei combustibili Misurare le emissioni: NOx, PM, HC, SOx, CO, CO
Valutazione di Emulsioni Acqua-DMA in un Motore Marino Ausiliario Impianti Tecnici Industriali Obiettivo della Prova Misurare i consumi dei combustibili Misurare le emissioni: NOx, PM, HC, SOx, CO, CO
Concentrazione delle polveri sottili nel 2016 in provincia di Verona
 Concentrazione delle polveri sottili nel 2016 in provincia di Verona Analisi sintetica dei dati misurati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 20 dicembre 2016, presso le centraline di misura della
Concentrazione delle polveri sottili nel 2016 in provincia di Verona Analisi sintetica dei dati misurati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 20 dicembre 2016, presso le centraline di misura della
La scheda di autovalutazione
 Seminario con le aziende del comparto legno 16 dicembre 2011 La scheda di autovalutazione Enzo Colombo Marco Riva Tecnici della prevenzione - Servizio PSAL Seminario con le aziende del comparto legno La
Seminario con le aziende del comparto legno 16 dicembre 2011 La scheda di autovalutazione Enzo Colombo Marco Riva Tecnici della prevenzione - Servizio PSAL Seminario con le aziende del comparto legno La
Nella newsletter dello scorso mese abbiamo iniziato a parlare della classificazione delle aree per la presenza di gas, vapori e nebbie.
 LA VENTILAZIONE DELLE AREE PERICOLOSE PER LA PRESENZA DI GAS Nella newsletter dello scorso mese abbiamo iniziato a parlare della classificazione delle aree per la presenza di gas, vapori e nebbie. In questa
LA VENTILAZIONE DELLE AREE PERICOLOSE PER LA PRESENZA DI GAS Nella newsletter dello scorso mese abbiamo iniziato a parlare della classificazione delle aree per la presenza di gas, vapori e nebbie. In questa
Esposizione combinata ad agenti chimici: una proposta operativa per la valutazione Autori: 1 R. d Angelo, 1 E. Russo, 2 G. Lama
 Esposizione combinata ad agenti chimici: una proposta operativa per la valutazione Autori: 1 R. d Angelo, 1 E. Russo, 2 G. Lama 1 Contarp INAIL- Direzione Regionale per la Campania 2 ASL CE2- Servizio
Esposizione combinata ad agenti chimici: una proposta operativa per la valutazione Autori: 1 R. d Angelo, 1 E. Russo, 2 G. Lama 1 Contarp INAIL- Direzione Regionale per la Campania 2 ASL CE2- Servizio
 46030 Pomponesco (MN) Italia Via XX Settembre, 58 w w w. g r u p p o f r a t i. c o m i n f o @ g r u p p o f r a t i. c o m Uff. Comm.: Tel. +39 0375 8401 Fax +39 0375 840403 Uff. Amm.: Tel. +39 0375
46030 Pomponesco (MN) Italia Via XX Settembre, 58 w w w. g r u p p o f r a t i. c o m i n f o @ g r u p p o f r a t i. c o m Uff. Comm.: Tel. +39 0375 8401 Fax +39 0375 840403 Uff. Amm.: Tel. +39 0375
AGENTI CHIMICI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE ATTIVITA DI VERNICIATURA a cura di Mariacristina Mazzari e Claudio Arcari
 Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro AGENTI CHIMICI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE ATTIVITA DI VERNICIATURA a cura di Mariacristina Mazzari e Claudio
Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro AGENTI CHIMICI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE ATTIVITA DI VERNICIATURA a cura di Mariacristina Mazzari e Claudio
NUOVE SCHIUME POLIURETANICHE CONTENENTI NANO PARTICELLE CON MIGLIORATE PROPRIETA COIBENTANTI. Ing. Paolo Maria Congedo, Ing.
 NUOVE SCHIUME POLIURETANICHE CONTENENTI NANO PARTICELLE CON MIGLIORATE PROPRIETA COIBENTANTI Ing. Paolo Maria Congedo, Ing. Caterina Lorusso INDICE Introduzione Uilizzi poliuretano Metodi di studio: Approccio
NUOVE SCHIUME POLIURETANICHE CONTENENTI NANO PARTICELLE CON MIGLIORATE PROPRIETA COIBENTANTI Ing. Paolo Maria Congedo, Ing. Caterina Lorusso INDICE Introduzione Uilizzi poliuretano Metodi di studio: Approccio
SCHEDA 11A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A CINGOLI MODELLO FIAT 955 E SIMILI (FIAT 95-55, etc.)
 SCHEDA 11A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A CINGOLI MODELLO FIAT 955 E SIMILI (FIAT 95-55, etc.) Il presente documento è stato realizzato nell ambito dell attività di ricerca prevista: dalla convenzione stipulata
SCHEDA 11A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A CINGOLI MODELLO FIAT 955 E SIMILI (FIAT 95-55, etc.) Il presente documento è stato realizzato nell ambito dell attività di ricerca prevista: dalla convenzione stipulata
Tumori maligni del naso e dei seni paranasali. I dati Inail Regione Piemonte
 Tumori maligni del naso e dei seni paranasali I dati Inail Regione Piemonte Francesca Filippi, Inail direzione Piemonte Torino 24.05.2013 Centro Incontri Regione Piemonte 1 Tumori maligni del naso e dei
Tumori maligni del naso e dei seni paranasali I dati Inail Regione Piemonte Francesca Filippi, Inail direzione Piemonte Torino 24.05.2013 Centro Incontri Regione Piemonte 1 Tumori maligni del naso e dei
LE FASI: LA POST-FORMATURA incollaggio, saldatura, decorazione, stampa, metallizzazione EMISSIONI DI SOSTANZE CHIMICHE DA TERMOPLASTICI
 LE FASI: PRE-FORMATURA FORMATURA: trattamento della materia prima; rammollimento pressurizzazione, pompaggio del fluido,, stripping sostanze volatili LA FORMATURA LA POST-FORMATURA FORMATURA: incollaggio,
LE FASI: PRE-FORMATURA FORMATURA: trattamento della materia prima; rammollimento pressurizzazione, pompaggio del fluido,, stripping sostanze volatili LA FORMATURA LA POST-FORMATURA FORMATURA: incollaggio,
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1982 concernente un valore limite per il piombo contenuto nell ' atmosfera ( 82/884/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE
 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1982 concernente un valore limite per il piombo contenuto nell ' atmosfera ( 82/884/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1982 concernente un valore limite per il piombo contenuto nell ' atmosfera ( 82/884/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la
Scheda informativa SABBIA FINE
 1. DATI IDENTIFICATIVI 1.1 - Nome commerciale del prodotto: SABBIA FINE Impiego tipico: Inerte sabbioso per preparazione asfalti, malte e calcestruzzi in edilizia e costruzioni in genere. 1.2 - Fornitore:
1. DATI IDENTIFICATIVI 1.1 - Nome commerciale del prodotto: SABBIA FINE Impiego tipico: Inerte sabbioso per preparazione asfalti, malte e calcestruzzi in edilizia e costruzioni in genere. 1.2 - Fornitore:
Corso di Psicometria Progredito
 Corso di Psicometria Progredito 5. La correlazione lineare Gianmarco Altoè Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia Università di Cagliari, Anno Accademico 2013-2014 Sommario 1 Tipi di relazione
Corso di Psicometria Progredito 5. La correlazione lineare Gianmarco Altoè Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia Università di Cagliari, Anno Accademico 2013-2014 Sommario 1 Tipi di relazione
Impiego sperimentale di aerosol d acqua d di polveri e quarzo respirabile nella lavorazione a a spacco del porfido. Dott.
 Impiego sperimentale di aerosol d acqua d per l abbattimento l di polveri e quarzo respirabile nella lavorazione a a spacco del porfido Dott. Azelio De Santa L idea è nata circa 5 anni fa in una discarica
Impiego sperimentale di aerosol d acqua d per l abbattimento l di polveri e quarzo respirabile nella lavorazione a a spacco del porfido Dott. Azelio De Santa L idea è nata circa 5 anni fa in una discarica
Controllo di qualità amianto dei laboratori nazionali: risultati del progetto INAIL
 Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambiente Controllo di qualità amianto dei laboratori nazionali: risultati del progetto INAIL Antonella Campopiano Circuiti di qualità nelle
Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambiente Controllo di qualità amianto dei laboratori nazionali: risultati del progetto INAIL Antonella Campopiano Circuiti di qualità nelle
Progetto galvaniche: piano d intervento mirato alla riduzione dell esposizione a rischi professionali. Il ruolo di ARPA Piemonte
 Progetto galvaniche: piano d intervento mirato alla riduzione dell esposizione a rischi professionali Il ruolo di ARPA Piemonte Giuseppe Bianco, Antonino Runci ARPA Piemonte - Polo Regionale Igiene Industriale
Progetto galvaniche: piano d intervento mirato alla riduzione dell esposizione a rischi professionali Il ruolo di ARPA Piemonte Giuseppe Bianco, Antonino Runci ARPA Piemonte - Polo Regionale Igiene Industriale
1 FASI LAVORATIVE 2 PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO COSTRUTTIVE E GESTIONALE
 4.12) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all uso
4.12) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all uso
Gruppo di lavoro. Claudio Arcari Barbara Mazzocchi Anna Bosi Maria Teresa Cella Mariacristina Mazzari Giorgio Passera Alessandra Pompini
 Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro La valutazione dell esposizione dei lavoratori ad Agenti Chimici. I dati di esposizione nelle attività di Saldatura e Verniciatura
Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro La valutazione dell esposizione dei lavoratori ad Agenti Chimici. I dati di esposizione nelle attività di Saldatura e Verniciatura
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
 RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO RISCHIO CANCEROGENO Le stime attualmente indicano che il 3-5% di tutti i tumori è di origine occupazionale. In Italia vi sono circa 200.000 morti/anno per tumore Tumori frequenti
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO RISCHIO CANCEROGENO Le stime attualmente indicano che il 3-5% di tutti i tumori è di origine occupazionale. In Italia vi sono circa 200.000 morti/anno per tumore Tumori frequenti
Patrizia Ferdenzi, William Montorsi
 Seminario L ESPOSIZIONE A CANCEROGENI PROFESSIONALI (Cromo e Nichel) NEL TAGLIO LASER DI ACCIAIO INOX : PROBLEMI E SOLUZIONI Modalità di controllo dell esposizione professionale a cromo e nichel REGGIO
Seminario L ESPOSIZIONE A CANCEROGENI PROFESSIONALI (Cromo e Nichel) NEL TAGLIO LASER DI ACCIAIO INOX : PROBLEMI E SOLUZIONI Modalità di controllo dell esposizione professionale a cromo e nichel REGGIO
STATISTICHE IN BREVE. Archivio Statistico delle Imprese Attive (Asia) Anni La struttura delle imprese e dell occupazione
 STATISTICHE IN BREVE Archivio Statistico delle Imprese Attive (Asia) Anni 2007-2010 La struttura delle imprese e dell occupazione Nel 2010, secondo l ATECO 2007, le imprese attive nell industria e nei
STATISTICHE IN BREVE Archivio Statistico delle Imprese Attive (Asia) Anni 2007-2010 La struttura delle imprese e dell occupazione Nel 2010, secondo l ATECO 2007, le imprese attive nell industria e nei
Fabio Montanaro. Registro Tumori Cantone Ticino Istituto Cantonale di Patologia, Locarno. Tel
 Fabio Montanaro Registro Tumori Cantone Ticino Istituto Cantonale di Patologia, Locarno Tel. 091 8160825 E-mail fabio.montanaro@ti.ch A total of 900 agents and groups of agents, mixtures, exposure circumstances:
Fabio Montanaro Registro Tumori Cantone Ticino Istituto Cantonale di Patologia, Locarno Tel. 091 8160825 E-mail fabio.montanaro@ti.ch A total of 900 agents and groups of agents, mixtures, exposure circumstances:
Classificazione Sigla identificazione Foglio 1 di 9 Prog. CNT Ris. III Arch R-0078 TITOLO
 in convenzione con Classificazione Sigla identificazione Foglio 1 di 9 Prog. CNT Ris. III Arch. +5 080101-R-0078 TITOLO DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI, DELLO SPESSORE DEI SETTI E DELLE PARETI, DELLA PLANARITA
in convenzione con Classificazione Sigla identificazione Foglio 1 di 9 Prog. CNT Ris. III Arch. +5 080101-R-0078 TITOLO DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI, DELLO SPESSORE DEI SETTI E DELLE PARETI, DELLA PLANARITA
La valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici e Cancerogeni Dati di esposizione a fumi di saldatura nell esperienza di Piacenza
 Seminari monografici di Medicina del Lavoro «Rischio cancerogeno ed altri rischi per la salute dei saldatori» Università degli Studi di Parma 13 maggio 2016 La valutazione del rischio da esposizione ad
Seminari monografici di Medicina del Lavoro «Rischio cancerogeno ed altri rischi per la salute dei saldatori» Università degli Studi di Parma 13 maggio 2016 La valutazione del rischio da esposizione ad
In realtà la T(x) è differente non essendo il flusso monodimensionale (figura 4.3).
 Richiami sui ponti termici (cap. 4) Autore: prof. ing. Francesco Minichiello, Università degli Studi di Napoli Federico II Anno di compilazione: 2005 Nota: si ringrazia vivamente il prof. ing. Pietro Mazzei,
Richiami sui ponti termici (cap. 4) Autore: prof. ing. Francesco Minichiello, Università degli Studi di Napoli Federico II Anno di compilazione: 2005 Nota: si ringrazia vivamente il prof. ing. Pietro Mazzei,
PUNTO CRITICO LINEE GUIDA 95-99
 PUNTO CRITICO LINEE GUIDA 95-99 Classificazione dei CA come sostanze Classificazione preparazione somministrazione come lavorazioni ( rispetto leggi UE e recepimenti nazionali) PILASTRI PREVENZIONE
PUNTO CRITICO LINEE GUIDA 95-99 Classificazione dei CA come sostanze Classificazione preparazione somministrazione come lavorazioni ( rispetto leggi UE e recepimenti nazionali) PILASTRI PREVENZIONE
Situazione meteorologica
 Situazione meteorologica Ad integrazione della presentazione dei dati rilevati nella rete di monitoraggio della qualità dell aria, si riportano in maniera sintetica i dati relativi ai parametri meteorologici
Situazione meteorologica Ad integrazione della presentazione dei dati rilevati nella rete di monitoraggio della qualità dell aria, si riportano in maniera sintetica i dati relativi ai parametri meteorologici
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA Radiazioni Ottiche Artificiali COERENTI
 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA Radiazioni Ottiche Artificiali COERENTI Riccardo Di Liberto Struttura Complessa di Fisica Sanitaria Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia 1 Radiazioni Ottiche Artificiali
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA Radiazioni Ottiche Artificiali COERENTI Riccardo Di Liberto Struttura Complessa di Fisica Sanitaria Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia 1 Radiazioni Ottiche Artificiali
utilizzano i dati relativi ad una sola stazione a terra e quelli che utilizzano due stazioni a terra più i profili verticali RASS e SODAR.
 Capitolo 5 Applicazione di modelli diffusionali al caso di studio pag. 173 utilizzano i dati relativi ad una sola stazione a terra e quelli che utilizzano due stazioni a terra più i profili verticali RASS
Capitolo 5 Applicazione di modelli diffusionali al caso di studio pag. 173 utilizzano i dati relativi ad una sola stazione a terra e quelli che utilizzano due stazioni a terra più i profili verticali RASS
Standard di esposizione umana. Ingegneria Sanitaria-Ambientale I Claudio Lubello
 Standard di esposizione umana Ingegneria Sanitaria-Ambientale I Claudio Lubello Introduzione In questa lezione l attenzione viene spostata dagli aspetti connessi alla salute degli ecosistemi in generale
Standard di esposizione umana Ingegneria Sanitaria-Ambientale I Claudio Lubello Introduzione In questa lezione l attenzione viene spostata dagli aspetti connessi alla salute degli ecosistemi in generale
I criteri tecnico-qualitativi dei dispositivi taglienti e pungenti con meccanismo di protezione
 I criteri tecnico-qualitativi dei dispositivi taglienti e pungenti con meccanismo di protezione DOCUMENTO REGIONALE LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI D USO DEI DISPOSITIVI MEDICI CON MECCANISMO DI SICUREZZA
I criteri tecnico-qualitativi dei dispositivi taglienti e pungenti con meccanismo di protezione DOCUMENTO REGIONALE LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI D USO DEI DISPOSITIVI MEDICI CON MECCANISMO DI SICUREZZA
Università del Piemonte Orientale. Corsi di Laurea Triennale di Area Tecnica. Corso di Statistica e Biometria
 Università del Piemonte Orientale Corsi di Laurea Triennale di Area Tecnica Corso di Statistica e Biometria Statistica descrittiva: Dati numerici: statistiche di tendenza centrale e di variabilità Corsi
Università del Piemonte Orientale Corsi di Laurea Triennale di Area Tecnica Corso di Statistica e Biometria Statistica descrittiva: Dati numerici: statistiche di tendenza centrale e di variabilità Corsi
Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica. Docente: Dr. Giorgio Pia
 Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica Docente: Dr. Giorgio Pia Proprietà allo stato fresco Proprietà allo stato fresco Il Calcestruzzo fresco deve poter essere Questo è possibile se
Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica Docente: Dr. Giorgio Pia Proprietà allo stato fresco Proprietà allo stato fresco Il Calcestruzzo fresco deve poter essere Questo è possibile se
CAMPIONAMENTI ALLE EMISSIONI
 CAMPIONAMENTI ALLE EMISSIONI PORTATA Metodica di riferimento: UNI 10169 del 31/12/2001 Strumentazione: Punti di misurazione: Area della sezione di Tubo di Pitot di cui si conosca la costante Micromanometro
CAMPIONAMENTI ALLE EMISSIONI PORTATA Metodica di riferimento: UNI 10169 del 31/12/2001 Strumentazione: Punti di misurazione: Area della sezione di Tubo di Pitot di cui si conosca la costante Micromanometro
SCHEDA DATI DI SICUREZZA. Sabbia silicea
 S.E.I. SpA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (REGOLAMENTO CE 453/2010) Rev. 3 Data 30/9/2011 SABBIA SILICEA 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA Descrizione del prodotto Altre
S.E.I. SpA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (REGOLAMENTO CE 453/2010) Rev. 3 Data 30/9/2011 SABBIA SILICEA 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA Descrizione del prodotto Altre
PRESENZA DI METALLI PESANTI NELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO SU STRADE E PIAZZALI DELLE AREE INDUSTRIALI E IMPLICAZIONI PER IL TRATTAMENTO
 PRESENZA DI METALLI PESANTI NELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO SU STRADE E PIAZZALI DELLE AREE INDUSTRIALI E IMPLICAZIONI PER IL TRATTAMENTO Qualità delle acque. In prima analisi, a partire dagli idrogrammi
PRESENZA DI METALLI PESANTI NELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO SU STRADE E PIAZZALI DELLE AREE INDUSTRIALI E IMPLICAZIONI PER IL TRATTAMENTO Qualità delle acque. In prima analisi, a partire dagli idrogrammi
