IMAGING MEDICO NUCLEARE DELLE INFEZIONI-INFIAMMAZIONI
|
|
|
- Casimiro Giordano
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IMAGING MEDICO NUCLEARE DELLE INFEZIONI-INFIAMMAZIONI A cura del Gruppo Italiano di Studio Infezioni-Infiammazioni Estensori: Alberto Biggi, Luca Burroni, Diego De Palma, Paola Anna Erba, Angela Cataldi, Elena Lazzeri, Giulia Manfredini, Napoleone Prandini, Brunella Rossi, Alberto Signore, Martina Sollini, Annibale Versari, Anna Laura Viglietti, Massimiliano Casali. Revisione 2017 di Luca Burroni Introduzione Imaging medico nucleare delle endocarditi e di infezioni di apparecchiature mediche elettroniche a residenza Imaging medico nucleare delle infezioni sternali Imaging medico nucleare della febbre di ndd Imaging medico nucleare delle vasculiti dei grossi vasi Imaging medico nucleare nelle infezioni del sistema nervoso centrale Imaging medico nucleare nelle infezioni osteomuscolari Imaging medico nucleare dei processi infettivi della colonna vertebrale Imaging medico nucleare delle malattie infiammatorie croniche dell intestino Imaging medico nucleare delle lesioni aterosclerotiche Imaging medico nucleare del piede diabetico Imaging medico nucleare della sarcoidosi Imaging medico nucleare delle protesi vascolari
2 INTRODUZIONE Lo scopo dell imaging medico-nucleare nello studio delle patologie infettive-infiammatorie è quello di identificare la sede del processo infettivo, di guidare il clinico per la scelta terapeutica e di valutare la risposta alla terapia. L infiammazione acuta è caratterizzata da un aumento di flusso ematico e da una alterata permeabilità capillare con conseguente trasudazione di proteine plasmatiche (inclusi fattori del complemento e anticorpi) e di leucociti nel tessuto infetto. Nell infiammazione cronica le cellule infiltranti sono invece costituite prevalentemente da macrofagi, linfociti, monociti e plasmacellule con associata proliferazione di vasi sanguigni e fibrosi. L infezione si differenzia dall infiammazione per la presenza di germi (generalmente batteri) che provocano un attiva diapedesi delle cellule immunocompetenti, costituite prevalentemente da granulociti neutrofili. Con riferimento alle differenti popolazioni cellulari e molecolari che caratterizzano il processo infettivo acuto e cronico, sono stati individuati radiofarmaci in grado di marcare molte delle componenti presenti in queste patologie: - Patologia flogistica acuta: Leucociti o granulociti autologhi marcati con 99m Tc-HMPAO o con 111 In-oxina, 99m Tc-Anticorpi antigranulociti (MoAb), 67 Gallio-citrato ( 67 Ga), 18 F-Fluorodesossiglucosio (FDG), 99m Tc-Difosfonati (HDP/MDP). - Patologia flogistica cronica: 67 Ga. I radiofarmaci descritti (sia le preparazioni da kit, sia quelli impiegati per allestire preparazioni estemporanee), hanno regolare autorizzazione all immissione in commercio (AIC) che ne consente l utilizzo per la diagnostica infettivologica. L indagine medico-nucleare da eseguire per la diagnostica delle patologie infettive-infiammatorie comprende alcune fasi: fase di pre-esame (fase di prenotazione e di accettazione medica con verifica delle controindicazioni e precauzioni da osservare), fase di iniezione del radiofarmaco, fase di acquisizione, elaborazione ed interpretazione delle immagini e fase di refertazione con valutazione delle possibili sorgenti di errore. Alcune di queste fasi sono uguali qualunque sia l indagine medico-nucleare da eseguire altre cambiano a seconda della procedura diagnostica. Riportiamo di seguito le fasi comuni delle indagini medico-nucleari che saranno comunque riportate in dettaglio, nelle schede seguenti, divise per patologia. INDICAZIONI vedi schede patologia CONTROINDICAZIONI GENERALI Stato di gravidanza in atto Scarsa compliance del paziente Grave leucopenia in caso di 99m Tc-HMPAO/ 111 In-leucociti misti autologhi o granulociti puri (G.B. < 2000) Allattamento (sospensione facoltativa in caso di scintigrafia con 99m Tc-
3 Difosfonati e di PET/TC con 18 F-FDG, interruzione definitiva in caso di scintigrafia con 67 Ga e comunque da valutare sul singolo caso con il medico prescrivente e l esperto in fisica medica) Assunzione di insulina/anti-diabetici orali < 6 ore o elevati valori di glicemia in caso di PET con 18 F-FDG (> di 180 mg%) Presenza di anticorpi anti HAMA in caso di pregresse somministrazioni di anticorpi monoclonali ( 99m Tc-MoAb antigranulociti) o mancato digiuno < 6 ore. PROCEDURA PRE-ESAME Prenotazione dell esame Accettazione Medica Verifica dell appropriatezza del quesito clinico proposto nella richiesta. Raccolta delle informazioni anagrafiche, clinico-anamnestiche, esami emato-chimici (VES, PCR, es. emocromo ed emocoltura quando indicata) e strumentali inerenti il quesito clinico che dovranno essere portate al momento dell esecuzione dell esame. Verifica della capacità del paziente di eseguire l esame (assenza di claustrofobia) e di completare le varie acquisizioni dell indagine (in particolare l acquisizione dopo 24 h nel caso fosse necessaria) e di rimanere in clinostatismo fermo sul lettino per tutta la durata dell esame (almeno 40 minuti quando è eseguita l acquisizione SPECT o SPECT-CT). Sospensione se indicato e possibile dei farmaci noti per interferire con la funzionalità dei leucociti o con la biodistribuzione di 67 Ga o di 18 F-FDG. Per garantire il massimo di accuratezza diagnostica in caso di PET/TC con 18 F-FDG si raccomanda di eseguire l'esame in fase acuta di malattia. Consegna al paziente di tutte le informazioni inerenti l esame (data di esecuzione, modalità di svolgimento, preparazioni specifiche ed istruzioni circa la eventuale sospensione dei farmaci interferenti). Conferma della appropriatezza del quesito clinico, della corretta comprensione da parte del paziente delle caratteristiche dell esame che gli è stato richiesto e delle procedure a cui verrà sottoposto. Firma del trattamento dei dati sensibili. Firma del consenso informato. Controllo della glicemia nel caso di indagine PET/TC (deve essere < di 180 mg%). Verifica controindicazioni (vedi paragrafo controindicazioni ) PRECAUZIONI Osservanza delle norme e raccomandazioni radioprotezionistiche. Mettere in atto tutte le procedure tracciabili che consentano di identificare il radio-farmaco, il paziente e la siringa da somministrare. Per quanto riguarda la marcatura degli elementi del sangue come quella dei globuli bianchi devono essere adottate precauzioni simili a quelle adottate per le trasfusioni di sangue. Pertanto è necessario adottare procedure che, a partire dal prelievo del campione di sangue, fino a tutta la procedura di marcatura e alla somministrazione dei globuli bianchi marcati, garantiscano sempre la corretta identificazione del campione di sangue e del paziente, nonché la corretta applicazione delle Norme di Buona Preparazione (NBP) dei radiofarmaci.
4 I globuli bianchi marcati devono essere reiniettati il più rapidamente possibile (entro 30 minuti dalla marcatura e non oltre 3-4 ore dal prelievo). RADIOFARMACI E DOSI vedi schede patologia 99m Tc-HMPAO leucociti o granulociti puri 111 In-ossina leucociti o granulociti puri L attività negli adulti è quella prevista dagli LDR (370 MBq) anche se può essere giustificato modificare la dose qualora siano necessarie acquisizioni tomografiche, in particolare in fase tardiva. Nei bambini i volumi di sangue prelevati devono essere proporzionati al peso corporeo mentre l attività da somministrare deve seguire le raccomandazioni previste nelle linee guida pediatriche (EANM Dosage Card). L attività negli adulti è quella prevista dagli LDR (20 MBq). Per motivi radiprotezionistici, l utilizzo di questo radiofarmaco nei bambini dovrebbe essere attentamente valutato e quando possibile sostituito con 99m Tc- HMPAO; se indicato, l attività da somministrare deve seguire le raccomandazioni previste nelle linee guida pediatriche (EANM Dosage Card). 99m Tc-MoAbantigranulociti In queste LG procedurali indicheremo con il termine di MoAb antigranulociti tutti i prodotti AIC utilizzabili in Italia che riconoscono antigeni presenti sulla superficie granulocitaria indipendentemente dalla loro struttura molecolare: anticorpi interi (IgG1 e IgM) e frammenti anticorpali (Fab e F(ab ) 2. Il loro utilizzo prevede un attività somministrata pressoché identica e un altrettanto identica modalità di acquisizione scintigrafica. L utilizzo di MoAb può indurre la formazione di anticorpi umani verso antigeni murini (HAMA); è pertanto raccomandabile dosare gli HAMA del paziente in caso di somministrazioni ripetute. L attività negli adulti è quella prevista dagli LDR (740 MBq) anche se può essere giustificato modificare la dose qualora siano necessarie acquisizioni tomografiche, in particolare in fase tardiva. L utilizzo di questo radiofarmaco nei bambini dovrebbe essere attentamente valutato e quando possibile sostituito con 99m Tc-HMPAO; se indicato, l attività da somministrare deve seguire le raccomandazioni previste nelle linee guida pediatriche (EANM Dosage Card). 18 F-FDG 99m Tc- Difosfonati 67 Ga L attività negli adulti è tipicamente 4-5 MBq/Kg. L attività deve essere calibrata in funzione della strumentazione disponibile. Se impiegato nei bambini, l attività da somministrare deve seguire le raccomandazioni previste nelle linee guida pediatriche (EANM Dosage Card). L attività negli adulti è tipicamente 740 MBq ( MBq). Per l utilizzo pediatrico l attività da somministrare deve seguire le raccomandazioni previste nelle linee guida pediatriche (EANM Dosage Card). L attività negli adulti è quella prevista dagli LDR, tipicamente 185 MBq ( MBq). Non esistono al momento indicazioni cliniche per l utilizzo di questo radiofarmaco nei bambini; se indicato, l attività da somministrare deve seguire le raccomandazioni previste nelle linee guida pediatriche (EANM Dosage Card).
5 PROTOCOLLO ACQUISIZIONE vedi schede patologia Scintigrafia con Leucociti marcati con 99m Tc-HMPAO / 111 In-Ossina Sc. con 99m Tc- MoAb-anti granulociti Scintigrafia con 67 Ga 18 F-FDG PET o PET/TC Sono stati descritti numerosi protocolli per l acquisizione delle immagini planari, total-body e SPECT nella scintigrafia con leucociti marcati, MoAb anti-granulociti e 67 Ga. Minor variabilità è riportata per l acquisizione di immagini PET con 18 F-FDG. Dato che non vi è chiara evidenza scientifica che un protocollo sia migliore di altri, riportiamo di seguito solo dei concetti generali di base cui sarebbe opportuno attenersi. Per l acquisizione di immagini con 99m Tc-HMPAO è consigliato l utilizzo di collimatore Low Energy High Resolution (140 KeV con finestra del 20%). Per l acquisizione di immagini con 111 In-Ossina è consigliato l utilizzo di collimatore Medium Energy (171 e 245 KeV con finestra del 20%) L acquisizione di immagini precoci (entro 60 minuti) con scansione totalbody (Matrice 128x512. Acquisizione 10 min/m) con particolare riferimento all attività di polmone, fegato e milza è necessaria per il controllo di qualità in vivo. Il rapporto della captazione milza/fegato deve essere sempre superiore a 1 e la captazione polmonare assente. Successivamente devono essere eseguite statiche planari delle regioni di interesse, queste acquisizioni possono essere eseguite a conteggio o a tempo. La scelta della metodica di acquisizione sarà effettuata in funzione della regione corporea da studiare. Le acquisizioni necessitano della correzione delle immagini tardive per il decadimento del radioisotopo. Acquisizione di immagini tardive (dopo 2 o 4 e 24 ore) variabile a seconda della patologia in esame (vedi Schede patologia). Le acquisizioni tardive planari (eseguite a conteggio o a tempo) possono essere seguite da acquisizione SPECT o SPECT/TC. L acquisizione SPECT/TC risulta essere fondamentale in certe patologie (vedi schede patologia). Le acquisizioni scintigrafiche sono eseguite dopo 4 e 24 ore dall iniezione e.v. del radiofarmaco con le stesse modalità dei leucociti marcati (vedi sopra). Per l acquisizione di immagini è consigliato l utilizzo di collimatore Medium Energy (93, 184 e 300 KeV con finestra del 20%). Le acquisizioni scintigrafiche sono eseguite a 6, 24, 48 e se necessario anche a 72 ore. Per il 67 Ga non è indispensabile l acquisizione a tempo, dato che il confronto delle immagini precoci e tardive si basa quasi esclusivamente sull analisi di aree di captazione non fisiologiche. Si consiglia l acquisizione di immagini con buona statistica di conteggio ( conti minimo) ed eventualmente integrare con acquisizione SPECT/TC (vedi schede patologie). Acquisizione standard total-body dopo 1 ora dall iniezione e.v. del 18 F-FDG con acquisizione di una immagine emissiva total body (dal vertice al terzo superiore di coscia), preceduta da un esame TC low-dose necessario per la ricostruzione di immagini topografiche corrette per l attenuazione fotonica. Acquisizione total-body (6-7 lettini) con tempo di acq, 2-4 min/lettino in funzione dell apparecchio. Le immagini possono essere acquisite sia in modalità 2D sia in 3D.
6 ELABORAZIONE vedi schede patologia Immagini SPECT, SPECT/TC e PET/TC: Riorientamento delle immagini secondo i piani coronale, transassiale e sagittale. Calcolo semiquantitativo del valore di uptake standardizzato (SUV) calcolato come rapporto tra l accumulo di 18 F-FDG (MBq/ml) in un area di interesse (disegnata sulle immagini corrette per l attenuazione) e l attività somministrata per il peso (kg) o la superficie corporea (cm 2 ). Il SUV deve essere valutato sulla parte della lesione con maggiore attività. INTERPRETAZIONE vedi schede patologia Generale La corretta interpretazione degli esami utilizzati nello studio della patologia infettivo-infiammatoria richiede la conoscenza della normale biodistribuzione dei diversi radiofarmaci e delle varianti normali. Nel caso di scintigrafia con globuli bianchi marcati ad esempio devono essere considerate le regioni di biodistribuzione normali: il rapporto di captazione fegato/milza predilige la milza; una captazione di leucociti che privilegia il fegato riflette scarsa vitalità della popolazione cellulare somministrata. La clearance dei globuli bianchi dal sangue ha un t 1/2 di circa 4 ore e pertanto è possibile visualizzare attività circolante a livello di cuore, polmone e grossi vasi anche in immagini tardive (più di 4 ore). Per tale motivo è raccomandato completare sempre con acquisizioni tardive lo studio di distretti con alta attività circolante. Con i globuli bianchi marcati con 99m Tc-HMPAO si osserva attività a livello intestinale derivante da una eliminazione attraverso il sistema epatobiliare del complessi idrofilici di 99m Tc che compare generalmente non prima di 2 ore e 30 minuti nell adulto (nel 20-30% di bambini ad 1 ora), l attività è generalmente piuttosto bassa e interessa l ileo terminale o il colon destro con tendenza ad incrementare e muoversi nel tempo. Può essere presente attività in sede colecistica nel 4% di pazienti normali a 2-4 ore e nel 10% a 24 ore. Sono normalmente visualizzati milza, fegato e midollo osseo. Si osserva, inoltre, attività a livello del rene e della vescica a partire da in tutti i pazienti con funzione renale normale; pertanto prima di iniziare un acquisizione della pelvi è necessario far svuotare la vescica al paziente. Con i globuli bianchi marcati con 111 In-oxina in condizioni normali non si osserva attività a livello intestinale (questo costituisce un vantaggio nello studio delle patologie infiammatorie intestinali) mentre il radiofarmaco si concentra prevalentemente nel sistema reticolo endoteliale del fegato, della milza e del midollo. La biodistribuzione normale dei MoAb anti-granulociti presenta caratteristiche simili a quanto descritto per le cellule autologhe marcate ad eccezione di una riduzione del rapporto di captazione tra milza e fegato ed una maggior componente in sede midollare ossea. La normale immagine della biodistribuzione del 67 Ga presenta una localizzazione del radiofarmaco a livello di organi del sistema reticolo endoteliale (con prevalente captazione epatica rispetto alla captazione splenica) e una clearance epatobiliare che determina la progressiva visualizzazione del tratto enterico.
7 Analisi semiquantitativa Il 18 F- FDG presenta un normale ed intenso accumulo di tracciante a livello del SNC e del sistema urinario. La captazione epatica è variabile così come quella presente a livello del miocardio (prevalentemente ventricolo sinistro). Si parla generalmente di valori di SUV patologici se > di 2.4. E sempre utile (specie per le scintigrafie con leucociti e MoAb antigranulociti) considerare l andamento nel tempo dell attività midollare in una regione di riferimento (es. sterno o cresta iliaca). I criteri generali di positività della scintigrafia con leucociti marcati e MoAb sono i seguenti: - Aumento dell attività (o del rapporto bersaglio/fondo) in una determinata area nel corso del tempo (prevalentemente tra 4 e 24 ore). - Aumento dell estensione dell area di sospetta captazione patologica nel corso del tempo. L interpretazione delle immagini patologiche è descritta nelle schede patologia L analisi di immagini SPECT/TC o PET/TC può rivelarsi fondamentale per localizzare esattamente la sede della lesione flogistica (es. distinzione tra tessuti molli ed ossei nell infezione dell apparato osteo-muscolare). Nei casi dubbi, e se non è stato effettuato uno studio midollare con colloidi, può essere utile calcolare l andamento nel tempo del rapporto bersaglio/fondo (aree di fondo su midollo sano). Il calcolo del rapporto bersaglio/fondo (ottenuto mediante conteggio di Regioni di Interesse (ROI) su area patologica e fondo) può aiutare nella differenziazione tra processo flogistico settico e/o asettico. Quando il rapporto bersaglio/fondo aumenta con il passare del tempo la scintigrafia è considerata positiva per presenza di infezione, quando il rapporto si mantiene invariato o diminuisce lievemente nel tempo l esame è considerato dubbio e quando invece il rapporto diminuisce significativamente la scintigrafia è considerata negativa per presenza di infezione. REPORT FINALE DELL INDAGINE MEDICO-NUCLEARE In generale il report finale può essere suddiviso in cinque parti: Identificazione Quesito clinico Procedura Corpo del testo E la parte che comprende i campi che identificano il paziente, la struttura in cui si è svolto l esame, la data dell esame, il tipo di esame eseguito (derivato dal tariffario nazionale) il nome commerciale del radiofarmaco e la dose di radiofarmaco somministrata al paziente (in MBq) ed il nome del TSRM responsabile dell acquisizione dell esame. I campi che generalmente identificano il paziente sono il nome, il cognome, la data di nascita, il numero di archivio con cui il paziente viene identificato in Medicina Nucleare. E la parte dedicata al quesito clinico ed eventuale sintesi della storia clinica del paziente. E la parte dedicata alla descrizione della strumentazione utilizzata, della via di somministrazione del radiofarmaco e della modalità di acquisizione dei dati. E la parte in cui si descrive l esame sia un punto di vista visivo e/o semiquantitativo, specificando in quest ultimo caso anche il tipo di analisi eseguita, l eventuale confronto con database di normalità, l eventuale utilizzo della TC ecc. In dettaglio, l analisi visiva deve specificare la presenza/assenza di uptake del radiofarmaco e quale sia la sede interessata dalla captazione.
8 L analisi deve descrivere in modo analitico le aree di captazione patologica del radiofarmaco eventualmente presenti nella/e sede/i esaminate, le dimensioni della/e area/e di captazione (quando possibile espresse in termini numerici), l entità di captazione relativamente a sedi di normale captazione di tracciante (in funzione della diversa tipologia di esame) eventualmente supportata da dati semiquantitativi. In questa parte occorre inoltre specificare l eventuale presenza di fattori che possono aver limitato la sensibilità e la specificità dei risultati come ad esempio la presenza di artefatti da movimento. Conclusioni E la parte in cui si risponde in modo chiaro e conclusivo al quesito clinico proposto tenendo conto dell insieme dei dati clinici e di eventuali altre tecniche di imaging effettuate in precedenza. Vengono inoltre suggerite eventuali procedure diagnostiche da effettuare per confermare o escludere le ipotesi diagnostiche formulate e la tempistica degli eventuali controlli. Nella descrizione della presenza o assenza di captazione del radiofarmaco e quindi sulla presenza/assenza di malattia, devono essere specificate le strutture anatomiche interessate, l estensione e l intensità di captazione. Al termine delle conclusioni deve comparire il nome e cognome del Medico Nucleare refertante. La struttura deve tenere copia documentale che permetta di tracciare le procedure e gli operatori coinvolti nei diversi processi (TSRM, Infermiere Professionale, Biologo; Chimico, ecc.). Presenza artefatti di SORGENTI DI ERRORE E possibile avere immagini artefatte per numerosi motivi, tra cui i più frequenti sono: movimento del paziente strumentazione utilizzata per l acquisizione dell esame (ad esempio, non corretto centro di rotazione, difetti di uniformità della testata, non corretta fusione delle immagini SPET con le immagini CT) eccessiva correzione dell attenuazione per presenza di materiale chirurgico, protesi meccaniche (in questo caso privilegiare le immagini non corrette per l attenuazione) radiofarmaco (contaminazione superficiale, distribuzioni anomale, stravaso e somministrazione attraverso accessi venosi, etc.). DOSIMETRIA RADIOFARMACI Per la dosimetria si rimanda ai foglietti illustrativi dei vari radiofarmaci utilizzati. FARMACI CHE INTERFERISCONO CON ESAMI SCINTIGRAFICI E/O PET/TC Alcuni farmaci possono interferire con la sensibilità di alcune indagini mediconucleari nell ambito della diagnostica infettivo-infiammatoria, si raccomanda pertanto, durante la raccolta anamnestica, particolare attenzione alla terapia eseguita dal paziente.
9 Leucociti marcati Classe Farmacologica Antibiotici beta lattamici Immunosoppressori Corticosteroidi Calcio-antagonisti Anticoagulanti Sulfamidici Ferro Nome del Farmaco Cefalosporine Azatioprina Ciclofosfamide Prednisolone Nifedipina Eparina Sulfasalazina Ferro Farmaci che possono influenzare l analisi visiva e semiquantitativa degli studi con 99m Tc-HMPAO/ 111 In-leucociti misti autologhi 18 F-FDG Classe Farmacologica Corticosteroidi Antiepilettici Catecolamine Nome del Farmaco Prednisolone Valproato Carbamazepina Fenitoina Fenobarbital Catecolamine Farmaci che possono influenzare l analisi visiva e semiquantitativa degli studi con 18 F-FDG per modificazione dei livelli glicemici 67 Ga Classe Farmacologica Terapia marziale Chemioterapici Corticosteroidi Gd DTPA (se assunto nelle 24 precedenti) Nome del Farmaco Ferrograd Tutti anche dopo 3 mesi dalla sospensione Prednisolone Farmaci che possono influenzare l analisi visiva degli studi con 67 Ga
10 IMAGING MEDICO NUCLEARE DELLE ENDOCARDITI E DELLE INFEZIONI DA APPARECCHIATURE MEDICHE ELETTRONICHE A RESIDENZA Indicazioni Sospetta IE in pazienti con protesi valvolare. La positività nella sede dell impianto protesico dimostrata alla 18 F-FDG PET/CT (solo se la protesi è stata posizionata da più di 3 mesi) o alla WBC SPECT/CT è considerate un criterio maggiore dei nuovi European Society of Cardiology 2015 modified criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Identificazione degli eventi embolici (escluso il SNC se non è utilizzata cect) o di aneurismi infettivi. La diagnosi di un evento embolico recente e di aneurismi micotici con le sole tecniche di imaging (eventi embolici silenti) deve essere considerate un criterio minore dei nuovi European Society of Cardiology 2015 modified criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Sospetta infezione di Cardiovascular Implantable Electronic Devices (CIED) con emocoltura positiva e ecocardiografia negativa (Class IIb
11 level of evidence C). Procedure Pre-esame verifica della esecuzione di ecocardiografia trans-toracica/trans-esofagea ripetuta nel caso di sospetto non confermato, emocoltura, indagini biochimiche e altre metodiche di imaging. Preparazione del paziente WBC SPECT/CT 18 F-FDG PET/CT Preparazione del paziente per minimizzare l accumulo fisiologico di 18 F-FDG nel miocardio normale: protocollo secondo correnti line guida SNMMI/ASNC/SCCT raccomanda h di dieta senza carboidrati prima dell esame e digiuno per 12-18h, e/o somministrazione i.v. di eparina a basso peso molecolare circa 15 minuti prima della somministrazione di 18 F-FDG. i dati della letteratura supportano l uso di una dieta HFLC per almeno 2 pasti con un digiuno di almeno 4 h. Digiuno e riposo vanno mantenuti dopo l iniezione di 18 F-FDG. La sospensione o la riduzione al minor dosaggio possibile dei corticosterioidi per le 24h precedente l indagine è raccomandata.
12 Protocollo di Acquisizione A. Leucociti autologhi marcati: Nel caso di infezioni di CIED assicurarsi che la tasca del generatore sia inclusa nel campo di vista, considerando tutte le possibili varianti (es. addome). SPECT/CT obbligatoria a 4-6 h e/o a h p.i. B. 18 F-FDG PET/CT Non ci sono sufficienti dati per raccomandare l acquisizione tardiva a 3h raddoppiando il tempo/lettino, anche se uno studio ne suggerisce l'utilità nel caso di infezioni di CIED. Anche se l embolizzazione nel SNC è frequente e condizionante il management dei pazienti, la scarsa sensibilità della PET/TC in questo distretto quando la TC è solo basale, non ne raccomanda l inclusione. Al contrario alcuni reports suggeriscono l importanza di includere le estremità per definire la presenza di aneurismi micotici. Interpretazione WBC
13 Parametri da definire: presenza e co-localizzazione delle aree di aumentata captazione con le anomalie strutturali definite all ecocardiografia localizzazione ed estensione della captazione, in particolare in presenza di PVE presenza e localizzazione di sedi extra-cardiache di infezione 18 F-FDG PET/TC Definizione della captazione nel sito target : pattern (focale, lineare, diffuso), intensità e estensione. Confronto con le immagini TC soptrattutto se vi è contemporanea acquisizione di CeCT. Attenzione a: protesi impiantate da meno di 3 mesi e al pattern di captazione lineare perivalvolare mild che può perdurare a lungo. Nel caso di infezioni di CIED considerare sempre il tragitto degli EC dalla tasca alle cavità cardiache e ricordare che le captazioni in corso di infezione possono essere in una qualsiasi delle porzioni del device ed apparire lineari e con bassa attività. Valutazione della presenza e localizzazione di sedi extra-cardiache di infezione (in genere sono tutte aree caratterizzate da aumentata captazione, ma possono essere anche molto piccole), inclusi il SNC, i vasi periferici, la milza. Report Finale I risultati delle indagini scintigrafiche e/o PET-CT vanno discussi ed interpretati all interno di un Endocarditis Team (recommendation class IIa level of evidence B) Sorgenti di errore WBC FN più frequenti a causa della presenza di biofilm, soprattutto nei CIED (Candida o Enterococcus spp., S. Epidermidis), della capacità di alcune specie microbiche (E. faecalis) di diminuire il recruitment di WBC nella sede di infezione e in caso di vegetazioni piccole (<1 cm). 18 F-FDG PET/TC Sono causa di FP: l ipertrofia lipomatosa, la reazione flogistica post-chirurgica, trombi recenti, placche aterosclerotiche, vasculiti, neoplasie, endocardite di Libman-Sacks. Per questo è necessario che la lettura e l interpretazione delle immagini PET avvenga sempre con la valutazione della TC e di tutte le altre informazioni cliniche e diagnostiche a disposizione e la discussione del risultato nell ambito dell Endocarditis Team.
14 La terapia antimicrobica e le piccole dimensioni delle vegetazioni possono essere causa di FN. IMAGING MEDICO NUCLEARE DELLE INFEZIONI STERNALI Indicazioni Valutazione delle complicanze infettive di pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia toracica che sono sintomatici con leucocitosi, aumento della VES, della PCR e colture dubbie dell aspirato. Follow-up e monitoraggio della risposta alla terapia antibiotica. Diagnosi differenziale tra infezione superficiale o profonda. Procedure Pre-esame Raccolta di notizie riguardanti altre indagini diagnostiche (esami di laboratorio, coltura batterica dell aspirato proveniente dal tessuto osseo che permette la diagnosi differenziale tra infezione superficiale e profonda, Rx, TC, RM ed ecografia dei tessuti molli). Radiofarmaco A. 99m Tc-HMPAO/ 111 In-ossina leucociti o granulociti puri: B. 99m Tc-MoAb-antigranulociti: Scelta dell indagine: la scintigrafia con leucociti marcati con acquisizioni planari nel tempo, con acquisizioni a tempo, corretto per il decadimento, ed acquisizioni SPECT e SPECT-CT a 20 h è l indagine di scelta in fase diagnostica e per il monitoraggio della risposta al trattamento antibiotico. Protocollo di Acquisizione Elaborazione A. B. Immagini planari Acquisizione di statica planare (30 minuti, 3-4 ore e ore) e SPECT o SPECT-CT del torace a 4-6 ore o 20 ore. E raccomandato l utilizzo di una gamma-camera a due teste oppure preferenzialmente con TC. Le acquisizioni seriate nel tempo devono essere acquisite a tempo corretto per il decadimento dell isotopo.. A. B. Immagini SPECT/CT Le acquisizioni SPECT dipendono dalla dose somministrata. Generalmente sullo sterno è sufficiente un acquisizione di sec/step per le SPECT a 3-4h e di sec/step per le SPECT a h. A. B. Immagini planari Le immagini acquisite devono essere proiettate in scala assoluta di colpi e non in percentuale del pixel massimo Valutazione qualitativa delle aree di patologica captazione in regione sternale e/o mediastinica. A. B. Immagini SPECT/CT Elaborazione standard con filtro Hanning o Iterativa
15 Interpretazione Per valutare le immagini bisogna considerare: E considerato patologica una captazione a livello sternale di entità superiore a quella fisiologica del midollo che incrementa in immagini tardive (confronto tra 4 e 20 ora). Un eventuale interessamento mediastinico è documentabile unicamente attraverso l imaging SPET o meglio SPET/CT. Valutazione qualitativa: un aumento di captazione nel tempo (confronto tra 4 e 20 ora) sternale e/o mediastinica è indicativo di patologia flogistica. Valutazione semiquantitativa: Pattern I: intenso ed irregolare uptake a livello dello sterno, che incrementa da 4 a 20 ore. Tale reperto indica la presenza di infezione profonda. Pattern II: regolare uptake a binario a livello sternale che non si modifica o riduce tra 4 e 20 ore. Tale distribuzione indica la presenza di infezione superficiale. Pattern III: scarsa intensità di captazione con distribuzione uniforme a carico di tutto lo sterno, che si riduce nel tempo. Tali reperti indicano assenza di patologia flogistica settica. Cause che possono determinare risultati falsi negativi o falsi positivi (es. mancata pulizia della ferita prima di eseguire le acquisizioni scintigrafiche) Report Finale Conclusioni: è la risposta al quesito clinico proposto circa la presenza/esclusione di infezione sternale superficiale o profonda. Sorgenti di errore E particolarmente importante eseguire la pulizia della ferita chirurgica. IMAGING MEDICO NUCLEARE nella FEBBRE di ndd Indicazioni Per febbre di natura da determinare (ndd) si intende una febbre >38,3 C per un periodo superiore a 3 settimane di cui non si è trovata una causa dopo una settimana di indagini diagnostiche approfondite in ricovero ospedaliero (Petersdorf) Ricerca della possibile causa: Infiammazione Infezione Neoplasia Identificazione della sede del processo infettivo/infiammatorio per ulteriori indagini (imaging, biopsia, ecc) Valutazione dell estensione di malattia
16 Radiofarmaco e dosi Protocollo di Acquisizione A. 99m Tc-HMPAO/ 111 In-ossina leucociti o granulociti puri: B. 18 F-FDG : Scelta dell indagine: la scintigrafia con leucociti marcati è indicata in caso di elevato sospetto di febbre settica. L indagine PET/TC con 18 F-FDG va preferita nel caso si ritengano più probabili altre ipotesi diagnostiche (infiammazione, vasculite, neoplasia), nel caso in cui le condizioni del paziente richiedano una procedura più rapida o nei casi in cui sia richiesta la verifica di assenza di malattia settica. A. 99m Tc-HMPAO Leucociti: B. 111 In-Ossina Leucociti: Metodiche acquisizioni total-body: Le acquisizioni total-body seguite dalle acquisizioni planari (A-P) vengono eseguite dopo 30 minuti, 4-6 e ore dall iniezione e.v. dei leucociti marcati. Le acquisizioni planari dovrebbero essere acquisite correggendo il tempo per il decadimento dell isotopo. L acquisizione SPECT o SPECT/TC dovrà essere eseguita in tempi diversi a seconda della regione corporea studiata (es: non oltre le 2 ore e 30 minuti per lo studio dell addome, dopo ore per lo studio del cuore). B 18 F-FDG: Elaborazione A. Immagini scintigrafiche SPECT o SPECT/TC Nel caso il paziente sia portatore di protesi o devices metallici, nelle scansioni ibride SPET/TC e PET/TC è necessario valutare sempre le immagini non corrette per l attenuazione, data la possibilità di artefatti susseguenti alla correzione per l attenuazione standard in presenza di oggetti metallici. Interpretazione Analisi qualitativa o visiva: tutte le aree di accumulo leucocitario, crescente nel tempo, devono essere considerate come potenzialmente patologiche (infezione). Le aree di accumulo leucocitario, stabile o decrescente nel tempo, dovrebbero essere considerate compatibili con patologia infiammatoria. Tutte le aree di accumulo del radiofarmaco (leucociti o 18 F-FDG) devono essere descritte nel referto indicando anche, qualora possibile, la diagnosi più probabile. Questa possibilità è legata anche ad un attento confronto con le indagini morfologiche disponibili in caso l indagine sia stata eseguita con SPECT/TC o PET/TC. IMAGING MEDICO NUCLEARE DELLE VASCULITI DEI GROSSI VASI Indicazioni Conferma del sospetto di vasculite dopo indagini di primo e secondo livello Valutazione delle sedi e dell estensione del processo infiammatorio Valutazione dell attività di malattia Valutazione della risposta alla terapia Sospetta recidiva clinico/laboratoristica di vasculite dei grandi vasi
17 Radiofarmaco 18 F-FDG Protocollo di Acquisizione Interpretazione L acquisizione va estesa fino al 1/3 inferiore della coscia. Analisi qualitativa o visiva: Valutare le sedi di iperfissazione per i seguenti distretti vascolari: arterie carotidi, ascellari, succlavie, iliache comuni, femorali, aorta toracica (aorta ascendente, arco aortico, aorta discendente), ed addominale. L approccio analitico visivo di Meller et al (EJNMMI, 2003), ad oggi il più comunemente utilizzato, rapporta la captazione vascolare a quella del parenchima epatico presa come riferimento, secondo quattro gradi di intensità: grado 0: assenza di captazione grado 1: captazione inferiore a quella epatica grado 2: captazione pari a quella epatica grado 3: captazione superiore a quella epatica Questa modalità di valutazione possiede alcuni vantaggi rispetto ad altri metodi: quello di essere più immediato per l operatore, meno timeconsuming, di possedere un elevata specificità (circa 100%, ma con livelli di sensibilità variabili tra il 56% ed il 77%), e un elevata riproducibilità inter- ed intra-osservatore (90% e 93% rispettivamente). L analisi visiva deve prendere in considerazione i seguenti parametri: - la tipologia di up-take (lineare, segmentaria, o focale): generalmente nel processo vasculitico la distribuzione del tracciante è tipo diffuso (o inizialmente segmentaria), mentre le captazioni di tipo focale possono essere facilmente attribuibili a fenomeni aterosclerotici (apprezzabili alla componente CT della PET). - l intensità di captazione vascolare: un grado visivo superiore a quello epatico (Grado 3) può essere considerato indicativo di processo vasculitico in atto. Un grado di captazione vascolare pari a quello epatico (Grado 2) può considerarsi sospetto, mentre captazioni di grado inferiore (Grado 0-1), tendono ad escluderne la presenza. Da un recente studio pubblicato (Prieto-Gonzales, 2016), è apparso come, con l avanzare dell età e proprio come accade per la patologia aterosclerotica, fino al 45% dei Pazienti controlli non vasculitici possano esprimere una captazione vascolare di Grado 1, il 14% una di Grado 2, ed il 4% una di Grado 3. Durante la valutazione visiva tenere in considerazione eventuali terapie cortisoniche e/o immunosoppressive del Paziente, in cui un Grado di captazione di tipo 1 potrebbe mascherare una componente flogistica residua (possibili cause: neo-angiogenesi, viraggio della malattia verso la cronicizzazione, resistenza al trattamento). - le arterie femorali possono essere sede di para-fisiologica fissazione di FDG di intensità variabile, per cui solo un grado di captazione pari a 3 in queste sedi può essere considerato indicativo di vasculite. Analisi semi-quantitativa: Sono metodi dotati di maggiore sensibilità rispetto alla sola analisi visiva. Tra i principali descritti in letteratura, vengono riportati: - il TVS (Total Vascular Score): si tratta di un approccio controverso, e tuttora non condiviso, che prevede di prendere in considerazione sette distretti vascolari (arterie carotidi, succlavie, ascellari, iliache, femorali, aorta toracica, aorta addominale), e di assegnare a ciascun distretto un punteggio di captazione (da 0 a 3 ) in base al grado di intensità (punteggio massimo pari a 21). Un TVS pari e/o superiore a 6 ± 0.2 viene considerato altamente specifico per la presenza di malattia vasculitica (Blockmans, 2006 e 2007).
18 - SUVmax vascolare: si tratta anche in questo caso di un approccio controverso e, al momento, non condiviso, in parte per valori di specificità riportati molto bassi (45%, Lehmann et al., 2011), in parte per la riconosciuta mancanza di un database di valori di normalità di riferimento (Prieto-Gonzales ed al., 2014). - Rapporto tra SUVmax vascolare e SUVmax di un organo preso come background: si tratta di un approccio che, basandosi sui valori di SUVmax vascolare e parenchimale di riferimento (epatico, polmonare, pool vascolare), risente dei limiti già indicati in precedenza. Al momento attuale non esiste una condivisione assoluta su quale sia il miglior organo di riferimento da utilizzare. Si citano, tuttavia: il fegato (cut-off = 1, sensibilità diagnostica 90% circa, specificità 94%; Hautzel et al, 2008), il polmone (sensibilità diagnostica 82% circa, specificità 73%; Besson et al, 2013), il pool vascolare a livello di vena cava inferiore o vena giugulare interna (cut-off = 1.53 per il solo arco aortico, sensibilità diagnostica 82% circa, specificità 91%; Besson et al, 2013). Dal punto di vista interpretativo l approccio migliore allo studio della patologia vasculitica con PET/CT sembra essere, pertanto, essere quello di natura visiva qualitativa, considerando la possibilità di affiancare un metodo semiquantitativo nei casi di imaging dubbio. Mooesig e at (2004), applicando in sequenza analisi qualitativa e semi-quantitativa (polmone come organo di riferimento) hanno riportato valori di sensibilità e specificità diagnostica prossimi al 100%. Report Finale Corpo del Testo : La descrizione delle immagini deve comprendere tutte le sedi di captazione vascolare con definizione dell estensione e del grado di intensità secondo la scala sopra descritta. Conclusioni IMAGING MEDICO NUCLEARE NELLE INFEZIONI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE Indicazioni Procedure Pre-esame Lesione cerebrale che si presenta alla CT come una lesione ipodensa con anello periferico ipervascolarizzato Diagnostica delle complicanze settiche e post traumatiche in ambito neurochirurgico Follow-up delle lesioni settiche in ambito neurochirurgico Diagnostica differenziale di lesioni cerebrali in pazienti con HIV Raccolta delle informazioni anagrafiche, clinico-anamnestiche e strumentali inerenti il quesito clinico: in particolare traumi ed interventi neurochirurgici pregressi, abuso di sostanze stupefacenti per via endovenosa, recenti viaggi, contatto con animali, ingestione di carne cruda e verifica della presenza di recenti esami di Imaging morfologico (TC/RM).
19 Radiofarmaco e dosi (attività) A. 99m Tc-HMPAO/ 111 In-ossina leucociti o granulociti puri: B. 18 F-FDG: E consigliato mantenere il paziente in ambiente con bassa stimolazione acustica e visiva per almeno 30 prima della somministrazione del radiofarmaco. Idratare il paziente. Scelta dell indagine: il radiofarmaco preferibile è costituito dal 99m Tc- HMPAO-leucociti; in alternativa può essere utilizzato 111 In-oxina-leucociti. La metodica convenzionale prevede l utilizzo di una popolazione mista di leucociti autologhi; una popolazione di granulociti puri è generalmente riservata ai pazienti pediatrici. Il 18 F-FDG è indicato unicamente nella diagnostica differenziale delle lesione encefaliche in pazienti con HIV.
20 Protocollo di Acquisizione Il protocollo di acquisizione deve essere personalizzato in funzione del quesito e del contesto clinico. Utile un acquisizione statica planare del torace e dell addome entro 60 minuti dall iniezione del radio farmaco (per controllo qualità in vivo). o Nel caso di una lesione encefalica sospetta ascessuale è generalmente sufficiente uno studio planare e SPET dell encefalo. La scelta di una acquisizione total-body può essere giustificata in funzione della ricerca di un focolaio settico occulto, responsabile del processo infettivo encefalico. Tale estensione della acquisizione andrebbe fatta in tutti i casi che hanno uno studio positivo a livello encefalico mentre negli altri casi potrebbe non essere necessaria, salvo casi particolari (ad es. caratterizzazione di reperti dubbi ad altro imaging). Negli studi di follow-up deve essere ripetuto l esame come effettuato in condizioni basali salvo evidenza clinica di progressione del processo infettivo. o Nel caso di una lesione in sede diversa da quella encefalica (ad es. complicanze neurochirurgiche a livello di mezzi di sintesi, etc.) è generalmente sufficiente uno studio planare e SPET del segmento interessato. La scelta di una acquisizione total-body può essere giustificata in funzione della ricerca di un focolaio settico occulto, responsabile del processo infettivo oggetto dello studio. Tale estensione della acquisizione andrebbe fatta in tutti i casi che hanno uno studio positivo a livello della lesione mentre negli altri casi potrebbe non essere necessaria, salvo casi particolari (ad es. caratterizzazione di reperti dubbi ad altro imaging). Negli studi di follow-up deve essere ripetuto l esame come effettuato in condizioni basali, salvo evidenza clinica di progressione del processo infettivo. Scintigrafia con leucociti autologhi marcati A. Lesione encefalica da caratterizzare Radiofarmaco HMPAO-Tc 99m (sufficiente acquisizione a 4 h) Acquisizioni statiche planari dopo 4 ore dall iniezione del radiofarmaco: proiezione anteriore, posteriore, laterale destra e sinistra del cranio. Acquisizione SPECT o meglio SPECT-CT dell encefalo. Radiofarmaco In 111 -Oxina Acquisizioni statiche planari dopo 4 ore dall iniezione del radiofarmaco: proiezione anteriore, posteriore, laterale destra e sinistra del cranio. Acquisizioni statiche planari dopo 24 ore dall iniezione del radio farmaco se non chiaramente positiva nelle immagini precoci : proiezione anteriore, posteriore, laterale destra e sin del cranio. Acquisizione SPECT o meglio SPECT-CT dell encefalo: da eseguire a 4 o a 24 ore a seconda della positività dell esame (meglio eseguirla quando la lesione è più evidente). B. Lesione extra-encefalica da caratterizzare Radiofarmaco HMPAO/In-oxina Acquisizioni statiche planari dopo 4 e dopo 24 ore dall iniezione del radio farmaco della/e sede/i sospetta/e: proiezioni : anteriore, posteriore ed eventuali proiezioni laterali. Acquisizione SPECT o meglio SPECT-CT della sede interessata da eseguirsi quando la la lesione è meglio documentabile nell imaging planare. Nei casi indicati è possibile fare una acquisizione di immagini total-body per ricercare focolai settivi occulti (vedi procedure generale).
21 Elaborazione Interpretazione A. Immagini scintigrafiche SPECT o SPECT/TC Valutazione visiva delle aree di patologica ipercaptazione in regione cerebrale. Valutazione semiquantitativa si effettua confrontando la captazione della lesione con quella della teca cranica. A. Immagini PET/TC Valutazione qualitativa e semiquantitativa dell uptake del 18 F-FDG si effettua confrontando il valore di SUV della lesione con quella del parenchima cerebrale controlaterale. A. 99m Tc-HMPAO/ 111 In-Oxina-leucociti autologhi 0 negativo + captazione uguale a quella della teca cranica ++ captazione superiore a quella della teca cranica +++ captazione uguale a quella della base cranica ++++ captazione superiore a quella della base cranica Le lesioni ascessuali hanno di norma una captazione di grado +++/++++ mentre le lesioni non ascessuali hanno di norma una captazione di grado +/++ o sono negative. La valutazione del grado di positività di norma va effettuata nelle immagini a 24 ore. Nelle lesioni ascessuali è comune osservare un incremento della captazione tra le immagini a 4-6 ore e le immagini a 24 ore. B. 18 F-FDG: nella diagnostica differenziale nei pazienti con HIV tra lesioni maligne ed infezioni (ad esempio toxoplasmosi) è comune osservare un elevato uptake nelle lesioni maligne a differenza di quanto si osserva nelle infezioni. Le lesioni di origine infettiva hanno di norma valori di SUV < 2.5 o un grado di captazione inferiore alla captazione del parenchima cerebrale controlaterale mentre lesioni maligne hanno di norma valori di SUV > 3.9 o un grado di captazione 1.5 volte superiore alla captazione del parenchima cerebrale controlaterale. Nella diagnostica differenziale nei pazienti con HIV tra lesioni maligne (linfoma) ed infezioni del SNC (più frequentemente toxoplasmosi ma anche sifilide e leucoencefalopatia multifocale progressiva) è comune osservare un elevato uptake nelle lesioni maligne a differenza di quanto si osserva nelle infezioni. Nelle acquisizioni total-body, si osserva ipercaptazione del radiofarmaco (grado di captazione > di quello presente in ambito epatico) in ambito linfonodale nella fase di attivazione della malattia in soggetti che presentano elevata carica virale. Le lesioni maligne presentano in questi pazienti un elevata captazione del radiofarmaco sia all analisi qualitativa che semiquantitativa delle immagini rispetto alle lesioni di origine infettiva. In particolare il valore di SUV è significativamente più basso nelle infezioni, in particolare da toxoplasma rispetto a quanto si osserva nei linfomi in pazienti HIV-positivi. In questi pazienti, spesso si associa un aumentata captazione del radiofarmaco in ambito splenico (>/= captazione epatica) che può essere dovuta ad un aumento dell utilizzo del glucosio HIV-correlato e non necessariamente corrisponde alla presenza di processo flogistico acuto o di interessamento neoplastico di malattia in tale sede. Report Finale Corpo del Testo: deve essere specificata la presenza/assenza di uptake del radiofarmaco in ambito cerebrale e la sede interessata dalla captazione. Conclusioni: necessaria la risposta al quesito clinico circa la natura della lesione encefalica.
22 IMAGING DELLE SOSPETTE INFEZIONI DI IMPIANTI PROTESICI NON ORTOPEDICI E DI APPARECCHIATURE MEDICHE ELETTRONICHE A RESIDENZA Indicazioni Diagnosi di infezione della protesi o dell apparecchiatura elettronica, nonché della sede in caso di apparecchiature formate da corpo e fili di conduzione. Radiofarmaci A. 99m Tc-HMPAO/ 111 In-ossina leucociti o granulociti puri: B. 18 F-FDG: Protocollo di Acquisizione Scelta dell indagine: L indagine di scelta è la scintigrafia con leucociti marcati con 99m Tc-HMPAO con acquisizioni SPECT e SPECT-CT per la maggior specificità rispetto all indagine PET o PET/TC con 18 F-FDG. A. Scintigrafia con 99m Tc HMPAO WBC: B. Scintigrafia con 111 In-Ossina WBC Acquisizione di immagini planari di 15 min per proiezione, integrate da scansione SPET/TC se disponibile e possibili in accordo con la attività iniettata; necessarie scansioni precoci e tardive (30 minuti, 4 e 24 ore dopo la somministrazione); al termine dell acquisizione total-body, dopo 4 e 24 ore; consigliabili in tutti i casi dubbi scansioni tardive 48 ore dopo la somministrazione. C. 18 F-FDG-PET o PET/TC: Elaborazione A. B. Immagini ibride SPET/TC e PET/TC E necessario valutare sempre le sezioni non corrette per l attenuazione, data la alta possibilità di artefatti susseguenti alla correzione per l attenuazione standard in presenza di oggetti metallici. Interpretazione L analisi visiva deve essere guidata dalla conoscenza della tipologia di apparecchiatura in esame e della sua situazione anatomica, nonché dal tempo trascorso dall impianto. I dati clinico-strumentali disponibili devono essere tenuti presenti. Report Finale Deve essere specificata la presenza e la sede di eventuali aree di anomalo accumulo del radio farmaco, i reperti patologici devono essere localizzati per quanto possibile, il pattern temporale di accumulo deve essere descritto. Segnalare altri reperti accessori ed occasionali, nonché gli artefatti eventuali o le contaminazioni. Fornire un interpretazione o delle ipotesi diagnostiche dei reperti, con particolare riferimento al quesito clinico IMAGING MEDICO NUCLEARE DELLE INFEZIONI OSTEOMUSCOLARI
23 Indicazioni Procedure Pre-esame Sospette infezioni protesiche in pazienti sintomatici o con indici di flogosi elevati (VES e/o PCR). Sospette infezioni in pseudoartrosi post-traumatiche (ritardi di consolidamento dopo fratture esposte o superinfezioni). Diagnosi di osteomielite e/o di complicanze infettive come artriti settiche in presenza di infezione superficiale nota con o senza fistola cutanea (DD tra infezione superficiale e/o profonda con interessamento limitato ai tessuti molli e/o all osso sottostante). Monitoraggio della risposta a cicli di terapia antibiotica e/o iperbarica. Esclusione di infezione pre-intervento di reimpianto di protesi e/o stabilizzazione articolare in presenza o meno di distanziatore di cemento antibiotato. Nel caso di paziente con recente intervento di impianto protesico o di mezzo/i di sintesi è consigliabile, anche se non costituisce controindicazione assoluta, non eseguire lo studio medico-nucleare prima di 3-4 mesi dall intervento per evitare possibili risultati falsi positivi.
RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI. per l imaging oncologico con. Ga-CITRATO
 Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI per l imaging oncologico con 67 Ga-CITRATO Estensore: Orazio Schillaci Vrs. 02/2012 INDICE IMAGING ONCOLOGICO
Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI per l imaging oncologico con 67 Ga-CITRATO Estensore: Orazio Schillaci Vrs. 02/2012 INDICE IMAGING ONCOLOGICO
Medicina Nucleare sistematica: Infettivologia Nucleare
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Corso Integrato di Diagnostica per Immagini e Radioprotezione (A.A. 2015-16) Diagnostica per Immagini e Radioterapia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Corso Integrato di Diagnostica per Immagini e Radioprotezione (A.A. 2015-16) Diagnostica per Immagini e Radioterapia
Tecniche di marcatura dei leucociti autologhi e metodologie diagnostiche in Medicina Nucleare. Relatrice: Dott.ssa Daniela Lardaruccio
 Tecniche di marcatura dei leucociti autologhi e metodologie diagnostiche in Medicina Nucleare. Relatrice: Dott.ssa Daniela Lardaruccio IL PROCESSO FLOGISTICO L infiammazione può essere: ACUTA CRONICA È
Tecniche di marcatura dei leucociti autologhi e metodologie diagnostiche in Medicina Nucleare. Relatrice: Dott.ssa Daniela Lardaruccio IL PROCESSO FLOGISTICO L infiammazione può essere: ACUTA CRONICA È
RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI ENDOCRINOLOGIA
 RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI in ENDOCRINOLOGIA Autori: Luca Zagaria, Guido Rovera, Massimo Salvatori Revisori: Massimo Eugenio Dottorini, Maria Cristina Marzola Vrs. 01/2018 Nome Prestazione Premessa La
RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI in ENDOCRINOLOGIA Autori: Luca Zagaria, Guido Rovera, Massimo Salvatori Revisori: Massimo Eugenio Dottorini, Maria Cristina Marzola Vrs. 01/2018 Nome Prestazione Premessa La
RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI. per lo studio delle INFEZIONI INFIAMMAZIONI
 Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI per lo studio delle INFEZIONI INFIAMMAZIONI a cura del Gruppo di Studio Infezioni- Infiammazioni Estensori:
Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI per lo studio delle INFEZIONI INFIAMMAZIONI a cura del Gruppo di Studio Infezioni- Infiammazioni Estensori:
Riccardo Sanco, Manuela Zappalà, Arnoldo Vanessa, Laura Memo, Giorgio Masiero, Elena Zaramella, Silvia Zampieri, Laura Evangelista
 PROCEDURE DI PREPARAZIONE, ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI ESAMI PET-CT CON FLUORODESOSSIGLUCOSIO E FLUOROCOLINA: STUDIO PROSPETTICO IN UNA COORTE DI PAZIENTI Riccardo Sanco, Manuela Zappalà, Arnoldo Vanessa,
PROCEDURE DI PREPARAZIONE, ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI ESAMI PET-CT CON FLUORODESOSSIGLUCOSIO E FLUOROCOLINA: STUDIO PROSPETTICO IN UNA COORTE DI PAZIENTI Riccardo Sanco, Manuela Zappalà, Arnoldo Vanessa,
RUOLO DELLA DIAGNOSTICA MEDICO-NUCLEARE NELL ONJ
 RUOLO DELLA DIAGNOSTICA MEDICO-NUCLEARE NELL ONJ IPOTESI PATOGENETICHE = è INCERTO IL MECCANISMO PER CUI I BIFOSFONATI INDURREBBERO ONJ 1. INFEZIONE (quasi universale reperimento di infezione da Actinomyces)
RUOLO DELLA DIAGNOSTICA MEDICO-NUCLEARE NELL ONJ IPOTESI PATOGENETICHE = è INCERTO IL MECCANISMO PER CUI I BIFOSFONATI INDURREBBERO ONJ 1. INFEZIONE (quasi universale reperimento di infezione da Actinomyces)
Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia Totale Corporea e/o polmonare con traccianti positivi cod
 Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia Totale Corporea e/o polmonare con traccianti positivi cod. 92.15.4 Che cosa è la scintigrafia polmonare con traccianti positivi? E un esame che si propone di studiare
Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia Totale Corporea e/o polmonare con traccianti positivi cod. 92.15.4 Che cosa è la scintigrafia polmonare con traccianti positivi? E un esame che si propone di studiare
LDR in Medicina Nucleare
 LDR in Medicina Nucleare In Medicina Nucleare i LDR sono espressi in termini di attività somministrata (MBq) e sono definiti per le tipologie più diffuse degli esami diagnostici, per pazienti di corporatura
LDR in Medicina Nucleare In Medicina Nucleare i LDR sono espressi in termini di attività somministrata (MBq) e sono definiti per le tipologie più diffuse degli esami diagnostici, per pazienti di corporatura
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA Sezione di Diagnostica per Immagini DIRETTORE: Prof. Giuseppe Angelelli METASTASI OSSEE: imaging Arnaldo Scardapane Le ossa sono una delle
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA Sezione di Diagnostica per Immagini DIRETTORE: Prof. Giuseppe Angelelli METASTASI OSSEE: imaging Arnaldo Scardapane Le ossa sono una delle
LA SPECT CON I123-IOFLUPANE NELLO STUDIO DELLA MALATTIA DI PARKINSON. Dott.ssa Emanuela La Malfa
 LA SPECT CON I123-IOFLUPANE NELLO STUDIO DELLA MALATTIA DI PARKINSON Dott.ssa Emanuela La Malfa LA MALATTIA DI PARKINSON PATOLOGIA DEGENERATIVA DEL SNC Tremore a Riposo Bradicinesia Rigidità Muscolare
LA SPECT CON I123-IOFLUPANE NELLO STUDIO DELLA MALATTIA DI PARKINSON Dott.ssa Emanuela La Malfa LA MALATTIA DI PARKINSON PATOLOGIA DEGENERATIVA DEL SNC Tremore a Riposo Bradicinesia Rigidità Muscolare
CASO CLINICO. Tutto per un calcolo. R.Bassu, A. Alessandrì, M. Checchi, I. Lucchesi, L. Teghini, G. Panigada
 CASO CLINICO Tutto per un calcolo R.Bassu, A. Alessandrì, M. Checchi, I. Lucchesi, L. Teghini, G. Panigada - G.F. Uomo di 47 aa - In anamnesi: storia di poliposi nasale e nefrolitiasi per cui nel 2001
CASO CLINICO Tutto per un calcolo R.Bassu, A. Alessandrì, M. Checchi, I. Lucchesi, L. Teghini, G. Panigada - G.F. Uomo di 47 aa - In anamnesi: storia di poliposi nasale e nefrolitiasi per cui nel 2001
UNIVERSITÀ - OSPEDALE di PADOVA MEDICINA NUCLEARE COS' E`?
 UNIVERSITÀ - OSPEDALE di PADOVA MEDICINA NUCLEARE SCINTIGRAFIA OSTEO-ARTICOLARE Franco Bui, Diego Cecchin COS' E`? E' una delle metodiche di imaging medico nucleare più comunemente utilizzate. Sfrutta
UNIVERSITÀ - OSPEDALE di PADOVA MEDICINA NUCLEARE SCINTIGRAFIA OSTEO-ARTICOLARE Franco Bui, Diego Cecchin COS' E`? E' una delle metodiche di imaging medico nucleare più comunemente utilizzate. Sfrutta
L AUTOMAZIONE NELLE PREPARAZIONI DI RADIOFARMACI PET: GALLIO-68 DOTATOC. VALUTAZIONE E CONFRONTO CON TECNICHE MANUALI
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia ANNO ACCADEMICO: 2014/2015 L AUTOMAZIONE NELLE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia ANNO ACCADEMICO: 2014/2015 L AUTOMAZIONE NELLE
*PARAMETRI DI ACQUISIZIONE SPECT
 *PARAMETRI DI ACQUISIZIONE SPECT TSRM V. Massetti Corso avanzato di Medicina Nucleare in Neurologia Pesaro, 2014 U.O. Medicina Nucleare, Fondazione Poliambulanza, Brescia Traccianti SPECT 99m Tc-HMPAO
*PARAMETRI DI ACQUISIZIONE SPECT TSRM V. Massetti Corso avanzato di Medicina Nucleare in Neurologia Pesaro, 2014 U.O. Medicina Nucleare, Fondazione Poliambulanza, Brescia Traccianti SPECT 99m Tc-HMPAO
*PET/CT nelle neoplasie cerebrali
 Pesaro 26 Settembre 2014 *PET/CT nelle neoplasie cerebrali La RM è il metodo di elezione per lo studio di tutte le lesioni cerebrali. Tuttavia in alcune applicazioni la sua accuratezza può essere ridotta
Pesaro 26 Settembre 2014 *PET/CT nelle neoplasie cerebrali La RM è il metodo di elezione per lo studio di tutte le lesioni cerebrali. Tuttavia in alcune applicazioni la sua accuratezza può essere ridotta
Dall invisibile al visibile: le immagini diagnostiche in medicina
 CT [ 18 F]FDG PET Dall invisibile al visibile: le immagini diagnostiche in medicina Claudio Landoni Dipartimento di Scienza della Salute Come eravamo. Fino alla fine dell 800 indagare la struttura di un
CT [ 18 F]FDG PET Dall invisibile al visibile: le immagini diagnostiche in medicina Claudio Landoni Dipartimento di Scienza della Salute Come eravamo. Fino alla fine dell 800 indagare la struttura di un
APPUNTAMENTI A FISICA CICLO DI INCONTRI DI FISICA MEDICA SECONDO INCONTRO 2012 IL POLMONE: PATOLOGIA, CLINICA E FISICA UN CASO CLINICO
 APPUNTAMENTI A FISICA CICLO DI INCONTRI DI FISICA MEDICA SECONDO INCONTRO 2012 IL POLMONE: PATOLOGIA, CLINICA E FISICA UN CASO CLINICO Veronica Rossetti S.C. di Fisica Sanitaria, AO Città della Salute
APPUNTAMENTI A FISICA CICLO DI INCONTRI DI FISICA MEDICA SECONDO INCONTRO 2012 IL POLMONE: PATOLOGIA, CLINICA E FISICA UN CASO CLINICO Veronica Rossetti S.C. di Fisica Sanitaria, AO Città della Salute
LA SCINTIGRAFIA CEREBRALE
 LA SCINTIGRAFIA CEREBRALE Sergio Baldari, Alfredo Campennì Medicina Nucleare Dipartimento di Scienze Radiologiche Università degli Studi di Messina - A.O.U. Policlinico G. Martino Donazione di organi e
LA SCINTIGRAFIA CEREBRALE Sergio Baldari, Alfredo Campennì Medicina Nucleare Dipartimento di Scienze Radiologiche Università degli Studi di Messina - A.O.U. Policlinico G. Martino Donazione di organi e
inizialmente. Solo per valutazione scheletrica prechirurgica
 CONFRONTO TRA LEA 2017 E DECRETO LORENZIN 2016 SULLE LIMITAZIONI PRESCRITTIVE DI TC E RMN SENZA MEZZO DI CONTRASTO ESAME(*) LEA 2017 Indicazioni prioritarie TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE.
CONFRONTO TRA LEA 2017 E DECRETO LORENZIN 2016 SULLE LIMITAZIONI PRESCRITTIVE DI TC E RMN SENZA MEZZO DI CONTRASTO ESAME(*) LEA 2017 Indicazioni prioritarie TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE.
Livelli Diagnostici di Riferimento
 Livelli Diagnostici di Riferimento I livelli diagnostici di riferimento (LDR) sono stati definiti nella Direttiva Europea 97/43 Euratom, successivamente recepita in Italia con il D.L. 187/00, in vigore
Livelli Diagnostici di Riferimento I livelli diagnostici di riferimento (LDR) sono stati definiti nella Direttiva Europea 97/43 Euratom, successivamente recepita in Italia con il D.L. 187/00, in vigore
Dr.ssa Alessia Levaggi ASL 5 Spezzino. Stadiazione e TNM
 Dr.ssa Alessia Levaggi ASL 5 Spezzino Stadiazione e TNM Rappresentazione sintetica dell estensione anatomica del tumore Informazioni prognostiche Stadiazione Indirizza la strategia terapeutica Linguaggio
Dr.ssa Alessia Levaggi ASL 5 Spezzino Stadiazione e TNM Rappresentazione sintetica dell estensione anatomica del tumore Informazioni prognostiche Stadiazione Indirizza la strategia terapeutica Linguaggio
Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia del midollo osseo total body cod
 Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia del midollo osseo total body cod. 92.05.6 Che cosa è la scintigrafia del midollo osseo total body? E un esame che valuta la distribuzione, lo stato di funzionalità
Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia del midollo osseo total body cod. 92.05.6 Che cosa è la scintigrafia del midollo osseo total body? E un esame che valuta la distribuzione, lo stato di funzionalità
Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia renale cod SPECT cod
 Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia renale cod. 92.03.1 + SPECT cod. 92.03.5 Che cosa è la scintigrafia renale? E una indagine diagnostica che serve per studiare il rene e che consente di vedere
Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia renale cod. 92.03.1 + SPECT cod. 92.03.5 Che cosa è la scintigrafia renale? E una indagine diagnostica che serve per studiare il rene e che consente di vedere
Cosa deve sapere se deve sottoporsi a SCINTIGRAFIA OSSEA:
 1 Medicina Nucleare Cosa deve sapere se deve sottoporsi a SCINTIGRAFIA OSSEA: La scintigrafia ossea è un esame metabolico funzionale per lo studio di patologie del tessuto osseo. Non è richiesta alcuna
1 Medicina Nucleare Cosa deve sapere se deve sottoporsi a SCINTIGRAFIA OSSEA: La scintigrafia ossea è un esame metabolico funzionale per lo studio di patologie del tessuto osseo. Non è richiesta alcuna
Approccio Terapeutico all iperglicemia a digiuno e postprandiale. Irene Brandolin S.C. Medicina Interna E.O. Ospedali Galliera Savona, 23 Marzo 2013
 Approccio Terapeutico all iperglicemia a digiuno e postprandiale Irene Brandolin S.C. Medicina Interna E.O. Ospedali Galliera Savona, 23 Marzo 2013 La triade glicemica nella gestione del diabete Glicemia
Approccio Terapeutico all iperglicemia a digiuno e postprandiale Irene Brandolin S.C. Medicina Interna E.O. Ospedali Galliera Savona, 23 Marzo 2013 La triade glicemica nella gestione del diabete Glicemia
Elenco referti strutturati disponibili in radiologia
 Elenco referti strutturati disponibili in radiologia Branca/Distretto anatomico Caratteristiche Generali - Possibilità di scegliere dinamicamente il modello di refertazione strutturata in base ai risultati
Elenco referti strutturati disponibili in radiologia Branca/Distretto anatomico Caratteristiche Generali - Possibilità di scegliere dinamicamente il modello di refertazione strutturata in base ai risultati
NB: Il rimborso delle spese mediche sostenute viene effettuato in base al tariffario, entro il limite del massimale 1
 ANGIOGRAFIA AORTA-ADDOMINALE 596,00 ANGIOGRAFIA ARTERIE PERIFERICHE (VASI ILIACI FEMORALI POPLITEI 478,00 TRONCHI TIBIALI) ANGIOGRAFIA DISTRETTO SOPRAAORTICO (CAROTIDI SUCCLAVIE VERTEBRALI E CIRC.INTRACR.)
ANGIOGRAFIA AORTA-ADDOMINALE 596,00 ANGIOGRAFIA ARTERIE PERIFERICHE (VASI ILIACI FEMORALI POPLITEI 478,00 TRONCHI TIBIALI) ANGIOGRAFIA DISTRETTO SOPRAAORTICO (CAROTIDI SUCCLAVIE VERTEBRALI E CIRC.INTRACR.)
PDTA lesioni focali epatiche
 PDTA lesioni focali epatiche Imaging TC e RM Dott. P.Bresciani U.O.C. Radiologia Azienda Ospedaliero Universitaria Parma I martedi dell ordine Parma 06/06/2017 Metodiche di imaging US. CEUS. TC con mdc.
PDTA lesioni focali epatiche Imaging TC e RM Dott. P.Bresciani U.O.C. Radiologia Azienda Ospedaliero Universitaria Parma I martedi dell ordine Parma 06/06/2017 Metodiche di imaging US. CEUS. TC con mdc.
Domande relative alla specializzazione in: Medicina nucleare
 Domande relative alla specializzazione in: Medicina nucleare Domanda #1 (codice domanda: n.961) : Quale tra queste condizioni è controindicazione assoluta al trattamento radiometabolico del dolore da metastasi
Domande relative alla specializzazione in: Medicina nucleare Domanda #1 (codice domanda: n.961) : Quale tra queste condizioni è controindicazione assoluta al trattamento radiometabolico del dolore da metastasi
Neoplasia Polmonare Diagnosi e Radioterapia
 Neoplasia Polmonare Diagnosi e Radioterapia Palazzo San Michele Fano - 7 maggio 2016 La qualità nel flusso diagnostico, radioterapico Dott. Matteo Mariselli U.O.C. Fisica Medica - A.O. Ospedali Riuniti
Neoplasia Polmonare Diagnosi e Radioterapia Palazzo San Michele Fano - 7 maggio 2016 La qualità nel flusso diagnostico, radioterapico Dott. Matteo Mariselli U.O.C. Fisica Medica - A.O. Ospedali Riuniti
andate, insegnate, guarite.
 andate, insegnate, guarite. Fondazione Istituto San Raffaele G.Giglio di Cefalù Servizio di Medicina Nucleare Servizio accoglienza: 0921 920553 Centro prenotazioni: 0921 920564 Servizio di Medicina Nucleare:
andate, insegnate, guarite. Fondazione Istituto San Raffaele G.Giglio di Cefalù Servizio di Medicina Nucleare Servizio accoglienza: 0921 920553 Centro prenotazioni: 0921 920564 Servizio di Medicina Nucleare:
semeiotica TC ed RM dei crolli vertebrali: osteoporotici vs neoplastici
 semeiotica TC ed RM dei crolli vertebrali: osteoporotici vs neoplastici Cremona, 13 gennaio 2017 C. Botti background: il caso clinico! pz maschio, 79 anni; in anamnesi microcitoma polmonare operato, ultimi
semeiotica TC ed RM dei crolli vertebrali: osteoporotici vs neoplastici Cremona, 13 gennaio 2017 C. Botti background: il caso clinico! pz maschio, 79 anni; in anamnesi microcitoma polmonare operato, ultimi
Diagnostica medico-nucleare delle patologie polmonari
 Diagnostica medico-nucleare delle patologie polmonari Distretto vascolare Distretto ventilatorio Deficit combinato-matched Deficit non combinato-mismatched Embolia polmonare Associata ad alta mortalità
Diagnostica medico-nucleare delle patologie polmonari Distretto vascolare Distretto ventilatorio Deficit combinato-matched Deficit non combinato-mismatched Embolia polmonare Associata ad alta mortalità
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE
 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI PER L IMAGING ONCOLOGICO CON COMPOSTI DOTA A cura del Gruppo di Studio Oncologia (Coordinatore: Pierluigi Zanco)
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI PER L IMAGING ONCOLOGICO CON COMPOSTI DOTA A cura del Gruppo di Studio Oncologia (Coordinatore: Pierluigi Zanco)
Vasculopatie venose. Dr. Giovanni Papa Coordinatore FIMMG FORMAZIONE LAZIO
 Vasculopatie venose Dr. Giovanni Papa Coordinatore FIMMG FORMAZIONE LAZIO CASO CLINICO Manfredi, 63 anni Anamnesi patologica remota: Ipertensione arteriosa Dislipidemia Insufficienza venosa di grado lieve
Vasculopatie venose Dr. Giovanni Papa Coordinatore FIMMG FORMAZIONE LAZIO CASO CLINICO Manfredi, 63 anni Anamnesi patologica remota: Ipertensione arteriosa Dislipidemia Insufficienza venosa di grado lieve
Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia ossea segmentaria polifasica cod
 Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia ossea segmentaria polifasica cod. 92.14.2 Che cosa è la scintigrafia ossea segmentaria? E un esame che si propone di studiare una parte (=segmento) dello scheletro,
Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia ossea segmentaria polifasica cod. 92.14.2 Che cosa è la scintigrafia ossea segmentaria? E un esame che si propone di studiare una parte (=segmento) dello scheletro,
Presidio Ospedaliero di Faenza. Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica. U.O. di Medicina Nucleare
 Presidio Ospedaliero di Faenza Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica U.O. di Medicina Nucleare Direttore: Dott. Mirco Bartolomei La Medicina Nucleare Informazioni utili
Presidio Ospedaliero di Faenza Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica U.O. di Medicina Nucleare Direttore: Dott. Mirco Bartolomei La Medicina Nucleare Informazioni utili
ACCERTAMENTI DI ALTA DIAGNOSTICA
 ANGIOGRAFIA AORTA-ADDOMINALE 596,00 Prescrizione medica ANGIOGRAFIA ARTERIE PERIFERICHE (VASI ILIACI FEMORALI POPLITEI TRONCHI TIBIALI) ANGIOGRAFIA DISTRETTO SOPRAAORTICO (CAROTIDI SUCCLAVIE VERTEBRALI
ANGIOGRAFIA AORTA-ADDOMINALE 596,00 Prescrizione medica ANGIOGRAFIA ARTERIE PERIFERICHE (VASI ILIACI FEMORALI POPLITEI TRONCHI TIBIALI) ANGIOGRAFIA DISTRETTO SOPRAAORTICO (CAROTIDI SUCCLAVIE VERTEBRALI
Impatto della FDGPET/TC nella definizione del target del distretto testa-collo
 Impatto della FDGPET/TC nella definizione del target del distretto testa-collo Dr.ssa Caterina Fardella U.C. Radioterapia Asl5 Direttore Dr. Tindaro Scolaro BACKGRAUND DIAGNOSI e STADIAZIONE dei TUMORI
Impatto della FDGPET/TC nella definizione del target del distretto testa-collo Dr.ssa Caterina Fardella U.C. Radioterapia Asl5 Direttore Dr. Tindaro Scolaro BACKGRAUND DIAGNOSI e STADIAZIONE dei TUMORI
Quando eseguire l ecografia dell aorta? Perché durante un ecocardiogramma?
 Quando eseguire l ecografia dell aorta? Perché durante un ecocardiogramma? A. Sulla e R. Lumare Unità Operativa di Cardiologia UTC P.O. San Giovanni di Dio Crotone ncontri Pitagorici di Cardiologia 2012
Quando eseguire l ecografia dell aorta? Perché durante un ecocardiogramma? A. Sulla e R. Lumare Unità Operativa di Cardiologia UTC P.O. San Giovanni di Dio Crotone ncontri Pitagorici di Cardiologia 2012
When should dynamic 18F-Choline Positron Emission Tomography/Computed Tomography acquisition be performed in suspected recurrence of prostatic cancer?
 When should dynamic 18F-Choline Positron Emission Tomography/Computed Tomography acquisition be performed in suspected recurrence of prostatic cancer? C. Caldarella1, M.A. Isgrò2, G. Bencivenga1, V. Rufini1,
When should dynamic 18F-Choline Positron Emission Tomography/Computed Tomography acquisition be performed in suspected recurrence of prostatic cancer? C. Caldarella1, M.A. Isgrò2, G. Bencivenga1, V. Rufini1,
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE
 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI PER L IMAGING ONCOLOGICO CON 18 F-COLINA PET/TC A cura del Gruppo di Studio Oncologia (Coordinatore: Pierluigi
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI PER L IMAGING ONCOLOGICO CON 18 F-COLINA PET/TC A cura del Gruppo di Studio Oncologia (Coordinatore: Pierluigi
SEGNI CLINICI CHE PIU FREQUENTEMENTE INDUCONO A SOSPETTARE UNA NEOPLASIA
 SEGNI CLINICI CHE PIU FREQUENTEMENTE INDUCONO A SOSPETTARE UNA NEOPLASIA FEBBRE LINFOADENOPATIE MASSE ADDOMINALI O MEDIASTINICHE DOLORI OSSEI NODULI SOTTOCUTANEI PUNTO DI RIFERIMENTO PEDIATRA DI BASE QUANDO
SEGNI CLINICI CHE PIU FREQUENTEMENTE INDUCONO A SOSPETTARE UNA NEOPLASIA FEBBRE LINFOADENOPATIE MASSE ADDOMINALI O MEDIASTINICHE DOLORI OSSEI NODULI SOTTOCUTANEI PUNTO DI RIFERIMENTO PEDIATRA DI BASE QUANDO
RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI PER LO STUDIO LINFOSCINTIGRAFICO DELLE PATOLOGIE DEL SISTEMA LINFATICO
 Associazione Italiana di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI PER LO STUDIO LINFOSCINTIGRAFICO DELLE PATOLOGIE DEL SISTEMA LINFATICO A cura del Gruppo di Studio di Chirurgia
Associazione Italiana di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI PER LO STUDIO LINFOSCINTIGRAFICO DELLE PATOLOGIE DEL SISTEMA LINFATICO A cura del Gruppo di Studio di Chirurgia
Embolia polmonare Ostruzione di uno o più vasi arteriosi polmonari, determinata dalla presenza di
 Embolia polmonare Ostruzione di uno o più vasi arteriosi polmonari, determinata dalla presenza di coaguli ematici di natura embolica trombosi locale o cardiaca emboli non trombotici (settici, neoplastici)
Embolia polmonare Ostruzione di uno o più vasi arteriosi polmonari, determinata dalla presenza di coaguli ematici di natura embolica trombosi locale o cardiaca emboli non trombotici (settici, neoplastici)
L IMAGING NELLE SPONDILOARTRITI
 L IMAGING NELLE SPONDILOARTRITI Raffaele Scarpa Cattedra di Reumatologia Scuola di specializzazione in Reumatologia Università Federico II Naples SPONDILOARTRITI - DEFINIZIONE Le Spondiloartriti sono malattie
L IMAGING NELLE SPONDILOARTRITI Raffaele Scarpa Cattedra di Reumatologia Scuola di specializzazione in Reumatologia Università Federico II Naples SPONDILOARTRITI - DEFINIZIONE Le Spondiloartriti sono malattie
vi sia un metabolismo attivo espressione cioè di una forma vitale. Emazie Marcate R B C
 La Medicina Nucleare è una branca medica specialistica che si avvale dell' uso dei radionuclidi a scopo diagnostico, terapeutico e di ricerca biomedica. Le metodiche medico - nucleari prevedono la somministrazione
La Medicina Nucleare è una branca medica specialistica che si avvale dell' uso dei radionuclidi a scopo diagnostico, terapeutico e di ricerca biomedica. Le metodiche medico - nucleari prevedono la somministrazione
CRITERI RECIST E IMAGING
 CRITERI RECIST E IMAGING Negrar 11 ottobre 2017 L. ROMANO E. DEMOZZI CRITERI RECIST 1.1 Tecnica standardizzata per la misura dei Tumori Scopo: garantire l obiettività e ridurre la variabilità inter-osservatore
CRITERI RECIST E IMAGING Negrar 11 ottobre 2017 L. ROMANO E. DEMOZZI CRITERI RECIST 1.1 Tecnica standardizzata per la misura dei Tumori Scopo: garantire l obiettività e ridurre la variabilità inter-osservatore
Dottor LOMUSCIO Giuseppe Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale UO Medicina Nucleare - Azienda Ospedaliera BUSTO ARSIZIO - Varese
 Dottor LOMUSCIO Giuseppe Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale UO Medicina Nucleare - Azienda Ospedaliera BUSTO ARSIZIO - Varese L adesione alle Linee Guida NON sarà assicurare al Paziente
Dottor LOMUSCIO Giuseppe Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale UO Medicina Nucleare - Azienda Ospedaliera BUSTO ARSIZIO - Varese L adesione alle Linee Guida NON sarà assicurare al Paziente
Informazioni per il PAZIENTE Angiocardioscintigrafia all equilibrio (MUGA) cod
 Informazioni per il PAZIENTE Angiocardioscintigrafia all equilibrio (MUGA) cod. 92.05.4 Che cos è l Angiocardioscintigrafia all equilibrio? E una indagine diagnostica che serve per studiare la funzione
Informazioni per il PAZIENTE Angiocardioscintigrafia all equilibrio (MUGA) cod. 92.05.4 Che cos è l Angiocardioscintigrafia all equilibrio? E una indagine diagnostica che serve per studiare la funzione
Protocollo IVU febbrili in età pediatrica. Premessa: l infezione urinaria con febbre è da considerare sempre una pielonefrite.
 Protocollo IVU febbrili in età pediatrica. Premessa: l infezione urinaria con febbre è da considerare sempre una pielonefrite. 1) Quando, nei primi tre anni di vita, bisogna sospettare un IVU e quindi
Protocollo IVU febbrili in età pediatrica. Premessa: l infezione urinaria con febbre è da considerare sempre una pielonefrite. 1) Quando, nei primi tre anni di vita, bisogna sospettare un IVU e quindi
Eradicazione della fonte
 Eradicazione della fonte RICONOSCERE E GESTIRE LA SEPSI a brand of SPEDALI CIVILI DI BRESCIA AZIENDA OSPEDALIERA Sommario Eradicazione della fonte... 3 I principi generali... 4 La metodologia... 5 2 Eradicazione
Eradicazione della fonte RICONOSCERE E GESTIRE LA SEPSI a brand of SPEDALI CIVILI DI BRESCIA AZIENDA OSPEDALIERA Sommario Eradicazione della fonte... 3 I principi generali... 4 La metodologia... 5 2 Eradicazione
Infezioni correlate con cateteri venosi centrali a permanenza
 Infezioni correlate con cateteri venosi centrali a permanenza Stefano Avanzini Alberto Michelazzi Massimo Conte* Dipartimento di Chirurgia Pediatrica *U.O.Emato-Oncologia IRCCS G.Gaslini Genova Cosenza
Infezioni correlate con cateteri venosi centrali a permanenza Stefano Avanzini Alberto Michelazzi Massimo Conte* Dipartimento di Chirurgia Pediatrica *U.O.Emato-Oncologia IRCCS G.Gaslini Genova Cosenza
Identificazione del conducente e del passeggero anteriore negli incidenti automobilistici attraverso la lesività degli organi interni
 18-20 settembre 2018, Verona 43 Congresso Nazionale SIMLA Identificazione del conducente e del passeggero anteriore negli incidenti automobilistici attraverso la lesività degli organi interni M. Solinas,
18-20 settembre 2018, Verona 43 Congresso Nazionale SIMLA Identificazione del conducente e del passeggero anteriore negli incidenti automobilistici attraverso la lesività degli organi interni M. Solinas,
PROFILASSI ANTITROMBOTICA IN CHIRURGIA GENERALE
 CHIRURGIA GENERALE MAGGIORE (tutti gli interventi di durata > 30 minuti o di chirurgia addominale) TIPO DI PATOLOGIA TIPO DI CHIRURGIA MIRE (tutti gli interventi di durata < 30 minuti, esclusa la chirurgia
CHIRURGIA GENERALE MAGGIORE (tutti gli interventi di durata > 30 minuti o di chirurgia addominale) TIPO DI PATOLOGIA TIPO DI CHIRURGIA MIRE (tutti gli interventi di durata < 30 minuti, esclusa la chirurgia
Il nuovo protocollo diagnostico terapeutico dello screening colo-rettale Patrizia Landi AUSL di Bologna Ass. Politiche per la Salute RER
 Il nuovo protocollo diagnostico terapeutico dello screening colo-rettale Patrizia Landi AUSL di Bologna Ass. Politiche per la Salute RER Perchè un protocollo Le organizzazioni che forniscono prestazioni
Il nuovo protocollo diagnostico terapeutico dello screening colo-rettale Patrizia Landi AUSL di Bologna Ass. Politiche per la Salute RER Perchè un protocollo Le organizzazioni che forniscono prestazioni
LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NELLA PANCREATITE ACUTA
 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, CORSO 2010/2013. PATOLOGIA DEL PANCREAS LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NELLA PANCREATITE ACUTA Elisabetta Ascari Fabio Bassi Medicina III Gastroenterologia
SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, CORSO 2010/2013. PATOLOGIA DEL PANCREAS LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NELLA PANCREATITE ACUTA Elisabetta Ascari Fabio Bassi Medicina III Gastroenterologia
Valutazione clinico-diagnostica delle lesioni ossee
 Valutazione clinico-diagnostica delle lesioni ossee Incontro AIRO LAM 22/10/2012 Dott. Maurizio Carcaterra U.O. RADIOTERAPIA Ospedale Belcolle Viterbo 1 introduzione Le ossa sono la sede più comune di
Valutazione clinico-diagnostica delle lesioni ossee Incontro AIRO LAM 22/10/2012 Dott. Maurizio Carcaterra U.O. RADIOTERAPIA Ospedale Belcolle Viterbo 1 introduzione Le ossa sono la sede più comune di
STRUTTURA COMPLESSA DI GASTROENTEROLOGIA
 FOGLIO INFORMATIVO E CONSENSO INFORMATO PER ECOENDOSCOPIA Gentile Paziente, L ecoendoscopia è una procedura diagnostica e terapeutica che impiega un approccio ecografico ed endoscopico combinato, nella
FOGLIO INFORMATIVO E CONSENSO INFORMATO PER ECOENDOSCOPIA Gentile Paziente, L ecoendoscopia è una procedura diagnostica e terapeutica che impiega un approccio ecografico ed endoscopico combinato, nella
Diagnostica clinica-strumentale
 Diagnostica clinica-strumentale Dott. Enrico Guidetti S.C. Radiologia Diagnostica ed interventistica Ospedale Umberto Parini Aosta La storia Leborgne R. The breast in roentgen diagnosis. Montevideo, Uruguay,
Diagnostica clinica-strumentale Dott. Enrico Guidetti S.C. Radiologia Diagnostica ed interventistica Ospedale Umberto Parini Aosta La storia Leborgne R. The breast in roentgen diagnosis. Montevideo, Uruguay,
Interpretativa Generale Non previsto INTRODUZIONE ALLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
 INTRODUZIONE ALLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Indirizza lo studente alla conoscenza delle varie macchine impiegate nella diagnostica per immagini (radiologia convenzionale, ultrasonografia, tomografia computerizzata,
INTRODUZIONE ALLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Indirizza lo studente alla conoscenza delle varie macchine impiegate nella diagnostica per immagini (radiologia convenzionale, ultrasonografia, tomografia computerizzata,
P. De Iaco Oncologia Ginecologica Policlinico S.Orsola - Bologna
 Protocolli di terapia antibiotica in ginecologia: dalla flogosi pelvica non chirurgica alla complicanza post operatoria. P. De Iaco Oncologia Ginecologica Policlinico S.Orsola - Bologna Chirurgia generale
Protocolli di terapia antibiotica in ginecologia: dalla flogosi pelvica non chirurgica alla complicanza post operatoria. P. De Iaco Oncologia Ginecologica Policlinico S.Orsola - Bologna Chirurgia generale
CEQ in CITOGENETICA ONCOLOGICA A. La qualità del bandeggio è insufficiente/inadeguata e non permette una corretta ricostruzione dei cariotipi
 CEQ in CITOGENETICA ONCOLOGICA 2013 Per il CEQ in citogenetica oncologica sono state definite due categorie di performance: sufficiente e insufficiente. Per ottenere una performance sufficiente è necessario
CEQ in CITOGENETICA ONCOLOGICA 2013 Per il CEQ in citogenetica oncologica sono state definite due categorie di performance: sufficiente e insufficiente. Per ottenere una performance sufficiente è necessario
Salvatore Renna DEA Pediatrico UOC di PS Medico e Medicina d Urgenza IRCCS - Istituto G. Gaslini - Genova
 Salvatore Renna DEA Pediatrico UOC di PS Medico e Medicina d Urgenza IRCCS - Istituto G. Gaslini - Genova La patologia (adeno) faringo tonsillare, per l aspetto flogistico - infettivo, rappresenta uno
Salvatore Renna DEA Pediatrico UOC di PS Medico e Medicina d Urgenza IRCCS - Istituto G. Gaslini - Genova La patologia (adeno) faringo tonsillare, per l aspetto flogistico - infettivo, rappresenta uno
L acquisizione e l elaborazione delle immagini di Medicina Nucleare
 L acquisizione e l elaborazione delle immagini di Medicina Nucleare UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Materiale didattico a cura della Dott.ssa Michela Lecchi Medicina Nucleare: strumentazione gamma camera
L acquisizione e l elaborazione delle immagini di Medicina Nucleare UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Materiale didattico a cura della Dott.ssa Michela Lecchi Medicina Nucleare: strumentazione gamma camera
- Non allergie farmacologiche - Ex fumatore - Tonsillectomia
 M.G. 44 anni, 79 Kg, 177 cm Anamnesi generale: - Non allergie farmacologiche - Ex fumatore - Tonsillectomia Agosto 2008: ENUCLEORESEZIONE RENALE SINISTRA di neoformazione di 42x59 mm in stadio clinico
M.G. 44 anni, 79 Kg, 177 cm Anamnesi generale: - Non allergie farmacologiche - Ex fumatore - Tonsillectomia Agosto 2008: ENUCLEORESEZIONE RENALE SINISTRA di neoformazione di 42x59 mm in stadio clinico
Regione SiciliaAzienda Ospedaliera Papardo. Unità Operativa di Medicina Nucleare
 Vengono di seguito riportate le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle indagini Medico-Nucleari effettuate presso questa Gli utenti sono pregati di attenersi scrupolosamente alle istruzioni descritte.
Vengono di seguito riportate le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle indagini Medico-Nucleari effettuate presso questa Gli utenti sono pregati di attenersi scrupolosamente alle istruzioni descritte.
Ruolo dell imaging nelle malattie linfoproliferative: Tomografia Computerizzata. Giorgio Limerutti
 Ruolo dell imaging nelle malattie linfoproliferative: Tomografia Computerizzata Giorgio Limerutti Radiodiagnostica Ospedaliera Città della Salute e della Scienza Torino Presidio Molinette Sin dall inizio
Ruolo dell imaging nelle malattie linfoproliferative: Tomografia Computerizzata Giorgio Limerutti Radiodiagnostica Ospedaliera Città della Salute e della Scienza Torino Presidio Molinette Sin dall inizio
XII Congresso Nazionale AIMN 2015 Rimini Aprile 2015
 XII Congresso Nazionale AIMN 2015 Rimini 16-19 Aprile 2015 Protocollo di ottimizzazione della PET-CT con 18F-Colina, al fine di migliorare l accuratezza diagnostica del paziente con carcinoma prostatico
XII Congresso Nazionale AIMN 2015 Rimini 16-19 Aprile 2015 Protocollo di ottimizzazione della PET-CT con 18F-Colina, al fine di migliorare l accuratezza diagnostica del paziente con carcinoma prostatico
Ortopedia e Traumatologia Direttore: Dott. Carlo Ranalletta. Consenso informato. -Chirurgia ortopedica-
 Ortopedia e Traumatologia Direttore: Dott. Carlo Ranalletta Consenso informato -Chirurgia ortopedica- Casa di Cura Privata Di Lorenzo S.p.a. Via Veneto n. 37, 67051 Avezzano (AQ) Unità Operativa di Ortopedia
Ortopedia e Traumatologia Direttore: Dott. Carlo Ranalletta Consenso informato -Chirurgia ortopedica- Casa di Cura Privata Di Lorenzo S.p.a. Via Veneto n. 37, 67051 Avezzano (AQ) Unità Operativa di Ortopedia
Dorsale. Protocollo d esame RM
 Dorsale Protocollo d esame RM Queste diapositive fanno parte di un corso completo e sono a cura dello staff di rm-online.it E vietata la riproduzione anche parziale Cenni Anatomici Cenni Anatomici Cenni
Dorsale Protocollo d esame RM Queste diapositive fanno parte di un corso completo e sono a cura dello staff di rm-online.it E vietata la riproduzione anche parziale Cenni Anatomici Cenni Anatomici Cenni
SCINTIGRAFIA PARATIROIDEA
 SCINTI GRAFIA PARATIROIDEA Estensori : Isabella Bruno e Carmelo Caldarella Versione 3/2017 Indicazioni cliniche Localizzazione di paratiroidi iperfunzionanti in pazienti con iperparatiroidismo primitivo
SCINTI GRAFIA PARATIROIDEA Estensori : Isabella Bruno e Carmelo Caldarella Versione 3/2017 Indicazioni cliniche Localizzazione di paratiroidi iperfunzionanti in pazienti con iperparatiroidismo primitivo
Figura 1 Distrofia simpatico riflessa:
 I conografia Figura 1 istrofia simpatico riflessa: alterazioni radiografiche.,. Quest uomo di 65 anni ha presentato dolore e tumefazione alla mano dopo un lieve trauma. Nella prima radiografia () si rileva
I conografia Figura 1 istrofia simpatico riflessa: alterazioni radiografiche.,. Quest uomo di 65 anni ha presentato dolore e tumefazione alla mano dopo un lieve trauma. Nella prima radiografia () si rileva
I TUMORI EMATOLOGICI schede operative
 XV Corso di aggiornamento per operatori dei Registri Tumori Modena, 6-8 ottobre 2015 I TUMORI EMATOLOGICI schede operative Francesca Roncaglia Registro Tumori Reggio Emilia Sommario - razionale del progetto
XV Corso di aggiornamento per operatori dei Registri Tumori Modena, 6-8 ottobre 2015 I TUMORI EMATOLOGICI schede operative Francesca Roncaglia Registro Tumori Reggio Emilia Sommario - razionale del progetto
11 a Conferenza Nazionale GIMBE SSN: uno per tutti, tutti per uno Bologna, 4 marzo 2016
 11 a Conferenza Nazionale GIMBE SSN: uno per tutti, tutti per uno Bologna, 4 marzo 2016 MALATTIA TROMBOEMBOLICA: un audit multiprofessionale per identificare aree di inappropriatezza Laura Cadorin, Marcello
11 a Conferenza Nazionale GIMBE SSN: uno per tutti, tutti per uno Bologna, 4 marzo 2016 MALATTIA TROMBOEMBOLICA: un audit multiprofessionale per identificare aree di inappropriatezza Laura Cadorin, Marcello
Le certezze e i dubbi del medico d urgenza
 GESTIONE IN DEA DEL PAZIENTE CON DOLORE ADDOMINALE Torino, 20 febbraio 2010 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano Le certezze e i dubbi del medico d urgenza Luisa Arnaldi SC Medicina d Urgenza Ospedale
GESTIONE IN DEA DEL PAZIENTE CON DOLORE ADDOMINALE Torino, 20 febbraio 2010 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano Le certezze e i dubbi del medico d urgenza Luisa Arnaldi SC Medicina d Urgenza Ospedale
SCELTA DEI TEST EZIOLOGICI A SUPPORTO DELLA DIAGNOSI DI LEISHMANIOSI CANINA
 SCELTA DEI TEST EZIOLOGICI A SUPPORTO DELLA DIAGNOSI DI LEISHMANIOSI CANINA Saverio Paltrinieri, DVM, PhD, Dipl ECVCP DIAGNOSI EZIOLOGICA DIRETTA (evidenziazione del parassita o di sue componenti) Citologia
SCELTA DEI TEST EZIOLOGICI A SUPPORTO DELLA DIAGNOSI DI LEISHMANIOSI CANINA Saverio Paltrinieri, DVM, PhD, Dipl ECVCP DIAGNOSI EZIOLOGICA DIRETTA (evidenziazione del parassita o di sue componenti) Citologia
L imaging per la rivalutazione e il follow-up del paziente trattato con Radio-223
 L imaging per la rivalutazione e il follow-up del paziente trattato con Radio-223 Sergio Baldari Cattedra e UOC di Medicina Nucleare Policlinico Universitario «G. Martino» Messina sbaldari@unime.it Capri,
L imaging per la rivalutazione e il follow-up del paziente trattato con Radio-223 Sergio Baldari Cattedra e UOC di Medicina Nucleare Policlinico Universitario «G. Martino» Messina sbaldari@unime.it Capri,
FUP del CDT a rischio intermedio-alto Ruolo dell Imaging pesante
 FUP del CDT a rischio intermedio-alto Ruolo dell Imaging pesante Massimo Salvatori Istituto di Medicina Nucleare Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma msalvatori@rm.unicatt.it
FUP del CDT a rischio intermedio-alto Ruolo dell Imaging pesante Massimo Salvatori Istituto di Medicina Nucleare Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma msalvatori@rm.unicatt.it
FOGLIO INFORMATIVO E CONSENSO INFORMATO PER GASTROSCOPIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA.
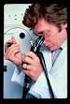 FOGLIO INFORMATIVO E CONSENSO INFORMATO PER GASTROSCOPIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA. Gentile Paziente, La gastroscopia è un esame endoscopico che permette la visualizzazione della mucosa dell esofago, dello
FOGLIO INFORMATIVO E CONSENSO INFORMATO PER GASTROSCOPIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA. Gentile Paziente, La gastroscopia è un esame endoscopico che permette la visualizzazione della mucosa dell esofago, dello
Daptomicina per una recidiva di sepsi da Staphylococcus aureus
 Daptomicina per una recidiva di sepsi da Staphylococcus aureus oxacillina-resistente complicata da ascesso del muscolo iliaco non responsiva alla terapia con vancomicina Paolo Carfagna, Francesca De Marco*
Daptomicina per una recidiva di sepsi da Staphylococcus aureus oxacillina-resistente complicata da ascesso del muscolo iliaco non responsiva alla terapia con vancomicina Paolo Carfagna, Francesca De Marco*
MAMMELLE. Protocollo d esame RM
 MAMMELLE Protocollo d esame RM Queste diapositive fanno parte di un corso completo e sono a cura dello staff di rm-online.it E vietata la riproduzione anche parziale Cenni Anatomici Questionario tipico
MAMMELLE Protocollo d esame RM Queste diapositive fanno parte di un corso completo e sono a cura dello staff di rm-online.it E vietata la riproduzione anche parziale Cenni Anatomici Questionario tipico
ECOGRAFIA CLINICA UNA DIAGNOSTICA SOSTENIBILE DANIELA CATALANO
 ECOGRAFIA CLINICA UNA DIAGNOSTICA SOSTENIBILE DANIELA CATALANO Università di Catania Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale PRECISION MEDICINE PER UNA ONCOLOGIA SOSTENIBILE DALLA DIAGNOSTICA ALLA
ECOGRAFIA CLINICA UNA DIAGNOSTICA SOSTENIBILE DANIELA CATALANO Università di Catania Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale PRECISION MEDICINE PER UNA ONCOLOGIA SOSTENIBILE DALLA DIAGNOSTICA ALLA
Il percorso del paziente con carcinoma differenziato della tiroide nella provincia di Ferrara LA TERAPIA RADIOMETABOLICA
 Il percorso del paziente con carcinoma differenziato della tiroide nella provincia di Ferrara LA TERAPIA RADIOMETABOLICA Stefano Panareo U.O.C. Medicina Nucleare e Terapia Radiometabolica Azienda Ospedaliero-Universitaria
Il percorso del paziente con carcinoma differenziato della tiroide nella provincia di Ferrara LA TERAPIA RADIOMETABOLICA Stefano Panareo U.O.C. Medicina Nucleare e Terapia Radiometabolica Azienda Ospedaliero-Universitaria
APPROPRIATEZZA IN RM. Dr. Enrico Vittorini
 APPROPRIATEZZA IN RM Dr. Enrico Vittorini Radiologia Carlo Poma Mantova S. Bonifacio, 2 febbraio 2013 RISONANZA MAGNETICA (RM) SORGENTE onde elettromagnetiche INTERAZIONE COI TESSUTI CORPOREI (RILASSAMENTO
APPROPRIATEZZA IN RM Dr. Enrico Vittorini Radiologia Carlo Poma Mantova S. Bonifacio, 2 febbraio 2013 RISONANZA MAGNETICA (RM) SORGENTE onde elettromagnetiche INTERAZIONE COI TESSUTI CORPOREI (RILASSAMENTO
Quality Editor. Data. 3M Sistemi Informativi per la Salute
 3M Sistemi Informativi per la Salute Quality Editor Data L utilizzo del Data Quality Editor per la valutazione della qualità delle informazioni della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) Utilizzo del
3M Sistemi Informativi per la Salute Quality Editor Data L utilizzo del Data Quality Editor per la valutazione della qualità delle informazioni della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) Utilizzo del
Seconda sessione: I risultati del progetto della regione Emilia-Romagna IMPATTO DELLA CARDIO-TC NEL PERCORSO ASSISTENZIALE.
 Seconda sessione: I risultati del progetto della regione Emilia-Romagna IMPATTO DELLA CARDIO-TC NEL PERCORSO ASSISTENZIALE Vincenzo Russo Dottorato in scienze pneumo-cardio cardio-toraciche Dipartimento
Seconda sessione: I risultati del progetto della regione Emilia-Romagna IMPATTO DELLA CARDIO-TC NEL PERCORSO ASSISTENZIALE Vincenzo Russo Dottorato in scienze pneumo-cardio cardio-toraciche Dipartimento
4D PET/CT GATED: acquisizione ed elaborazione
 Imaging Metabolico PET per una Moderna Radioterapia 3 Meeting Internazionale 4D PET/CT GATED: acquisizione ed elaborazione - Alfredo Palmieri U.O. Medicina Nucleare ASMN Il percorso Introduzione al Gating
Imaging Metabolico PET per una Moderna Radioterapia 3 Meeting Internazionale 4D PET/CT GATED: acquisizione ed elaborazione - Alfredo Palmieri U.O. Medicina Nucleare ASMN Il percorso Introduzione al Gating
RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI per l imaging oncologico con 18F-FDG PET/TC. A cura del Gruppo di Studio Oncologia ( Segretario Pierluigi Zanco)
 RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI per l imaging oncologico con 18F-FDG PET/TC A cura del Gruppo di Studio Oncologia ( Segretario Pierluigi Zanco) Estensori: Maria Picchio e Flavio Crippa Versione: 4/2017 INDICE:
RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI per l imaging oncologico con 18F-FDG PET/TC A cura del Gruppo di Studio Oncologia ( Segretario Pierluigi Zanco) Estensori: Maria Picchio e Flavio Crippa Versione: 4/2017 INDICE:
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CASA DI CURA PRIVATA SANATRIX
 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CASA DI CURA PRIVATA SANATRIX DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Il servizio di Diagnostica per Immagini di Clinica Sanatrix si avvale di apparecchiature che, utilizzando varie forme di
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CASA DI CURA PRIVATA SANATRIX DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Il servizio di Diagnostica per Immagini di Clinica Sanatrix si avvale di apparecchiature che, utilizzando varie forme di
L imaging morfologico. Maja Ukmar. U.C.O di Radiologia Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Trieste
 LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NEL TREATMENT PLANNING DELLA RADIOTERAPIA L imaging morfologico Maja Ukmar U.C.O di Radiologia Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Trieste Radiogramma diretto
LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NEL TREATMENT PLANNING DELLA RADIOTERAPIA L imaging morfologico Maja Ukmar U.C.O di Radiologia Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Trieste Radiogramma diretto
IMMUNITA RIMOZIONE DELL AGENTE INFETTIVO. Riconoscimento da parte di effettori preformati non
 IMMUNITA INFEZIONE Immunità innata specifici RIMOZIONE DELL AGENTE INFETTIVO Riconoscimento da parte di effettori preformati non (risposta immediata 0-4 ore) Risposta indotta precoce Riconoscimento, Reclutamento
IMMUNITA INFEZIONE Immunità innata specifici RIMOZIONE DELL AGENTE INFETTIVO Riconoscimento da parte di effettori preformati non (risposta immediata 0-4 ore) Risposta indotta precoce Riconoscimento, Reclutamento
SCINTIGRAFIA RENALE DINAMICA
 UNIVERSITÀ - OSPEDALE di PADOVA MEDICINA NUCLEARE 1 SCINTIGRAFIA RENALE DINAMICA Franco Bui, Diego Cecchin COS`È? È una metodica che sfrutta la capacità di alcuni radiofarmaci di concentrarsi nei reni
UNIVERSITÀ - OSPEDALE di PADOVA MEDICINA NUCLEARE 1 SCINTIGRAFIA RENALE DINAMICA Franco Bui, Diego Cecchin COS`È? È una metodica che sfrutta la capacità di alcuni radiofarmaci di concentrarsi nei reni
(Tempi min. e max che intercorrono dalla prenotazione all'accesso alla prestazione)
 (Tempi min. e max che intercorrono dalla prenotazione all'accesso alla prestazione) Prenotati 06.11.2 Agoaspirazione ecoguidata dei 1-6 gg 15-45 gg 5-15 gg 2 mesi 7-45 gg noduli tiroidei 92.05.4 Angiocardio
(Tempi min. e max che intercorrono dalla prenotazione all'accesso alla prestazione) Prenotati 06.11.2 Agoaspirazione ecoguidata dei 1-6 gg 15-45 gg 5-15 gg 2 mesi 7-45 gg noduli tiroidei 92.05.4 Angiocardio
Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia con leucociti marcati cod. 92.18.4
 Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia con leucociti marcati cod. 92.18.4 Che cos è la scintigrafia con leucociti marcati? E una indagine diagnostica che si propone di identificare la presenza di eventuali
Informazioni per il PAZIENTE Scintigrafia con leucociti marcati cod. 92.18.4 Che cos è la scintigrafia con leucociti marcati? E una indagine diagnostica che si propone di identificare la presenza di eventuali
