Il limite come contingenza. Finito e infinito nel pensiero di G. Duns Scoto Pontificia Università Lateranense - 4 aprile 2019.
|
|
|
- Mariangela Petrucci
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL LIMITE COME CONTINGENZA. Finito e infinito nel pensiero di Giovanni Duns Scoto TESTI DI RIFERIMENTO T1 Necessità di una dottrina rivelata (Ordinatio, Prologus, p. 1, q. un., nn ; Ed. Vaticana I, ) «A proposito di tale questione (de necessitate doctrinae revelatae) sembra esservi una controversia tra i filosofi e i teologi. I filosofi sostengono (tenent) la perfezione della natura e negano la perfezione soprannaturale; i teologi invece riconoscono il difetto della natura (cognoscunt defectum naturae), la necessità della Grazia e la perfezione soprannaturale. Direbbe dunque un filosofo che l uomo, nell attuale condizione (pro statu isto), non ha bisogno di alcuna conoscenza soprannaturale, ma può acquisire ogni conoscenza che gli è necessaria in base all azione delle cause naturali. E a sostegno di ciò vengono addotte, da luoghi diversi, insieme l autorità e l argomentazione razionale del Filosofo. ( ) Ma nota: per mezzo della ragione naturale non è possibile dimostrare che qualcosa di soprannaturale inerisca all uomo in questa sua condizione di viator o sia richiesto per la sua perfezione; anzi, neppure colui che possiede tale conoscenza soprannaturale può mostrare che qualcosa del genere è presente in sé. Quindi è impossibile servirsi qui contro Aristotele della ragione naturale: se si argomentasse a partire da ciò che viene creduto, non sarebbe un argomento valido contro il filosofo, perché egli non concederebbe una premessa che si ammette solo per fede. Anche negli argomenti che qui si presentano contro il filosofo, una delle due premesse o è concessa per fede o è provata a partire da ciò che si crede, e perciò non sono che persuasioni teologiche (persuasiones), che procedono da qualcosa che viene creduto ad altro che pure viene creduto». T2 Exordium del De primo Principio (DPP n. 1 - tr. it. a c. di P. Porro, Bompiani 2008) «Primum rerum principium mihi ea credere, sapere et proferre concedat, quae ipsius placeant maiestati et ad eius contemplationem elevent mentes nostram. Domine Deus noster, Moysi servo tuo, de tuo nomine filiis Israel proponendo, a te Doctore veracissimo sciscitanti, sciens quid posset de te concipere intellectus mortalium, nomen tuum benedictum reserans, respondisti: EGO SUM QUI SUM. Tu es verum esse, tu es totum esse. Hoc si mihi esset possibile, scire vellem. Adiuva me, Domine, inquirentem ad quantam cognitionem de vero esse, quod tu es, possit pertingere nostra ratio naturalis ab ente, quod de te praedicasti, inchoando» (DPP, n. 1) «Il Primo Principio delle cose mi conceda di credere, comprendere ed esprimere ciò che piace alla sua maestà e può elevare le nostre menti alla sua contemplazione. Signore Dio nostro, al Tuo servitore Mosé che cercava di conoscere da Te, maestro assolutamente veritiero, con quale nome avrebbe dovuto annunciarti ai Figli di Israele, Tu, sapendo ciò che l intelletto dei mortali potrebbe arrivare a concepire di Te, ha risposto, rivelando il Tuo nome benedetto: IO SONO COLUI CHE SONO. Tu sei l essere vero, Tu sei tutto l essere. Questo è ciò che credo, questo è ciò che, se mi fosse possibile, vorrei comprendere. Aiutami, Signore, a ricercare fin dove possa pervenire la nostra ragione naturale nella conoscenza dell essere vero, che Tu sei, a partire proprio dall ente, che hai predicato di Te stesso». T3 Univocità dell ens (Ordinatio I, d. 3, p. 1, q. 1-2, n. 27; Ed. Vaticana III, p. 18) «Dico quod non tantum in conceptu analogo conceptui creaturae concipitur Deus, scilicet qui omnino sit alius ab illo qui de creatura dicitur, sed in conceptu aliquo univoco sibi et creaturae. Et ne fiat contentio de nomine «Sostengo che Dio è concepito non solo in un concetto analogo al concetto della creatura, così che sia del tutto diverso da quello che è attribuito alla creatura, ma in un certo concetto univoco a lui e alla creatura. E affinché non 1
2 univocationis, univocum conceptum dico, qui ita est unus quod eius unitas sufficit ad contradictionem, affirmando et negando ipsum de eodem; sufficit etiam pro medio syllogistico, ut extrema unita in medio sic uno sine fallacia aequivocationis concludantur inter se uniri». ci siano discussioni sul termine univocità, definisco univoco un concetto che è tanto unitario che la sua unità basti a far sì che sia contraddittorio affermare e negare tale concetto della stessa cosa, e basti a far sì che tale concetto possa fungere da medio in una dimostrazione sillogistica in modo che gli estremi uniti fra loro da un tale medio possano concludere senza fallacia di equivocazione». T4 Le passiones entis (Ordinatio I, d. 8, p. 1, q. 3, n. 113; Ed. Vaticana IV, p. 205) «Ens prius dividitur in infinitum et finitum quam in decem praedicamenta, quia alterum istorum, scilicet finitum, est commune ad decem genera; ergo quaecumque conveniunt enti ut indifferens ad finitum et infinitum vel ut est proprium enti infinito, conveniunt sibi non ut determinatur ad genus, sed ut prius, et per consequens ut est transcendens et est extra omne genus. Quaecumque sunt communia Deo et creaturae, sunt talia quae conveniunt enti ut est indifferens ad finitum et infinitum: ut enim conveniunt Deo, sunt infinita, ut creaturae, sunt finita». «L ente si divide in infinito e finito prima che nei dieci predicamenti, poiché uno di questi, cioè finito, è comune ai dieci generi; dunque, tutto ciò che conviene all ente in quanto è indifferente al finito e all infinito, o che è proprio dell ente infinito, gli conviene non in quanto è determinato a un genere, ma precedentemente, e di conseguenza in quanto è trascendente ed è fuori di ogni genere. Tutte le caratteristiche comuni a Dio e alle creature sono tali che convengono all ente on quanto è indifferente al finito e all infinito: infatti, in quanto convengono a Dio sono infinite, in quanto alle creature sono finite». T5. Le passiones entis: convertibili semplici o disgiuntive [disiunctae] (Ordinatio I, d.8, p.1, q.3, n. 115; Ed. Vaticana IV, pp ) «Ens non tantum habet passiones simplices convertibiles, - sicut unum, verum et bonum- sed habet aliquas passiones ubi opposita distinguuntur contra se, sicut necesse-esse vel possibile, actus vel potentia, et huiusmodi. Sicut autem passiones convertibiles sunt transcendentes quia consequuntur ens in quantum non determinatur ad aliquod genus, ita passiones disiunctae sunt transcendentes, et utrumque membrum illius disiuncti est transcendens quia neutrum determinat suum determinabile ad certum genus: et tamen unum membrum illius disiuncti formaliter est speciale, non conveniens nisi uni enti, - sicut necesse-esse in ista divisione 'necesse-esse vel possibile-esse, et infinitum in ista divisione 'finitum vel infinitum', et sic de aliis». «L ente non possiede solo le passioni semplici convertibili, - come uno, vero e buono ma ha anche alcune passioni in cui si distinguono fra loro caratteristiche opposte, come essere necessario-opossibile, atto-o-potenza, e così via. Allora, allo stesso modo in cui le passioni convertibili sono trascendenti perché caratterizzano l ente in quanto non è determinato a un genere, anche le passioni disgiuntive sono trascendenti, e ciascuno dei due membri della disgiunzione è trascendente perché nessuno dei due determina il proprio determinabile a un particolare genere: e tuttavia uno dei due termini della disgiunzione è formalmente speciale in quanto non conviene che a un ente, - come essere necessario nella divisione esserenecessario o essere-possibile e infinito nella divisione finito-o-infinito, e così degli altri». T6 - Definizione di ordine essenziale (ordo essentialis) «Non intendo tuttavia l ordine essenziale in senso stretto come fanno alcuni, affermando che ciò che è posteriore (posterius) è ordinato, mentre ciò che è anteriore (prius) o primo (primum) si pone al di sopra dell ordine -, ma in senso largo (communiter), in quanto l ordine è una relazione di comparazione che si dice dell anteriore rispetto al posteriore e viceversa, in quanto cioè ciò che è ordinato viene adeguatamente diviso tra ciò che è anteriore e ciò che è posteriore (ordo est relatio aequiparantiae dicta de priori respectu posterioris et e converso, prout scilicet ordinatum sufficienter dividitur per prius et posterius). Così, talora si parlerà di ordine, talora di anteriorità e posteriorità» (DPP n. 3). 2
3 - Divisioni dell ordine essenziale (DPP nn. 4-7) Ordine essenziale / / eminenza (eminente ecceduto) - materiale (causa materiale materiatum) / - causalità formale (causa formale formatum) / / - efficiente (causa efficiente - effectum) / / - finale (causa finale - finitum) dipendenza (causa - causatum) \ prossimo \ / condizionamento (condizione condizionato) \ remoto Il lessico del possibile: - causa efficiente effectum effectivum effectibile - causa finale finitum finitivum finibile - ordo eminentiae eminens - excessum T 7 - Struttura dell argomentazione (DPP nn ) n Domine Deus noster, qui te primum esse ac novissimum predicasti, doce servum tuum, te esse primum efficiens et primum eminens finemque ultimum ostendere ratione, quod certissima fide tenet. De sex quippe ordinibus essentialisbus supradictis tres placet eligere; duos causalitatis extrinsecae et unum eminentiae, atque in istis tribus ordinibus aliquam naturam unam simpliciter primam esse, si dederis, demonstrare. Ideo autem dico naturam unam, quia in hoc capitulo tertio praedictae tres primitates non de unico singulari seu secundum numerum ostendetur, sed de unica quidditate vel natura; de unitate vero numerali inferius erit sermo. n PRIMA CONCLUSIO: Aliqua est natura in entibus effectiva. Quod ostenditur: Aliqua est effectibilis, ergo aliqua effectiva. Consequentia patet per natura correlativorum. Antecedens probatur: Tum, quia aliqua est contingens; igitur possibilis esse post non esse; ergo non a se, nec a nihilo utroque enim modo ens foret a non ente; ergo ab alio effectibilis. Tum, quia aliqua natura est mobilis vel mutabilis, quia possibilis carere aliqua perfectione possibili sibi inesse; ergo terminus motus potest incipere et ita effici. n In hac conclusione et quibusdam sequentibus n Signore Dio nostro, che hai designato te stesso come primo e come ultimo, insegna al Tuo servo a mostrare con la ragione ciò che già tiene con fede saldissima, che Tu sei il primo efficiente, il primo eminente e il fine ultimo. Dei sei ordini essenziali prima distinti, ci piace dunque sceglierne tre i due relativi alla causalità estrinseca e quello dell eminenza e in questi tre ordini vorremmo mostrare, se ce lo concederai, che vi è una natura unitaria assolutamente prima. Dico natura unitaria perché in questo terzo capitolo le tre primità (primitates) prima citate non saranno mostrare come proprie di un solo individuo o secondo l unità numerica, ma come proprie di un unica quiddità o natura; dell unità numerica si parlerà invece più oltre n PRIMA CONCLUSIONE: Tra gli enti vi è una natura capace di produrre effetti. Si dimostra: vi è una natura capace di essere prodotta, dunque deve esservene una capace di produrre. La conseguenza risulta evidente per la natura dei correlativi. Si dimostra l antecedente: in primo luogo, perché qualche natura è contingente, e dunque è possibile che sia dopo non essere stata, ma non da sé, né dal nulla (in entrambi i casi infatti un ente sarebbe a partire dal non-ente), dunque in quanto può essere prodotta da altro. In secondo luogo, perché qualche natura è mobile o mutevole, perché può mancare di una qualche perfezione che potrebbe appartenergli; dunque il termine del movimento può avere un inizio e così essere prodotto. n In questa conclusione e in alcune delle successive 3
4 possem proponere actum sic: Aliqua natura est efficiens, quia aliqua est effecta, quia aliqua incipit esse, quia aliqua est terminus motus et contingens. Sed malo de possibili proponere conclusiones et praemissas. Illi quippe de actu concessis, istae de possibili conceduntur, non e converso. Illae etiam de actu sunt contingentes, licet satis manifestae, istae de possibili sunt necessariae. Illae ad ens existens, istae ad ens etiam quidditative sumptum possunt proprie pertinere. Et existentia illius quidditatis inferius ostendetur, de qua nunc ostenditur efficientia. potrei riferirmi a ciò che è in atto in questo modo: qualche natura è capace di produrre effetti, perché qualcuna è prodotta, o perché qualcuna inizia a essere, o perché qualcuna è termine di un movimento e contingente. Ma preferisco proporre conclusioni e premesse intorno al possibile. Concesse quelle conclusioni a proposito di ciò che è in atto, si concedono queste intorno al possibile, non viceversa. Quelle relative a ciò che è in atto sono per di più contingenti, per quanto abbastanza manifeste, queste sul possibile sono necessarie. Quelle possono riferirsi propriamente all ente esistente, queste anche all ente preso in senso quidditativo. E l esistenza della quiddità di cui si dimostra l efficienza si mostrerà più oltre T 8 Definizione di contingente «Non chiamo qui contingente tutto ciò che non è necessario né eterno, ma ciò il cui opposto potrebbe attuarsi nel momento in cui esso si realizza (cuius oppositum posset fieri quando istud fit). Proprio per questo ho detto qualcosa è causato in modo contingente e non qualcosa è contingente» (DPP n. 56) T 9 Divenire e contingenza (Ordinatio I, d. 38, p. 2; Ed. Vaticana VI, Appendix A, pp ) «Dico quod istum disiunctum necessarium vel possibile est passio entis [...] Ideo igitur non potest ostendi de ente - per aliquod prius medium - disiunctum necessarium vel contingens. Nec etiam ista pars disiuncti - quae est contingens - posset ostendi de aliquo, supposito necessario de aliquo; et ideo videtur ista aliquod ens est contingens esse vera primo et non demonstrabilis propter quid. [...] Et ideo negantes talia manifesta indigent poena vel sensu, quia - secundum Avicennam I Metaphysicae - negantes primum principium sunt vapulandi vel exponendi igni, quousque concedant quod non est idem comburi et non comburi, vapulari et non vapulari. Ita etiam isti qui negant aliquod ens contingens, exponendis sunt tormentis, quousque concedant quod possibile est eos non torqueri». «Dico che questa disgiunzione necessario o possibile è una proprietà dell ente ( ) Pertanto la disgiunzione necessario o contingente non può essere dimostrata dell ente attraverso un termine medio anteriore. Neppure questa parte della disgiunzione che è contingente può essere mostrata di qualcosa, supponendo necessario di altro; perciò sembra che questa proposizione qualche ente è contingente è vera in modo immediato e non dimostrabile a posteriori ( ) Perciò coloro che negano tali cose evidenti hanno bisogno di una punizione o di un supplemento dei sensi, poiché secondo Avicenna Metafisica I coloro che negano un principio primo devono essere bastonati o esposti al fuoco finché non ammettano che non è la stessa cosa essere bruciati e non essere bruciati, bastonati o non bastonati. Allo stesso modo, coloro che negano che qualche ente è contingente, devono essere esposti ai tormenti, finché non ammettano che è possibile non contorcersi». T 10 Unità dell ordine, unità e unicità dell universo (DPP nn. 43, 47-48) n Sine unitate ordinis non est unitas universi. In ipso fine uno ponit Aristoteles bonitatem principalem universi. Et quia ad unum summum est unus ordo, sufficit mihi loqui de solo universo, non fingere aliud de quo nullam habeo rationem, immo potius obviantem. n Senza unità d ordine non c è unità di universo. Nello stesso unico fine Aristotele pone la bontà principale dell universo. E poiché rispetto a un termine sommo vi è un solo ordine, mi è sufficiente parlare di un solo universo, senza immaginarne un altro, che non ho alcuna ragione di porre (anzi, semmai di evitare). n Quod non est finis nec ad finem aliquem, frustra; in entibus nihil est frustra; igitur quaelibet natura alia a primo fine est ad aliquem finem; et si ad aliquem, ergo ad primum, ex tertia secundi. n Ciò che non è né fine né ordinato a un fine è invano. Ma nulla è invano tra gli esseri; dunque, ogni natura diversa dal fine primo è ordinata a un fine e, se così è, è ordinata al primo, come risulta dalla terza 4
5 Similiter de eminente: Quod non est supremum nec excessum ab aliquo, nullum gradum habet; sic nihil est; igitur omne quod non est supremum est excessum ad aliquo; igitur a supremo ex tertia secundi. Ex his ostenditur de efficientia, quae negatur: Quidlibet est finis primus vel finitum iam supra; ergo est primum efficiens vel effectum, nam membra huius disiuncti convertuntur cum membris illius. ( ) Similiter per eminentiam: Si quidlibet est supremum vel excessum a supremo, ergo primum efficiens vel effectum, quia et haec membra convertuntur ex penultima et ultima secundi et decima quinta huius tertii. Positio etiam alicuius entis nullum ordinem habentis irrationalis est valde ( ). n Vere, Domine, omnia in sapientia ordinate fecisti, ut cuilibet intellectui rationabile videatur quod omne ens est ordinatum. Unde absurdum fuit philosophantibus ordinem ab aliquo amovere. Ex hac autem universali omne ens est ordinatum sequitur quod non omne ens est posterius et non omne prius; quia utroque modo vel idem ad se ordinaretur velcirculus in ordine poneretur. Est ergo aliquod ens prius non posterius, et ita primum; et aliquod posterius et non prius; nullum autem quin vel prius vel posterius. Tu es unicum primum, et omne aliud a te posterius est te, sicut in triplici ordine, ut potui, declaravi. conclusione del secondo capitolo. Analogamente in rapporto all eminenza: ciò che non è supremo né ecceduto da qualche altra cosa, non possiede alcun grado, e così è nulla; di conseguenza, tutto ciò che non è supremo è ecceduto da qualcosa; dunque, da ciò che è supremo, come risulta dalla terza conclusione del secondo capitolo. A partire da ciò si mostra in rapporto all efficienza, che è negata: ogni cosa è o fine primo o è un finito, com è stato dimostrato; dunque, o è il primo efficiente o è un effetto, perché i termini di questa disgiunzione sono convertibili con quelli dell altra 1 ( ) Analogamente si dimostra per mezzo dell eminenza: se qualsiasi cosa è o lo stesso supremo o è ecceduto dall essere supremo, dunque o è il primo efficiente o un effetto, perché anche questi termini sono convertibili, come risulta dalla penultima e dall ultima conclusione del secondo capitolo e dalla quindicesima di questo terzo capitolo 2. Porre un qualche ente del tutto privo di ordine è assolutamente irrazionale 3 ( ) n Davvero Signore, hai fatto ordinatamente tutte le cose nella sapienza, in modo tale che a qualunque intelletto sembri ragionevole che ogni ente sia ordinato. E per questo è risultato assurdo a coloro che si dedicavano alla filosofia rimuovere l ordine da qualcosa. Da questa universale ogni ente è ordinato segue che non ogni ente è posteriore e non ogni ente è anteriore, perché in entrambi i modi o una cosa si troverebbe a essere ordinata a se stessa o si porrebbe una circolarità nell ordine. Vi è dunque qualche ente che è anteriore e non posteriore, e così primo; e qualche ente che è posteriore, e non anteriore; nessuno tuttavia che non sia o anteriore o posteriore. Tu sei l unico primo, e ogni cosa diversa da Te è posteriore a Te, così come ho cercato di illustrare, per quanto mi è stato possibile, secondo un triplice ordine. T 11 Alle radici della contingenza (DPP n. 56) n Aliquid causatur contingenter; igitur prima causa contingenter causat; igitur volens causat. Probatio primae consequentiae: Quaelibet causa secunda n Qualcosa è causato in modo contingente; quindi, la causa prima causa in modo contingente, e, perciò, in modo volontario. Prova della prima conseguenza: ogni causa seconda causa 1 Si veda in proposito DPP cap. 2, concl. 4 Quod non est finitum non est effectum, e concl. 5 Quod non est effectum non est finitum (ed. Porro nn ). Scoto dimostra in questi termini: il finito non dipende dal fine quanto all essere, ma perché il fine, in quanto amato, muove l efficiente a dargli l essere. 2 Cfr. DPP cap. 2 concl. 15 (ed. Porro, n. 21): Non si deve mai porre una pluralità senza necessità e Cap. concl. 16 (ed. Porro, n. 22): Tutto ciò che finito è ecceduto (omne finitum est excessum). Scoto dimostra quest ultima conclusione osservando che il fine è migliore di ciò che è ordinato a esso; ciò si dimostra perché il fine, in quanto amato, muove l efficiente a causare. La concl. 15 del cap. 3 dichiara: la triplice primità (primitas) nel triplice ordine essenziale citato, cioè di efficienza, di fine e di eminenza, appartiene a una sola e identica natura esistente in atto (ed. Porro n. 40). 3 Cfr. DPP cap. 3, concl. 17: qualunque primità (primitas) della causa estrinseca di uno stesso tipo appartiene a una sola natura. In caso contrario, se vi fosse un altro primo di altri posteriori, questi formerebbero un altro universo, poiché quegli enti e questi non avrebbero alcun ordine tra loro né rispetto a una stessa cosa. Senza unità d ordine non c è unità di universo (ed. Porro, n. 43). La concl. 6 del cap. 3 è la seguente: la necessità di essere per sé conviene a una sola natura (ed. Porro, n. 36); la seconda prova a cui Scoto fa riferimento è la seguente: se due nature fossero necessarie, l una non avrebbe alcuna dipendenza dall altra nell essere, e dunque neppure nessun ordine essenziale; quindi una delle due non apparterrebbe a questo universo, perché dall ordine delle parti risulta l unità dell universo. 5
6 causat in quantum movetur a prima; ergo si prima necessario movet, quaelibet necessario movetur et quidlibet necessario causatur. Probatio secundae consequentiae: Nullum est principium contingenter operandi nisi voluntas vel concomitans voluntatem, quia quaelibet alia agit ex necessitate naturae, et non contingenter in quanto è mossa dalla prima; quindi, se la prima muovesse in modo necessario, ogni altra sarebbe mossa in modo necessario e tutto sarebbe causato in modo necessario. Prova della seconda conseguenza: nulla è principio dell operare in modo contingente se non la volontà o qualcosa di concomitante ad essa, perché qualunque altra causa agisce per necessità di natura e, quindi, non in modo contingente. T 12 Contingenza e volontà (Quaestiones subtilissimae super libros Metaphysicorum Aristotelis IX, q. 15, n ; Opera Philosophica IV, St. Bonaventure - New York 1997, pp ) 22 - Prima distinctio potentiae activae est secundum diversum modum eliciendi operationem ( ) Iste autem modus eliciendi operationem propriam non potest esse in genere nisi duplex. Aut enim potentia ex se est determinata ad agendum, ita quod, quantum est ex se, non potest non agere quando non impeditur ab estrinseco. Aut non est ex se determinata, sed potest agere hunc actum vel oppositum actum, agere etiam vel non agere. Prima potentia communiter dicitur natura, secunda dicitur voluntas 34 - Indeterminatio autem quae ponitur in voluntate non est materialis, nec imperfectionis, in quantum ipsa est activa sed excellentis perfectionis et potestativae, non alligatae ad determinatum actum 43 - Voluntas autem actionis suae ( ) non est principium ex se determinatum, sed potestativum determinativum sui ad alterutrum ( ) voluntas est principium activum distinctum contra genus principiorum activorum, quae non sunt voluntas, per oppositum modum agendi». Per Scoto la volontà è una perfezione pura, comune al finito e all infinito Voluntas, quando est in aliqua volitione, tunc contingenter est in illa, et illa volitio tunc contingenter est ab ipsa; nisi enim tunc, numquam, quia numquam alias est ab ipsa. Et sicut illa contingenter inest, ita voluntas tunc est potentia potens respectu oppositi. La prima distinzione delle potenze attive è secondo il diverso modo di operare ( ) ma questo modo di compiere l azione propria non può essere in genere se non duplice. O infatti la potenza è determinata ad agire per natura (ex se) così che, considerata in se stessa, non può non agire quando non è impedita da fattori esterni. Oppure non è determinata per natura, ma può compiere un azione o quella opposta, agire o non agire. La prima potenza comunemente è detta natura, la seconda è detta volontà L indeterminazione che caratterizza la volontà non è di tipo materiale, né dovuta a imperfezione, in quanto la stessa è attiva, ma è dovuta a eccellenza di perfezione e di potere, non vincolato a un determinato atto 43 - La volontà tuttavia ( ) non è principio intrinsecamente determinato della sua azione, ma è in potere di determinare se stessa ad altro ( ) La volontà è un principio attivo distinto dagli altri generi di principi attivi che non sono volontà, a motivo di un modo di agire opposto La volontà quando compie una certa volizione, lo fa in modo contingente, e quella volizione procede da essa in modo contingente ( ) E poiché opera in modo contingente, per tale motivo la volontà è una potenza aperta agli opposti. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE SERAFINI M., Dagli enti finiti all Ente Infinito nel De primo Principio di Giovanni Duns Scoto, in Dagli enti all Essere. Itinerari di teologia naturale (vol. monografico di Sensus Communis. International Yearbook for Studies on Alethic Logic, n. 22), Casa Editrice Leonardo da Vinci, Roma 2015, pp SERAFINI M., Fede e ragione nel mistero di libertà della persona umana, in Fede e ragione. Le luci della verità. In occasione del decimo anniversario dell enciclica Fides et ratio, a cura di Antonio Porras, EDUSC, Roma 2012, pp SERAFINI M., Dignità e limiti della ragione nel De primo Principio di Giovanni Duns Scoto, in Mediaeval Sophia. Studi e ricerche sui saperi medievali, Peer e-review semestrale dell Officina di Studi Medievali 10 (luglio-dicembre 2011), pp
Guido Alliney Trento, 4 dicembre Libera volontà. Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto
 Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista. Se Dio esista
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
Tommaso d Aquino > NOTE INTRODUTTIVE <
 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
> NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642)
 Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642) In tutte e tre le prove delle Meditazioni Descartes parte dall idea di Dio: III Meditazione: 2 prove a posteriori che procedono dall effetto
Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642) In tutte e tre le prove delle Meditazioni Descartes parte dall idea di Dio: III Meditazione: 2 prove a posteriori che procedono dall effetto
L univocità dell essere in Duns Scoto e Spinoza
 L univocità dell essere in Duns Scoto e Spinoza Premessa La filosofia e la matematica sono le uniche attività intellettuali dell uomo che per certi aspetti, nonostante il passare dei secoli, mantengono
L univocità dell essere in Duns Scoto e Spinoza Premessa La filosofia e la matematica sono le uniche attività intellettuali dell uomo che per certi aspetti, nonostante il passare dei secoli, mantengono
BENEDETTO SPINOZA a cura di Pietro Gavagnin con il contributo degli alunni di 4AOL as
 BENEDETTO SPINOZA 1632-1677 a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net con il contributo degli alunni di 4AOL as 2014-2015 OPERE: TRATTATO TEOLOGICO - POLITICO (1670) Scopo fondamentale del trattato è la
BENEDETTO SPINOZA 1632-1677 a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net con il contributo degli alunni di 4AOL as 2014-2015 OPERE: TRATTATO TEOLOGICO - POLITICO (1670) Scopo fondamentale del trattato è la
Tommaso d Aquino > NOTE INTRODUTTIVE <
 1221 1274 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare,
1221 1274 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare,
LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO
 LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO Con Anselmo d Aosta nasce all interno della Chiesa una corrente di pensiero, la teologia analitica, che si ripropone di dimostrare l esistenza di Dio
LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO Con Anselmo d Aosta nasce all interno della Chiesa una corrente di pensiero, la teologia analitica, che si ripropone di dimostrare l esistenza di Dio
PERCORSI DELL'INFINITO NEL PENSIERO FILOSOFICO E TEOLOGICO DI DUNS SCOTO
 PERCORSI DELL'INFINITO NEL PENSIERO FILOSOFICO E TEOLOGICO DI DUNS SCOTO 2 Alessandro Ghisalberti* SÍNTESE Com base na metafísica dos transcendentais, quer-se mostrar a análise scotista do conceito de
PERCORSI DELL'INFINITO NEL PENSIERO FILOSOFICO E TEOLOGICO DI DUNS SCOTO 2 Alessandro Ghisalberti* SÍNTESE Com base na metafísica dos transcendentais, quer-se mostrar a análise scotista do conceito de
Introduzione. - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare
 Falsiroli Simonetta 1 Introduzione Scopi: - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare - Focalizzare l attenzione ai riferimenti matematici contenuti nel testo 2 1 L opera:
Falsiroli Simonetta 1 Introduzione Scopi: - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare - Focalizzare l attenzione ai riferimenti matematici contenuti nel testo 2 1 L opera:
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 1 Il fine ultimo dell uomo. Il fine ultimo dell'uomo
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 1 Il fine ultimo dell uomo Il fine ultimo dell'uomo prima pars secundae partis Quaestio 1 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione 1 Proemio [33405]
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 1 Il fine ultimo dell uomo Il fine ultimo dell'uomo prima pars secundae partis Quaestio 1 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione 1 Proemio [33405]
Introduzione alla Teologia
 Introduzione alla Teologia Settima lezione: La nascita della teologia scolastica Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 11 dicembre
Introduzione alla Teologia Settima lezione: La nascita della teologia scolastica Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 11 dicembre
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali
 S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
Parte prima > Trattato relativo all'essenza di Dio > La scienza di Dio
 Parte prima > Trattato relativo all'essenza di Dio > La scienza di Dio Prima pars Quaestio 14 Prooemium Prima parte Questione 14 Proemio [28893] Iª q. 14 pr. Post considerationem eorum quae ad divinam
Parte prima > Trattato relativo all'essenza di Dio > La scienza di Dio Prima pars Quaestio 14 Prooemium Prima parte Questione 14 Proemio [28893] Iª q. 14 pr. Post considerationem eorum quae ad divinam
Duns Scoto e l analogia entis
 19 Duns Scoto e l analogia entis LEONARDO CAPPELLETTI This article shows that, within the Duns Scotus s metaphisical doctrine (like in quaestiones subtilissimae super libros metaphysicorum Aristotelis),
19 Duns Scoto e l analogia entis LEONARDO CAPPELLETTI This article shows that, within the Duns Scotus s metaphisical doctrine (like in quaestiones subtilissimae super libros metaphysicorum Aristotelis),
sempre vere sempre false
 Logica: elementi I principi della logica sono innanzitutto i seguenti: Identità: a=a (ogni cosa è cioè identica a se stessa) Non contraddizione: non (a e non a). E impossibile che la stessa cosa sia e
Logica: elementi I principi della logica sono innanzitutto i seguenti: Identità: a=a (ogni cosa è cioè identica a se stessa) Non contraddizione: non (a e non a). E impossibile che la stessa cosa sia e
Il primato del bene sul vero nella dottrina dei perfettibili di Padre Alberto Boccanegra
 Il primato del bene sul vero nella dottrina dei perfettibili di Padre Alberto Boccanegra P. Giovanni Bertuzzi O.P. P. Alberto Boccanegra distingue, prima di tutto, il punto di vista analitico da quello
Il primato del bene sul vero nella dottrina dei perfettibili di Padre Alberto Boccanegra P. Giovanni Bertuzzi O.P. P. Alberto Boccanegra distingue, prima di tutto, il punto di vista analitico da quello
GIOVANNI DI MIRECOURT, COMMENTO ALLE SENTENZE
 GIOVANNI DI MIRECOURT, COMMENTO ALLE SENTENZE nato 1310/1315 legge e commenta le Sentenze a Parigi nel 1345 condannato nel 1346 morto probabilmente durante la grande peste del 1348/50 monaco cistercense
GIOVANNI DI MIRECOURT, COMMENTO ALLE SENTENZE nato 1310/1315 legge e commenta le Sentenze a Parigi nel 1345 condannato nel 1346 morto probabilmente durante la grande peste del 1348/50 monaco cistercense
Immanuel Kant. Critica della Ragion Pratica. I Postulati
 Immanuel Kant Critica della Ragion Pratica. I Postulati I postulati di Kant sono quelle proposizioni teoretiche non dimostrabili che ineriscono alla legge morale come condizione della sua stessa esistenza
Immanuel Kant Critica della Ragion Pratica. I Postulati I postulati di Kant sono quelle proposizioni teoretiche non dimostrabili che ineriscono alla legge morale come condizione della sua stessa esistenza
TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI
 TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI LA SCOLASTICA E LA FILOSOFIA CRISTIANA DEL MEDIOEVO SVILUPPATASI FRA L XI e IL XIV SECOLO ESSA VENNE ELABORATA NELLE SCHOLAE ISTITUITE NEI MONASTERI, DOPO
TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI LA SCOLASTICA E LA FILOSOFIA CRISTIANA DEL MEDIOEVO SVILUPPATASI FRA L XI e IL XIV SECOLO ESSA VENNE ELABORATA NELLE SCHOLAE ISTITUITE NEI MONASTERI, DOPO
I PRONOMI E AGGETTIVI
 I PRONOMI E AGGETTIVI INDEFINITI Quis, quid Qui, quae, quod I pronomi e gli aggettivi indefiniti più frequenti Aliquis, aliquid Aliqui, aliqua, aliquod Quisquam, quidquam Ullus, a, um Quidam, quaedam,
I PRONOMI E AGGETTIVI INDEFINITI Quis, quid Qui, quae, quod I pronomi e gli aggettivi indefiniti più frequenti Aliquis, aliquid Aliqui, aliqua, aliquod Quisquam, quidquam Ullus, a, um Quidam, quaedam,
lemma traduzione parte del discorso gruppo posizione māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 Declinazione)
 māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
Padre Luigi Salerno, OP L oggetto della metafisica
 Padre Luigi Salerno, OP L oggetto della metafisica In relazione all opera fondamentale del Padre Tyn Metafisica della sostanza, ritengo opportuno esporre queste mie riflessioni, già contenute in una mia
Padre Luigi Salerno, OP L oggetto della metafisica In relazione all opera fondamentale del Padre Tyn Metafisica della sostanza, ritengo opportuno esporre queste mie riflessioni, già contenute in una mia
LA QUESTIONE DEL RAPPORTO FRA OPERAZIONE DIVINA E OPERAZIONE CREATURALE NEL PENSIERO DI TOMMASO D AQUINO
 LA QUESTIONE DEL RAPPORTO FRA OPERAZIONE DIVINA E OPERAZIONE CREATURALE NEL PENSIERO DI TOMMASO D AQUINO MARCO FORLIVESI La dottrina del Liber de veritate catholicæ fidei QUESTIONE GENERALE Il Liber de
LA QUESTIONE DEL RAPPORTO FRA OPERAZIONE DIVINA E OPERAZIONE CREATURALE NEL PENSIERO DI TOMMASO D AQUINO MARCO FORLIVESI La dottrina del Liber de veritate catholicæ fidei QUESTIONE GENERALE Il Liber de
IMMANUEL KANT CRITICA DELLA RAGION PURA LOGICA TRASCENDENTALE
 IMMANUEL KANT CRITICA DELLA RAGION PURA LOGICA TRASCENDENTALE Senza sensibilità nessun oggetto ci sarebbe dato, e senza intelletto nessun oggetto verrebbe pensato. I pensieri senza contenuto sono vuoti,
IMMANUEL KANT CRITICA DELLA RAGION PURA LOGICA TRASCENDENTALE Senza sensibilità nessun oggetto ci sarebbe dato, e senza intelletto nessun oggetto verrebbe pensato. I pensieri senza contenuto sono vuoti,
possibili [LEIBNIZ, Discours de Metaphysique, 6: GP IV 431; cfr. GP III 558; VI 244, 241,
 Gennaro AULETTA Il problema della scelta di Dio. Un breve esame di una tesi di Leibniz alla luce della discussione medievale Summary: Leibniz thesis that God chooses the best possible world is analyzed.
Gennaro AULETTA Il problema della scelta di Dio. Un breve esame di una tesi di Leibniz alla luce della discussione medievale Summary: Leibniz thesis that God chooses the best possible world is analyzed.
Esse, essentia, ordo. Verso una metafisica della partecipazione operativa Alain Contat
 Esse, essentia, ordo. Verso una metafisica della partecipazione operativa Alain Contat Non c è discepolo dell Aquinate che non sappia che l ultima resolutio metafisica dell ente sbocca su haec sublimis
Esse, essentia, ordo. Verso una metafisica della partecipazione operativa Alain Contat Non c è discepolo dell Aquinate che non sappia che l ultima resolutio metafisica dell ente sbocca su haec sublimis
Riflessioni in margine ad una opportuna distinzione tra le verità di fede e l autonomia della ragione umana.
 SAGGIO di Angelo Marchesi Riflessioni in margine ad una opportuna distinzione tra le verità di fede e l autonomia della ragione umana. Ho letto con interesse, (come vecchio docente di Filosofia della religione
SAGGIO di Angelo Marchesi Riflessioni in margine ad una opportuna distinzione tra le verità di fede e l autonomia della ragione umana. Ho letto con interesse, (come vecchio docente di Filosofia della religione
Ockham e la dimostrazione dell esistenza di Dio
 Annali del Dipartimento di Filosofia (Nuova Serie), XIII (2007), pp. 5-31 ISSN 1824-3770 (online) 2008 Firenze University Press Ockham e la dimostrazione dell esistenza di Dio Fabrizio Amerini In this
Annali del Dipartimento di Filosofia (Nuova Serie), XIII (2007), pp. 5-31 ISSN 1824-3770 (online) 2008 Firenze University Press Ockham e la dimostrazione dell esistenza di Dio Fabrizio Amerini In this
Boezio e la teoria delle proporzioni. Calcidio e il commento al Timeo di Platone
 Boezio e la teoria delle proporzioni Calcidio e il commento al Timeo di Platone 1 Boethii De institutione arithmetica libri duo 2. 40-54 dottrina delle proporzioni 2 media aritmetica posti tre o più termini,
Boezio e la teoria delle proporzioni Calcidio e il commento al Timeo di Platone 1 Boethii De institutione arithmetica libri duo 2. 40-54 dottrina delle proporzioni 2 media aritmetica posti tre o più termini,
STUDI ALCUNE TRATTAZIONI TARDO-MEDIEVALI SULL UNIVOCITÀ E L ANALOGIA DELL ENTE* di Saverio Di Liso
 STUDI ALCUNE TRATTAZIONI TARDO-MEDIEVALI SULL UNIVOCITÀ E L ANALOGIA DELL ENTE* di Saverio Di Liso 1. L analogia, l univocità, il concetto di ente: un excursus storico Le teorie medievali dell analogia
STUDI ALCUNE TRATTAZIONI TARDO-MEDIEVALI SULL UNIVOCITÀ E L ANALOGIA DELL ENTE* di Saverio Di Liso 1. L analogia, l univocità, il concetto di ente: un excursus storico Le teorie medievali dell analogia
NICOLA ABBAGNANO TULLIO GREGORY
 COLLEZIONE FONDATA DA NICOLA ABBAGNANO DIRETTA DA TULLIO GREGORY LIBRO DELLA GUARIGIONE LE COSE DIVINE di Avicenna (Ibn Sīnā) a cura di AMOS BERTOLACCI UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE 2007 Unione
COLLEZIONE FONDATA DA NICOLA ABBAGNANO DIRETTA DA TULLIO GREGORY LIBRO DELLA GUARIGIONE LE COSE DIVINE di Avicenna (Ibn Sīnā) a cura di AMOS BERTOLACCI UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE 2007 Unione
Crisi dell Eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo
 Marco Rainini Crisi dell Eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22 maggio 2015 1 «Hinc est, quod saepe divina virtus armatos dialecticorum syllogismos,
Marco Rainini Crisi dell Eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22 maggio 2015 1 «Hinc est, quod saepe divina virtus armatos dialecticorum syllogismos,
Cicerone, Somnium Scipionis 27-28
 Cicerone, Somnium Scipionis 27-28 Andrea Barabino Nel Somnium Scipionis, che costituisce la parte conclusiva del De re publica - un'opera a noi giunta solo in frammenti di varia estensione - Cicerone immagina
Cicerone, Somnium Scipionis 27-28 Andrea Barabino Nel Somnium Scipionis, che costituisce la parte conclusiva del De re publica - un'opera a noi giunta solo in frammenti di varia estensione - Cicerone immagina
Enrico di Gand (Henricus de Gandavo)
 Enrico di Gand (Henricus de Gandavo) Somma delle questioni ordinarie (Summa quaestionum ordinariarum), art. 21, q. 2: Se Dio comunichi, nell essere, con le creature (Utrum Deus in esse communicet cum creaturis).
Enrico di Gand (Henricus de Gandavo) Somma delle questioni ordinarie (Summa quaestionum ordinariarum), art. 21, q. 2: Se Dio comunichi, nell essere, con le creature (Utrum Deus in esse communicet cum creaturis).
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER I BENEFICIARI
 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER I BENEFICIARI Linee guida per i beneficiari per realizzare targhe e cartelli informativi sugli interventi realizzati con il sostegno del PSR Toscana 2014-2020.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER I BENEFICIARI Linee guida per i beneficiari per realizzare targhe e cartelli informativi sugli interventi realizzati con il sostegno del PSR Toscana 2014-2020.
ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C.
 ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C. CONFRONTO CON PLATONE DA OSSERVARE: - DifFERENTE CONTESTO SOCIO-POLITICO; - INTERESSE POLITICO-EDUCATIVO IN PLATONE; INTERESSE CONOSCITIVO-SCIENTIFICO IN
ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C. CONFRONTO CON PLATONE DA OSSERVARE: - DifFERENTE CONTESTO SOCIO-POLITICO; - INTERESSE POLITICO-EDUCATIVO IN PLATONE; INTERESSE CONOSCITIVO-SCIENTIFICO IN
Prefazione 13. Capitolo ii
 Prefazione 13 Capitolo i Introduzione alla logica 1 Definizioni della logica....................... 20 1.1 Logica naturale e logica scientifica.............. 21 1.2 L oggetto della logica.....................
Prefazione 13 Capitolo i Introduzione alla logica 1 Definizioni della logica....................... 20 1.1 Logica naturale e logica scientifica.............. 21 1.2 L oggetto della logica.....................
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 179 Divisione della vita in attiva e contemplativa. Divisione della vita in attiva e contemplativa
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 179 Divisione della vita in attiva e contemplativa Divisione della vita in attiva e contemplativa Prooemium Proemio [46084] IIª-IIae, q. 179 pr. Consequenter
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 179 Divisione della vita in attiva e contemplativa Divisione della vita in attiva e contemplativa Prooemium Proemio [46084] IIª-IIae, q. 179 pr. Consequenter
Prologo dell'ordinatio
 BEATO GIOVANNI DUNS SCOTO Prologo dell'ordinatio Traduzione italiana con testo originale a fronte A cura del Seminario Teologico "Immacolata Mediatrice" dei Frati Francescani dell'immacolata Premessa di
BEATO GIOVANNI DUNS SCOTO Prologo dell'ordinatio Traduzione italiana con testo originale a fronte A cura del Seminario Teologico "Immacolata Mediatrice" dei Frati Francescani dell'immacolata Premessa di
MALATTIE PROFESSIONALI: UN ADEGUATA TUTELA?
 Bergamo, 2 Febbraio 2018 Dr.Gianna Beranti SSR INAIL Lombardia MALATTIE PROFESSIONALI: UN ADEGUATA TUTELA? DENUNCE MP LAVORATORI- anno di protocollazione 2012-2016- BANCA DATI INAIL 9.000 Denunce 8.000
Bergamo, 2 Febbraio 2018 Dr.Gianna Beranti SSR INAIL Lombardia MALATTIE PROFESSIONALI: UN ADEGUATA TUTELA? DENUNCE MP LAVORATORI- anno di protocollazione 2012-2016- BANCA DATI INAIL 9.000 Denunce 8.000
4^ liceo Scientifico-Tecnologico (2010/2011) IL SILLOGISMO
 4^ liceo Scientifico-Tecnologico (2010/2011) IL SILLOGISMO Chiarita la natura delle sue proposizioni Aristotele negli analitici primi spiega quelle che sono le strutture e i modi del ragionamento, perché
4^ liceo Scientifico-Tecnologico (2010/2011) IL SILLOGISMO Chiarita la natura delle sue proposizioni Aristotele negli analitici primi spiega quelle che sono le strutture e i modi del ragionamento, perché
Logica filosofica. Terza Parte Il ragionamento
 Logica filosofica Terza Parte Il ragionamento Caratteristiche generali del ragionamento Definizione: Il ragionamento è un movimento della mente per il quale passiamo da diversi giudizi confrontatisi fra
Logica filosofica Terza Parte Il ragionamento Caratteristiche generali del ragionamento Definizione: Il ragionamento è un movimento della mente per il quale passiamo da diversi giudizi confrontatisi fra
Descartes Meditazioni Metafisiche. Schema
 Descartes Meditazioni Metafisiche Schema Corso di Storia della Filosofia 2015-16 Giovanni Paoletti Nota: La numerazione in paragrafi si riferisce all edizione a cura di S. Landucci, Laterza I meditazione
Descartes Meditazioni Metafisiche Schema Corso di Storia della Filosofia 2015-16 Giovanni Paoletti Nota: La numerazione in paragrafi si riferisce all edizione a cura di S. Landucci, Laterza I meditazione
!)Ku,Ky(! Luca Visone : PORTFOLIO :.
 .: PORTFOLIO :. ...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!... i 2 punti esclamativi all inizio ed alla fine del logo rappresentano la ferma volontà di voler riuscire in quelli
.: PORTFOLIO :. ...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!... i 2 punti esclamativi all inizio ed alla fine del logo rappresentano la ferma volontà di voler riuscire in quelli
Principio di non contraddizione e dialettica 3
 Principio di non contraddizione e dialettica 3 DIALET TICA E CONTRADDIZIONE IN HEGEL Passaggio dalla seconda alla terza lezione Nelle prime due lezioni abbiamo mostrato come la relazione tra le categorie
Principio di non contraddizione e dialettica 3 DIALET TICA E CONTRADDIZIONE IN HEGEL Passaggio dalla seconda alla terza lezione Nelle prime due lezioni abbiamo mostrato come la relazione tra le categorie
PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica
 PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica Tassi, I saperi dell educazione, cap. 1, pp. 5-19 Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 1, pp. 479-83 + testo pp. 502-503 SCOLASTICA = filosofia cristiana del
PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica Tassi, I saperi dell educazione, cap. 1, pp. 5-19 Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 1, pp. 479-83 + testo pp. 502-503 SCOLASTICA = filosofia cristiana del
S.Th., I a, q. 13, a. 1 Se Dio sia da noi nominabile
 S.Th., I a, q. 13, a. 1 Se Dio sia da noi nominabile [Ob. 2] Omne nomen aut dicitur in abstracto, aut in concreto. Sed nomina significantia in concreto, non competunt Deo, cum simplex sit, neque nomina
S.Th., I a, q. 13, a. 1 Se Dio sia da noi nominabile [Ob. 2] Omne nomen aut dicitur in abstracto, aut in concreto. Sed nomina significantia in concreto, non competunt Deo, cum simplex sit, neque nomina
PARMENIDE-ZENONE LA SCUOLA ELEATICA
 PARMENIDE-ZENONE LA SCUOLA ELEATICA Antonia D Aria Dispensa ad uso degli studenti del Liceo Natta di Milano BIBLIOGRAFIA: MASSARO Il pensiero che conta SINI I filosofi e le opere ALTRO MATERIALE SCARICATO
PARMENIDE-ZENONE LA SCUOLA ELEATICA Antonia D Aria Dispensa ad uso degli studenti del Liceo Natta di Milano BIBLIOGRAFIA: MASSARO Il pensiero che conta SINI I filosofi e le opere ALTRO MATERIALE SCARICATO
68 h 40 min km. Da Kant a Hegel
 Da Kant a Hegel 68 h 40 min. 5.956 km Da Kant a Hegel La critica a Kant La critica a Kant riguarda il rapporto tra soggetto e oggetto della conoscenza, tra pensiero ed essere. Nella Critica della ragion
Da Kant a Hegel 68 h 40 min. 5.956 km Da Kant a Hegel La critica a Kant La critica a Kant riguarda il rapporto tra soggetto e oggetto della conoscenza, tra pensiero ed essere. Nella Critica della ragion
4^ liceo Scientifico-Tecnologico (2010/2011) La fisica
 4^ liceo Scientifico-Tecnologico (2010/2011) La fisica I movimenti La fisica è quella scienza che studia l essere come movimento. Quindi le sostanze in movimento, che si possono percepire attraverso i
4^ liceo Scientifico-Tecnologico (2010/2011) La fisica I movimenti La fisica è quella scienza che studia l essere come movimento. Quindi le sostanze in movimento, che si possono percepire attraverso i
Pro Loco di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento
 _ Pro Loco di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento PREMIO LETTERARIO DI CULTURA LATINA Preside SALVATORE PACELLI Per gli studenti del penultimo e dell ultimo anno dei Licei Classici e Scientifici
_ Pro Loco di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento PREMIO LETTERARIO DI CULTURA LATINA Preside SALVATORE PACELLI Per gli studenti del penultimo e dell ultimo anno dei Licei Classici e Scientifici
Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità
 Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità Tommaso d Aquino 1225-1274 diritto naturale classico vs. antico vs. moderno Summa Theologiae I a -II ae, qq. 90
Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità Tommaso d Aquino 1225-1274 diritto naturale classico vs. antico vs. moderno Summa Theologiae I a -II ae, qq. 90
ISSN Marilena Maddaluna LE QUAESTIONES SUGLI ANALITICI PRIMI DELLO PSEUDOSCOTO
 ISSN 1722-9782 Marilena Maddaluna LE QUAESTIONES SUGLI ANALITICI PRIMI DELLO PSEUDOSCOTO 1 PREFAZIONE In quella miniera di sterminata letteratura logica che è la produzione scientifica e culturale del
ISSN 1722-9782 Marilena Maddaluna LE QUAESTIONES SUGLI ANALITICI PRIMI DELLO PSEUDOSCOTO 1 PREFAZIONE In quella miniera di sterminata letteratura logica che è la produzione scientifica e culturale del
Il credere come atto volontario secondo San Tommaso
 CONGRESSO TOMISTA INTERNAZIONALE L UMANESIMO CRISTIANO NEL III MILLENNIO: PROSPETTIVA DI TOMMASO D AQUINO ROMA, 21-25 settembre 2003 Pontificia Accademia di San Tommaso Società Internazionale Tommaso d
CONGRESSO TOMISTA INTERNAZIONALE L UMANESIMO CRISTIANO NEL III MILLENNIO: PROSPETTIVA DI TOMMASO D AQUINO ROMA, 21-25 settembre 2003 Pontificia Accademia di San Tommaso Società Internazionale Tommaso d
Sacra Famiglia anno C
 1 Prima lettura (1 Sam 1,20-22.24-28) Sacra Famiglia anno C Al finir dell anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, «perché diceva al Signore l ho richiesto». Quando poi Elkanà andò con
1 Prima lettura (1 Sam 1,20-22.24-28) Sacra Famiglia anno C Al finir dell anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, «perché diceva al Signore l ho richiesto». Quando poi Elkanà andò con
I PRONOMI RELATIVI. LA PROPOSIZIONE RELATIVA LA PROLESSI DELLA PROPOSIZIONE
 I PRONOMI RELATIVI. LA PROPOSIZIONE RELATIVA LA PROLESSI DELLA PROPOSIZIONE RELATIVA. IL NESSO RELATIVO. I PRONOMI RELATIVI-INDEFINITI IL PRONOME RELATIVO QUI, QUAE, QUOD (IL QUALE, LA QUALE, LA QUALE
I PRONOMI RELATIVI. LA PROPOSIZIONE RELATIVA LA PROLESSI DELLA PROPOSIZIONE RELATIVA. IL NESSO RELATIVO. I PRONOMI RELATIVI-INDEFINITI IL PRONOME RELATIVO QUI, QUAE, QUOD (IL QUALE, LA QUALE, LA QUALE
Come si fa a distinguere il vero dal falso? Occorre elaborare una filosofia pratica che migliori la vita dell uomo.
 1596-1650 Il Problema Come si fa a distinguere il vero dal falso? Occorre elaborare una filosofia pratica che migliori la vita dell uomo. Questa filosofia deve possedere un metodo unico e semplice che
1596-1650 Il Problema Come si fa a distinguere il vero dal falso? Occorre elaborare una filosofia pratica che migliori la vita dell uomo. Questa filosofia deve possedere un metodo unico e semplice che
Un codice semisconosciuto del Liber Abaci di Leonardo Pisano e le sue relazioni con Luca Pacioli
 Un codice semisconosciuto del Liber Abaci di Leonardo Pisano e le sue relazioni con Luca Pacioli ENRICO GIUSTI IL GIARDINO DI ARCHIMEDE, FIRENZE Sansepolcro, 14 giugno 2017 1. Codici contenenti tutta o
Un codice semisconosciuto del Liber Abaci di Leonardo Pisano e le sue relazioni con Luca Pacioli ENRICO GIUSTI IL GIARDINO DI ARCHIMEDE, FIRENZE Sansepolcro, 14 giugno 2017 1. Codici contenenti tutta o
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 5 Il conseguimento della beatitudine. Il conseguimento della beatitudine
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 5 Il conseguimento della beatitudine Il conseguimento della beatitudine Prima pars secundae partis Quaestio 5 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 5 Il conseguimento della beatitudine Il conseguimento della beatitudine Prima pars secundae partis Quaestio 5 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione
ISSN Direttore Capo Redattore. Filippo Ramondino Gianandrea de Antonellis Comitato di Redazione
 ISSN 2421-4736 Direttore Capo Redattore Comitato di Redazione Comitato Scientifico Direzione ed amministrazione Editore Progetto grafico Indirizzo Web is a Peer Reviewed Journal Numero 5, anno III www.samnium.org/veritatis-diaconia
ISSN 2421-4736 Direttore Capo Redattore Comitato di Redazione Comitato Scientifico Direzione ed amministrazione Editore Progetto grafico Indirizzo Web is a Peer Reviewed Journal Numero 5, anno III www.samnium.org/veritatis-diaconia
Sezione III. Tradizione
 Sezione III. Tradizione I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il mistero di Dio nella Tradizione IV. Presentazione sistematica del Mistero di Dio 8. L epoca prenicea
Sezione III. Tradizione I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il mistero di Dio nella Tradizione IV. Presentazione sistematica del Mistero di Dio 8. L epoca prenicea
Quale domanda fondamentale pone?
 S. Tommaso d Aquino Nasce nel 1225 nel castello di Roccasecca presso Aquino, nel basso Lazio, da un antica famiglia nobile (il padre di stirpe longobarda, la madre di stirpe normanna, I primi studi li
S. Tommaso d Aquino Nasce nel 1225 nel castello di Roccasecca presso Aquino, nel basso Lazio, da un antica famiglia nobile (il padre di stirpe longobarda, la madre di stirpe normanna, I primi studi li
ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio
 MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio Ti ringrazio, buon Signore, ti ringrazio, perché ciò che prima ho creduto per tuo dono, ora lo
MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio Ti ringrazio, buon Signore, ti ringrazio, perché ciò che prima ho creduto per tuo dono, ora lo
ANSELMO D AOSTA
 Prova ontologica (argomento a priori ) Lo stolto afferma: Qualcun altro, invece, afferma: DIO NON ESISTE (proposizione A) DIO È CIÒ DI CUI NON SI PUÒ PENSARE IL MAGGIORE (proposizione B) A questo punto
Prova ontologica (argomento a priori ) Lo stolto afferma: Qualcun altro, invece, afferma: DIO NON ESISTE (proposizione A) DIO È CIÒ DI CUI NON SI PUÒ PENSARE IL MAGGIORE (proposizione B) A questo punto
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814)
 Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta
 BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta corretto e vero. Un ragionamento è corretto se segue uno
BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta corretto e vero. Un ragionamento è corretto se segue uno
Il problema dell eternità del mondo in Matteo d Acquasparta
 Partecipazione ai processi documentari e cultura grafica degli ufficiali minori 169 Schola Salernitana - Annali, XXII (2017): 169-182 DOI 10.6092/1590-7937/5160 2017 Università degli Studi di Salerno ISSN
Partecipazione ai processi documentari e cultura grafica degli ufficiali minori 169 Schola Salernitana - Annali, XXII (2017): 169-182 DOI 10.6092/1590-7937/5160 2017 Università degli Studi di Salerno ISSN
LA DISTINZIONE REALE TRA ESSERE ED ESISTERE CHIAVE DI VOLTA DELLA METAFISICA TOMISTICA
 LA DISTINZIONE REALE TRA ESSERE ED ESISTERE CHIAVE DI VOLTA DELLA METAFISICA TOMISTICA d. CURZIO NITOGLIA 1 dicembre 2011 http://www.doncurzionitoglia.com/essere_esistere_tomistica.htm L esse come actus
LA DISTINZIONE REALE TRA ESSERE ED ESISTERE CHIAVE DI VOLTA DELLA METAFISICA TOMISTICA d. CURZIO NITOGLIA 1 dicembre 2011 http://www.doncurzionitoglia.com/essere_esistere_tomistica.htm L esse come actus
Quaestio 76 De unione animae ad corpus
 Quaestio 76 della Parte I della Summa Theologiae di San Tommaso d Aquino 1 A cura di Marcello Landi 2 Quaestio 76 De unione animae ad corpus Prooemium [31504] Iª q. 76 pr. Deinde considerandum est de unione
Quaestio 76 della Parte I della Summa Theologiae di San Tommaso d Aquino 1 A cura di Marcello Landi 2 Quaestio 76 De unione animae ad corpus Prooemium [31504] Iª q. 76 pr. Deinde considerandum est de unione
SECONDA PARTE la libertà umana
 P.Tomas Tyn, OP BOZZA TESI 78 - da p.465 a p.576 : Seconda parte -465- (131-1) SECONDA PARTE la libertà umana Dopo aver messo in risalto l azione divina infallibile e di per sé efficace su tutte le cause
P.Tomas Tyn, OP BOZZA TESI 78 - da p.465 a p.576 : Seconda parte -465- (131-1) SECONDA PARTE la libertà umana Dopo aver messo in risalto l azione divina infallibile e di per sé efficace su tutte le cause
Pasquale Porro. Tommaso d Aquino. Un profilo storico-filosofico. Carocci editore
 Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
THOMAS HOBBES: il fondatore dell assolutismo
 THOMAS HOBBES: il fondatore dell assolutismo (Westport, 1588 Londra, 1679) La filosofia di Hobbes è volta a costituire una comunità ordinata e pacifica, sulla base di uno Stato assoluto. Il SAPERE consiste
THOMAS HOBBES: il fondatore dell assolutismo (Westport, 1588 Londra, 1679) La filosofia di Hobbes è volta a costituire una comunità ordinata e pacifica, sulla base di uno Stato assoluto. Il SAPERE consiste
Lezioni XII-XIII. Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele
 Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara)
 APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
Schopenhauer Tra razionale e irrazionale
 Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?
Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?
LO STATUTO EPISTEMOLOGICO DELLA METAFISICA IN TOMMASO D AQUINO
 LO STATUTO EPISTEMOLOGICO DELLA METAFISICA IN TOMMASO D AQUINO Rafael Pascual, L.C. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Introduzione. 1. Tres sunt partes philosophiae theoricae, scilicet mathematica,
LO STATUTO EPISTEMOLOGICO DELLA METAFISICA IN TOMMASO D AQUINO Rafael Pascual, L.C. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Introduzione. 1. Tres sunt partes philosophiae theoricae, scilicet mathematica,
Lezione N.14 Quale Dio, quale mondo?
 Lezione N.14 Quale Dio, quale mondo? percorsi 1. Un Dio conoscibile? 2. Un Dio esistente? 3. Un Dio esperibile? obiettivi Vogliamo interrogarci sullo stretto rapporto tra raffigurazione del mondo ed argomentazione
Lezione N.14 Quale Dio, quale mondo? percorsi 1. Un Dio conoscibile? 2. Un Dio esistente? 3. Un Dio esperibile? obiettivi Vogliamo interrogarci sullo stretto rapporto tra raffigurazione del mondo ed argomentazione
FONDAMENTO DELLA MORALITA SECONDO DUNS SCOTO
 FONDAMENTO DELLA MORALITA SECONDO DUNS SCOTO Per cogliere il senso del fondamento della legge morale e della moralità dell atto umano, secondo Duns Scoto, bisogna sottendere da un lato la sua visione teologica
FONDAMENTO DELLA MORALITA SECONDO DUNS SCOTO Per cogliere il senso del fondamento della legge morale e della moralità dell atto umano, secondo Duns Scoto, bisogna sottendere da un lato la sua visione teologica
LA CAUSALITÀ DEL MOTORE IMMOBILE NEL COMMENTO DI TOMMASO D AQUINO A METAFISICA XII
 STEPHEN L. BROCK LA CAUSALITÀ DEL MOTORE IMMOBILE NEL COMMENTO DI TOMMASO D AQUINO A METAFISICA XII È indubbio, mi pare, che sulla questione della causalità del primo motore nel libro XII della Metafisica,
STEPHEN L. BROCK LA CAUSALITÀ DEL MOTORE IMMOBILE NEL COMMENTO DI TOMMASO D AQUINO A METAFISICA XII È indubbio, mi pare, che sulla questione della causalità del primo motore nel libro XII della Metafisica,
IMMANUEL KANT
 IMMANUEL KANT 1724-1804 Prof. Monti a.s. 2017-2018 Parte prima Kant prende le mosse dall Empirismo arrivando a elaborare il suo CRITICISMO (anche detto filosofia trascendentale o filosofia del limite )
IMMANUEL KANT 1724-1804 Prof. Monti a.s. 2017-2018 Parte prima Kant prende le mosse dall Empirismo arrivando a elaborare il suo CRITICISMO (anche detto filosofia trascendentale o filosofia del limite )
Analisi di testi di Aristotele: Metafisica, l.xii
 Dispense del Servo di Dio Padre Tomas Tyn, OP Testo dattiloscritto e testi ciclostilati per studenti (S.T.A.B.) Analisi di testi di Aristotele: Metafisica, l.xii Aristotele - II parte 1-113 VII. L essenza
Dispense del Servo di Dio Padre Tomas Tyn, OP Testo dattiloscritto e testi ciclostilati per studenti (S.T.A.B.) Analisi di testi di Aristotele: Metafisica, l.xii Aristotele - II parte 1-113 VII. L essenza
NELLO SCRIPTUM DI PIETRO AUREOLO
 NELLO SCRIPTUM DI PIETRO AUREOLO mente lo Scriptum super primum Sententiarum è soltanto uno dei tanti commenti al Libro delle Sentenze interesse storico Proœmium un in È Prooemium allo Scriptum Storia
NELLO SCRIPTUM DI PIETRO AUREOLO mente lo Scriptum super primum Sententiarum è soltanto uno dei tanti commenti al Libro delle Sentenze interesse storico Proœmium un in È Prooemium allo Scriptum Storia
IMMANUEL KANT. (1724 Germania-1804) INTRODUZIONE
 IMMANUEL KANT (1724 Germania-1804) INTRODUZIONE ILLUMINISMO ROMANTICISMO SAPERE AUDE (Ultimo periodo della sua vita) USCIRE DALLO STATO DI MINORITA Nella CRITICA DEL GIUDIZIO CONDIZIONE DELL UOMO CHE NON
IMMANUEL KANT (1724 Germania-1804) INTRODUZIONE ILLUMINISMO ROMANTICISMO SAPERE AUDE (Ultimo periodo della sua vita) USCIRE DALLO STATO DI MINORITA Nella CRITICA DEL GIUDIZIO CONDIZIONE DELL UOMO CHE NON
PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE.
 PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE. -307- San Tommaso, prima di affrontare il tema dell azione divina per mezzo dell infusione della grazia, si chiede se la giustificazione è la remissione
PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE. -307- San Tommaso, prima di affrontare il tema dell azione divina per mezzo dell infusione della grazia, si chiede se la giustificazione è la remissione
02 - Logica delle dimostrazioni
 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Economia Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Appunti del corso di Matematica 0 - Logica delle dimostrazioni Anno Accademico 015/016
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Economia Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Appunti del corso di Matematica 0 - Logica delle dimostrazioni Anno Accademico 015/016
BERO MAGNI DE LUDOSIA DISPUTATA SUPER LIBROS DE ANIMA
 DRAFT 2017-02-01 BERO MAGNI DE LUDOSIA DISPUTATA SUPER LIBROS DE ANIMA f. 1r 1 Circa 1 primum librum De anima quaeritur primo
DRAFT 2017-02-01 BERO MAGNI DE LUDOSIA DISPUTATA SUPER LIBROS DE ANIMA f. 1r 1 Circa 1 primum librum De anima quaeritur primo
HEGEL Fenomenologia dello spirito. Stoccarda Berlino 1831
 HEGEL Fenomenologia dello spirito Stoccarda 1770- Berlino 1831 L assoluto e le parti Le singole cose sono parti o manifestazioni dell assoluto che è inteso come un organismo unitario. Queste parti non
HEGEL Fenomenologia dello spirito Stoccarda 1770- Berlino 1831 L assoluto e le parti Le singole cose sono parti o manifestazioni dell assoluto che è inteso come un organismo unitario. Queste parti non
NOTE DI ALGEBRA LINEARE v = a 1 v a n v n, w = b 1 v b n v n
 NOTE DI ALGEBRA LINEARE 2- MM 9 NOVEMBRE 2 Combinazioni lineari e generatori Sia K un campo e V uno spazio vettoriale su K Siano v,, v n vettori in V Definizione Un vettore v V si dice combinazione lineare
NOTE DI ALGEBRA LINEARE 2- MM 9 NOVEMBRE 2 Combinazioni lineari e generatori Sia K un campo e V uno spazio vettoriale su K Siano v,, v n vettori in V Definizione Un vettore v V si dice combinazione lineare
LE DESINENZE E LE PARTICOLARITÀ
 LA PRIMA DECLINAZIONE LE DESINENZE E LE PARTICOLARITÀ ALCUNE NOTAZIONI STORICHE LE CONGIUNZIONI E GLI AVVERBI FREQUENTI La prima declinazione comprende: -sostantivi femminili (la maggior parte) -sostantivi
LA PRIMA DECLINAZIONE LE DESINENZE E LE PARTICOLARITÀ ALCUNE NOTAZIONI STORICHE LE CONGIUNZIONI E GLI AVVERBI FREQUENTI La prima declinazione comprende: -sostantivi femminili (la maggior parte) -sostantivi
P : gli iscritti all università di Bari sono più di 1000
 BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia il ragionamento deduttivo, ovvero le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta corretto e vero. Un ragionamento
BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia il ragionamento deduttivo, ovvero le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta corretto e vero. Un ragionamento
LA NATURA ANALOGICA DEL BENE: RADICE METAFISICA DELLA LIBERTA DELLA SCELTA IN TOMMASO D'AQUINO
 Revista Espanola de Filosofia Medieval, II (2004), pp. 83-96 LA NATURA ANALOGICA DEL BENE: RADICE METAFISICA ' DELLA LIBERTA DELLA SCELTA IN TOMMASO D'AQUINO Federica Bergamino Pontificia Universita della
Revista Espanola de Filosofia Medieval, II (2004), pp. 83-96 LA NATURA ANALOGICA DEL BENE: RADICE METAFISICA ' DELLA LIBERTA DELLA SCELTA IN TOMMASO D'AQUINO Federica Bergamino Pontificia Universita della
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 30 La pluralità delle Persone in Dio. La pluralità delle Persone in Dio
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 30 La pluralità delle Persone in Dio La pluralità delle Persone in Dio Prima pars Quaestio 30 Prooemium Prima parte Questione 30 Proemio [29691] Iª q. 30 pr. Deinde
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 30 La pluralità delle Persone in Dio La pluralità delle Persone in Dio Prima pars Quaestio 30 Prooemium Prima parte Questione 30 Proemio [29691] Iª q. 30 pr. Deinde
Quesito intorno al libro delle Categorie
 Quesito intorno al libro delle Categorie Latino AD PER QUAM ILLUSTREM DOMINUM DIEGUM DE MENDOZA AD PAULUM III PONTIFICEM CAESAREUM LEGATUM. ANGELI THYI DE MORCIANO, YDRUNTINI SCHOLAE PATAVINAE PUBLICI
Quesito intorno al libro delle Categorie Latino AD PER QUAM ILLUSTREM DOMINUM DIEGUM DE MENDOZA AD PAULUM III PONTIFICEM CAESAREUM LEGATUM. ANGELI THYI DE MORCIANO, YDRUNTINI SCHOLAE PATAVINAE PUBLICI
Sezione III. Tradizione
 Sezione III. Tradizione I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il mistero di Dio nella Tradizione IV. Presentazione sistematica del Mistero di Dio 8. L epoca prenicea
Sezione III. Tradizione I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il mistero di Dio nella Tradizione IV. Presentazione sistematica del Mistero di Dio 8. L epoca prenicea
TOMMASO D'AQUINO. Legge naturale e legge umana
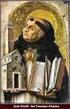 MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT TOMMASO D'AQUINO Legge naturale e legge umana www.maat.it/maat4 1 I secolo a.c. Cicerone, De re publica Vi è una legge vera, ragione retta conforme
MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT TOMMASO D'AQUINO Legge naturale e legge umana www.maat.it/maat4 1 I secolo a.c. Cicerone, De re publica Vi è una legge vera, ragione retta conforme
