Argentometria. (titolazioni con lo ione argento Ag + ) (titolazioni argentometriche)
|
|
|
- Fortunato Zanella
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Argentometria (titolazioni con lo ione argento Ag + ) (titolazioni argentometriche) D.C. Harris, Elementi di chimica analitica, Zanichelli, Capitolo 6 1
2 Il titolante è, di solito, una soluzione standard di AgNO 3. (AgNO 3 è fotosensibile e non bisogna lavorare sotto la luce solare diretta) Come reazione di titolazione si sfrutta la formazione di un sale poco solubile di argento, quale AgCl, che precipita: Ag + (aq) + Cl - (aq) AgCl (s) La costante K di reazione è l inverso del prodotto di solubilità. Per AgCl si ha: K ps = e quindi: K = 1/K ps = La reazione è completa! 2
3 Argentometria Titolazione secondo Mohr In corrispondenza del punto finale si ha la formazione di un precipitato colorato. The leading scientific pharmacist of his time in Germany, he was the author of many improvements in analytical processes. Karl Friedrich MOHR ( ) 3
4 Argentometria Titolazione secondo Mohr Il metodo permette la determinazione degli ioni cloruro, bromuro e cianuro. Il ph della soluzione deve essere basico perché l acido cromico (debole) sia dissociato. Si ha un errore sistematico positivo: titolante in eccesso deve essere aggiunto per vedere la colorazione rossa. L errore si può valutare con una titolazione in bianco o standardizzando AgNO 3 con NaCl standard, nelle stesse condizioni. 4
5 Argentometria Titolazione secondo Volhard Il punto finale è evidenziato dalla formazione di un complesso solubile colorato. German chemist who devised various significant methods of organic synthesis, and a method of quantitatively analysing for an element via silver chloride. Jacob VOLHARD ( ) 5
6 Argentometria Titolazione secondo Volhard Si tratta di una titolazione di ritorno. 1 step 2 step 6
7 Argentometria Titolazione secondo Volhard La soluzione deve essere acida per evitare la precipitazione di Fe(III) come idrossido. Ciò evita anche l interferenza di altri ioni che formano con l argento sali poco solubili, quali carbonato, arseniato e ossalato. La colorazione del complesso di Fe(III) col tiocianato è molto intensa: una concentrazione di Fe(III) di 0.01 M è sufficiente e l errore di titolazione è inferiore all uno per mille. Nella determinazione del cloruro è richiesta la filtrazione del precipitato prima della seconda titolazione con tiocianato, in quanto AgCl è più solubile di AgSCN. La filtrazione non è richiesta per gli altri alogenuri. 7
8 Argentometria Titolazione secondo Fajans Il punto finale è evidenziato dall adsorbimento di un indicatore colorato sul precipitato. Polish-born US chemist who did pioneering work on radioactivity and isotopes. Kasimir FAJANS ( ) 8
9 Argentometria Titolazione secondo Fajans Nella titolazione argentometrica secondo Fajans viene utilizzato un indicatore ad adsorbimento, il cui colore cambia quando si adsorbono sul precipitato. eosina diclorofluoresceina Prima del punto equivalente (eccesso di ioni cloruro) Dopo il punto equivalente (eccesso di ioni argento) 9
10 Argentometria Titolazione secondo Fajans 10
11 Argentometria Titolazione secondo Fajans La variazione di colore è dovuta ad un processo di adsorbimento e non di precipitazione. L adsorbimento è reversibile: il colorante viene desorbito se si effettua una retro-titolazione con ioni cloruro. Le titolazioni che coinvolgono indicatori ad adsorbimento sono rapide, accurate ed affidabili, ma la loro applicazione è limitata alla poche reazioni di precipitazione nelle quali si forma rapidamente un precipitato colloidale (favorito dalla bassa concentrazione di elettroliti). Alcuni indicatori ad adsorbimento sono fotosensibili e bisogna evitare di lavorare sotto luce solare diretta. 11
12 Indicatori strumentali L elettrodo ad argento può essere usato per determinare [I - ] e anche per seguire la titolazione di una soluzione di I - con Ag +. Titolazione di una soluzione di ioduro con argento nitrato 12
13 Indicatori strumentali Una titolazione per precipitazione può essere seguita anche per via turbidimetrica o nefelometrica. Turbidimetria: la luce trasmessa diminuisce progressivamente fino al punto equivalente e poi non varia più. Nefelometria: la luce diffusa aumenta progressivamente fino al punto equivalente e poi non varia più. TITRATION OF CHLORIDE IONS WITH SILVER NITRATE 13
14 Argentometria (titolazioni di precipitazione) Reattivo (titolante) Analiti Indicatori AgNO 3 anioni che formano sali insolubili con Ag + cromato; Fe 3+ /tiocianato; adsorbimento 14
15 Complessometria D.C. Harris, Elementi di chimica analitica, Zanichelli Capitolo 15 15
16 Teoria di Lewis (1923) Un acido è una sostanza capace di accettare un doppietto elettronico da un'altra specie chimica. Una base è una sostanza capace di donare un doppietto elettronico ad un'altra specie chimica. Gli acidi di Lewis sono noti in chimica organica anche come reagenti elettrofili. Le basi di Lewis sono note in chimica organica anche come reagenti nucleofili. Lewis was the most successful chemist of the twentieth century who did not win a Nobel Prize. He developed theories of chemical bonding and acids and bases. Gilbert Newton Lewis ( ) 16
17 Esempio: lo ione cianuro (base di Lewis) può comportarsi da legante monodentato nei confronti dello ione Ag + (acido di Lewis). N.B. Il legame formato (legame dativo) è un legame di coordinazione. Il numero di legami di coordinazione in un complesso metallico non ha nulla a che vedere con la carica dello ione metallico. La carica finale del complesso dipende dalla stechiometria del complesso stesso ed è la somma delle cariche del metallo e dei leganti. 17
18 Esistono leganti polidentati (detti anche chelanti) che possono legarsi ad uno ione metallico tramite più atomi donatori. Un esempio è l acido etilendiamminotetracetico (EDTA) che può comportarsi da legante esadentato nei confronti di molti ioni metallici, formando complessi di stechiometria 1:1 molto stabili. 18
19 Un altro esempio di legante polidentato è l adenosintrifosfato (ATP) che può comportarsi da legante tetradentato. 19
20 Alcuni chelanti sono impiegati come farmaci, per esempio nelle intossicazioni da metalli. Un caso interessante è quello della talassemia desferiossammina B 20
21 Una titolazione basata sulla formazione di un complesso è chiamata TITOLAZIONE COMPLESSOMETRICA Il reagente chelante largamente più usato è l EDTA. 21
22 L EDTA può essere descritto come un legante esaprotico e indicato come H 6 Y 2+ : 22
23 Composizione delle soluzioni di EDTA in funzione del ph 23
24 Reazione di titolazione: La costante di equilibrio per la reazione di un metallo con un legante è chiamata costante di formazione, K f, o costante di stabilità. L inverso della costante di formazione è la costante di dissociazione, K d. 24
25 25
26 Indicatori metallocromici Un indicatore metallocromico è un composto il cui colore varia quando esso si lega ad uno ione metallico. 26
27 Indicatori metallocromici Affinché un indicatore sia utilizzabile in una titolazione complessometrica, esso deve legarsi al metallo analizzato più debolmente di quanto non faccia l EDTA. Se un metallo non si dissocia liberamente dall indicatore, in presenza di EDTA, si dice che esso «blocca» l indicatore. 27
28 TECNICHE DI TITOLAZIONE CON EDTA 1. Titolazione diretta 2. Titolazione di ritorno 3. Titolazione per spostamento 4. Titolazione indiretta 5. Mascheramento 28
29 TECNICHE DI TITOLAZIONE CON EDTA 1. Titolazione diretta L analita viene titolato con una soluzione standard di EDTA. Requisiti: ph opportuno (agente complessante ausiliario) Esempi: titolazione diretta dello ione Pb 2+ a ph 10 in presenza di tartrato determinazione della durezza dell acqua 29
30 DUREZZA DELL'ACQUA (Wikipedia) Per durezza dell'acqua si intende un valore che esprime il contenuto totale di ioni di calcio e magnesio (provenienti dalla presenza di sali solubili nell'acqua) oltre che di eventuali altri metalli alcalino-terrosi presenti nell'acqua. Un acqua dura influisce negativamente sui processi di lavaggio, richiedendo maggiori quantitativi di detergente e facendo infeltrire le fibre. Inoltre, è dannosa per gli impianti industriali, sia per l azione corrosiva, sia per le incrostazioni che si formano. Per questo sono spesso utilizzate tecniche di addolcimento, ovvero di rimozione dei sali di calcio e magnesio. In genere, le acque vengono classificate in base alla loro durezza come segue: fino a 4 f: molto dolci da 4 f a 8 f: dolci da 8 f a 12 f: medio-dure da 12 f a 18 f: discretamente dure da 18 f a 30 f: dure oltre 30 f: molto dure. La durezza viene generalmente espressa in gradi francesi ( f, da non confondere con F, che sono i gradi Fahrenheit), dove un grado rappresenta 10 mg di carbonato di calcio (CaCO 3 ) per litro di acqua (1 f = 10 mg/l = 10 ppm). Hera Rapporto semestrale sulla qualità delle acque Ferrara - Anno 2018 II semestre Durezza: 18 f 30
31 TECNICHE DI TITOLAZIONE CON EDTA 2. Titolazione di ritorno Si usa quando: 1) l analita precipita in assenza di EDTA; 2) la reazione è lenta; 3) l analita blocca l indicatore. 1. Un eccesso noto di EDTA viene aggiunto alla soluzione dell analita. 2. L eccesso di EDTA viene poi titolato con una soluzione standard di ione metallico. Esempio: determinazione dello ione Ni 2+ mediante titolazione di ritorno con Zn 2+ a ph 5.5, con arancio xilenolo come indicatore. Esempio: determinazione dello ione Al 3+ mediante titolazione di ritorno con Zn 2+ a ph 5.5, con indicatore nero di eriocromo T. Requisito: il metallo usato nella titolazione di ritorno non deve spostare il «metallo analita» dall EDTA. 31
32 TECNICHE DI TITOLAZIONE CON EDTA 3. Titolazione per spostamento Serve per ioni metallici per i quali non è disponibile un indicatore soddisfacente. 1. L analita viene trattato con un eccesso di Mg(EDTA) Mg 2+ spostato viene poi titolato con una soluzione standard di EDTA. Requisito: la costante di formazione del complesso di EDTA con l analita deve essere più grande di quella di Mg 2+. Esempi: - determinazione dello ione Hg 2+ ; - determinazione di Ag + usando il complesso tetracianonichelato Ni(CN)
33 TECNICHE DI TITOLAZIONE CON EDTA 4. Titolazione indiretta Anioni che fanno precipitare ioni metallici possono essere determinati mediante l aggiunta di un eccesso di ione metallico e successiva titolazione con EDTA standard dell eccesso di metallo (dopo filtrazione). In alternativa, il precipitato può essere filtrato, complessato con un eccesso di EDTA standard (che sposta il metallo dal precipitato); EDTA in eccesso viene poi titolato con Mg 2+ o Zn 2+ standard. Esempi: determinazione di solfati, carbonati, cromati o solfuri. 33
34 TECNICHE DI TITOLAZIONE CON EDTA 5. Mascheramento Un agente mascherante è un reagente che protegge alcune componenti dell analita dalla reazione con EDTA. In presenza di due o più metalli, uno di essi può essere determinato mascherando gli altri. Esempio: determinazione di Mg 2+ in presenza di Al 3+, mascherando Al 3+ con F -. Altri agenti mascheranti: CN -, trietanolammina, 2,3-dimercapto-1-propanolo trietanolammina 2,3-dimercapto-1-propanolo 34
35 Titolazioni red-ox (ossidimetriche) 35
36 Titolazioni basate sullo iodio Lo iodio è un blando ossidante Iodimetria: titolazione diretta di un analita riducente con I 2 (con produzione di I - ). Iodometria: titolazione di ritorno di I 2 (prodotto dall aggiunta di un eccesso di I - ad un analita ossidante) con una soluzione standard di tiosolfato. N.B. I 2 è poco solubile in acqua ma la sua solubilità aumenta per complessazione con lo ione ioduro: Le soluzioni di iodio impiegate come titolante contengono sempre un eccesso di ione ioduro. 36
37 complesso con lo iodio L indicatore impiegato è la salda d amido che forma con lo iodio un complesso di colore blu intenso. Limite di rivelabilità di I 2 : M (10 volte più basso in presenza di salda d amido). L amido è facilmente biodegradabile e la soluzione va preparata di fresco. La salda d amido può essere aggiunta all inizio della titolazione in iodimetria ma andrebbe aggiunta solo prima del punto equivalente in iodometria. 37
38 Titolazione di iodio con tiosolfato, usando amido come indicatore a) b) c) d) a) soluzione di iodio al punto iniziale; b) soluzione di iodio poco prima del punto finale; c) soluzione di iodio con amido poco prima del punto finale; d) soluzione di iodio con amido al punto finale. Iodometric Titration (1 24 ) 38
39 Esempio Valutazione della rancidità di un olio di oliva 39
40 Esempio Determinazione del contenuto di Vitamina C L acido ascorbico è un riducente è può essere titolato direttamente con I 3- standard, in presenza di salda d amido. La reazione di titolazione è la seguente: 40
41 PERMANGANATOMETRIA 40
42 Titolazioni basate sul permanganato Il permanganato è un ossidante forte La costante di questa reazione è molto alta, ma la cinetica è molto lenta. 41
43 Titolazioni basate sul permanganato Il permanganato non è uno standard primario Lo standard primario più largamente utilizzato per standardizzare le soluzioni di permanganato è l ossalato di sodio: La reazione è lenta a temperatura ambiente e la titolazione viene di solito effettuata a circa 60 C e in ambiente di acido solforico. La reazione è catalizzata dallo ione Mn 2+ e quindi accelera col procedere della titolazione. 43
44 Complessometria Reattivo (titolante) Analiti Indicatori EDTA (o altri chelanti) cationi metallici anioni che formano sali insolubili metallocromici Titolazioni red-ox Reattivo (titolante) Analiti Indicatori Iodio (iodimetria) composti riducenti salda d amido tiosolfato (iodometria) composti ossidanti salda d amido permanganato composti riducenti - 44
Argentometria. D.C. Harris, Elementi di chimica analitica, Zanichelli Capitolo 6
 Argentometria D.C. Harris, Elementi di chimica analitica, Zanichelli Capitolo 6 1 Il titolante è, di solito, una soluzione standard di AgNO 3. (N.B.: AgNO 3 è fotosensibile e bisogna evitare di lavorare
Argentometria D.C. Harris, Elementi di chimica analitica, Zanichelli Capitolo 6 1 Il titolante è, di solito, una soluzione standard di AgNO 3. (N.B.: AgNO 3 è fotosensibile e bisogna evitare di lavorare
Solubilità dei sali Prodotto di solubilità
 Solubilità dei sali Prodotto di solubilità Aggiunta di una soluzione di NaCl ad una di AgNO 3 : formazione di un precipitato -AgCl- Solubilità Stabilite le condizioni di equilibrio di una soluzione satura
Solubilità dei sali Prodotto di solubilità Aggiunta di una soluzione di NaCl ad una di AgNO 3 : formazione di un precipitato -AgCl- Solubilità Stabilite le condizioni di equilibrio di una soluzione satura
Titolazioni di Precipitazione
 Titolazioni di Precipitazione Le titolazioni di precipitazione si basano su reazioni che generano composti poco solubili L agente titolante è anche detto agente precipitante La velocità di formazione di
Titolazioni di Precipitazione Le titolazioni di precipitazione si basano su reazioni che generano composti poco solubili L agente titolante è anche detto agente precipitante La velocità di formazione di
ANALISI DEI FARMACI I
 ANALISI DEI FARMACI I TESTI CONSIGLIATI Skoog - West - Holler - (Crouch): Fondamenti di chimica analitica Harris: Chimica analitica quantitativa Per la Conduttimetria Cozzi - Protti - Ruaro: Analisi chimica
ANALISI DEI FARMACI I TESTI CONSIGLIATI Skoog - West - Holler - (Crouch): Fondamenti di chimica analitica Harris: Chimica analitica quantitativa Per la Conduttimetria Cozzi - Protti - Ruaro: Analisi chimica
Determinazione Complessometriche EDTA
 Determinazione Complessometriche EDTA Complessometria l La complessometria è l'analisi volumetrica che sfrutta le reazioni di formazione di complessi stabili e stechiometricamente definiti. l Un complesso
Determinazione Complessometriche EDTA Complessometria l La complessometria è l'analisi volumetrica che sfrutta le reazioni di formazione di complessi stabili e stechiometricamente definiti. l Un complesso
TITOLAZIONI PER PRECIPITAZIONE
 PRECIPITOMETRIA TITOLAZIONI PER PRECIPITAZIONE Le titolazioni per precipitazione sono un alternativa alle analisi gravimetriche (non trattate in questo insegnamento) che, nonostante l accuratezza possono
PRECIPITOMETRIA TITOLAZIONI PER PRECIPITAZIONE Le titolazioni per precipitazione sono un alternativa alle analisi gravimetriche (non trattate in questo insegnamento) che, nonostante l accuratezza possono
TITOLAZIONE DI PRECIPITAZIONE
 TITOLAZIONE DI PRECIPITAZIONE Nelle titolazioni di precipitazione si ha la formazione di un sale poco solubile. Il K ps sostituisce il K w dell acqua ed il pme o il px sostituiscono rispettivamente il
TITOLAZIONE DI PRECIPITAZIONE Nelle titolazioni di precipitazione si ha la formazione di un sale poco solubile. Il K ps sostituisce il K w dell acqua ed il pme o il px sostituiscono rispettivamente il
I COMPOSTI DI COORDINAZIONE: sono molecole o ioni in cui un catione metallico è legato con un determinato numero di molecole o ioni negativi.
 I COMPOSTI DI COORDINAZIONE: sono molecole o ioni in cui un catione metallico è legato con un determinato numero di molecole o ioni negativi. [Fe(CN) 6 ] 3- Carica della molecola coordinatore legante Numero
I COMPOSTI DI COORDINAZIONE: sono molecole o ioni in cui un catione metallico è legato con un determinato numero di molecole o ioni negativi. [Fe(CN) 6 ] 3- Carica della molecola coordinatore legante Numero
Complessometria M + L
 Complessometria Analisi volumetrica per formazione di complessi M + L ML M (nucleo centrale) è un acido di Lewis (accettore di coppie di elettroni) L (legante) è una base di Lewis (donatore di coppie di
Complessometria Analisi volumetrica per formazione di complessi M + L ML M (nucleo centrale) è un acido di Lewis (accettore di coppie di elettroni) L (legante) è una base di Lewis (donatore di coppie di
Evento Crui: il 21 marzo «primavera» delle università italiane
 Evento Crui: il 21 marzo «primavera» delle università italiane Su iniziativa della CRUI, il prossimo 21 marzo in ogni sede Universitaria nazionale si terranno incontri e dibattiti pubblici per sensibilizzare
Evento Crui: il 21 marzo «primavera» delle università italiane Su iniziativa della CRUI, il prossimo 21 marzo in ogni sede Universitaria nazionale si terranno incontri e dibattiti pubblici per sensibilizzare
Formazione di complessi
 Formazione di complessi Struttura degli ioni complessi Gli ioni complessi sono formati da un catione metallico legato ad anioni come OH -, Cl -, CN -, SCN -, o a molecole neutre come H 2 O, NH 3., detti
Formazione di complessi Struttura degli ioni complessi Gli ioni complessi sono formati da un catione metallico legato ad anioni come OH -, Cl -, CN -, SCN -, o a molecole neutre come H 2 O, NH 3., detti
24. PRECIPITAZIONE Prodotto di solubilità (K s )
 24. PRECIPITAZIONE D. In un racconto di Primo Levi, a proposito di un analisi chimica di campioni di roccia, si incontrano queste parole apparentemente prive di senso: «... giù il ferro con ammoniaca,
24. PRECIPITAZIONE D. In un racconto di Primo Levi, a proposito di un analisi chimica di campioni di roccia, si incontrano queste parole apparentemente prive di senso: «... giù il ferro con ammoniaca,
METODO DI VOLHARD. Nel metodo di Volhard gli ioni argento sono titolati con una soluzione standard di ione tiocianato: Ag + + SCN - AgSCN
 METODO DI VOLHARD Il metodo viene impiegato per la determinazione di ioni alogenuro quali I -, Cl -, Br -. Un eccesso noto di soluzione standard di nitrato di argento AgNO 3 viene aggiunto al campione
METODO DI VOLHARD Il metodo viene impiegato per la determinazione di ioni alogenuro quali I -, Cl -, Br -. Un eccesso noto di soluzione standard di nitrato di argento AgNO 3 viene aggiunto al campione
PROGRAMMA DEL CORSO DI CHIMICA ANALITICA 1 CON LABORATORIO a.a
 PROGRAMMA DEL CORSO DI CHIMICA ANALITICA 1 CON LABORATORIO a.a. 2009-2010 Testo consigliato: Daniel C. Harris, Chimica Analitica Quantitativa, Seconda Edizione Italiana, Ed. Zanichelli, 2005 Alcune parti
PROGRAMMA DEL CORSO DI CHIMICA ANALITICA 1 CON LABORATORIO a.a. 2009-2010 Testo consigliato: Daniel C. Harris, Chimica Analitica Quantitativa, Seconda Edizione Italiana, Ed. Zanichelli, 2005 Alcune parti
FORMAZIONE DI COMPLESSI In soluzione, gli ioni metallici reagiscono con specie elettron-donatrici (capaci di donare coppie di elettroni) a formare
 FORMAZIONE DI COMPLESSI In soluzione, gli ioni metallici reagiscono con specie elettron-donatrici (capaci di donare coppie di elettroni a formare complessi o composti di coordinazione. Il legante deve
FORMAZIONE DI COMPLESSI In soluzione, gli ioni metallici reagiscono con specie elettron-donatrici (capaci di donare coppie di elettroni a formare complessi o composti di coordinazione. Il legante deve
Prodotto di solubilità ed Effetto dello ione comune
 Prodotto di solubilità ed Effetto dello ione comune Dr. Gabriella Giulia Pulcini Ph.D. Student, Development of new approaches to teaching and learning Natural and Environmental Sciences University of Camerino,
Prodotto di solubilità ed Effetto dello ione comune Dr. Gabriella Giulia Pulcini Ph.D. Student, Development of new approaches to teaching and learning Natural and Environmental Sciences University of Camerino,
PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2014/ istituto "ALBERTI-PORRO" Analisi Chimica 3 E
 Nome docenti Castellino Daniele Romagnollo Lidia Materia insegnata Analisi Chimica Classe Previsione numero ore di insegnamento 3 E ore complessive di insegnamento di cui in compresenza di cui di approfondimento
Nome docenti Castellino Daniele Romagnollo Lidia Materia insegnata Analisi Chimica Classe Previsione numero ore di insegnamento 3 E ore complessive di insegnamento di cui in compresenza di cui di approfondimento
LABORATORIO DI CHIMICA
 LABORATORIO DI CHIMICA Presentazione 3 a ESPERIENZA Titolazione Acido-Base ANALISI VOLUMETRICA Tipi di titolazioni Esistono diversi tipi di titolazione, classificati in funzione della reazione su cui si
LABORATORIO DI CHIMICA Presentazione 3 a ESPERIENZA Titolazione Acido-Base ANALISI VOLUMETRICA Tipi di titolazioni Esistono diversi tipi di titolazione, classificati in funzione della reazione su cui si
A.S. 2016/2017 PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI PER IL RECUPERO ESTIVO. Proff. ZANNI PAOLO e FRANCHINI MANUELA. docenti di ANALISI CHIMICA STRUMENTALE
 A.S. 2016/2017 PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI PER IL RECUPERO ESTIVO Proff. ZANNI PAOLO e FRANCHINI MANUELA docenti di ANALISI CHIMICA STRUMENTALE Classe 3^B Moduli Contenuti Mod. 1 L atomo e la mole,
A.S. 2016/2017 PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI PER IL RECUPERO ESTIVO Proff. ZANNI PAOLO e FRANCHINI MANUELA docenti di ANALISI CHIMICA STRUMENTALE Classe 3^B Moduli Contenuti Mod. 1 L atomo e la mole,
COMPLESSI coppia di elettroni liberi Ammoniaca L
 COMPLESSI Molti cationi formano complessi in soluzione con sostanze che abbiano una coppia di elettroni liberi (es. atomi di N, O, S) capaci di soddisfare il numero di coordinazione del metallo. Me = metallo
COMPLESSI Molti cationi formano complessi in soluzione con sostanze che abbiano una coppia di elettroni liberi (es. atomi di N, O, S) capaci di soddisfare il numero di coordinazione del metallo. Me = metallo
APPLICAZIONE DI RIDUCENTI IN VOLUMETRICA
 APPLICAZIONE DI RIDUCENTI IN VOLUMETRICA Le sostanze riducenti reagiscono con l O 2 dell aria, per questo motivo è meglio conservarle in atmosfera inerte. Metodo: agente riducente non standardizzato +
APPLICAZIONE DI RIDUCENTI IN VOLUMETRICA Le sostanze riducenti reagiscono con l O 2 dell aria, per questo motivo è meglio conservarle in atmosfera inerte. Metodo: agente riducente non standardizzato +
Titolazione acido debole (diprotico)
 Titolazione acido debole (diprotico) Calcolo ph spontaneo (acido debole da solo) H 2 O + H 2 O H 3 O + + OH - H 2 B + H 2 O HB - + H 3 O + HB - + H 2 O B 2- + H 3 O + 5 incognite 5 equazioni indipendenti
Titolazione acido debole (diprotico) Calcolo ph spontaneo (acido debole da solo) H 2 O + H 2 O H 3 O + + OH - H 2 B + H 2 O HB - + H 3 O + HB - + H 2 O B 2- + H 3 O + 5 incognite 5 equazioni indipendenti
Parti svolte dal libro di testo Chimica Analitica Quantitativa
 PROGRAMMA DEL CORSO DI CHIMICA ANALITICA 1 CON LABORATORIO a.a. 2007-2008 E stato seguito il testo: Daniel C. Harris, Chimica Analitica Quantitativa, Seconda Edizione Italiana, Ed. Zanichelli, 2005 mentre
PROGRAMMA DEL CORSO DI CHIMICA ANALITICA 1 CON LABORATORIO a.a. 2007-2008 E stato seguito il testo: Daniel C. Harris, Chimica Analitica Quantitativa, Seconda Edizione Italiana, Ed. Zanichelli, 2005 mentre
BaSO. BaSO 4 è una costante quindi: K ps = prodotto di solubilità
 Gli equilibri di solubilità sono equilibri eterogenei in quanto si stabiliscono tra due fasi: un solido e la soluzione satura dei suoi ioni. Sono gli equilibri che coinvolgono le reazioni di dissoluzione
Gli equilibri di solubilità sono equilibri eterogenei in quanto si stabiliscono tra due fasi: un solido e la soluzione satura dei suoi ioni. Sono gli equilibri che coinvolgono le reazioni di dissoluzione
EQUILIBRI DI SOLUBILITA
 EQUILIBRI DI SOLUBILITA Solubilità In generale solo una quantità finita di un solido si scioglie in un dato volume di solvente dando luogo ad una soluzione satura, cioè una soluzione in equilibrio con
EQUILIBRI DI SOLUBILITA Solubilità In generale solo una quantità finita di un solido si scioglie in un dato volume di solvente dando luogo ad una soluzione satura, cioè una soluzione in equilibrio con
Chimica Analitica con elementi di statistica. Lezione n 9
 Chimica Analitica con elementi di statistica Lezione n 9 Christian Durante E mail: christian.durante@unipd.it Tel. 049 8275112 Zona quadrilatero ufficio 00 215 02 142 (orario di ricevimento: tutti I giorni
Chimica Analitica con elementi di statistica Lezione n 9 Christian Durante E mail: christian.durante@unipd.it Tel. 049 8275112 Zona quadrilatero ufficio 00 215 02 142 (orario di ricevimento: tutti I giorni
1 - Titolazioni acido-base e ph
 1 - Titolazioni acido-base e ph Procedimento (m.m. di NH 3 = 17,03) Moli di NaOH consumate (1,04 x 10-3 ) Moli di HCl iniziali (7,75 x 10-3 ) Moli di NH 3 (6,71 x 10-3 ) Massa di NH 3 (114,3 mg) Concentrazione
1 - Titolazioni acido-base e ph Procedimento (m.m. di NH 3 = 17,03) Moli di NaOH consumate (1,04 x 10-3 ) Moli di HCl iniziali (7,75 x 10-3 ) Moli di NH 3 (6,71 x 10-3 ) Massa di NH 3 (114,3 mg) Concentrazione
Sapienza Università di Roma Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2014/2015
 Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2014/2015 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z) Dott. Giuseppe La Regina Programma
Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2014/2015 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z) Dott. Giuseppe La Regina Programma
I.T.I.S. E. FERMI _ MODENA
 I.T.I.S. E. FERMI _ MODENA Programma svolto del corso di Analisi Chimica, Elab. Dati e Laboratorio Classe 3^C a.s. 2011-12 Docenti: Giorgia Messori, Claudia Tacconi I l libro di testo utilizzato è stato
I.T.I.S. E. FERMI _ MODENA Programma svolto del corso di Analisi Chimica, Elab. Dati e Laboratorio Classe 3^C a.s. 2011-12 Docenti: Giorgia Messori, Claudia Tacconi I l libro di testo utilizzato è stato
Titolazioni di Precipitazione
 Titolazioni di Precipitazione Le!tolazioni di precipitazione si basano su reazioni che generano compos2 poco solubili L agente 2tolante è anche de8o agente precipitante La velocità di formazione di un
Titolazioni di Precipitazione Le!tolazioni di precipitazione si basano su reazioni che generano compos2 poco solubili L agente 2tolante è anche de8o agente precipitante La velocità di formazione di un
Chimica Analitica. Equilibri in soluzione
 Chimica Analitica Equilibri in soluzione I complessi sono caratterizzati da Legante - Specie elettron-donatrici - basi di Lewis, specie anioniche, cationiche o neutre capaci di donare un paio di elettroni
Chimica Analitica Equilibri in soluzione I complessi sono caratterizzati da Legante - Specie elettron-donatrici - basi di Lewis, specie anioniche, cationiche o neutre capaci di donare un paio di elettroni
Solubilità. Il fatto che un composto sia un elettrolita forte (cioè si dissoci completamente in acqua) non deve essere confuso con la sua solubilità.
 Solubilità Il fatto che un composto sia un elettrolita forte (cioè si dissoci completamente in acqua) non deve essere confuso con la sua solubilità. La solubilità di un composto in acqua è definita come
Solubilità Il fatto che un composto sia un elettrolita forte (cioè si dissoci completamente in acqua) non deve essere confuso con la sua solubilità. La solubilità di un composto in acqua è definita come
TEORIE DEGLI ACIDI E DELLE BASI
 TERIE DEGLI ACIDI E DELLE BASI Teoria di Arrhenius: Un acido è una sostanza che in soluzione acquosa libera ioni H + Es. HCl = H + (aq) + Cl - (aq) H 2 S 4 = 2 H + (aq) + S 4 2- (aq) Una base è una sostanza
TERIE DEGLI ACIDI E DELLE BASI Teoria di Arrhenius: Un acido è una sostanza che in soluzione acquosa libera ioni H + Es. HCl = H + (aq) + Cl - (aq) H 2 S 4 = 2 H + (aq) + S 4 2- (aq) Una base è una sostanza
SOLUBILITA EQUILIBRI ETEROGENEI
 SOLUBILITA EQUILIBRI ETEROGENEI Cosa succede quando si scioglie un sale (NaCl) in acqua Cl - LEGAME IONE DIPOLO Se sciogliamo in un solvente polare (tipo H 2 O) una sostanza ionica(tipo NaCl) questa si
SOLUBILITA EQUILIBRI ETEROGENEI Cosa succede quando si scioglie un sale (NaCl) in acqua Cl - LEGAME IONE DIPOLO Se sciogliamo in un solvente polare (tipo H 2 O) una sostanza ionica(tipo NaCl) questa si
Metodi volumetrici di analisi: titolazioni
 D.C. Harris, Elementi di chimica analitica, Zanichelli Capitolo 6 1 Metodi volumetrici di analisi: titolazioni Nell viene misurato il volume di un reagente a concentrazione nota necessario per la reazione
D.C. Harris, Elementi di chimica analitica, Zanichelli Capitolo 6 1 Metodi volumetrici di analisi: titolazioni Nell viene misurato il volume di un reagente a concentrazione nota necessario per la reazione
Corso di Laurea triennale in Chimica
 Università degli Studi di Cagliari Corso di Laurea triennale in Chimica Chimica Analitica I e Laboratorio 1 (Modulo A) CFU 6 Docente Prof. Davide Atzei SSD CHIM/01 Tel. +39 070 675 4460 Fa. +39 070 675
Università degli Studi di Cagliari Corso di Laurea triennale in Chimica Chimica Analitica I e Laboratorio 1 (Modulo A) CFU 6 Docente Prof. Davide Atzei SSD CHIM/01 Tel. +39 070 675 4460 Fa. +39 070 675
Sapienza Università di Roma Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2016/2017
 Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2016/2017 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche Corso di Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z) Dott. Giuseppe La Regina Programma
Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2016/2017 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche Corso di Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z) Dott. Giuseppe La Regina Programma
Solubilità dei sali Prodotto di solubilità
 Programma Misure ed Unità di misura. Incertezza della misura. Cifre significative. Notazione scientifica. Atomo e peso atomico. Composti, molecole e ioni. Formula molecolare e peso molecolare. Mole e massa
Programma Misure ed Unità di misura. Incertezza della misura. Cifre significative. Notazione scientifica. Atomo e peso atomico. Composti, molecole e ioni. Formula molecolare e peso molecolare. Mole e massa
METODI GRAVIMETRICI DI ANALISI
 METODI GRAVIMETRICI DI ANALISI I metodi gravimetrici si basano sulla misura della massa e sono sostanzialmente di due tipi: - nei metodi di precipitazione l analita viene trasformato in un precipitato
METODI GRAVIMETRICI DI ANALISI I metodi gravimetrici si basano sulla misura della massa e sono sostanzialmente di due tipi: - nei metodi di precipitazione l analita viene trasformato in un precipitato
Avvisi. Totale: 14 CFU. Il voto finale sarà la media pesata fra: 1. Voto di Chimica Generale ed Inorganica (6/14) 2. Voto di Chimica Organica (8/14)
 Avvisi Chimica (Corso Integrato): Chimica Generale ed Inorganica (6 CFU) Dott. Francesco Musiani Chimica Organica (8 CFU) Modulo 1 (teoria): Prof. Luca Gentilucci Modulo 2 (laboratorio): Dott. Andrea Gualandi
Avvisi Chimica (Corso Integrato): Chimica Generale ed Inorganica (6 CFU) Dott. Francesco Musiani Chimica Organica (8 CFU) Modulo 1 (teoria): Prof. Luca Gentilucci Modulo 2 (laboratorio): Dott. Andrea Gualandi
1. Metodo di Mohr 2. Metodo di Volhard 3. Metodo di Fajans
 ARGENTOMETRIA I metodi argentometrici si basano sulla precipitazione di un sale d argento poco solubile. Come reattivo titolante si impiega una soluzione di AgNO 3. I principali metodi sono: 1. Metodo
ARGENTOMETRIA I metodi argentometrici si basano sulla precipitazione di un sale d argento poco solubile. Come reattivo titolante si impiega una soluzione di AgNO 3. I principali metodi sono: 1. Metodo
Solubilità dei sali Prodotto di solubilità
 Solubilità dei sali Prodotto di solubilità Aggiunta di una soluzione di NaCl ad una di AgNO 3 : formazione di un precipitato -AgCl- Solubilità Stabilite le condizioni di equilibrio di una soluzione satura
Solubilità dei sali Prodotto di solubilità Aggiunta di una soluzione di NaCl ad una di AgNO 3 : formazione di un precipitato -AgCl- Solubilità Stabilite le condizioni di equilibrio di una soluzione satura
Sapienza Università di Roma Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2015/2016
 Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2015/2016 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche Corso di Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z) Programma d esame PARTE PRIMA
Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2015/2016 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche Corso di Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z) Programma d esame PARTE PRIMA
2.1 Iodimetria-iodometria
 .1 Iodimetria-iodometria Sono metodi analitici basati su reazioni di ossidoriduzione in cui una delle due coppie redox è I / I - Equazione della semireazione di riduzione dello iodio I + e - I - E = 0,535
.1 Iodimetria-iodometria Sono metodi analitici basati su reazioni di ossidoriduzione in cui una delle due coppie redox è I / I - Equazione della semireazione di riduzione dello iodio I + e - I - E = 0,535
Sommario della lezione 24. Equilibri di solubilità. Chimica Organica. Elettrochimica
 Sommario della lezione 24 Equilibri di solubilità Chimica Organica Elettrochimica EQUILIBRI DI SOLUBILITA Solubilità È la concentrazione del soluto in una soluzione satura (dove è presente il corpo di
Sommario della lezione 24 Equilibri di solubilità Chimica Organica Elettrochimica EQUILIBRI DI SOLUBILITA Solubilità È la concentrazione del soluto in una soluzione satura (dove è presente il corpo di
11 luglio 2008 Prova scritta di Chimica Analitica 1 con Laboratorio
 11 luglio 008 Prova scritta di Chimica Analitica 1 con Laboratorio 1. Considerate il seguente sistema elettrodico: Pt Ox Red costituito da una sbarretta di Pt immersa in una soluzione contenente la coppia
11 luglio 008 Prova scritta di Chimica Analitica 1 con Laboratorio 1. Considerate il seguente sistema elettrodico: Pt Ox Red costituito da una sbarretta di Pt immersa in una soluzione contenente la coppia
I.T.I.S. E. FERMI _ MODENA
 I.T.I.S. E. FERMI _ MODENA Programma svolto del corso di Chimica Analitica e Strumentale Classe 3^C a.s. 2016-17 Docenti: Giorgia Messori, Claudia Tacconi Il libro di testo utilizzato è stato: Chimica
I.T.I.S. E. FERMI _ MODENA Programma svolto del corso di Chimica Analitica e Strumentale Classe 3^C a.s. 2016-17 Docenti: Giorgia Messori, Claudia Tacconi Il libro di testo utilizzato è stato: Chimica
Analisi Chimico-Farmaceutiche e Tossicologiche 1
 Analisi Chimico-Farmaceutiche e Tossicologiche 1 Corso A (A H) Prof.ssa Alessia Carocci E-mail: alessia.carocci@uniba.it Studio: stanza 429, III Piano Tel: 080/5442745 Ricevimento studenti: lunedì, mercoledì,
Analisi Chimico-Farmaceutiche e Tossicologiche 1 Corso A (A H) Prof.ssa Alessia Carocci E-mail: alessia.carocci@uniba.it Studio: stanza 429, III Piano Tel: 080/5442745 Ricevimento studenti: lunedì, mercoledì,
Università degli Studi di Torino CORSO DI CHIMICA GENERALE ED INORGANICA C. Schede di valutazione relative alle esercitazioni pratiche in laboratorio
 Università degli Studi di Torino CORSO DI CHIMICA GENERALE ED INORGANICA C Schede di valutazione relative alle esercitazioni pratiche in laboratorio Anno accademico 2006-2007 Dott.ssa Elena Ghibaudi Dott.
Università degli Studi di Torino CORSO DI CHIMICA GENERALE ED INORGANICA C Schede di valutazione relative alle esercitazioni pratiche in laboratorio Anno accademico 2006-2007 Dott.ssa Elena Ghibaudi Dott.
Prodotto di solubilità (Kps)
 Prodotto di solubilità (Kps) SOLUBILITA Concentrazione massima che si può raggiungere per un soluto in un dato solvente ad una certa temperatura. (Es: g soluto/100g di solvente) Solubiltà di NaCl in acqua
Prodotto di solubilità (Kps) SOLUBILITA Concentrazione massima che si può raggiungere per un soluto in un dato solvente ad una certa temperatura. (Es: g soluto/100g di solvente) Solubiltà di NaCl in acqua
DETERMINAZIONE DUREZZA ACQUA
 DETERMINAZIONE DUREZZA ACQUA Le acque contengono disciolti un gran numero di sali e quindi sono presenti molti cationi metallici, tra cui quelli polivalenti che sono i responsabili della durezza. Contribuiscono
DETERMINAZIONE DUREZZA ACQUA Le acque contengono disciolti un gran numero di sali e quindi sono presenti molti cationi metallici, tra cui quelli polivalenti che sono i responsabili della durezza. Contribuiscono
Gli equilibri di solubilità
 Gli equilibri di solubilità Abbiamo definito la solubilità come la concentrazione della soluzione satura, che è una soluzione il cui il composto in soluzione è in equilibrio con il composto indisciolto.
Gli equilibri di solubilità Abbiamo definito la solubilità come la concentrazione della soluzione satura, che è una soluzione il cui il composto in soluzione è in equilibrio con il composto indisciolto.
DISSOLUZIONE DEI SALI IN ACQUA
 1 DISSLUZINE DEI SALI IN ACQUA 1. La dissoluzione di un sale è un equilibrio. 2. Diversi Sali hanno diverse solubilità (K ps ). 3. La solubilità dipende dall energia del reticolo ionico (U) e dall entalpia
1 DISSLUZINE DEI SALI IN ACQUA 1. La dissoluzione di un sale è un equilibrio. 2. Diversi Sali hanno diverse solubilità (K ps ). 3. La solubilità dipende dall energia del reticolo ionico (U) e dall entalpia
Sapienza Università di Roma Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2017/2018
 Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2017/2018 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche Corso di Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z) Dott. Giuseppe La Regina Programma
Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2017/2018 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche Corso di Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z) Dott. Giuseppe La Regina Programma
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A. S.:
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A. S.: 2018/2019 CLASSE: 3^ A CHI MATERIALI MATERIA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE DOCENTI: Prof. Curzio MERLO, Prof. Gianluca TONANI Il docente di Chimica analitica e strumentale
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A. S.: 2018/2019 CLASSE: 3^ A CHI MATERIALI MATERIA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE DOCENTI: Prof. Curzio MERLO, Prof. Gianluca TONANI Il docente di Chimica analitica e strumentale
Corso di Studi di Fisica Corso di Chimica
 Corso di Studi di Fisica Corso di Chimica Luigi Cerruti www.minerva.unito.it Lezione 41 2009 Solubilità Diapositiva della prof. Nadia Lotti Solubilità Stabilite le condizioni di equilibrio di una soluzione
Corso di Studi di Fisica Corso di Chimica Luigi Cerruti www.minerva.unito.it Lezione 41 2009 Solubilità Diapositiva della prof. Nadia Lotti Solubilità Stabilite le condizioni di equilibrio di una soluzione
Esploriamo la chimica
 1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 17 Acidi e basi si scambiano protoni 1. Le teorie sugli acidi e sulle basi 2. La ionizzazione
1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 17 Acidi e basi si scambiano protoni 1. Le teorie sugli acidi e sulle basi 2. La ionizzazione
Dissoluzione dei Solidi
 Dissoluzione dei Solidi La capacità di un solvente di sciogliere un certo soluto non è illimitata Un solido si scioglie tanto più in un solvente quanto più gli è affine chimicamente; questo significa che
Dissoluzione dei Solidi La capacità di un solvente di sciogliere un certo soluto non è illimitata Un solido si scioglie tanto più in un solvente quanto più gli è affine chimicamente; questo significa che
TITOLAZIONI DI PRECIPITAZIONE
 1 TITOLAZIONI DI PRECIPITAZIONE Nonostante siano caratterizzate da un'accuratezza generalmente elevata, le determinazioni gravimetriche richiedono tempi di esecuzione piuttosto lunghi. Inoltre possono
1 TITOLAZIONI DI PRECIPITAZIONE Nonostante siano caratterizzate da un'accuratezza generalmente elevata, le determinazioni gravimetriche richiedono tempi di esecuzione piuttosto lunghi. Inoltre possono
Chimica Generale. Reazioni Chimiche. Reazioni Chimiche
 Una reazione chimica è un processo in cui avviene un cambiamento chimico di uno o più composti, detti reagenti, che vengono convertiti in una nuova serie di composti detti prodotti. Spesso le reazioni
Una reazione chimica è un processo in cui avviene un cambiamento chimico di uno o più composti, detti reagenti, che vengono convertiti in una nuova serie di composti detti prodotti. Spesso le reazioni
1 Durezza totale dell acqua
 1 Durezza totale dell acqua Materiale occorrente: una pipetta a una tacca da 100 ml; una buretta di Schellbach; una beuta. Reattivi: soluzione titolata di EDTA sale disodico 0,0100 M; indicatore nero eriocromo
1 Durezza totale dell acqua Materiale occorrente: una pipetta a una tacca da 100 ml; una buretta di Schellbach; una beuta. Reattivi: soluzione titolata di EDTA sale disodico 0,0100 M; indicatore nero eriocromo
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA I
 2 TITOLAZIONI DI PRECIPITAZIONE Nonostante siano caratterizzate da un'accuratezza generalmente elevata, le determinazioni gravimetriche richiedono tempi di esecuzione piuttosto lunghi. Inoltre possono
2 TITOLAZIONI DI PRECIPITAZIONE Nonostante siano caratterizzate da un'accuratezza generalmente elevata, le determinazioni gravimetriche richiedono tempi di esecuzione piuttosto lunghi. Inoltre possono
Gli acidi (forti o deboli) si titolano con una base forte. Le basi (forti o deboli) si titolano con un acido forte.
 Gli acidi (forti o deboli) si titolano con una base forte. Le basi (forti o deboli) si titolano con un acido forte. D.C. Harris, Elementi di chimica analitica, Zanichelli Capitolo 11 1 e-mail: analitica.biotec@unife.it
Gli acidi (forti o deboli) si titolano con una base forte. Le basi (forti o deboli) si titolano con un acido forte. D.C. Harris, Elementi di chimica analitica, Zanichelli Capitolo 11 1 e-mail: analitica.biotec@unife.it
Compito di analisi dei farmaci I. Bari,9 settembre 1998
 Compito di analisi dei farmaci I Bari,9 settembre 1998 1) L acido formico in una soluzione 0.1 M è dissociato per il 4.6%.50 ml di questa soluzione si diluiscono a 250 ml con acqua e si titolano con NaOH
Compito di analisi dei farmaci I Bari,9 settembre 1998 1) L acido formico in una soluzione 0.1 M è dissociato per il 4.6%.50 ml di questa soluzione si diluiscono a 250 ml con acqua e si titolano con NaOH
18.4 Equilibri di solubilità
 Problemi risolti 18. Equilibri di solubilità A) Quanti ml di una soluzione 5. 10 M di acido solforico è necessario aggiungere a 50 ml di una soluzione 3,. 10 M di CaCl affinchè inizi a precipitare CaSO
Problemi risolti 18. Equilibri di solubilità A) Quanti ml di una soluzione 5. 10 M di acido solforico è necessario aggiungere a 50 ml di una soluzione 3,. 10 M di CaCl affinchè inizi a precipitare CaSO
M di acido formico (Ka =
 14 gennaio 2002 1. Calcolare quanti microlitri di soluzione 0.001 M di Pb 2+ (PA 207) devono essere prelevati per preparare una soluzione di concentrazione pari a 10 ppm e volume 50 ml. 2. Calcolare la
14 gennaio 2002 1. Calcolare quanti microlitri di soluzione 0.001 M di Pb 2+ (PA 207) devono essere prelevati per preparare una soluzione di concentrazione pari a 10 ppm e volume 50 ml. 2. Calcolare la
scheda di lavoro relativa all'esperienza di laboratorio: REAZIONI FRA IONI IN SOLUZIONE ACQUOSA Scopo dell'esperienza: verificare la formazione di...
 scheda di lavoro relativa all'esperienza di laboratorio: REAZIONI FRA IONI IN SOLUZIONE ACQUOSA Scopo dell'esperienza: verificare la formaz di... Prerequisiti: :.. composto ionico:.. reazioni di doppio
scheda di lavoro relativa all'esperienza di laboratorio: REAZIONI FRA IONI IN SOLUZIONE ACQUOSA Scopo dell'esperienza: verificare la formaz di... Prerequisiti: :.. composto ionico:.. reazioni di doppio
Calcolare il ph di una sol. di CH 3 NH 2 (aq) 0,300 M
 Calcolare il ph di una sol. di CH 3 NH 2 (aq) 0,300 M CH 3 NH 2 (aq) + H 2 O(l) CH 3 NH 3+ (aq) + OH (aq) K b = [CH 3 NH 3+ ] [OH ] / [CH 3 NH 2 ] = 3,6 * 10-4 [CH 3 NH 2 ] [CH 3 NH 3+ ] [OH ] inizio 0,300
Calcolare il ph di una sol. di CH 3 NH 2 (aq) 0,300 M CH 3 NH 2 (aq) + H 2 O(l) CH 3 NH 3+ (aq) + OH (aq) K b = [CH 3 NH 3+ ] [OH ] / [CH 3 NH 2 ] = 3,6 * 10-4 [CH 3 NH 2 ] [CH 3 NH 3+ ] [OH ] inizio 0,300
Chimica A.A. 2017/2018
 Chimica A.A. 2017/2018 INGEGNERIA BIOMEDICA Tutorato Lezione 9 Calcolare la solubilità molare del solfato di bario in una soluzione 0.020 M di solfato di sodio. Il prodotto di solubilità del solfato di
Chimica A.A. 2017/2018 INGEGNERIA BIOMEDICA Tutorato Lezione 9 Calcolare la solubilità molare del solfato di bario in una soluzione 0.020 M di solfato di sodio. Il prodotto di solubilità del solfato di
1)Calcolare il ph di una soluzione che contenga al9%(w/w)naoh ed abbia una densità pari a 1.098g/ml.
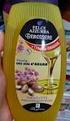 Compito di Analisi dei farmaci I Bari,3 febbraio 1999 1)Calcolare il ph di una soluzione che contenga al9%(w/w)naoh ed abbia una densità pari a 1.098g/ml. 1)Quale deve essere la sensibilità della bilancia
Compito di Analisi dei farmaci I Bari,3 febbraio 1999 1)Calcolare il ph di una soluzione che contenga al9%(w/w)naoh ed abbia una densità pari a 1.098g/ml. 1)Quale deve essere la sensibilità della bilancia
TUTORAGGIO CHIMICA A.A. 2018/2019 Tutoraggio Chimica (Prof. L. Pilia) Nicola Melis
 TUTORAGGIO CHIMICA 18.12.2018 1 Es. 1: Il fluoruro di calcio si discioglie in piccole quantità in acqua. Calcolare il valore di K ps sapendo che [Ca 2+ ] = 2,3*10-4 CaF 2 (s) Ca 2+ (aq) + 2 F - (aq) Es.
TUTORAGGIO CHIMICA 18.12.2018 1 Es. 1: Il fluoruro di calcio si discioglie in piccole quantità in acqua. Calcolare il valore di K ps sapendo che [Ca 2+ ] = 2,3*10-4 CaF 2 (s) Ca 2+ (aq) + 2 F - (aq) Es.
Esercizi - A.A. 2017/2018
 Esercizi - A.A. 2017/2018 Preparazione soluzioni e diluizioni Es. 1 2 ml di piridina (d = 0.892 g/ml) sono disciolti in 80 ml di etanolo (d = 0.79 g/ml). Trovare la % in massa di piridina nella soluzione.
Esercizi - A.A. 2017/2018 Preparazione soluzioni e diluizioni Es. 1 2 ml di piridina (d = 0.892 g/ml) sono disciolti in 80 ml di etanolo (d = 0.79 g/ml). Trovare la % in massa di piridina nella soluzione.
Titolazioni Redox Dipenden0 dal ph
 Titolazioni Redox Dipenden0 dal ph Poiché molte reazioni redox dipendono fortemente dall ambiente acido o basico in cui sono condo8e, c è da a8endersi che il punto equivalente delle =tolazioni redox che
Titolazioni Redox Dipenden0 dal ph Poiché molte reazioni redox dipendono fortemente dall ambiente acido o basico in cui sono condo8e, c è da a8endersi che il punto equivalente delle =tolazioni redox che
I.T.I.S. E. FERMI _ MODENA
 I.T.I.S. E. FERMI _ MODENA Programma svolto del corso di Chimica Analitica e Strumentale Classe 3^C a.s. 2015-16 Docenti: Giorgia Messori, Claudia Tacconi Il libro di testo utilizzato è stato: Chimica
I.T.I.S. E. FERMI _ MODENA Programma svolto del corso di Chimica Analitica e Strumentale Classe 3^C a.s. 2015-16 Docenti: Giorgia Messori, Claudia Tacconi Il libro di testo utilizzato è stato: Chimica
COMPORTAMENTO DI SALI CONTENENTI PARTICOLARI CATIONI IN SEGUITO A TRATTAMENTO CON COMPLESSANTI, BASI ED ACIDI
 COMPORTAMENTO DI SALI CONTENENTI PARTICOLARI CATIONI IN SEGUITO A TRATTAMENTO CON COMPLESSANTI, BASI ED ACIDI Perché le soluzioni dei cationi metallici di partenza sono acide. Una volta sciolto un sale
COMPORTAMENTO DI SALI CONTENENTI PARTICOLARI CATIONI IN SEGUITO A TRATTAMENTO CON COMPLESSANTI, BASI ED ACIDI Perché le soluzioni dei cationi metallici di partenza sono acide. Una volta sciolto un sale
Formazione di complessi [M a L nb ] a-nb
![Formazione di complessi [M a L nb ] a-nb Formazione di complessi [M a L nb ] a-nb](/thumbs/96/127683676.jpg) Formazione di complessi [M a L nb ] a-nb Struttura degli ioni complessi Gli ioni complessi sono formati da un catione metallico legato a un numero di anioni come OH -, Cl -, CN -, SCN -, o di molecole
Formazione di complessi [M a L nb ] a-nb Struttura degli ioni complessi Gli ioni complessi sono formati da un catione metallico legato a un numero di anioni come OH -, Cl -, CN -, SCN -, o di molecole
Analisi chimico-farmaceutiche e tossicologiche I
 Analisi chimico-farmaceutiche e tossicologiche I Corso I Z Prof.ssa Alessia Catalano E-mail: alessia.catalano@uniba.it Tel: 080/5442745 Stanza 429 - III piano Ricevimento studenti: lunedì, mercoledì, venerdì
Analisi chimico-farmaceutiche e tossicologiche I Corso I Z Prof.ssa Alessia Catalano E-mail: alessia.catalano@uniba.it Tel: 080/5442745 Stanza 429 - III piano Ricevimento studenti: lunedì, mercoledì, venerdì
Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie -Articolazione Biotecnologie sanitarie CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 3 anno
 Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie -Articolazione Biotecnologie sanitarie CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 3 anno UDA CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA UDA N. 1 Gli acidi e le Ore: 11 Settembre-
Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie -Articolazione Biotecnologie sanitarie CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 3 anno UDA CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA UDA N. 1 Gli acidi e le Ore: 11 Settembre-
+ NO 2 + 3H 2 O = Ce +3 + NO 3 + 2H 3 O +, b) 0.478 g
 1) Una soluzione di Na 3 PO 4 (PM = 163.94) viene titolata con una soluzione di AgNO 3 (PM = 169.87) a) Scrivere l equazione chimica del processo di titolazione e specificare di quale tecnica si tratta
1) Una soluzione di Na 3 PO 4 (PM = 163.94) viene titolata con una soluzione di AgNO 3 (PM = 169.87) a) Scrivere l equazione chimica del processo di titolazione e specificare di quale tecnica si tratta
Determinazione del Cu in pigmenti
 FACOLTÁ DI SCEINZE E TECNOLOGIE Determinazione del Cu in pigmenti I. Rossetti, G. Cappelletti, C. Crippa Introduzione I pigmenti a base di rame sono stati utilizzati fin dall antichità per impartire una
FACOLTÁ DI SCEINZE E TECNOLOGIE Determinazione del Cu in pigmenti I. Rossetti, G. Cappelletti, C. Crippa Introduzione I pigmenti a base di rame sono stati utilizzati fin dall antichità per impartire una
L ANALISI CHIMICA 2 SOSTANZA INCOGNITA. Analisi degli anioni e dei cationi. Riconoscimento della sostanza
 L ANALISI CHIMICA 1 L Analisi Chimica è un insieme di operazioni che si eseguono per separare, riconoscere (Analisi Chimica Qualitativa) e dosare (Analisi Chimica Quantitativa) una sostanza o una miscela
L ANALISI CHIMICA 1 L Analisi Chimica è un insieme di operazioni che si eseguono per separare, riconoscere (Analisi Chimica Qualitativa) e dosare (Analisi Chimica Quantitativa) una sostanza o una miscela
L importanza dell acqua. Magoga Romeo e Tosku Melisa Classe 2 GA I.I.S. Nervi
 L importanza dell acqua Magoga Romeo e Tosku Melisa Classe 2 GA I.I.S. Nervi L'acqua potabile contaminata è il più diffuso problema nelle abitazioni che sono molto vecchie o molto nuove. Un tempo era pratica
L importanza dell acqua Magoga Romeo e Tosku Melisa Classe 2 GA I.I.S. Nervi L'acqua potabile contaminata è il più diffuso problema nelle abitazioni che sono molto vecchie o molto nuove. Un tempo era pratica
Studio della curva di titolazione acido-base
 D.C. Harris, Elementi di chimica analitica, Zanichelli Capitolo 11 1 e-mail: analitica.biotec@unife.it Studio della curva di titolazione acido-base 2 Studio della curva di titolazione acido-base Calcolo
D.C. Harris, Elementi di chimica analitica, Zanichelli Capitolo 11 1 e-mail: analitica.biotec@unife.it Studio della curva di titolazione acido-base 2 Studio della curva di titolazione acido-base Calcolo
Reazioni in Soluzioni Acquose. Capitolo 4
 Reazioni in Soluzioni Acquose Capitolo 4 Una soluzione è una miscela omogenea di 2 o più sostanze Il soluto è(sono) la(le) sostanza(e) presente(i) in minore quantità Il solvente è la sostanza presente
Reazioni in Soluzioni Acquose Capitolo 4 Una soluzione è una miscela omogenea di 2 o più sostanze Il soluto è(sono) la(le) sostanza(e) presente(i) in minore quantità Il solvente è la sostanza presente
CHIMICA ANALITICA I E LABORATORIO M - Z
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE Corso di laurea in Chimica Anno accademico 2016/2017-2 anno CHIMICA ANALITICA I E LABORATORIO M - Z 12 CFU - 1 semestre Docente titolare dell'insegnamento ALESSANDRO GIUFFRIDA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE Corso di laurea in Chimica Anno accademico 2016/2017-2 anno CHIMICA ANALITICA I E LABORATORIO M - Z 12 CFU - 1 semestre Docente titolare dell'insegnamento ALESSANDRO GIUFFRIDA
LE SOSTANZE PRESENTI NELL ACQUA SI POSSONO SUDDIVIDERE IN: sostanze in sospensione sostanze in soluzione gas disciolti
 LE SOSTANZE PRESENTI NELL ACQUA SI POSSONO SUDDIVIDERE IN: sostanze in sospensione sostanze in soluzione gas disciolti Tipi di acque Acque Per Uso Industriale (I) Le acque impiegate dalle industrie per
LE SOSTANZE PRESENTI NELL ACQUA SI POSSONO SUDDIVIDERE IN: sostanze in sospensione sostanze in soluzione gas disciolti Tipi di acque Acque Per Uso Industriale (I) Le acque impiegate dalle industrie per
specie chimiche. in quantità maggiore presente nella soluzione, e tutti gli altri componenti che sono detti soluti. Un componente di una soluzione
 Equilibri di solubilità 1 1 Si definisce SOLUZIONE una miscela omogenea di due o più specie chimiche. In una soluzione si distinguono un solvente, che è il componente in quantità maggiore presente nella
Equilibri di solubilità 1 1 Si definisce SOLUZIONE una miscela omogenea di due o più specie chimiche. In una soluzione si distinguono un solvente, che è il componente in quantità maggiore presente nella
Osservazioni su alcuni ossidanti comuni che agiscono in soluzione acquosa
 Osservazioni su alcuni ossidanti comuni che agiscono in soluzione acquosa Esercizio: scrivere la reazione corrispondente ad ogni asterisco e bilanciare. PERMANGANATO Il permanganato di potassio K è un
Osservazioni su alcuni ossidanti comuni che agiscono in soluzione acquosa Esercizio: scrivere la reazione corrispondente ad ogni asterisco e bilanciare. PERMANGANATO Il permanganato di potassio K è un
RICERCA RICERCA DEGLI ANIONI
 RICERCA DEGLI ANIONI 1 SOSTANZA INIZIALE Na 2 CO 3 Ricerca: ACETATI SOLFITI CARBONATI TARTRATI SOLUZIONE ALCALINA Limpida Incolore RESIDUO Si scarta Ricerca: SOLFATI OSSALATI ARSENIATI NITRITI NITRATI
RICERCA DEGLI ANIONI 1 SOSTANZA INIZIALE Na 2 CO 3 Ricerca: ACETATI SOLFITI CARBONATI TARTRATI SOLUZIONE ALCALINA Limpida Incolore RESIDUO Si scarta Ricerca: SOLFATI OSSALATI ARSENIATI NITRITI NITRATI
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E. FERMI - MODENA
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E. FERMI - MODENA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA EDUCATIVA di CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE Classe 3^ G anno scolastico 2016/2017 Docenti: prof. Paola Morganti - Antonietta Grande
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E. FERMI - MODENA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA EDUCATIVA di CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE Classe 3^ G anno scolastico 2016/2017 Docenti: prof. Paola Morganti - Antonietta Grande
REAZIONI CHIMICHE. Idrogeno + ossigeno acqua
 REAZIONI CHIMICHE Reagenti Prodotti L unità che si conserva è l atomo, durante una reazione cambia solo la disposizione relative degli atomi. Si rompono i legami chimici tra le molecole dei reagenti e
REAZIONI CHIMICHE Reagenti Prodotti L unità che si conserva è l atomo, durante una reazione cambia solo la disposizione relative degli atomi. Si rompono i legami chimici tra le molecole dei reagenti e
ANALISI SISTEMATICA DEI CATIONI
 ANALISI SISTEMATICA DEI CATIONI Particolare procedura analitica attraverso la quale tutte le specie cationiche presenti in una ipotetica miscela vengono inizialmente separate in gruppi, mediante l uso
ANALISI SISTEMATICA DEI CATIONI Particolare procedura analitica attraverso la quale tutte le specie cationiche presenti in una ipotetica miscela vengono inizialmente separate in gruppi, mediante l uso
Sapienza Università di Roma Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2013/2014
 Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2013/2014 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z) Dott. Giuseppe La Regina I.
Facoltà di Farmacia e Medicina Anno Accademico 2013/2014 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche Corso di Analisi Chimico-Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z) Dott. Giuseppe La Regina I.
Principali classi di composti inorganici. Idruri Idracidi Ossidi Idrossidi Ossoacidi Sali Perossidi
 Principali classi di composti inorganici Idruri Idracidi ssidi Idrossidi ssoacidi Sali Perossidi Idruri Sono composti binari dell idrogeno con gli elementi più elettropositivi idruri Metalli I e II gruppo
Principali classi di composti inorganici Idruri Idracidi ssidi Idrossidi ssoacidi Sali Perossidi Idruri Sono composti binari dell idrogeno con gli elementi più elettropositivi idruri Metalli I e II gruppo
Acidi Basi e Sali. ChimicaGenerale_lezione19 1
 Acidi Basi e Sali Le soluzioni della maggior parte dei sali sono acide o basiche piuttosto che neutre. Infatti, cationi e anioni possono agire da basi o acidi E possibile prevedere il ph di una soluzione
Acidi Basi e Sali Le soluzioni della maggior parte dei sali sono acide o basiche piuttosto che neutre. Infatti, cationi e anioni possono agire da basi o acidi E possibile prevedere il ph di una soluzione
ossidazione/riduzione, ossidante/riducente
 ossidazione/riduzione, ossidante/riducente Esercizio tipo: bilanciamento redox +6-1 -1 +3-1 K 2 Cr 2 O 7 (aq) + HI(aq) KI(aq) + CrI 3 (aq) + I 2 (s) + H 2 O(l) 0 K 2 Cr 2 O 7 (aq) + 6HI(aq) KI(aq) + 2CrI
ossidazione/riduzione, ossidante/riducente Esercizio tipo: bilanciamento redox +6-1 -1 +3-1 K 2 Cr 2 O 7 (aq) + HI(aq) KI(aq) + CrI 3 (aq) + I 2 (s) + H 2 O(l) 0 K 2 Cr 2 O 7 (aq) + 6HI(aq) KI(aq) + 2CrI
