2 Logica e Cultura Generale
|
|
|
- Franco Roberti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 2 Logica e Cultura Generale
2 LOGICA E CULTURA GENERALE 1. Il sonetto è A. una struttura narrativa B. una struttura chiusa di 14 versi C. una struttura poetica composta di ottave D. una composizione a struttura libera E. un componimento destinato ad essere musicato 2. L archeologo Schliemann è famoso per A. gli scavi nell isola di Creta B. gli studi sulle catacombe cristiane C. le sue ricerche sulla civiltà Maya D. aver scoperto i resti dell antica Ilio E. la ricostruzione della topografia dell antica Atene 3. Delitto e Castigo è un celebre romanzo scritto da A. Lev Tolstoj B. Boris Pasternak C. Fiodor Dostoevskij D. Anton Cechov E. Vladimir Putin Logica e Cultura Generale 3
3 4. Nella teoria della comunicazione il termine ridondanza indica A. l adozione di un registro sproporzionato all argomento B. la mancanza di uno schema coerente C. l abbondanza di figure retoriche D. la continua ripetizione di un termine E. la presenza di informazioni superflue 5. La metafora è A. un traslato basato sull opposizione B. l uso di termini volutamente ambigui C. lo scambio della parte per il tutto D. un traslato fondato sulla somiglianza E. l uso di un linguaggio immaginoso 6. Il super uomo è un concetto di A. Schelling B. Nietzsche C. Fichte D. Kant E. Hegel 4 Logica e Cultura Generale
4 Vengono ora presentati due brani, tratti da testi significativi, ai quali non è stata apportata alcuna modifica, se non l eliminazione di riferimenti non essenziali. Ciascuno dei brani presentati è seguito da cinque quesiti riguardanti il suo contenuto. Per ogni quesito sono previste cinque risposte differenti, contrassegnate con le lettere A, B, C, D, E. Per ogni quesito scegliete fra le cinque risposte o affermazioni quella che ritenete corretta in base soltanto a ciò che risulta esplicito o implicito nel brano, cioè solo in base a quanto si ricava dal brano e non in base a quanto eventualmente sapete già sull argomento. Logica e Cultura Generale 5
5 TESTO I ARTE E CONOSCENZA Molte sono state e sono tuttora le dispute e le polemiche intorno al problema d una esperienza gnoseologica quale premessa d ogni assaporamento dell arte e d ogni sua valutazione. Non si può negare che alla base dell incomprensione, oggi cosí spesso avvertita, sia posta anche un assenza o insufficienza d educazione e dunque di conoscenza. L educazione all arte - oltre all educazione attraverso l arte - è un dato di fatto; gli esempi di quanto possa una giusta e accorta educazione per la comprensione dell arte sono indicativi. Basterebbe citare un esperimento eseguito negli USA da cui risulta quanto valga per una giusta comprensione dell arte moderna l elemento educativo e come alcuni gruppi di adulti totalmente sordi all arte moderna prima dell esperimento siano divenuti, dopo un certo numero di sedute di visualizzazione, capaci di intendere opere e argomenti ai quali precedentemente erano del tutto refrattari. Questo non deve significare per altro che sia necessario voler rendere scientificamente probatorio e sperimentalmente valutabile ogni elemento estetico, come non è necessario considerare che ogni problema estetico possa e debba essere tradotto in termini razionali e concettuali per venir giustamente inteso. Parlando di comprensione dell arte, infatti, non intendo riferirmi esclusivamente ad una comprensione concettualizzata, che si rivolga esclusivamente al segmento cerebrale, intellettuale, della mente umana. Molto spesso la comprensione e dunque l educazione artistica dovrà valersi di elementi prevalentemente irrazionali soprattutto nel settore delle arti visuali e della musica, e meno in quelle della parola. Sarà 6 Logica e Cultura Generale
6 possibile, anzi, ammettere, accanto a un pensiero razionale, la presenza di quello che gli inglesi definiscono visual thinking, pensiero visivo, e, alla stessa stregua, d un pensiero auditivo o comunque di un genere di pensiero che si svolge al di fuori della comune soglia coscienziale. Accettare l esistenza d un visual thinking significa oltretutto ammettere la possibilità di un azione dell arte di carattere del tutto diverso da quello della logica e della scienza: un azione che si esplicita e invade il territorio in cui agiscono e si sviluppano i grandi miti dell umanità; quel territorio magico che un tempo parve popolato da forze occulte, demoniche, numinose, e che oggi vede agitarsi - sotto altri nomi - forze analoghe. Certo, già Vico, già Schelling avevano cercato di restituire un valore conoscitivo al pensiero mitico e quindi al linguaggio e all arte che sono cosí strettamente connesse al mito; ma la loro ipotesi doveva essere raccolta soprattutto da Cassirer che a questo tipo di pensiero dedicava la sua opera maggiore. Oggi, dopo la lezione di Cassirer, che si è propagata e in un certo senso diluita attraverso le opere di Susanne Langer, molti dei recenti pensatori, antropologi, estetologi, hanno affrontato ed accettato questa impostazione filosofica nei riguardi del pensiero estetico. Quello che a me preme, tuttavia, non è di rendere nuovamente nebuloso l universo artistico o di rimettere in discussione recenti acquisizioni circa i rapporti tra arte e linguaggio, tra arte e scienza, ma solo di ribadire come, per giudicare l evoluzione (e l involuzione) del gusto, e dei gusti, si debba tener conto anche di questa sottomissione dell arte a un tipo di conoscenza che non è quella di solito accettata dalle consuete impostazioni gnoseologiche riguardanti la ragione umana. Logica e Cultura Generale 7
7 QUESITI RELATIVI AL TESTO I 7. La fruizione di un opera d arte A. è riducibile in termini concettuali B. è possibile senza specifica preparazione C. è assolutamente soggettiva D. cambia secondo l evoluzione del gusto E. richiede forme extra-concettuali di pensiero 8. L educazione attraverso l arte è A. un processo formativo avente l arte come strumento B. la conoscenza della storia dell arte C. la formazione culturale generale D. un settore distinto dalla formazione generale E. l acquisizione delle diverse tecniche 9. L educazione all arte è A. lo studio delle teorie estetiche B. inutile perché il gusto estetico è soggettivo C. il superamento di una considerazione puramente concettualizzante D. la formazione di una capacità critica settoriale E. la capacità di capire l arte contemporanea 8 Logica e Cultura Generale
8 10. Arte e mito sono strettamente connessi perché A. esprimono gusti e tradizioni popolari B. hanno lo stesso carattere simbolico C. dipendono da forze prelogiche dello spirito D. hanno gli stessi contenuti E. sono il prodotto di una ispirazione divina 11. L arte è dotata di valore conoscitivo? A. No, si basa su valori soggettivi B. Sì, è comprensibile da parte di persone preparate C. Sì, fa capire molto del mondo spirituale D. Sì, aldilà dei parametri gnoseologici abituali E. No, non dimostra nulla Logica e Cultura Generale 9
9 TESTO II DALL ORALE ALLO SCRITTO Per ogni essere umano, fin dalle prime ore di vita, i fatti linguistici sono legati profondamente agli affetti, alle esperienze quotidiane, alla maturazione delle capacità di socializzazione e di elaborazione conoscitiva. Pervadono il nostro privato in tutte le sue forme più concrete. Per il profano risulta quindi sempre faticoso capire che a questa concretezza grondante di materialità, affettività e quotidianità possa essere e sia vantaggioso guardare anche da un punto di vista molto astratto, non per negare la concretezza, ma per intenderne meglio la sottile trama, una trama logica, matematica, che la innerva. Alcuni grandi teorici del Novecento, anche se non consenzienti in tutto tra loro, hanno messo in luce questi vantaggi, da Saussure, all inizio del secolo, fino a Chomsky, al termine. Guardare al linguaggio, alle lingue e all esprimersi da questo punto di vista molto astratto vuol dire accostarsi (cercare di accostarsi) al modo in cui un matematico guarda a un calcolo oaunafigura. Che usiate carta e penna, gesso e lavagna, tastiere e video, o la vostra voce e le parole della vostra o di un altra lingua, e cifre arabe o romane o cinesi e sistemi di numerazione in base due, o dieci o dodici, o pietruzze e sabbia e bastoncini, tutto questo non ha alcun interesse. Il suo occhio coglie invarianti e relazioni tra invarianti, queste le cose interessanti. Lunghezze o spazi e quantità numeriche, così diverse nella concreta esperienza e così diversamente rappresentate, gli appaiono proiezioni di entità concettualmente identiche: saturazioni diverse di identiche relazioni astratte. Se si guarda al linguaggio in questo modo, parlare e scrivere appaiono solo saturazioni diverse del costruire segni valendosi delle unità e regole di una lin- 10 Logica e Cultura Generale
10 gua. E del resto le lingue stesse, nella loro immensa varietà, appaiono proiezioni accidentalmente diverse, ma concettualmente equivalenti, di un unica capacità di identificare, differenziare e associare ciò che vogliamo dire e ciò che ci permette di esprimerlo. Nell atmosfera remota e rarefatta della pura teoria parlare e scrivere sono equivalenti. Ma se mettiamo le due attività in rapporto con le concrete capacità dei singoli, in un contesto storico e culturale determinato, le cose cambiano. (Cambia anche, e come, fare calcoli con pietruzze o con carta e penna, a memoria o su una calcolatrice...) Almeno oggi e per ora, ben poco di ciò che chiamiamo scrittura è davvero, in via di fatto, soltanto una diversa saturazione di un parlare e il parlato lo è di uno scrivere. La scrittura si avvicina a equivalere al parlare quando qualcosa viene scritto sotto dettatura. Sarà ancora meglio equivalente se e quando saranno assai più perfetti, cioè ben più aderenti a qualunque dettaglio di qualunque realizzazione parlata, i sistemi di dettatura automatica, cioè di registrazione e trascrizione automatica della voce parlante. Ma nel comune scrivere e anche nell attuale dettatura automatica (che, per ora, è però un parlato orientato al suo dover essere scritto) le cose stanno assai diversamente. Una frase scritta equivale a una frase parlata e viceversa, solo in quanto vi è tra le due un buon grado di sinonimia, cioè una più o meno estesa comunanza di sensi attribuibili indifferentemente all una e all altra. Ma molte sono le differenze formalmente e sostanzialmente rilevanti. Il parlato non può sottrarsi mai del tutto all integrazione con riferimenti evidenti a chi parla, allo stato in cui si trova, alle circostanze presenti nell immediato e a gesti, toni, pause che accompagnano e colorano il dire e orientano chi ascolta nella compren- Logica e Cultura Generale 11
11 sione del senso concreto, più vero, perfino contro la volontà, a volte, di chi sta parlando. Tutto ciò èforzatamente semplificato in ogni usuale sistema di scrittura. Ciò che scriviamo qui e ora verrà letto (forse) un giorno lontano altrove, da chi per afferrare il senso di ciò che vogliamo dire non ha altro indizio che la nuda forma delle nostre frasi o parole. Guai se queste fanno troppo affidamento sui toni o sulla mimica con cui le pronunceremmo parlando o sulle evidenze materiali che ci circondano mentre scriviamo. Di conseguenza la redazione di un testo scritto, per modesto che sia, obbliga chi scrive a una riflessione preliminare sulle forme linguistiche da impiegare perché il testo, privo di sussidi che accompagnano il parlato, risulti accessibile a destinatari lontani nello spazio e nel tempo e, forse, nella cultura e negli affetti. La scrittura è un impietosa spoliazione di tutto ciò che informalmente ed estemporaneamente ci aiuta a esprimerci nel parlare. Ci aiuta e deve aiutarci. Un buon parlatore sa che, per quanto abbia progettato con cura e fissato in mente ciò che deve dire, il dire effettivo è mortifero se non tiene conto delle necessità o delle possibilità che un concreto interlocutore o un determinato pubblico e una specifica situazione presentano. D altra parte, proprio per questa spoliazione, la scrittura deve rendere esplicito tutto ciò che nel parlare può e deve rimanere implicito. L implicito del parlato va portato nella forma delle parole e delle frasi scritte, va formalizzato. 12 Logica e Cultura Generale
12 QUESITI RELATIVI AL TESTO II 12. La considerazione astratta del linguaggio riguarda A. le sue strutture B. l evoluzione storica C. il parlato effettivo D. il lessico preso per sé E. il solo aspetto fonologico 13. Per saturazione di una struttura si intende A. il completamento della sua evoluzione B. l atto esplicito del discorso C. la sua conformità con le regole morfo-sintattiche D. il passaggio dal dialetto alla lingua E. la sua realizzazione con un contenuto concreto 14. Tra saturazione orale e scritta di un messaggio A. non esistono equivalenze di significato B. sono diversi i registri espressivi C. cambia la regolarità grammaticale D. la diversità èradicale E. cambiano sia la forma che il contenuto Logica e Cultura Generale 13
13 15. Il senso di un messaggio orale è accompagnato da A. un inferiore controllo sintattico B. un accentuato livello di spontaneità C. fattori fonologici, gestuali e mimici D. una esatta determinazione dei destinatari E. una conoscibilità immediata della ricezione 16. La saturazione scritta di un messaggio deve A. prevedere le modalità di ricezione B. rendere espliciti i fattori impliciti nell orale C. corrispondere esattamente alle sue finalità D. riprodurre esattamente il contenuto del parlato E. essere totalmente autonoma rispetto al parlato 14 Logica e Cultura Generale
14 17. Luciano, Luigi, Massimo e Patrizio stanno valutando se partire per una vacanza. Si sa che: se parte Massimo, parte anche Patrizio; se non parte Luciano non parte nemmeno Patrizio; se parte Luciano parte anche Luigi. Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta? A. Non parte nessuno B. Se non parte Luigi, non parte nemmeno Massimo C. Partono Luciano e Luigi D. Partono tutti E. Se parte Luciano, parte anche Massimo 18. Si consideri la seguente sequenza Indicare quale delle 5 figure continua la sequenza indicata A. Figura 3 B. Figura 4 C. Figura 2 D. Figura 1 E. Figura 5 Logica e Cultura Generale 15
15 19. Piera ha quattro pretendenti, Aristide, Basilio, Carlo e Donato, e, dovendo sceglierne uno, decide di consigliarsi con le sue quattro amiche Letizia, Marina, Nives e Olga. Letizia consiglia decisamente Aristide (e solo lui). Marina pensa che sia Basilio che Carlo siano degli ottimi ragazzi, mentre gli altri due sono poco affidabili. Nives non ha dubbi: Carlo è la persona giusta per Piera. Olga pensa che Aristide e Carlo siano entrambi molto raccomandabili, ma sospende il suo giudizio sugli altri due, che non conosce bene. Dopo aver meditato a lungo, alla fine Piera decide, consapevole del fatto che: A. se sceglie Basilio la maggioranza delle sue amiche la criticherà B. qualunque persona lei scelga, non riuscirà mai a seguire i consigli di più di due amiche C. Carlo è l unico approvato dalla maggioranza delle sue amiche D. la persona da lei scelta non piace a nessuna sua amica E. se non sceglie Carlo, la maggioranza delle sue amiche la criticherà 16 Logica e Cultura Generale
16 20. Si consideri la seguente sequenza: Indicare quale delle 5 figure continua la sequenza indicata A. Figura 4 B. Figura 2 C. Figura 5 D. Figura 1 E. Figura 3 Logica e Cultura Generale 17
17 21. Nel sottopassaggio di Porta Nuova il signor Truffolin ha allestito il suo banchetto per il gioco delle 6 coppette, che consiste nel nascondere sotto ciascuna delle sue 6 coppette (tutte uguali e numerate da1a6)unadelle seguenti monete: una da 5 centesimi, una da 10, una da 20 e una da 50 centesimi, una da 1 Euro e una da 2 Euro. Egli ha appeso un cartello dove espone le regole che segue nel nascondere le monete: la moneta da 50 centesimi sta sotto una coppetta numerata con un numero inferiore a quella che nasconde la moneta da 20 centesimi; le monete da 1 Euro e da 10 centesimi stanno sempre sotto due coppette etichettate con numeri consecutivi; la moneta da 5 centesimi sta sempre sotto la coppetta numero 5 (e ovviamente non si può scommettere su di essa). Amilcare e Basilio si fermano presso il banchetto; Basilio scommette che la moneta da 20 centesimi si trova sotto la coppetta numero 2 e vince. A questo punto Amilcare può affermare con assoluta certezza che: A. la sequenza delle monete è, nell ordine dalla prima alla sesta coppetta, 50C, 20C, 10C, 1E, 5C, 2E B. le monete da 1E e da 5C non sono adiacenti C. la sequenza delle monete è, nell ordine dalla prima alla sesta coppetta, 50C, 20C, 1E, 10C, 5C, 2E D. le monete da 20C e da 5C sono adiacenti E. la moneta da 2E sta sotto la coppetta numero 6 18 Logica e Cultura Generale
18 22. Si devono distribuire le cifre da 1 a 8 negli otto cerchietti mostrati nella figura, con questa condizione: nei cerchi connessi direttamente da una linea non si devono trovare due cifre immediatamente vicine nella successione numerica. Ad esempio: se si mette il 5nel cerchio A, non si possono mettere il 4 ed il 6 in nessuno dei tre cerchi B, C, D che formano la riga orizzontale sottostante ad esso. Quante delle soluzioni proposte risultano accettabili? A. nessuna B. tutte e quattro C. tre D. due E. una A=7, B=3, C=1, D=4, E=5, F=8, G=6, H=2; A=3, B=7, C=1, D=4, E=5, F=8, G=6, H=2; A=7, B=1, C=3, D=4, E=5, F=8, G=6, H=2; A=7, B=3, C=4, D=1, E=5, F=8, G=6, H=2; Logica e Cultura Generale 19
19 23. Tre amici hanno assistito a una finale di pattinaggio artistico femminile. Alcuni giorni dopo cercano di ricordare chi si è aggiudicato il podio dei primi tre posti, ma ognuno ha un ricordo diverso. Silvano afferma: Si sono piazzate ai primi posti la Aista, la Batijnka e la Chunky. Teresio invece ricorda che le prime tre sono state la Aista, la Chunky e la Delatombée. Umberto invece afferma Si sono classificate nei primi tre posti la Batijnka la Delatombée e la Einigefallen. Sapendo che ognuno di loro ricorda due nomi esatti e uno sbagliato, possiamo affermare che A. I dati sono insufficienti per rispondere. B. Si piazzarono la Aista, la Chunky e la Einigefallen C. Si piazzarono la Batijnka, la Delatombée e la Einigefallen D. Si piazzarono la Batijnka, la Chunky e la Einigefallen E. Si piazzarono la Aista, la Batijnka e la Delatombée 20 Logica e Cultura Generale
20 24. Ogni figura geometrica può essere ottenuta attraverso la combinazione di elementi geometrici più piccoli (pezzi). Quali di queste figure sono ottenute con gli stessi pezzi? A. La n. 1 e la n. 2 B. La n. 2 e la n.4 C. La n. 1 e la n.4 D. La n. 2 e la n. 3 E. Sono tutte equivalenti 25. Dire quale dei 5numeri sottostanti continua la successione A B C. 19 D. 135 E ? Logica e Cultura Generale 21
21 26. Un cubo di carta è dipinto esternamente e il suo sviluppo è mostrato dalla seguente figura. Indicare quale tra i 5cubi sottostanti ne è laricomposizione. Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 A. Figura 5 B. Figura 4 C. Figura 3 D. Figura 1 E. Figura 2 22 Logica e Cultura Generale
22 Logica e Cultura Generale 23
A CHE COSA SERVE LA PROVA DI AMMISSIONE
 A CHE COSA SERVE LA PROVA DI AMMISSIONE Sono tenuti a sottoporsi a questa prova di ammissione con finalità selettive tutti coloro che vogliono iscriversi alla Facoltà di Architettura, ai corsi di laurea
A CHE COSA SERVE LA PROVA DI AMMISSIONE Sono tenuti a sottoporsi a questa prova di ammissione con finalità selettive tutti coloro che vogliono iscriversi alla Facoltà di Architettura, ai corsi di laurea
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA
 CURRICOLO QUINQUENNALE Istituto Comprensivo Cavour - Pavia LINGUA E SECONDA LINGUA COMUNITARIA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA (Livello A1 del Quadro Comune
CURRICOLO QUINQUENNALE Istituto Comprensivo Cavour - Pavia LINGUA E SECONDA LINGUA COMUNITARIA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA (Livello A1 del Quadro Comune
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA
 CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA CONTENUTI ABILITA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI LINGUA PER NARRARE Testo fantastico fiaba favola mito leggenda racconto di fantasia Testo realistico
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA CONTENUTI ABILITA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI LINGUA PER NARRARE Testo fantastico fiaba favola mito leggenda racconto di fantasia Testo realistico
CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCUOLA DELL INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCUOLA DELL INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Il bambino: ascolta e comprende brevi messaggi orali;
CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCUOLA DELL INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Il bambino: ascolta e comprende brevi messaggi orali;
Istituto Comprensivo di Pralboino Curricolo Verticale
 ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
ITALIANO CLASSE 2 a PRIMARIA ASCOLTO E PARLATO -L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
Obiettivi di apprendimento
 Curricolo verticale di Lingua Inglese classe Prima Primaria Indicatori Obiettivi di apprendimento 1. RICEZIONE ORALE (ascolto) 1.1 Comprendere istruzioni, espressioni di uso quotidiano pronunciate chiaramente
Curricolo verticale di Lingua Inglese classe Prima Primaria Indicatori Obiettivi di apprendimento 1. RICEZIONE ORALE (ascolto) 1.1 Comprendere istruzioni, espressioni di uso quotidiano pronunciate chiaramente
Tutti i giovedì lavoro al computer e vado in palestra. 1. Qualche giovedì non lavoro al computer e non vado in palestra.
 Test Logica Domanda 1 Sapendo che la seguente frase Tutti i giovedì lavoro al computer e vado in palestra è falsa, se ne deduce necessariamente che: 1. Qualche giovedì non lavoro al computer e non vado
Test Logica Domanda 1 Sapendo che la seguente frase Tutti i giovedì lavoro al computer e vado in palestra è falsa, se ne deduce necessariamente che: 1. Qualche giovedì non lavoro al computer e non vado
LE COMPETENZE CHIAVE PER L APPRENDIMENTO PERMANENTE
 FRANCESE LE COMPETENZE CHIAVE PER L APPRENDIMENTO PERMANENTE L intero iter scolastico ha come finalità il raggiungimento delle seguenti competenze definite dal Parlamento e dal Consiglio dell Unione Europea
FRANCESE LE COMPETENZE CHIAVE PER L APPRENDIMENTO PERMANENTE L intero iter scolastico ha come finalità il raggiungimento delle seguenti competenze definite dal Parlamento e dal Consiglio dell Unione Europea
Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri. ABILITÀ Obiettivi di apprendimento
 Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri NUCLEI FONDANTI ASCOLTO E PARLATO COMPETENZE Ascoltare e comprendere messaggi in contesti
Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri NUCLEI FONDANTI ASCOLTO E PARLATO COMPETENZE Ascoltare e comprendere messaggi in contesti
Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria
 CURRICOLO DISCIPLINARE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Obiettivi di apprendimento
CURRICOLO DISCIPLINARE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Seconda Lingua Comunitaria (Francese Spagnolo) Classe seconda secondaria Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Obiettivi di apprendimento
2. Quesiti dell area scientifica e scientifico-tecnologica
 2. Quesiti dell area scientifica e scientifico-tecnologica Logica 01 Scegliere fra le alternative proposte quella che completa la serie: a b c d e 02 Un auto percorre 20.000 km nel corso di un lungo viaggio.
2. Quesiti dell area scientifica e scientifico-tecnologica Logica 01 Scegliere fra le alternative proposte quella che completa la serie: a b c d e 02 Un auto percorre 20.000 km nel corso di un lungo viaggio.
Filosofia o. Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia
 Filosofia o Storia della Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia della Filosofia! Utilità! È un po come per l interesse: della nostra materia non ha molto senso chiedere
Filosofia o Storia della Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia della Filosofia! Utilità! È un po come per l interesse: della nostra materia non ha molto senso chiedere
Istituto Comprensivo
 CURRICOLO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) Comprendere frasi semplici, brevi registrazioni trattanti argomenti con significati molto
CURRICOLO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) Comprendere frasi semplici, brevi registrazioni trattanti argomenti con significati molto
Insiemistica. Capitolo 1. Prerequisiti. Obiettivi. Gli insiemi numerici di base Divisibilità e fattorizzazione nei numeri interi
 Capitolo 1 Insiemistica Prerequisiti Gli insiemi numerici di base Divisibilità e fattorizzazione nei numeri interi Obiettivi Sapere utilizzare opportunamente le diverse rappresentazioni insiemistiche Sapere
Capitolo 1 Insiemistica Prerequisiti Gli insiemi numerici di base Divisibilità e fattorizzazione nei numeri interi Obiettivi Sapere utilizzare opportunamente le diverse rappresentazioni insiemistiche Sapere
COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA INGLESE
 COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA INGLESE I traguardi sono riconducibili al Livello A1 (scuola primaria) e al Livello A2 (scuola secondaria di I grado) del Quadro Comune
COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA INGLESE I traguardi sono riconducibili al Livello A1 (scuola primaria) e al Livello A2 (scuola secondaria di I grado) del Quadro Comune
Scuola Primaria. Scuola Secondaria di Primo Grado. L I N G U A T E D E S C A Scuola dell Infanzia. Primo anno Secondo anno Terzo anno
 Primo anno Secondo anno Terzo anno Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno L I N G U A T E D E S C A Scuola dell Infanzia Scuola Primaria a. Obiettivi formativi della disciplina Scuola
Primo anno Secondo anno Terzo anno Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno L I N G U A T E D E S C A Scuola dell Infanzia Scuola Primaria a. Obiettivi formativi della disciplina Scuola
LINGUA INGLESE CLASSE I OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 LINGUA INGLESE CLASSE I SKILLS TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA COMPETENZA CHIAVE E DI CITTADINANZA LISTENING L alunno comprende brevi
LINGUA INGLESE CLASSE I SKILLS TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA COMPETENZA CHIAVE E DI CITTADINANZA LISTENING L alunno comprende brevi
Programmazione annuale a. s
 Programmazione annuale a. s. 2016-2017 MATERIA: CLASSE: ITALIANO SECONDA LIBRO/I DI TESTO: AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI L ITALIANO DA SAPERE IN TEORIA E IN PRATICA
Programmazione annuale a. s. 2016-2017 MATERIA: CLASSE: ITALIANO SECONDA LIBRO/I DI TESTO: AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI L ITALIANO DA SAPERE IN TEORIA E IN PRATICA
LA PIANIFICAZIONE. Le tipologie di testo che si prestano maggiormente ad essere oggetto di pianificazione sono:
 LA PIANIFICAZIONE La pianificazione di un testo è un'attività che spesso viene recepita dagli alunni come non utile, faticosa e difficile. Quello che viene affrontato nella Scuola Primaria è un avvio ad
LA PIANIFICAZIONE La pianificazione di un testo è un'attività che spesso viene recepita dagli alunni come non utile, faticosa e difficile. Quello che viene affrontato nella Scuola Primaria è un avvio ad
SCUOLA PRIMARIA RONZO-CHIENIS
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORI Via Giovanni XXIII, n. 64-38065 MORI Cod. Fisc. 94024510227 - Tel. 0464-918669 Fax 0464-911029 www.icmori.it e-mail: segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORI Via Giovanni XXIII, n. 64-38065 MORI Cod. Fisc. 94024510227 - Tel. 0464-918669 Fax 0464-911029 www.icmori.it e-mail: segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it REPUBBLICA ITALIANA
LINGUA COMUNITARIA INGLESE SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA
 LINGUA COMUNITARIA INGLESE SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA Livello A2 Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d Europa TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE RELATIVI AD ASCOLTO
LINGUA COMUNITARIA INGLESE SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA Livello A2 Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d Europa TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE RELATIVI AD ASCOLTO
Heidegger e Hölderlin Filosofia e letteratura
 Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Heidegger e Hölderlin Filosofia e letteratura Comprensione del testo 1. Da quale poesia sono tratti i versi che aprono l animazione?
Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Heidegger e Hölderlin Filosofia e letteratura Comprensione del testo 1. Da quale poesia sono tratti i versi che aprono l animazione?
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 INGLESE CLASSE1^ INGLESE CLASSE1^ SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE Ascolto orale) Parlato (produzione e interazione orale) Lettura
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 INGLESE CLASSE1^ INGLESE CLASSE1^ SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE Ascolto orale) Parlato (produzione e interazione orale) Lettura
Cerchiamo di capire che cosa questo significa
 http://filosofia.dipafilo.unimi.it/~paganini/index.html A tutti appare chiaro che Quando leggiamo una frase ambigua facciamo molto fatica a cogliere l ambiguità, noi leggiamo la frase in base a una certa
http://filosofia.dipafilo.unimi.it/~paganini/index.html A tutti appare chiaro che Quando leggiamo una frase ambigua facciamo molto fatica a cogliere l ambiguità, noi leggiamo la frase in base a una certa
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
 PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 3^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE I Q. II Q. CONTENUTI /ATTIVITA 1a) Ascolto e comprensione di ciò che l insegnante e i compagni comunicano
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 3^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE I Q. II Q. CONTENUTI /ATTIVITA 1a) Ascolto e comprensione di ciò che l insegnante e i compagni comunicano
Educazione Linguistica (lingua come codice) ortografia e punteggiatura morfologia sintassi della frase semplice e complessa
 Liceo B. Russell VIA IV NOVEMBRE 35, 38023 CLES Tutti gli indirizzi Anno scolastico Disciplina: Lingua e letteratura italiana CLASSE 1 1. comunicare e interagire verbalmente in contesti di varia natura
Liceo B. Russell VIA IV NOVEMBRE 35, 38023 CLES Tutti gli indirizzi Anno scolastico Disciplina: Lingua e letteratura italiana CLASSE 1 1. comunicare e interagire verbalmente in contesti di varia natura
da valutare e certificare Seminario CIDI Milano 20 gennaio 2011 a cura di Daniela Bertocchi
 da valutare e certificare a cura di Daniela Bertocchi 1 Definizione europea (QEQ) di competenza La comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni
da valutare e certificare a cura di Daniela Bertocchi 1 Definizione europea (QEQ) di competenza La comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni
CLASSE PRIMA LINGUA INGLESE COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006) LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
 COMPETENZE SPECIFICHE DELLA CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE * (Indicazioni per il curricolo 2012) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Comprendere il significato di semplici istruzioni e
COMPETENZE SPECIFICHE DELLA CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE * (Indicazioni per il curricolo 2012) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Comprendere il significato di semplici istruzioni e
COMPETENZA. Presta attenzione al contesto ed al contenuto cogliendo le informazioni esplicite della comunicazione
 L alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, discussione ) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti formulati in un registro chiaro il più possibile adeguato
L alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, discussione ) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti formulati in un registro chiaro il più possibile adeguato
COMPETENZE DI ITALIANO
 ASCOLTARE PARLARE CLASSE I COMPETENZE DI ITALIANO Sa ascoltare testi presentati e comunicazioni orali, ne riconosce le caratteristiche rielaborandoli in modo autonomo e personale, li sa riferire con proprietà
ASCOLTARE PARLARE CLASSE I COMPETENZE DI ITALIANO Sa ascoltare testi presentati e comunicazioni orali, ne riconosce le caratteristiche rielaborandoli in modo autonomo e personale, li sa riferire con proprietà
APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA. 4 settembre 2014 Alessandra Scabia
 APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA 4 settembre 2014 Alessandra Scabia L apprendimento della letto-scrittura presuppone l acquisizione di: competenze fonologiche: produzione di tutti i suoni, ripetizioni
APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA 4 settembre 2014 Alessandra Scabia L apprendimento della letto-scrittura presuppone l acquisizione di: competenze fonologiche: produzione di tutti i suoni, ripetizioni
Istituto Comprensivo Campagnola-Galilei. Area Didattica
 Sezione Competenze Contenuti/attività Scuola dell Infanzia Sezione 3 anni 1. Essere in grado di esprimersi in modo comprensibile. 2. Essere in grado di ascoltare. Narrazioni orali Letture Comprensioni
Sezione Competenze Contenuti/attività Scuola dell Infanzia Sezione 3 anni 1. Essere in grado di esprimersi in modo comprensibile. 2. Essere in grado di ascoltare. Narrazioni orali Letture Comprensioni
III Circolo di Rho. Programmazione annuale. Lingua Italiana. Classe III
 III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe III ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende le informazioni principali di un messaggio Interviene nel dialogo e nella conversazione in modo
III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe III ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende le informazioni principali di un messaggio Interviene nel dialogo e nella conversazione in modo
UDA n.1 STUDIARE LA GRAMMATICA C1_01: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l interazione
 CPIA PALERMO 2 PROGETTAZIONE PER UNITA DI APPRENDIMENTO PERCORSO DI ISTRUZIONE DI I LIVELLO - SECONDO PERIODO DIDATTICO a.s. 2016/2017 ASSE DEI LINGUAGGI (ITALIANO) UDA n.1 STUDIARE LA GRAMMATICA C1_01:
CPIA PALERMO 2 PROGETTAZIONE PER UNITA DI APPRENDIMENTO PERCORSO DI ISTRUZIONE DI I LIVELLO - SECONDO PERIODO DIDATTICO a.s. 2016/2017 ASSE DEI LINGUAGGI (ITALIANO) UDA n.1 STUDIARE LA GRAMMATICA C1_01:
SCRIVERE Costruire l interesse per la scrittura autonoma. Scrivere autonomamente un breve testo su un esperienza motivante.
 CURRICOLO DI LINGUA CLASSI 1 Ascoltare e parlare Avvio alla costruzione del Sé e alla percezione delle emozioni Ascoltare e comprendere una semplice consegna organizzativa e didattica Narrare un esperienza
CURRICOLO DI LINGUA CLASSI 1 Ascoltare e parlare Avvio alla costruzione del Sé e alla percezione delle emozioni Ascoltare e comprendere una semplice consegna organizzativa e didattica Narrare un esperienza
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA LINGUE COMUNITARIE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA LINGUE COMUNITARIE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAGNACCO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS PROGETTO SET. Scheda di lavoro. Problemi procedurali NONSOLOPESO
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAGNACCO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS PROGETTO SET Scheda di lavoro Problemi procedurali NONSOLOPESO 1. Obiettivi formativi Sviluppo della capacità di analisi e deduzione Ragionare
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAGNACCO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS PROGETTO SET Scheda di lavoro Problemi procedurali NONSOLOPESO 1. Obiettivi formativi Sviluppo della capacità di analisi e deduzione Ragionare
COMUNICAZIONE COMPRENSIBILE
 COMUNICAZIONE COMPRENSIBILE DALLA PARTE DEL LETTORE! Il plain language nasce negli anni 70 nei paesi anglofoni per la semplificazione del linguaggio della burocrazia Negli anni 80 in Italia nasce Due parole
COMUNICAZIONE COMPRENSIBILE DALLA PARTE DEL LETTORE! Il plain language nasce negli anni 70 nei paesi anglofoni per la semplificazione del linguaggio della burocrazia Negli anni 80 in Italia nasce Due parole
Istituto Comprensivo Francesco D'Assisi TEZZE SUL BRENTA Scuola Primaria CLASSE 2 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE ITALIANO
 Istituto Comprensivo Francesco D'Assisi TEZZE SUL BRENTA Scuola Primaria CLASSE 2 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE ITALIANO OBIETTIVI ASCOLTO E PARLATO Prestare attenzione in varie situazioni comunicative
Istituto Comprensivo Francesco D'Assisi TEZZE SUL BRENTA Scuola Primaria CLASSE 2 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE ITALIANO OBIETTIVI ASCOLTO E PARLATO Prestare attenzione in varie situazioni comunicative
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. Micro- obiettivi
 SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA LINGUA CLASSE SECONDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
Il numero. Gli arabi usano simboli diversi dai nostri: Anche i cinesi usano altri simboli: I romani usavano simboli ancora diversi:
 il testo: 01 Il sistema di numerazione decimale Per scrivere i numeri in Italia usiamo un modo (sistema) diverso da altri paesi. Si chiama sistema di numerazione decimale perché usa 10 segni (simboli)
il testo: 01 Il sistema di numerazione decimale Per scrivere i numeri in Italia usiamo un modo (sistema) diverso da altri paesi. Si chiama sistema di numerazione decimale perché usa 10 segni (simboli)
I.C. AMEDEO DI SAVOIA AOSTA Martina Franca (Ta) Disciplina: Lingua Francese a.s
 I.C. AMEDEO DI SAVOIA AOSTA Martina Franca (Ta) LINEE DI PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA CLASSE Disciplina: Lingua Francese a.s. 2012 2013 Docenti : Margiotta Raffaella Montinaro Barbara Nucci Maria Grazia
I.C. AMEDEO DI SAVOIA AOSTA Martina Franca (Ta) LINEE DI PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA CLASSE Disciplina: Lingua Francese a.s. 2012 2013 Docenti : Margiotta Raffaella Montinaro Barbara Nucci Maria Grazia
LE ESPRESSIONI. Espressioni
 VI LE ESPRESSIONI Le difficoltà di alcuni bambini nel leggere derivano dalla scarsa confidenza col fare ipotesi su quanto è implicito in ciò che leggono. Insegnare ai bambini a contare sulla propria conoscenza
VI LE ESPRESSIONI Le difficoltà di alcuni bambini nel leggere derivano dalla scarsa confidenza col fare ipotesi su quanto è implicito in ciò che leggono. Insegnare ai bambini a contare sulla propria conoscenza
PERCORSO 2 Poligoni e triangoli
 PERCORSO 2 Poligoni e triangoli di Elena Ballarin Riferimento al testo base: A. Acquati, Mate.com, volume 1B, capitolo 4, pp. 132-177 Destinatari: scuola secondaria di primo grado, classe 1 a In classe
PERCORSO 2 Poligoni e triangoli di Elena Ballarin Riferimento al testo base: A. Acquati, Mate.com, volume 1B, capitolo 4, pp. 132-177 Destinatari: scuola secondaria di primo grado, classe 1 a In classe
U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre
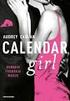 U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre ABILITÀ a. Ascoltare attivamente e comprendere vari tipi di testo. b. Intervenire appropriatamente ed esprimere attraverso il parlato pensieri e stati d animo.
U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre ABILITÀ a. Ascoltare attivamente e comprendere vari tipi di testo. b. Intervenire appropriatamente ed esprimere attraverso il parlato pensieri e stati d animo.
PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE
 LICEO STATALE SANDRO PERTINI Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane (con Opzione Economico- Sociale) Liceo Musicale e Coreutico Sez. Musicale Via C. Battisti, 5-16145 Genova - Corso Magenta, 2 A
LICEO STATALE SANDRO PERTINI Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane (con Opzione Economico- Sociale) Liceo Musicale e Coreutico Sez. Musicale Via C. Battisti, 5-16145 Genova - Corso Magenta, 2 A
LINGUA INGLESE CURRICULUM SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA. PARLATO Produzione e interazione orale. ASCOLTO Comprensione orale
 CURRICULUM SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA LINGUA INGLESE CLASSI PRIMARIA ASCOLTO Comprensione orale O B I E T T I V I D I PARLATO Produzione e interazione orale A P P R E N D I M E N T O LETTURA Comprensione
CURRICULUM SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA LINGUA INGLESE CLASSI PRIMARIA ASCOLTO Comprensione orale O B I E T T I V I D I PARLATO Produzione e interazione orale A P P R E N D I M E N T O LETTURA Comprensione
La matematica come forma di comunicazione PRIN
 La matematica come forma di comunicazione PRIN 2009-2011 Introduzione Quanto è chiara l idea di comunicazione matematica? Possiamo distinguere il discorso matematico da tutti gli altri concentrandoci soltanto
La matematica come forma di comunicazione PRIN 2009-2011 Introduzione Quanto è chiara l idea di comunicazione matematica? Possiamo distinguere il discorso matematico da tutti gli altri concentrandoci soltanto
CHE VUOL DIRE DECIDERE
 info@didatticaperprogetti.it PROGETTO 4. 4. 4 AREA 3 Antropologica (Psicologia) TITOLO Che vuol dire decidere? (Un ragionamento scritto) SCUOLA Elementare: classi 4-5 Media: classi 1-2 - 3 OBIETTIVO Esercitare
info@didatticaperprogetti.it PROGETTO 4. 4. 4 AREA 3 Antropologica (Psicologia) TITOLO Che vuol dire decidere? (Un ragionamento scritto) SCUOLA Elementare: classi 4-5 Media: classi 1-2 - 3 OBIETTIVO Esercitare
Leggere per studiare
 Leggere per studiare A cura di Silvana Loiero Che cosa vuol dire leggere per studiare? Quando si legge un testo per studiare si devono fare diverse operazioni per capire il testo letto: rielaborare le
Leggere per studiare A cura di Silvana Loiero Che cosa vuol dire leggere per studiare? Quando si legge un testo per studiare si devono fare diverse operazioni per capire il testo letto: rielaborare le
ICS Erasmo da Rotterdam Via Giovanni XXIII n CISLIANO Tel./Fax
 ICS Erasmo da Rotterdam Via Giovanni XXIII n.8 20080 CISLIANO www.albaciscuole.gov.it Tel./Fax02.9018574 info@albaciscuole.gov.it MAIL miic86900d@istruzione.it PEC: miic86900d@pec.istruzione.it C.F. 90015600159
ICS Erasmo da Rotterdam Via Giovanni XXIII n.8 20080 CISLIANO www.albaciscuole.gov.it Tel./Fax02.9018574 info@albaciscuole.gov.it MAIL miic86900d@istruzione.it PEC: miic86900d@pec.istruzione.it C.F. 90015600159
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA STRANIERA SCUOLA PRIMARIA
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA STRANIERA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI FORMATIVI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA STRANIERA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI FORMATIVI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo
PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME ITALIANO STORIA GEOGRAFIA
 PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME ITALIANO STORIA GEOGRAFIA Anno Scolastico 2013-2014 ITALIANO Obiettivi minimi ASCOLTARE E PARLARE Prestare attenzione ad un messaggio per un breve periodo di tempo Cogliere
PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME ITALIANO STORIA GEOGRAFIA Anno Scolastico 2013-2014 ITALIANO Obiettivi minimi ASCOLTARE E PARLARE Prestare attenzione ad un messaggio per un breve periodo di tempo Cogliere
1. equivalenze e implicazioni logiche. Esercizio 1.2. Trovare le implicazioni che legano i seguenti enunciati (x, y R):
 . equivalenze e implicazioni logiche Esercizio.. Trovare le implicazioni che legano i seguenti enunciati (x, y R): () x < y, () x = y, () x y, () x y, () (x y) > 0. Osserviamo subito che (x y) > 0 equivale
. equivalenze e implicazioni logiche Esercizio.. Trovare le implicazioni che legano i seguenti enunciati (x, y R): () x < y, () x = y, () x y, () x y, () (x y) > 0. Osserviamo subito che (x y) > 0 equivale
I numeri irrazionali: simboli e calcoli. Daniela Valenti, Treccani scuola
 I numeri irrazionali: simboli e calcoli 1 Un video per esplorare il tema Che cosa vuol dire numero irrazionale? Guardiamo un breve video per trovare le prime risposte I numeri irrazionali 2 Che cosa ha
I numeri irrazionali: simboli e calcoli 1 Un video per esplorare il tema Che cosa vuol dire numero irrazionale? Guardiamo un breve video per trovare le prime risposte I numeri irrazionali 2 Che cosa ha
OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO
 OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO TERZA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE VERIFICHE ASCOLTARE Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni, regole. Seguire una conversazione e comprendere ciò di
OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO TERZA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE VERIFICHE ASCOLTARE Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni, regole. Seguire una conversazione e comprendere ciò di
FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe 1 a
 FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe 1 a Competenze Conoscenze Abilità Tecniche di lettura espressiva: intonazione, pause, punteggiatura. Applicare diverse strategie di lettura: lettura espressiva
FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe 1 a Competenze Conoscenze Abilità Tecniche di lettura espressiva: intonazione, pause, punteggiatura. Applicare diverse strategie di lettura: lettura espressiva
Liceo delle Scienze Umane Valfredo Carducci Forlimpopoli. Anno scolastico 2010/2011 PROGRAMMAZIONE ANNUALE
 Classi prime Liceo delle Scienze Umane Valfredo Carducci Forlimpopoli IL TESTO EPICO o Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario Origini
Classi prime Liceo delle Scienze Umane Valfredo Carducci Forlimpopoli IL TESTO EPICO o Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario Origini
Unità didattica di. Educazione all Immagine
 Unità didattica di Educazione all Immagine L unità didattica ha come finalità l acquisizione da parte degli alunni di competenze di lettura e comprensione delle opere d arte, allo scopo di capire l evoluzione
Unità didattica di Educazione all Immagine L unità didattica ha come finalità l acquisizione da parte degli alunni di competenze di lettura e comprensione delle opere d arte, allo scopo di capire l evoluzione
La rappresentazione delle informazioni
 La rappresentazione delle informazioni In queste pagine cercheremo di capire come sia possibile rappresentare mediante numeri e memorizzare in un file testi, immagini, video, suoni... Il computer per lavorare
La rappresentazione delle informazioni In queste pagine cercheremo di capire come sia possibile rappresentare mediante numeri e memorizzare in un file testi, immagini, video, suoni... Il computer per lavorare
LINGUA ITALIANA L.E.1 ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE. L.E.2 LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO.
 LINGUA ITALIANA L.E.1 ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE. 1a. Prestare attenzione e dimostrare di aver capito i discorsi dei coetanei e degli adulti. 1b. Saper ascoltare ciò che viene letto
LINGUA ITALIANA L.E.1 ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE. 1a. Prestare attenzione e dimostrare di aver capito i discorsi dei coetanei e degli adulti. 1b. Saper ascoltare ciò che viene letto
ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO. MODELLO PROGETTUALE secondo le Indicazioni Nazionali 2012
 ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO MODELLO PROGETTUALE secondo le Indicazioni Nazionali 2012 Scuola Primaria Paritaria Santa Luisa de Marillac Anno scolastico 2015 2016 PREMESSA L organizzazione del curricolo
ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO MODELLO PROGETTUALE secondo le Indicazioni Nazionali 2012 Scuola Primaria Paritaria Santa Luisa de Marillac Anno scolastico 2015 2016 PREMESSA L organizzazione del curricolo
Una delle più classiche è quella della donna giovane e bella, in. abbigliamento belle epoque che convive con una donna anziana, dal naso e dai
 Matteo 6, 24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Ci sono delle immagini che
Matteo 6, 24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Ci sono delle immagini che
Si può fare un riassunto in matematica?
 Si può fare un riassunto in matematica? Livello scolare: 1 biennio Abilità Esprimersi nel linguaggio naturale con coerenza e proprietà. Usare, in varie situazioni, linguaggi simbolici. Analizzare semplici
Si può fare un riassunto in matematica? Livello scolare: 1 biennio Abilità Esprimersi nel linguaggio naturale con coerenza e proprietà. Usare, in varie situazioni, linguaggi simbolici. Analizzare semplici
COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
 COMPETENZA ITALIANO COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Definizione: è la capacità di esprimere e interpretare pensieri,sentimenti e fatti in forma sia in forma orale che scritta (comprensione
COMPETENZA ITALIANO COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Definizione: è la capacità di esprimere e interpretare pensieri,sentimenti e fatti in forma sia in forma orale che scritta (comprensione
LICEO GINNASIO STATALE G. B. BROCCHI Bassano del Grappa -VI. Progettazione didattico educativa di dipartimento CLASSE INDIRIZZO
 Pagina 1 di 5 DIPARTIMENTO CLASSE INDIRIZZO FRANCESE PRIMO BIENNIO LINGUISTICO SCIENZE UMANE (OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE) OBIETTIVI IN TERMINI DI: COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE E ATTIVITÀ COMPETENZA ABILITÀ
Pagina 1 di 5 DIPARTIMENTO CLASSE INDIRIZZO FRANCESE PRIMO BIENNIO LINGUISTICO SCIENZE UMANE (OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE) OBIETTIVI IN TERMINI DI: COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE E ATTIVITÀ COMPETENZA ABILITÀ
Schopenhauer Tra razionale e irrazionale
 Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?
Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?
LIVELLI DI COMPETENZA ITALIANO CL. 1 Livello non sufficiente 5
 LIVELLI DI COMPETENZA ITALIANO CL. 1 Non scrive parole/frasi autonomamente. Se guidato scrive in modo non Scrive parole/frasi autonomamente ma in modo non Scrive parole/frasi con qualche imperfezione.
LIVELLI DI COMPETENZA ITALIANO CL. 1 Non scrive parole/frasi autonomamente. Se guidato scrive in modo non Scrive parole/frasi autonomamente ma in modo non Scrive parole/frasi con qualche imperfezione.
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
 RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO Classi prima e seconda. DIMENSIONI DI COMPETENZA (quali aspetti considero?) CRITERI (Cosa valuto?) OBIETTIVI DI LIVELLO / BASE
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO Classi prima e seconda. DIMENSIONI DI COMPETENZA (quali aspetti considero?) CRITERI (Cosa valuto?) OBIETTIVI DI LIVELLO / BASE
Via Resistenza Partigiana, Modica (Rg) SCUOLA PRIMARIA A.S
 Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani Via Resistenza Partigiana, 165 - Modica (Rg) SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-17 ITALIANO Interagisce in modo pertinente e correttamente nello scambio comunicativo con
Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani Via Resistenza Partigiana, 165 - Modica (Rg) SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-17 ITALIANO Interagisce in modo pertinente e correttamente nello scambio comunicativo con
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria Università di Genova MATEMATICA Il
 LEZIONE 11: 03/04/2003 NUMERI DECIMALI E MISURE Verbale a cura di Gandini Tatiana e Turco Valeria Partendo dal compito assegnatoci la lezione precedente, l argomento affrontato oggi è «l analisi delle
LEZIONE 11: 03/04/2003 NUMERI DECIMALI E MISURE Verbale a cura di Gandini Tatiana e Turco Valeria Partendo dal compito assegnatoci la lezione precedente, l argomento affrontato oggi è «l analisi delle
ALLEGATO B OBIETTIVI MINIMI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Comunica in modo comprensibile e funzionale allo scopo;
 ALLEGATO B OBIETTIVI MINIMI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ITALIANO Comprensione della lingua orale: Ascolta con attenzione almeno per un tempo di cinque minuti; Comprende globalmente un testo
ALLEGATO B OBIETTIVI MINIMI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ITALIANO Comprensione della lingua orale: Ascolta con attenzione almeno per un tempo di cinque minuti; Comprende globalmente un testo
CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE. - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni
 CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE ITALIANO - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni - Potenziare l ascolto reciproco, il rispetto e
CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE ITALIANO - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni - Potenziare l ascolto reciproco, il rispetto e
Questionario della storia linguistica. (Versione 2.0, 2013) Veda per uso online e crediti
 Questionario della storia linguistica (Versione 2.0, 2013) Veda http://blclab.org per uso online e crediti Per favore, compili i seguenti dati Nome: E-mail: Telefono: Per favore, risponda alle seguenti
Questionario della storia linguistica (Versione 2.0, 2013) Veda http://blclab.org per uso online e crediti Per favore, compili i seguenti dati Nome: E-mail: Telefono: Per favore, risponda alle seguenti
PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA. Classe quarta
 PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA Classe quarta ASCOLTARE E PARLARE 1. Strategie essenziali dell'ascolto. 2. Processi di controllo da mettere in atto durante l'ascolto. 3. Interazioni fra testo e contesto.
PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA Classe quarta ASCOLTARE E PARLARE 1. Strategie essenziali dell'ascolto. 2. Processi di controllo da mettere in atto durante l'ascolto. 3. Interazioni fra testo e contesto.
SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA
 SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRMA SCUOLA PRIMARIA AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA COMPETENZE ABILITA SPECIFICHE CONOSCENZE (nuclei tematici) Competenza
SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRMA SCUOLA PRIMARIA AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA COMPETENZE ABILITA SPECIFICHE CONOSCENZE (nuclei tematici) Competenza
I D.S.A. e la DISCALCULIA: L ALLEANZA EDUCATIVA CASA-SCUOLA
 Aderente all Associazione Europea Dislessia I D.S.A. e la DISCALCULIA: L ALLEANZA EDUCATIVA CASA-SCUOLA www.aiditalia.org Relatore: CHIARA BARAUSSE Formatore A.I.D. Insegnante Pedagogista clinico A cura
Aderente all Associazione Europea Dislessia I D.S.A. e la DISCALCULIA: L ALLEANZA EDUCATIVA CASA-SCUOLA www.aiditalia.org Relatore: CHIARA BARAUSSE Formatore A.I.D. Insegnante Pedagogista clinico A cura
NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE
 CURRICOLO DI LINGUA ITALIANA - CLASSE QUINTA NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE ASCOLTO E PARLATO Strategie essenziali dell ascolto finalizzato e dell ascolto attivo e relativi processi di
CURRICOLO DI LINGUA ITALIANA - CLASSE QUINTA NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE ASCOLTO E PARLATO Strategie essenziali dell ascolto finalizzato e dell ascolto attivo e relativi processi di
TRAGUARDI PER LO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE TRASVERSALI ASCOLTO E PARLATO ESSERE AUTONOMI E RESPONSABILI COMUNICARE
 CURRICOLO D ISTITUTO a. s. 2012 / 2013 CLASSE I SCUOLA SECONDARIA I GRADO COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA FONTI DI SVILUPPO DELLE OBIETTIVI DI ASCOLTO E PARLATO 1. L allievo interagisce in diverse situazioni
CURRICOLO D ISTITUTO a. s. 2012 / 2013 CLASSE I SCUOLA SECONDARIA I GRADO COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA FONTI DI SVILUPPO DELLE OBIETTIVI DI ASCOLTO E PARLATO 1. L allievo interagisce in diverse situazioni
COMPETENZE DI BASE IN LINGUA FRANCESE
 DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: DISCIPLINE CONCORRENTI: COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Fonti di legittimazione: TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO L alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: DISCIPLINE CONCORRENTI: COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Fonti di legittimazione: TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO L alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO
 Istituto Comprensivo Luciano Manara Scuola Primaria Luciano Manara - Carlo Poma - San Giusto ***** PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO CLASSI SECONDE A.S. 2016/17 I BIMESTRE NUCLEI TEMATICI ASCOLTO E PARLATO
Istituto Comprensivo Luciano Manara Scuola Primaria Luciano Manara - Carlo Poma - San Giusto ***** PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO CLASSI SECONDE A.S. 2016/17 I BIMESTRE NUCLEI TEMATICI ASCOLTO E PARLATO
AMBITO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO
 AMBITO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO Area disciplinare: LINGUA ITALIANA LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO 1, 2 e 3 anno della Scuola Primaria l'alunno è in grado di leggere in modo scorrevole;
AMBITO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO Area disciplinare: LINGUA ITALIANA LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO 1, 2 e 3 anno della Scuola Primaria l'alunno è in grado di leggere in modo scorrevole;
Istituto Comprensivo Perugia 9 Anno scolastico 2014/2015 Programmazione delle attività educativo didattiche ITALIANO
 Istituto Comprensivo Perugia 9 Anno scolastico 2014/2015 Programmazione delle attività educativo didattiche ITALIANO CLASSE: Prima DISCIPLINA: Italiano AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/ABILITÀ CONOSCENZE
Istituto Comprensivo Perugia 9 Anno scolastico 2014/2015 Programmazione delle attività educativo didattiche ITALIANO CLASSE: Prima DISCIPLINA: Italiano AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/ABILITÀ CONOSCENZE
Unità A1. Informazioni e dati. Obiettivi. Informazione automatica. Informatica. Informazione e conoscenza. Il concetto di informazione
 Obiettivi Unità A1 Informazioni e dati Conoscere i principali concetti legati all informatica Saper distinguere tra informazioni e dati Conoscere il concetto di rappresentazione analogica e digitale Conoscere
Obiettivi Unità A1 Informazioni e dati Conoscere i principali concetti legati all informatica Saper distinguere tra informazioni e dati Conoscere il concetto di rappresentazione analogica e digitale Conoscere
CURRICOLO INGLESE - CLASSE QUINTA -
 CURRICOLO INGLESE - CLASSE QUINTA - COMPETENZA Acquisire ed interpretare l informazione Collaborare e partecipare ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) - Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di
CURRICOLO INGLESE - CLASSE QUINTA - COMPETENZA Acquisire ed interpretare l informazione Collaborare e partecipare ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) - Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE ASCOLTO A.1 - Comprendere ed eseguire istruzioni relative a modalità di comprensione orale
 INGLESE CLASSI 1^ INGLESE CLASSI 1^ SCUOLA PRIMARIA INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE ASCOLTO A.1 - Comprendere ed eseguire istruzioni relative a modalità di comprensione orale lavoro a
INGLESE CLASSI 1^ INGLESE CLASSI 1^ SCUOLA PRIMARIA INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE ASCOLTO A.1 - Comprendere ed eseguire istruzioni relative a modalità di comprensione orale lavoro a
Traguardi per lo sviluppo delle competenze. Obiettivi operativi. essenziali
 Traguardi per lo sviluppo delle competenze Nuclei tematici Obiettivi d apprendimento essenziali Obiettivi operativi Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative,
Traguardi per lo sviluppo delle competenze Nuclei tematici Obiettivi d apprendimento essenziali Obiettivi operativi Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative,
Che cos è un insieme? Come si individua un insieme? 1. Scrivendone esplicitamente gli elementi: C = {2, 4, 6, 8, 10,...}.
 Teoria degli insiemi Che cos è un insieme? Come si individua un insieme? 1. Scrivendone esplicitamente gli elementi: A = {a, b, c} B = {1, 2} C = {2, 4, 6, 8, 10,...}. 2. Enunciando una proprietà che è
Teoria degli insiemi Che cos è un insieme? Come si individua un insieme? 1. Scrivendone esplicitamente gli elementi: A = {a, b, c} B = {1, 2} C = {2, 4, 6, 8, 10,...}. 2. Enunciando una proprietà che è
Montessori e Psicomatematica
 Cinisello Balsamo, 29 novembre 2014 Montessori e Psicomatematica Benedetto Scoppola, Opera Nazionale Montessori e Universita di Roma Tor Vergata Sommario - Grazie - Montessori e la matematica: l origine
Cinisello Balsamo, 29 novembre 2014 Montessori e Psicomatematica Benedetto Scoppola, Opera Nazionale Montessori e Universita di Roma Tor Vergata Sommario - Grazie - Montessori e la matematica: l origine
presentarlo Paolo Ferrario
 1/72 Paolo Ferrario LA SCRITTURA DI TESTI PROFESSIONALI (testi, articoli, saggi) con particolare riferimento alle POLITICHE DEI SERVIZI. Tracce di lavoro in forma di schede Obiettivi costruire un testo
1/72 Paolo Ferrario LA SCRITTURA DI TESTI PROFESSIONALI (testi, articoli, saggi) con particolare riferimento alle POLITICHE DEI SERVIZI. Tracce di lavoro in forma di schede Obiettivi costruire un testo
LINGUA COMUNITARIA INGLESE SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
 LINGUA COMUNITARIA INGLESE SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA Livello A2 Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d Europa D ASCOLTO ( COMPRENSIONE ORALE ) L alunno comprende oralmente
LINGUA COMUNITARIA INGLESE SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA Livello A2 Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d Europa D ASCOLTO ( COMPRENSIONE ORALE ) L alunno comprende oralmente
INDICATORI PER IL REGISTRO CLASSI PRIME 2015 2016
 INDICATORI PER IL REGISTRO CLASSI PRIME 2015 2016 Nell ordine: Italiano, Matematica, Scienze, Tecnologia, Storia, Geografia, Inglese, Arte ed Immagine, Musica e Motoria. ITALIANO ASCOLTO E PARLATO 1)a
INDICATORI PER IL REGISTRO CLASSI PRIME 2015 2016 Nell ordine: Italiano, Matematica, Scienze, Tecnologia, Storia, Geografia, Inglese, Arte ed Immagine, Musica e Motoria. ITALIANO ASCOLTO E PARLATO 1)a
Musica. Programmazione d istituto
 Istituto comprensivo MARCONI ANTONELLI Torino Scuola Secondaria di 1 Grado G.Marconi Musica Programmazione d istituto CLASSI PRIME Obiettivi Decodificazione e utilizzo della notazione tradizionale ed altri
Istituto comprensivo MARCONI ANTONELLI Torino Scuola Secondaria di 1 Grado G.Marconi Musica Programmazione d istituto CLASSI PRIME Obiettivi Decodificazione e utilizzo della notazione tradizionale ed altri
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO : SCHEMA ANALISI DISCIPLINA - LINGUE COMUNITARIE- INGLESE
 DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO : SCHEMA ANALISI DISCIPLINA - LINGUE COMUNITARIE- INGLESE COMPETENZA CHIAVE (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006). LA
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO : SCHEMA ANALISI DISCIPLINA - LINGUE COMUNITARIE- INGLESE COMPETENZA CHIAVE (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006). LA
UNITÀ DIDATTICA N. 1
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIGONZA UNITÀ DIDATTICA N. 1 LEGGERE Leggere in modo chiaro, scorrevole e corretto. Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo per mantenere l attenzione, orientarsi nella
DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIGONZA UNITÀ DIDATTICA N. 1 LEGGERE Leggere in modo chiaro, scorrevole e corretto. Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo per mantenere l attenzione, orientarsi nella
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO AREE DA SVILUPPARE. Riflettere sulla lingua
 Riflettere sulla lingua 1. Consolidare ed approfondire la conoscenza degli obiettivi affrontati in prima classe. 2. Conoscere l'alfabeto e le lettere straniere. 3. Affrontare le seguenti difficoltà: -
Riflettere sulla lingua 1. Consolidare ed approfondire la conoscenza degli obiettivi affrontati in prima classe. 2. Conoscere l'alfabeto e le lettere straniere. 3. Affrontare le seguenti difficoltà: -
Istituto Comprensivo di Pralboino CURRICOLO VERTICALE
 INGLESE CLASSE 4 a PRIMARIA INDICATORE ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI -L alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. -Svolge i compiti
INGLESE CLASSE 4 a PRIMARIA INDICATORE ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI -L alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. -Svolge i compiti
Per una comprensione del testo. basata sull analisi delle idee espresse e dei connettivi
 Per una comprensione del testo basata sull analisi delle idee espresse e dei connettivi Motivo della proposta Se un testo informativo è semplice e discorsivo,per comprenderlo può essere sufficiente una
Per una comprensione del testo basata sull analisi delle idee espresse e dei connettivi Motivo della proposta Se un testo informativo è semplice e discorsivo,per comprenderlo può essere sufficiente una
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. Micro- obiettivi
 SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nuclei Macro- obiettivi al termine della classe terza Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
