STUDIO DELLA BATRACOFAUNA DEI SITI NATURA 2000 DELLA REGIONE ABRUZZO COMPRESI NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
|
|
|
- Albina Manzo
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ricerca, Pianificazione, Progettazione, Educazione e Divulgazione Ambientale STUDIO DELLA BATRACOFAUNA DEI SITI NATURA 2000 DELLA REGIONE ABRUZZO COMPRESI NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA RELAZIONE FINALE PhD Cristiano Spilinga 30 Settembre 2013
2 INDICE 1. Premessa pag Materiali e metodi pag Risultati pag Conclusioni pag Bibliografia pag. 52 ALLEGATI Documentazione fotografica Allegato I - Database delle specie rilevate e dei biotopi censiti 2
3 1. Premessa Nell ambito del progetto Predisposizione di indirizzi gestionali a integrazione della pianificazione esistente per la protezione e gestione dei siti Natura 2000 IT , IT , IT , IT , IT , IT nell ambito dei finanziamenti previsti dal P.S.R Regione Abruzzo Asse 3 Bando della Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, è previsto lo Studio della batracofauna dei Siti di Natura 2000 della Regione Abruzzo territorialmente compresi nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. L incarico prevede nello specifico l aggiornamento delle conoscenze sulla distribuzione generale nei Siti di Importanza Comunitaria della Regione Abruzzo compresi nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, mediante monitoraggio delle principali popolazioni di specie di interesse conservazionistico e/o biogeografico, con particolare riferimento a: Salamandrina terdigitata (cfr S. perspicillata), Salamandra salamandra, Lissotriton italicus, Triturus carnifex, Bombina pachypus e Speleomantes italicus. In dettaglio, come previsto dal disciplinare il lavoro è stato articolato nelle seguenti fasi: 1. individuazione, localizzazione, georeferenziazione e mappatura dei siti di presenza della batracofauna mediante censimenti negli habitat potenziali, utilizzando metodi di rilevamento standardizzati concordati con l Ente; 2. monitoraggio della batracofauna nei siti di presenza già conosciuti; 3. individuazione dei fattori di minaccia ed elaborazione di proposte per la gestione e conservazione della popolazioni; 4. definizione di misure di conservazione da inserire nei piani di gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Abruzzo compresi all interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Come stabilito dal disciplinare sono previsti almeno tre incontri, ai quali lo scrivente si impegna a partecipare anche dopo la consegna del presente documento, nell ambito dei processi partecipativi che saranno attivati per la predisposizione e l approvazione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 della Regione Abruzzo compresi all interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 3
4 2. Materiali e Metodi Al fine di impostare le ricerche di campo è stato realizzato un progetto GIS attraverso il software open source Quantum GIS versione e sono state eseguite alcune analisi di seguito sinteticamente descritte. Preliminarmente è stata eliminata la parte dell area protetta non ricadente nella Regione Abruzzo, a questa sono stati sovrapposti i Siti Natura 2000 oggetto del presente incarico e il reticolo UTM di 10 x 10 km di lato eliminando le celle comprendenti una superficie di Parco inferiore al 5% dell estensione totale della singola cella. A tali layer sono state sovrapposte le curve di livello e l intera area protetta è stata suddivisa in tre settori: quote comprese tra 300 e 1600 m s.l.m., dove concentrare la maggior parte delle ricerche; quote tra 1700 e 1900 m s.l.m., dove effettuare uscite opportunistiche solo in siti precedentemente individuati su carta o segnalati in passato; quote tra 2000 e 2900 m s.l.m., dove non effettuare ricerche. 4
5 5
6 All interno di ognuna delle 22 celle decachilometriche individuate è stata effettuata almeno una sessione di rilevamento nel periodo compreso tra aprile e settembre 2013, applicando le tecniche di seguito descritte. Contestualmente con l inizio dell attività di campo è stata condotta un approfondita ricerca bibliografica, allo scopo di ottenere informazioni su quanto già noto in relazione a distribuzione e status conservazionistico delle specie di Anfibi presenti nell area di studio. I dati bibliografici editi sono stati integrati con quelli inediti ritenuti attendibili in quanto forniti da ricercatori, studiosi e profondi conoscitori delle specie indagate. La ricerca di campo è stata condotta seguendo, in via generale, le linee guida già note sia a livello nazionale (Sindaco et alii, 2006) che internazionale (Heyer et alii, 1994), con le opportune diversificazioni dovute agli obiettivi da raggiungere ed ai limiti tecnici e temporali della ricerca. Tali metodiche hanno permesso di accertare la presenza e la distribuzione delle specie oggetto di monitoraggio nelle aree di studio, con contestuale raccolta di informazioni sugli habitat occupati o potenzialmente idonei per il ciclo vitale e sui più evidenti fattori di minaccia attuali o potenziali per le singole specie e per i relativi habitat. In particolare sono state utilizzate le seguenti tecniche di indagine: - censimenti a vista presso i siti individuati (Balletto & Giacoma, 1990; Heyer et alii, 1994); - censimenti notturni con fari durante il periodo riproduttivo; - inchiesta sul territorio, sfruttando testimoni privilegiati (personale del Parco; Agenti Provinciali; personale del Corpo Forestale dello Stato; speleologi; ecc.) e persone residenti in loco, per avere alcune indicazioni e/o notizie utili da confermare a posteriori con osservazioni dirette sulle specie ivi presenti. Per ogni uscita è stata compilata una scheda cartacea contenente le seguenti indicazioni: - rilevatore, data, orario; - dati stazione (toponimo, quota, condizioni meteo, coordinate geografiche rilevate mediante GPS); - specie osservate; - per ogni specie rilevata: stadio ontogenetico (adulto, giovane, stadi larvali, ovature), numero o stima numerica degli esemplari osservati e, quando rilevati, sesso e misure biometriche principali; - tipologia di rilevamento; - descrizione della tipologia di habitat; - breve descrizione della tipologia di habitat limitrofi al sito di rilevamento della/e specie; - fattori di minaccia attuali e/o potenziali; 6
7 - altre informazioni e note ritenute utili. Tutti i dati raccolti nell ambito del presente studio (segnalazioni delle specie e biotopi di interesse) sono stati georeferenziati direttamente sul campo mediante GPS (Geographic Positioning System). I dati bibliografici, per i quali non sono disponibili coordinate geografiche ma soltanto toponimi, sono stati inseriti manualmente mediante l utilizzo del software geografico libero Quantum GIS versione , impostato con Sistema di Riferimento UTM33 WGS84 codice EPGS Tale analisi vettoriale è stata effettuata mediante utilizzo del plugin QGIS Cattura coordinate, riportando i valori delle coordinate estratte in corrispondenza dei toponimi individuati su Carta topografica IGM scala 1: e mediante GoogleEarth ( Le segnalazioni delle specie e i biotopi censiti sono stati archiviati in due database (formato.dbf) associati ai relativi shape file e comprendenti i campi di seguito riportati. Per le specie: ID, specie latino, specie italiano, data, UTM X, UTM Y, reperto, tipologia habitat, Sito Natura 2000 interessato e note. Per i biotopi: ID (codice che identifica il sito), tipologia, data I rilevamento, data II rilevamento, UTM X, UTM Y, Sito Natura 2000 interessato, toponimo, comune, specie segnalata e idoneità del sito per gli Anfibi, come di seguito riportato. Id_Salsal * (Idoneità del sito rispetto a Salamandra salamandra) Id_Salper * (Idoneità del sito rispetto a Salamandrina perspicillata) Id_Tricar * (Idoneità del sito rispetto a Triturus carnifex) Id_Lisita * (Idoneità del sito rispetto a Lissotriton italicus) Id_Speita *(Idoneità del sito rispetto a Speleomantes italicus) Id_Bompac * (Idoneità del sito rispetto a Bombina pachypus) Id_Ranita * (Idoneità del sito rispetto a Rana italica) * Idoneità del sito espressa con valori numerici da 1 a 3: 1 idoneo, 2 idoneo con interventi, 3 non idoneo. 7
8 3. Risultati I sopralluoghi volti ad indagare la presenza di specie di Anfibi di interesse conservazionistico e biogeografico nei siti individuati sono stati effettuati secondo il seguente cronogramma: Data Rilevatori 15/04/2013 Cristiano Spilinga, Emi Petruzzi 16/04/2013 Cristiano Spilinga, Emi Petruzzi 17/04/2013 Cristiano Spilinga, Emi Petruzzi 18/04/2013 Cristiano Spilinga, Emi Petruzzi 27/05/2013 Cristiano Spilinga, Emi Petruzzi 23/06/2013 Cristiano Spilinga, Francesca Montioni, Claudio Cauzillo 24/06/2013 Cristiano Spilinga, Francesca Montioni, Claudio Cauzillo 25/06/2013 Cristiano Spilinga, Francesca Montioni, Claudio Cauzillo 10/07/2013 Cristiano Spilinga, Francesca Montioni 11/07/2013 Cristiano Spilinga, Francesca Montioni 12/07/2013 Cristiano Spilinga, Francesca Montioni 08/08/2013 Cristiano Spilinga, Francesca Montioni, Silvia Carletti 09/08/2013 Cristiano Spilinga, Francesca Montioni, Silvia Carletti 10/08/2013 Cristiano Spilinga, Francesca Montioni, Silvia Carletti 10/09/2013 Cristiano Spilinga, Emi Petruzzi 11/09/2013 Cristiano Spilinga, Emi Petruzzi 18/09/2013 Cristiano Spilinga, Francesca Montioni 19/09/2013 Cristiano Spilinga, Francesca Montioni 20/09/2013 Cristiano Spilinga, Francesca Montioni In totale sono 71 le osservazioni relative ad Anfibi riguardanti 7 specie: Salamandrina perspicillata (1), Triturus carnifex (7), Lissotriton italicus (2), Bufo bufo (29), Phelophylax bergeri - Pelophylax klepton hispanicus (20) e Rana italica (12). Di seguito vengono riportate le schede descrittive relative alle specie di Anfibi di interesse conservazionistico e biogeografico rilevate o potenzialmente presenti nell area di studio. 8
9 SALAMANDRA PEZZATA Salamandra salamandra gigliolii Eiselt & Lanza 1956, Caudata, Salamandridae Distribuzione Presente negli Appennini e, più in generale, nell Italia Peninsulare, verso nord fino alle Alpi Marittime. In Abruzzo la distribuzione è abbastanza frammentaria e nel complesso risulta localizzata; è abbondante soltanto sulla Majella e nel gruppo dei Pizzi (Ferri et alii, 2007). Biologia ed ecologia Gli adulti hanno una vita esclusivamente terrestre pur prediligendo ambienti umidi ed ombreggiati quali boschi di latifoglie decidue. La presenza è fortemente influenzata dalla piovosità. L accoppiamento avviene a terra, generalmente nel periodo primaverile, ma anche in autunno; la femmina infatti può conservare gli spermatozoi anche per un anno e mezzo. In aprile le femmine partoriscono delle piccole larve acquatiche con un aspetto molto simile a quello dell adulto dal quale si differenziano per la presenza di ciuffi branchiali e di una bassa cresta dorso-caudale. Tali caratteri verranno persi con la metamorfosi con la quale vengono, invece, acquisite le tipiche macchie gialle. I siti riproduttivi sono rappresentati da ruscelli caratterizzati da assenza di vegetazione acquatica ed acque limpide, correnti e ben ossigenate. 9
10 Conservazione La principale minaccia è rappresentata dall alterazione degli ambienti in cui vive, in particolare la perdita di boschi maturi di latifoglie in seguito ad incendi o tagli forestali, la captazione dei corsi d acqua nonché la loro artificializzazione ed inquinamento. Un altro fattore di rischio è rappresentato dall immissione di salmonidi nei corsi d acqua utilizzati per la riproduzione. Fattori di minaccia nel Parco All interno del PNGSML per la specie sono stati rilevati i seguenti fattori di minaccia: gestione forestale, apertura di nuove strade in ambito forestale, traffico veicolare, attingimenti ad uso potabile e/o irriguo, prelievo di acque superficiali per produzione di energia idroelettrica, discarica abusiva di rifiuti solidi e torrentismo. 10
11 SALAMANDRINA DAGLI OCCHIALI SETTENTRIONALE Salamandrina perspicillata (Savi, 1821), Caudata, Salamandridae Distribuzione Presente negli Appennini settentrionali e centrali, dalla Liguria al fiume Volturno; negli Appennini meridionali è presente Salamandrina terdigitata. Risulta più frequente lungo il versante Tirrenico. In Abruzzo la distribuzione risulta non uniforme e la maggior parte delle segnalazioni sembra concentrata sul settore sud-orientale (Provincia di Chieti), pur essendo presente sui principali massicci montuosi del Parco Nazionale d Abruzzo, Monti Sibruini-Ernici, Sirente-Velino, Majella, Monti della Laga e Gran Sasso (Ferri et alii, 2007). Biologia ed ecologia È una specie dai costumi spiccatamente terrestri, con una predilezione per boschi umidi ed ombreggiati caratterizzati da corsi d acqua a debole portata. L accoppiamento avviene a terra e soltanto le femmine si recano in acqua in primavera per la deposizione. Le uova vengono ancorate, una ad una, a supporti quali rocce, foglie e rametti. Dalla schiusa delle uova si originano larve che, dopo 2-5 mesi, compiono la metamorfosi completa. In caso di pericolo può inarcare il tronco e la coda mettendo in evidenza la vivace colorazione ventrale e scoraggiare così i possibili predatori. La macchia chiara a forma di V rovesciata presente sulla testa, che risalta rispetto alla colorazione bruna dorsale, gli conferisce il nome di 11
12 salamandrina dagli occhiali. Conservazione La principale minaccia è rappresentata dalle alterazioni dei siti riproduttivi e delle aree contermini operate dall uomo. Tagli forestali, captazioni, inquinamento delle falde, perdita dei siti riproduttivi ed immissione di ittiofauna rappresentano i maggiori pericoli per la specie. Fattori di minaccia nel Parco All interno del PNGSML per la specie sono stati rilevati i seguenti fattori di minaccia: mancata manutenzione dei fontanili, gestione forestale, apertura di nuove strade in ambito forestale, traffico veicolare, attingimenti ad uso potabile e/o irriguo, prelievo di acque superficiali per produzione di energia idroelettrica, discarica abusiva di rifiuti solidi e torrentismo. 12
13 TRITONE CRESTATO ITALIANO Triturus carnifex (Laurenti, 1768), Caudata, Salamandridae Distribuzione In Italia è presente nel settore continentale e peninsulare, manca nelle isole. In Abruzzo risulta maggiormente diffuso nella provincia dell Aquila, meno in quella di Chieti e risulta scarso nelle restanti provincie di Teramo e Pescara (Ferri et alii, 2007). Biologia ed ecologia La specie può trovarsi in acqua tutto l anno anche se spesso diventa terricola nel periodo non riproduttivo. Predilige acque a debole corrente o ferme come stagni, pozze, fontanili, canali di irrigazione. Nel periodo riproduttivo il maschio evidenzia rituali di corteggiamento caratteristici: marca una porzione di territorio con feromoni di origine cloacale, quindi individuata una femmina con movimenti ondulatori, mostra i caratteri sessuali secondari della coda e crea una corrente d acqua che spinge i feromoni prodotti verso la femmina. Dopo averla così attratta depone una spermatofora che la femmina raccoglierà con la cloaca, fecondando le uova che verranno deposte ( per ogni femmina) dopo un periodo di tempo variabile. Sia le larve che gli adulti si nutrono prevalentemente di Invertebrati, gli adulti possono predare anche piccoli avannotti, larve e giovani di altri Anfibi o congeneri e conspecifici di dimensioni minori. 13
14 Conservazione La specie risulta di indubbio valore conservazionistico considerando che buona parte del suo areale interessa il solo territorio italiano. I principali fattori di minaccia per la sopravvivenza di questa specie risultano: l inquinamento dei corpi idrici, la distruzione degli ambienti umidi, l introduzione indiscriminata di ittiofauna in stagni e fontanili e la ripulitura periodica di questi ultimi. Fattori di minaccia nel Parco All interno del PNGSML per la specie sono stati rilevati i seguenti fattori di minaccia: pascolo intensivo, erronea ristrutturazione dei fontanili, mancata manutenzione dei fontanili, presenza di manufatti trappola, apertura di nuove strade in ambito forestale e nelle praterie, alterazioni causate da cinghiale (eccessiva densità di popolazione), immissione di ittiofauna e di altre specie alloctone invasive, attingimenti ad uso potabile e/o irriguo, discarica abusiva di rifiuti solidi e realizzazione di aree ricreative presso i fontanili. 14
15 TRITONE ITALIANO Lissotriton italicus (Peracca, 1898), Caudata, Salamandridae Distribuzione Specie endemica dell Italia centro-meridionale, dalle Marche centrali e Lazio meridionale fino alla Calabria meridionale. In Abruzzo la presenza della specie è piuttosto frammentata; risulta comunque maggiormente frequente nel settore meridionale ed orientale, mentre nella parte più occidentale la specie sembrerebbe assente. Nel teramano la specie viene segnalata al confine con le Marche e nei comuni di Civitella del Tronto, Isola del Gran Sasso e Penna S. Andrea (Ferri et alii, 2007). Biologia ed ecologia Specie caratterizzata da ampia valenza ecologica, presente in ogni tipo di corpo idrico, naturale o artificiale, privilegiando gli ambienti di acque stagnanti o a lento scorrimento. L attività riproduttiva avviene in acqua ed è condizionata dalle condizioni climatiche. La fase di corteggiamento è compresa tra la stagione autunnale e quella primaverile, mentre la deposizione avviene a partire dalla fine di gennaio all inizio di giugno nelle popolazioni d alta quota, a volte anche in autunno nelle popolazioni di bassa quota. Le femmine depongono generalmente uova; la schiusa di queste avviene dopo circa 10 giorni in condizioni di temperatura dell acqua intorno ai 20 C. La specie si nutre di Invertebrati, ma sono note predazioni su larve e giovani della medesima specie. 15
16 Conservazione La principale minaccia è rappresentata dall alterazione dei corpi idrici, che ha condotto negli ultimi dieci anni ad un decremento delle popolazioni note pari al 30%. Fattori di minaccia nel Parco All interno del PNGSML per la specie sono stati rilevati i seguenti fattori di minaccia: pascolo intensivo, erronea ristrutturazione dei fontanili, mancata manutenzione dei fontanili, presenza di manufatti trappola, apertura di nuove strade nelle praterie, alterazioni causate da cinghiale (eccessiva densità di popolazione), immissione di ittiofauna e di altre specie alloctone invasive, attingimenti ad uso potabile e/o irriguo, discarica abusiva di rifiuti solidi e realizzazione di aree ricreative presso i fontanili. 16
17 GEOTRITONE ITALIANO Speleomante italicus (Dunn, 1923), Caudata, Plethodontidae Distribuzione Endemismo dell Appennino settentrionale e centrale, presente dalla provincia di Reggio Emilia e Lucca alla provincia di Pescara. L Abruzzo rappresenta il limite meridionale di diffusione della specie, segnalata nel settore centro settentrionale della regione (Ferri et alii, 2007). Biologia ed ecologia Specie notturna, dai costumi terrestri, reperibile in habitat piuttosto diversificati: boschi misti, macchie, boschi di latifoglie, boschi di conifere, zone rocciose, ecc. Rilevabile generalmente all interno di cavità sotterranee (grotte, fessure ecc.), mentre in superficie è rilevabile solo in determinate condizioni di umidità, generalmente di notte o di giorno con tempo coperto. La specie è attiva soprattutto nei periodi freschi, anche se un certo grado di attività sembra essere mantenuto anche nei periodi più caldi vista la capacità di rifugiarsi nel sottosuolo. Non esistono dati sulla riproduzione in natura; dati sperimentali mostrano che la fase di ovodeposizione ha luogo tra febbraio e settembre. 17
18 Conservazione La principale minaccia per la specie è rappresentata dal disturbo e alterazione delle cavità ipogee in modo particolare all interno di quelle cavità ove la specie si aggrega in gran numero almeno in certi mesi dell anno. Fattori di minaccia nel Parco All interno del PNGSML per la specie sono stati rilevati i seguenti fattori di minaccia: gestione forestale, apertura di nuove strade in ambito forestale, torrentismo e turisticizzazione delle cavità naturali e artificiali. 18
19 ULULONE APPENNINICO Bombina Pachypus (Bonaparte, 1838), Anura, Bombinatoridae Distribuzione L ululone appenninico è distribuito, in maniera discontinua, lungo tutta la catena Appenninica, dalla Liguria Centrale all Aspromonte. In Abruzzo la specie è piuttosto localizzata e la maggior parte delle segnalazioni sono concentrate nel settore sud-orientale della regione, nella provincia di Chieti (Ferri et alii, 2007). Biologia ed ecologia Bombina pachypus è una specie eliofila che, da aprile a ottobre, frequenta raccolte d acqua poco profonde e di modeste dimensioni. Pozze temporanee, anse morte o stagnanti di corsi d acqua, vasche, canali, abbeveratoi e solchi nelle carrarecce vengono utilizzati per l accoppiamento e la deposizione. Sverna nel terreno o sotto le pietre ricoperte da vegetazione, a poca distanza dalle pozze d acqua frequentate. Se disturbata secerne una sostanza fortemente irritante per le mucose ed inarca il corpo, appiattendosi e sollevando gli arti anteriori e posteriori per mettere in mostra la vivace colorazione ventrale e inibire eventuali predatori. Il nome comune della specie è legato ai richiami emessi dal maschio consistenti in ripetuti uuh, uuh uuh. 19
20 Conservazione La specie negli ultimi anni ha subito un vistoso declino delle popolazioni imputabile, come per molti altri Anfibi, alla distruzione e alterazione degli habitat. Tra questi la captazione delle acque con il conseguente essiccamento delle piccole raccolte d acqua e l errata o mancata manutenzione di piccoli manufatti quali fontanili ed abbeveratoi rappresentano la maggiore minaccia. Fattori di minaccia nel Parco All interno del PNGSML per la specie sono stati rilevati i seguenti fattori di minaccia: pascolo intensivo, erronea ristrutturazione dei fontanili, mancata manutenzione dei fontanili, presenza di manufatti trappola, gestione forestale, apertura di nuove strade in ambito forestale e nelle praterie, alterazioni causate da cinghiale (eccessiva densità di popolazione), attingimenti ad uso potabile e/o irriguo, prelievo di acque superficiali per produzione di energia idroelettrica, discarica abusiva di rifiuti solidi, torrentismo e realizzazione di aree ricreative presso i fontanili. 20
21 RANA APPENNINICA Rana italica (Dubois, 1987), Anura, Ranidae Distribuzione Specie endemica dell Italia peninsulare, ne sono stati evidenziati tre contingenti: in Italia centro-settentrionale, in Italia meridionale e in Calabria, prevalentemente lungo la dorsale appenninica. Risulta presente in Abruzzo, dove le popolazioni sono le più numerose del versante adriatico (Ferri et alii, 2007). Biologia ed ecologia La Rana appenninica è prettamente acquatica e vive nei pressi di torrenti e ruscelli che scorrono all interno di aree boschive, prevalentemente in boschi misti di latifoglie e faggete. Può essere rinvenuta anche in anfratti e grotte allagati, vicini a corsi d acqua. La sua attività è legata all altitudine e alle condizioni microclimatiche locali: nelle zone di bassa quota resta attiva tutto l anno, nelle aree montuose la sua attività si arresta durante i mesi più freddi. In estate è più facile rinvenirla al crepuscolo e di notte, mentre dall autunno alla primavera, prevalentemente di giorno. Anche il periodo riproduttivo è legato al microclima, nell Italia meridionale, a livello del mare, gli accoppiamenti e le deposizioni hanno luogo i primi di febbraio e durano tre-quattro settimane, mentre in aree montane, questi sono ritardati di circa due-tre settimane. 21
22 Ogni femmina depone in media 500 uova raggruppate in due-tre ovature, ancorate da un peduncolo vischioso a sassi e tronchi sommersi, in tratti di torrente poco profondi e con debole corrente. La specie si alimenta prevalentemente durante il giorno, la dieta si compone di Invertebrati e loro larve. Conservazione La specie soffre delle captazioni delle sorgenti senza il rilascio del deflusso minimo vitale, e delle immissioni di ittiofauna non regolamentate. Non appare comunque minacciata, in quanto risulta ampiamente distribuita nell Italia peninsulare. Fattori di minaccia nel Parco All interno del PNGSML per la specie sono stati rilevati i seguenti fattori di minaccia: gestione forestale, apertura di nuove strade in ambito forestale, traffico veicolare, attingimenti ad uso potabile e/o irriguo, prelievo di acque superficiali per produzione di energia idroelettrica, discarica abusiva di rifiuti solidi e torrentismo. 22
23 Oltre alle 71 osservazioni dirette di Anfibi, sono stati censiti un totale di 279 siti così ripartiti: - 9 cavità artificiali; - 6 cavità naturali; - 92 corsi d acqua; fontanili; - 5 tra pozzi e cisterne; - 24 tra prati allagati e pozze; - 7 raccolte d acqua artificiali; - 21 raccolte d acqua naturali; - 12 tra sorgenti e risorgive. 23
24 24
25 Dei 279 siti censiti 180 sono risultati idonei o idonei con interventi per gli Anfibi e in particolare per le specie di interesse conservazionistico e biogeografico: - 46 siti sono stati ritenuti idonei o idonei con interventi per Salamandra salamandra di cui 44 idonei e 2 idonei con interventi; - 49 siti sono stati ritenuti idonei o idonei con interventi per Salamandrina perspicillata di cui 43 idonei e 6 idonei con interventi; - 90 siti sono stati ritenuti idonei o idonei con interventi per Triturus carnifex di cui 31 idonei e 59 idonei con interventi; - 73 siti sono stati ritenuti idonei o idonei con interventi per Lissotriton italicus di cui 14 idonei e 59 idonei con interventi; - 3 siti sono stati ritenuti idonei o idonei con intervento per Speleomantes italicus di cui 2 idonei e 1 idoneo con interventi; - 69 siti sono stati ritenuti idonei o idonei con interventi per Bombina pachypus di cui 13 idonei e 56 idonei con intervento; - 54 siti sono stati ritenuti idonei o idonei con intervento per Rana italica di cui 52 idonei e 2 idonei con intervento. Il grafico che segue mostra a confronto il grado di idoneità dei siti ispezionati per le specie di Anfibi di interesse conservazionistico e biogeografico. 25
26 Nessuna cavità artificiale tra quelle ispezionate è risultata idonea al geotritone italiano (Speleomantes italicus), mentre tre cavità naturali sono risultate idonee o idonee con intervento. Dei 92 biotopi riferiti a corsi d acqua, 54 sono risultati idonei e 3 idonei con intervento, i restanti non idonei. 26
27 Dei 103 fontanili rilevati, 5 sono risultati idonei e 61 idonei con intervento, i restanti non idonei. Dei 5 tra pozzi e cisterne nessuno è risultato idoneo, anzi potenziali trappole per la fauna. Dei 24 tra prati allagati e pozze, 9 sono risultati idonei e 14 idonei con interventi, i restanti non idonei. 27
28 Delle 7 raccolte d acqua artificiali, 4 sono risultate idonee con interventi, le restanti non idonee. Delle 21 raccolte d acqua naturali, 16 sono risultate idonee e 5 idonee con interventi. Delle 12 tra sorgenti e risorgive, 6 sono risultate idonee, 1 idonea con interventi e le restanti non idonee. 28
29 Complessivamente è evidente come la maggior parte dei corsi d acqua indagati non necessitino di interventi, risultando questi già idonei. I restanti siti non sono idonei alla presenza di Anfibi per le caratteristiche intrinseche dell habitat stesso. Relativamente ai fontanili invece un elevato numero necessita di interventi di ripristino o di manutenzione, mentre pochi sono risultati idonei. Relativamente ai Siti Natura 2000 presenti nel settore abruzzese del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga: siti ricadono nella ZPS IT Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga (versante Abruzzese) di cui 9 cavità artificiali, 6 cavità naturali, 41 corsi d acqua, 61 fontanili, 5 tra pozzi e cisterne, 11 tra prati allagati e pozze, 2 raccolte d acqua artificiali, 9 raccolte d acqua naturali e 5 tra sorgenti e risorgive; - 61 siti ricadono nel SIC IT Gran Sasso, di cui 23 corsi d acqua, 18 fontanili, 2 prati allagati e pozze, 1 raccolta d acqua artificiale, 12 raccolte d acqua naturali e 4 tra sorgenti e risorgive; - 3 siti ricadono nel SIC IT Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito di cui 2 raccolte d acqua artificiali e 1 sorgente; - 28 siti ricadono nel SIC IT Monti della Laga e Lago di Campotosto di cui 23 corsi d acqua, 3 fontanili, 1 prato allagato/pozza e 1 sorgente/risorgiva; - 1 fontanile ricade nel SIC IT Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello ; - 14 siti ricadono nel SIC IT Monte Picca - Monte di Roccatagliata di cui 3 corsi d acqua, 5 fontanili e 6 tra prati allagati e pozze; - 23 siti sono localizzati fuori Parco. 29
30 Codice e denominazione SIC Grado di idoneità ZPS IT Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga SIC IT Gran Sasso SIC IT Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito SIC IT Monti della Laga e Lago di Campotosto SIC IT Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello SIC IT Monte Picca - Monte di Roccatagliata FUORI PARCO N siti ispezionati Cavità artificiali Cavità naturali Corsi d'acqua Fontanili Pozzi e cisterne Prati allagati e pozze Raccolte d'acqua artificiali Raccolte d'acqua naturali Sorgenti e risorgive Idoneo Idoneo con interventi Non idoneo TOTALE Idoneo Idoneo con interventi Non idoneo TOTALE Idoneo 0 Idoneo con interventi 0 Non idoneo TOTALE Idoneo Idoneo con interventi Non idoneo TOTALE Idoneo 0 Idoneo con interventi 1 1 Non idoneo 0 TOTALE 1 1 Idoneo 2 2 Idoneo con interventi Non idoneo 1 1 TOTALE Idoneo Idoneo con interventi Non idoneo TOTALE
31 Di seguito si riporta per ogni Sito della Rete Natura 2000 oggetto di studio, una carta che indica la localizzazione nel PNGSML, le pressioni e minacce rilevate per le singole specie, le indicazioni gestionali e le relative misure di conservazione. ZPS IT Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga (versante Abruzzese) Tipologia di biotopi censiti: cavità artificiali (9), cavità naturali (6), corsi d acqua (90), fontanili (88), pozzi e cisterne (5), prati allagati e pozze (20), raccolte d acqua artificiali (5), raccolte d acqua naturali (21), sorgenti e risorgive (12). Specie censite: Salamandrina perspicillata, Triturus carnifex, Lissotriton italicus, Bufo bufo, Pelophylax bergeri/pelophylax Klepton hispanicus, Rana italica. La tabella che segue riassume le pressioni e le minacce individuate per ciascuna specie rilevata o potenzialmente presente nella ZPS IT Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.
32 ZPS IT Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga Specie presenti e/o potenziali Pressioni/Minacce Salsal* Salper Tricar Lisita Speita Bompac* Ranita Pascolo intensivo x x x Erronea ristrutturazione dei fontanili x x x Mancata manutenzione dei fontanili x x x x Presenza di manufatti trappola x x x Gestione forestale x x x x x Apertura di nuove strade in ambito forestale e nelle praterie x x x x x x x Traffico veicolare x x x Alterazioni causate da cinghiale (eccessiva densità di popolazione) Immissione di ittiofauna e di altre specie alloctone invasive x x x Attingimenti ad uso potabile e/o irriguo x x x x x x Prelievo di acque superficiali per produzione di energia idroelettrica x x x x x x Discarica abusiva di rifiuti solidi x x x x x x Torrentismo x x x x x Turisticizzazione delle cavità naturali e artificiali Realizzazione di aree ricreative presso i fontanili x x x * Specie potenziale (segnalata in passato e non riconfermata dal presente studio e/o mai segnalata ma potenzialmente presente per le caratteristiche dell habitat). x Per il Sito Natura 2000 in oggetto vengono di seguito riportate le proposte gestionali e le misure di conservazione per le relative pressioni e/o minacce individuate. Pressioni/Minacce Pascolo intensivo ZPS IT Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga Proposte gestionali e misure di conservazione Al fine di ridurre l involuzione, la frammentazione e il degrado di praterie, pratipascoli, prati naturali, è auspicabile realizzare nelle aree a maggiore intensità di pascolamento un numero di punti d'acqua per l'abbeveraggio congruo con il numero di capi e omogeneamente distribuito sul territorio al fine di evitare massicce concentrazioni di animali nei pochi punti d'acqua disponibili. Nei pressi degli abbeveratoi dove si creano fenomeni di ristagno idrico temporaneo, in funzione delle deboli pendenze, una limitazione dell'accesso al bestiame di dette aree, attraverso la realizzazione di staccionate o recinzioni elettrificate, 32
33 Pressioni/Minacce Erronea ristrutturazione dei fontanili Mancata manutenzione dei fontanili Presenza di manufatti trappola Gestione forestale ZPS IT Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga Proposte gestionali e misure di conservazione favorirebbe la presenza di specie di particolare interesse conservazionistico quali l'ululone appenninico. Attraverso la consultazione del database dei biotopi per anfibi censiti all'interno del settore abruzzese del PNGSML, l'ente gestore sarà in grado di verificare quale sito e quali specie di anfibi associate sono presenti all'interno delle aree oggetto di pascolamento; la maggiore idoneità di detti siti per le specie di interesse conservazionistico-biogeografico consentirà all'ente di porre maggiore attenzione in alcune aree e predisporre piani congrui con la presenza o la possibilità di insediamento di alcune specie di anfibi. All'interno del PNGSML sono presenti numerosi fontanili tra cui molti abbeveratoi ristrutturati o realizzati in anni recenti che presentano impedimenti per gli anfibi all'ingresso e all'uscita. Al fine di favorire l'utilizzo di tali siti artificiali da parte di specie quali l'ululone appenninico, il tritone crestato e il tritone italiano, tutti i fontanili classificati come "idoneo con intervento" dovrebbero essere ristrutturati realizzando all'interno degli stessi una rampa di uscita a debole pendenza e all'esterno, almeno su un lato, un cumulo di terra o roccia che consenta agli animali di entrare facilmente in acqua. É comunque vietata la pavimentazione delle aree perimetrali ai fontanili. Per assicurare il giusto apporto di acqua durante l arco dell anno, in particolare durante il periodo riproduttivo, l'ente Parco dovrà sorvegliare periodicamente i fontanili ritenuti di maggiore interesse per gli anfibi (vedi database) verificandone l'integrità delle condutture e la capacità di trattenere l'acqua. Gli stessi fontanili, oggetto di ripulitura da parte degli allevatori o dei residenti (vedi lavatoi nei centri abitati) dovranno essere oggetto di uno specifico piano di manutenzione, che preveda in particolare il divieto assoluto di ripulitura attraverso prodotti chimici e l'asportazione della vegetazione acquatica (alghe e idrofite) da febbraio a ottobre. Durante l'inverno e solo quando la vasca si presenta particolarmente piena di vegetazione, sarà possibile rimuovere circa l'80% della stessa, mantenendola per alcuni giorni al margine del fontanile, consentendo così agli anfibi e alle larve di invertebrati acquatici eventualmente presenti di rientrare in acqua. Le cisterne, le vecchi vasche da bagno abbandonate e i pozzi lasciati aperti sul piano di campagna, sono causa di caduta e intrappolamento di molte specie animali tra cui gli anfibi. Nei soli casi in cui non sia possibile chiudere l'accesso a detti siti, dovrà essere posizionata una rampa di adeguata pendenza, costituita anche da un semplice ramo o tavola di legno ben fissata, che consentirà agli esemplari caduti all'interno di poter uscire. Periodicamente l'ente Parco dovrà sorvegliare tali siti sostituendo, se necessario, le rampe. Nell'ambito della gestione forestale dovrà essere fatto divieto di taglio, degli individui arbustivi e arborei di eccezionale sviluppo (definibili monumentali ) appartenenti a qualsiasi specie. Nelle formazioni boschive di qualsiasi tipo sottoposte ad utilizzazione o altro intervento selvicolturale, dovrà essere vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d acqua perenni e temporanei, fossi, impluvi, stagni, pozze, sorgenti, fontanili, emergenze rocciose, per una fascia della profondità minima di metri 20 dai margini esterni di tali formazioni. Dovrà inoltre essere vietato il transito con qualsiasi mezzo nei corpi idrici perenni, temporanei, puntuali, lineari, areali, e negli impluvi, se non per comprovate esigenze produttive e di servizio su predefiniti punti di guado. Nelle formazioni boschive di qualsiasi tipo sarà necessario mantenere, per ogni ettaro di superficie sottoposta 33
34 Pressioni/Minacce Apertura di nuove strade in ambito forestale e nelle praterie Traffico veicolare Alterazioni causate da cinghiale (eccessiva densità di popolazione) Immissione di ittiofauna e di altre specie alloctone invasive Attingimenti ad uso potabile e/o irriguo Prelievo di acque superficiali per produzione di energia idroelettrica Discarica abusiva di rifiuti solidi Torrentismo ZPS IT Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga Proposte gestionali e misure di conservazione ad utilizzazione o altro intervento selvicolturale, almeno 2 individui arborei annosi e marcescenti a terra, almeno 3 individui arborei annosi e marcescenti ancora in piedi, almeno 5 individui arborei, dei quali 3 appartenenti alla specie dominante e 2 alle subordinate, scelti tra gli esemplari maturi più anziani, ma ancora in piedi ed in buone condizioni vegetative. Nelle aree di particolare interesse per gli anfibi forestali quali la salamandra pezzata appenninica, la salamandrina dagli occhiali settentrionale e la rana appenninica, sarebbe auspicabile incentivare l adozione di sistemi di esbosco alternativi all uso di veicoli a motore. É auspicabile inoltre incentivare la conservazione o il ripristino di compagini forestali caratterizzate dall alternanza di diversi tipi di governo del bosco e gli interventi di diversificazione specifica dei popolamenti forestali e di conservazione di esemplari di piante mature. L'ente gestore dovrà inoltre impegnarsi a favorire il mantenimento di aree boscate non soggette a tagli e alla rimozione degli alberi morti o marcescenti nonché la conservazione degli strati erbacei ed arbustivi nelle formazioni boschive. Sarà inoltre necessario incentivare il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo. L'Ente Parco dovrà impegnarsi a disincentivare, mitigare e proibire la realizzazione di nuove strade e piste di servizio agro-silvo-pastorale nonché la pavimentazione impermeabile o semipermeabile di quelle esistenti. Dovrà essere sottoposto a limitazione il transito di veicoli a motore al di fuori della rete rotabile come su mulattiere e sentieri di boschi, pascoli, prati e seminativi se non per comprovate esigenze produttive e di servizio. In corrispondenze delle aree particolarmente sensibili per anfibi, minacciate dalla presenza di una rete viaria caratterizzata da un cospicuo traffico veicolare, sarebbe auspicabile intervenire mediate la realizzazione ex novo di varchi atti al transito protetto degli stessi. Nei pressi dei siti riproduttivi dove si creano fenomeni di ristagno idrico temporaneo, in funzione delle deboli pendenze, è auspicabile limitare l'accesso ai cinghiali, attraverso la realizzazione di staccionate o recinzioni elettrificate. Il PNGSML dovrebbe impegnarsi a disincentivare l immissione di ittiofauna in aree di particolare interesse per gli anfibi e comunque dove questa non sia naturalmente presente. Deve inoltre essere vietata l'introduzione di specie alloctone invasive, in grado di alterare le biocenosi esistenti, promuovendo specifici piani di comunicazione rivolti a tutti i possibili fruitori (turisti, residenti, pescatori). È vietata la sottrazione temporanea o permanente, per qualsiasi scopo, da corpi idrici perenni, temporanei, puntuali, lineari, areali, senza il rilascio delle quantità minime vitali. È vietata la sottrazione temporanea o permanente, per la produzione di energia idroelettrica, da corpi idrici perenni, temporanei, puntuali, lineari, senza il rilascio delle quantità minime vitali. L'Ente Parco dovrà impegnarsi ad adottare specifici sistemi di dissuasione atti a disincentivare l'abbandono di rifiuti solidi in prossimità di siti riproduttivi per anfibi. Lo svolgimento di attività di torrentismo dovrebbe essere regolamentato nelle modalità e nei tempi, prevedendo un piano di fruizione che tenga conto del 34
35 Pressioni/Minacce Turisticizzazione delle cavità naturali e artificiali Realizzazione di aree ricreative presso i fontanili ZPS IT Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga Proposte gestionali e misure di conservazione periodo riproduttivo degli anfibi (febbraio-ottobre) e dei siti maggiormente idonei alla loro riproduzione, quali pozze e tratti a lento scorrimento. La fruizione delle cavità naturali e artificiali dovrebbe essere regolamentata nelle modalità e nei tempi, attraverso l'adozione di uno specifico piano di fruizione e, in quelle particolarmente importanti per il geotritone, provvedendo all'installazione di barriere atte ad impedire il transito umano ed a consentire il libero transito della fauna. Sarebbe opportuno limitare gli interventi di turisticizzazione delle cavità ipogee e comunque la realizzazione di nuove aperture e di strutture e attrezzature per la visita, dovranno essere sottoposte a valutazioni specifiche che tengano conto delle esigenze ecologiche delle specie eventualmente presenti, nello specifico del geotritone. Nei pressi di fontanili localizzati in zone facilmente accessibili da escursionisti e visitatori, è auspicabile non realizzare aree ricreative nelle immediate vicinanze degli stessi. É comunque vietata la pavimentazione delle aree perimetrali ai fontanili. 35
36 SIC IT Gran Sasso Tipologia di biotopi censiti: corsi d acqua (23), fontanili (18), prati allagati e pozze (2), raccolte d acqua artificiali (1), raccolte d acqua naturali (12), sorgenti e risorgive (5). Specie rilevate: Triturus carnifex, Lissotriton italicus, Bufo bufo, Pelophylax bergeri/pelophylax Klepton hispanicus, Rana italica, tre delle quali di interesse conservazionistico-biogeografico. La tabella seguente riassume le pressioni e le minacce individuate per ciascuna specie rilevata o potenzialmente presente nel SIC IT Gran Sasso. SIC IT Gran Sasso Pressioni/Minacce Specie presenti e/o potenziali Salsal* Salper* Tricar Lisita Speita* Bompac* Ranita Pascolo intensivo x x x 36
37 Pressioni/Minacce SIC IT Gran Sasso Specie presenti e/o potenziali Salsal* Salper* Tricar Lisita Speita* Bompac* Ranita Erronea ristrutturazione dei fontanili x x x Mancata manutenzione dei fontanili x x x Presenza di manufatti trappola x x x Gestione forestale x x x x Apertura di nuove strade in ambito forestale e nelle praterie x x x x x x x Traffico veicolare x x x Attingimenti ad uso potabile e/o irriguo x x x Prelievo di acque superficiali per produzione di energia idroelettrica Turisticizzazione delle cavità naturali e artificiali Realizzazione di aree ricreative presso i fontanili x x x x x x x * Specie potenziale (segnalata in passato e non riconfermata dal presente studio e/o mai segnalata ma potenzialmente presente per le caratteristiche dell habitat). x Per il Sito Natura 2000 in oggetto vengono di seguito riportate le proposte gestionali e le misure di conservazione per le relative pressioni e/o minacce individuate. Pressioni/Minacce Pascolo intensivo SIC IT Gran Sasso Proposte gestionali e misure di conservazione Al fine di ridurre l involuzione, la frammentazione e il degrado di praterie, pratipascoli, prati naturali, è auspicabile realizzare nelle aree a maggiore intensità di pascolamento un numero di punti d'acqua per l'abbeveraggio congruo con il numero di capi e omogeneamente distribuito sul territorio al fine di evitare massicce concentrazioni di animali nei pochi punti d'acqua disponibili. Nei pressi degli abbeveratoi dove si creano fenomeni di ristagno idrico temporaneo, in funzione delle deboli pendenze, una limitazione dell'accesso al bestiame di dette aree, attraverso la realizzazione di staccionate o recinzioni elettrificate, favorirebbe la presenza di specie di particolare interesse conservazionistico quali l'ululone appenninico. Attraverso la consultazione del database dei biotopi per anfibi censiti all'interno del settore abruzzese del PNGSML, l'ente gestore sarà in grado di verificare quale sito e quali specie di anfibi associate sono presenti all'interno delle aree oggetto di pascolamento; la maggiore idoneità di detti siti per le specie di interesse conservazionistico-biogeografico consentirà all'ente di 37
38 Pressioni/Minacce Erronea ristrutturazione dei fontanili Mancata manutenzione dei fontanili Presenza di manufatti trappola Gestione forestale SIC IT Gran Sasso Proposte gestionali e misure di conservazione porre maggiore attenzione in alcune aree e predisporre piani congrui con la presenza o la possibilità di insediamento di alcune specie di anfibi. All'interno del PNGSML sono presenti numerosi fontanili tra cui molti abbeveratoi ristrutturati o realizzati in anni recenti che presentano impedimenti per gli anfibi all'ingresso e all'uscita. Al fine di favorire l'utilizzo di tali siti artificiali da parte di specie quali l'ululone appenninico, il tritone crestato e il tritone italiano, tutti i fontanili classificati come "idoneo con intervento" dovrebbero essere ristrutturati realizzando all'interno degli stessi una rampa di uscita a debole pendenza e all'esterno, almeno su un lato, un cumulo di terra o roccia che consenta agli animali di entrare facilmente in acqua. É comunque vietata la pavimentazione delle aree perimetrali ai fontanili. Per assicurare il giusto apporto di acqua durante l arco dell anno, in particolare durante il periodo riproduttivo, l'ente Parco dovrà sorvegliare periodicamente i fontanili ritenuti di maggiore interesse per gli anfibi (vedi database) verificandone l'integrità delle condutture e la capacità di trattenere l'acqua. Gli stessi fontanili, oggetto di ripulitura da parte degli allevatori o dei residenti (vedi lavatoi nei centri abitati) dovranno essere oggetto di uno specifico piano di manutenzione, che preveda in particolare il divieto assoluto di ripulitura attraverso prodotti chimici e l'asportazione della vegetazione acquatica (alghe e idrofite) da febbraio a ottobre. Durante l'inverno e solo quando la vasca si presenta particolarmente piena di vegetazione, sarà possibile rimuovere circa l'80% della stessa, mantenendola per alcuni giorni al margine del fontanile, consentendo così agli anfibi e alle larve di invertebrati acquatici eventualmente presenti di rientrare in acqua. Le cisterne, le vecchi vasche da bagno abbandonate e i pozzi lasciati aperti sul piano di campagna, sono causa di caduta e intrappolamento di molte specie animali tra cui gli anfibi. Nei soli casi in cui non sia possibile chiudere l'accesso a detti siti, dovrà essere posizionata una rampa di adeguata pendenza, costituita anche da un semplice ramo o tavola di legno ben fissata, che consentirà agli esemplari caduti all'interno di poter uscire. Periodicamente l'ente Parco dovrà sorvegliare tali siti sostituendo, se necessario, le rampe. Nell'ambito della gestione forestale dovrà essere fatto divieto di taglio, degli individui arbustivi e arborei di eccezionale sviluppo (definibili monumentali ) appartenenti a qualsiasi specie. Nelle formazioni boschive di qualsiasi tipo sottoposte ad utilizzazione o altro intervento selvicolturale, dovrà essere vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d acqua perenni e temporanei, fossi, impluvi, stagni, pozze, sorgenti, fontanili, emergenze rocciose, per una fascia della profondità minima di metri 20 dai margini esterni di tali formazioni. Dovrà inoltre essere vietato il transito con qualsiasi mezzo nei corpi idrici perenni, temporanei, puntuali, lineari, areali, e negli impluvi, se non per comprovate esigenze produttive e di servizio su predefiniti punti di guado. Nelle formazioni boschive di qualsiasi tipo sarà necessario mantenere, per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione o altro intervento selvicolturale, almeno 2 individui arborei annosi e marcescenti a terra, almeno 3 individui arborei annosi e marcescenti ancora in piedi, almeno 5 individui arborei, dei quali 3 appartenenti alla specie dominante e 2 alle subordinate, scelti tra gli esemplari maturi più anziani, ma ancora in piedi ed in buone condizioni vegetative. Nelle aree di particolare interesse per gli anfibi forestali quali la salamandra pezzata appenninica, la salamandrina dagli occhiali 38
39 Pressioni/Minacce Apertura di nuove strade in ambito forestale e nelle praterie Traffico veicolare Attingimenti ad uso potabile e/o irriguo Prelievo di acque superficiali per produzione di energia idroelettrica Turisticizzazione delle cavità naturali e artificiali Realizzazione di aree ricreative presso i fontanili SIC IT Gran Sasso Proposte gestionali e misure di conservazione settentrionale e la rana appenninica, sarebbe auspicabile incentivare l adozione di sistemi di esbosco alternativi all uso di veicoli a motore. É auspicabile inoltre incentivare la conservazione o il ripristino di compagini forestali caratterizzate dall alternanza di diversi tipi di governo del bosco e gli interventi di diversificazione specifica dei popolamenti forestali e di conservazione di esemplari di piante mature. L'ente gestore dovrà inoltre impegnarsi a favorire il mantenimento di aree boscate non soggette a tagli e alla rimozione degli alberi morti o marcescenti nonché la conservazione degli strati erbacei ed arbustivi nelle formazioni boschive. Sarà inoltre necessario incentivare il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo. L'Ente Parco dovrà impegnarsi a disincentivare, mitigare e proibire la realizzazione di nuove strade e piste di servizio agro-silvo-pastorale nonché la pavimentazione impermeabile o semipermeabile di quelle esistenti. Dovrà essere sottoposto a limitazione il transito di veicoli a motore al di fuori della rete rotabile come su mulattiere e sentieri di boschi, pascoli, prati e seminativi se non per comprovate esigenze produttive e di servizio. In corrispondenze delle aree particolarmente sensibili per anfibi, minacciate dalla presenza di una rete viaria caratterizzata da un cospicuo traffico veicolare, sarebbe auspicabile intervenire mediate la realizzazione ex novo di varchi atti al transito protetto degli stessi. È vietata la sottrazione temporanea o permanente, per qualsiasi scopo, da corpi idrici perenni, temporanei, puntuali, lineari, areali, senza il rilascio delle quantità minime vitali. È vietata la sottrazione temporanea o permanente, per la produzione di energia idroelettrica, da corpi idrici perenni, temporanei, puntuali, lineari, senza il rilascio delle quantità minime vitali. La fruizione delle cavità naturali e artificiali dovrebbe essere regolamentata nelle modalità e nei tempi, attraverso l'adozione di uno specifico piano di fruizione e, in quelle particolarmente importanti per il geotritone, provvedendo all'installazione di barriere atte ad impedire il transito umano ed a consentire il libero transito della fauna. Sarebbe opportuno limitare gli interventi di turisticizzazione delle cavità ipogee e comunque la realizzazione di nuove aperture e di strutture e attrezzature per la visita, dovranno essere sottoposte a valutazioni specifiche che tengano conto delle esigenze ecologiche delle specie eventualmente presenti, nello specifico del geotritone. Nei pressi di fontanili localizzati in zone facilmente accessibili da escursionisti e visitatori, è auspicabile non realizzare aree ricreative nelle immediate vicinanze degli stessi. É comunque vietata la pavimentazione delle aree perimetrali ai fontanili. 39
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE E DELL UOMO
 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE E DELL UOMO LABORATORIO DI ETOLOGIA v. Accademia Albertina, 13-10123 TORINO - Italy Tel. Prof. C. Giacoma (011) 6704558 Laboratori (011)
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE E DELL UOMO LABORATORIO DI ETOLOGIA v. Accademia Albertina, 13-10123 TORINO - Italy Tel. Prof. C. Giacoma (011) 6704558 Laboratori (011)
FACOLTA DI ARCHITETTURA
 CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO Laboratorio di Pianificazione del Paesaggio Insegnamento Paesaggio Docente: CRITERI E METODI DI ANALISI DELLA COPERTURA DEL SUOLO SOMMARIO 1) Legenda del Protocollo
CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO Laboratorio di Pianificazione del Paesaggio Insegnamento Paesaggio Docente: CRITERI E METODI DI ANALISI DELLA COPERTURA DEL SUOLO SOMMARIO 1) Legenda del Protocollo
Censimento e schedatura dei siti riproduttivi di Anfibi presenti nel Parco del Po (Cuneese) e nei suoi immediati dintorni.
 Programma Interreg III Alcotra AQUA Censimento e schedatura dei siti riproduttivi di Anfibi presenti nel Parco del Po (Cuneese) e nei suoi immediati dintorni. Relazione Finale Daniele Seglie & Stefano
Programma Interreg III Alcotra AQUA Censimento e schedatura dei siti riproduttivi di Anfibi presenti nel Parco del Po (Cuneese) e nei suoi immediati dintorni. Relazione Finale Daniele Seglie & Stefano
Ente Parco dei Nebrodi. Progetto di ricerca scientifica IL TRANSETTO DELLA BIODIVERSITÁ Attività di monitoraggio ambientale
 Ente Parco dei Nebrodi Area III Conservazione della Natura e Gestione G del Territorio Area IV Promozione e Fruizione Sociale Progetto di ricerca scientifica IL TRANSETTO DELLA BIODIVERSITÁ Attività di
Ente Parco dei Nebrodi Area III Conservazione della Natura e Gestione G del Territorio Area IV Promozione e Fruizione Sociale Progetto di ricerca scientifica IL TRANSETTO DELLA BIODIVERSITÁ Attività di
La valorizzazione della biodiversità in Liguria con i fondi strutturali
 Provincia di Savona Servizio Parchi e Aree Protette La valorizzazione della biodiversità in Liguria con i fondi strutturali 2000-2006 VALORIZZAZIONE DELLE ZONE UMIDE COSTIERE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Provincia di Savona Servizio Parchi e Aree Protette La valorizzazione della biodiversità in Liguria con i fondi strutturali 2000-2006 VALORIZZAZIONE DELLE ZONE UMIDE COSTIERE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
 DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
Schema degli argomenti da trattare nella Relazione tecnica descrittiva.
 Misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi Azione 1 Investimenti materiali e immateriali per la ricostituzione di aree percorse dal fuoco. Schema degli argomenti
Misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi Azione 1 Investimenti materiali e immateriali per la ricostituzione di aree percorse dal fuoco. Schema degli argomenti
- a tutte le tipologie di aree a cui è riconosciuta valenza ambientale, istituite e gestite da associazioni ambientaliste (Oasi, IBA, Aree Wilderness)
 - alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) - alle zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar - a tutte le tipologie di aree a cui è riconosciuta valenza ambientale, istituite e gestite da associazioni ambientaliste
- alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) - alle zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar - a tutte le tipologie di aree a cui è riconosciuta valenza ambientale, istituite e gestite da associazioni ambientaliste
21) FLAVIO ANDO (chalet)
 21) FLAVIO ANDO (chalet) QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...7 Clima acustico
21) FLAVIO ANDO (chalet) QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...7 Clima acustico
REGGIO CALABRIA 29 ottobre 2015
 III Convegno Nazionale sulla Riqualificazione Fluviale Sessione Internazionale Riqualificare i corsi d acqua nella regione mediterranea ispirazione dalle buone pratiche - impegno per le sfide correnti
III Convegno Nazionale sulla Riqualificazione Fluviale Sessione Internazionale Riqualificare i corsi d acqua nella regione mediterranea ispirazione dalle buone pratiche - impegno per le sfide correnti
LE ACQUE SOTTERRANEE
 LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
La connessione ecologica per la biodiversità, il LIFE + TIB (Trans Insubria Bionet) e l esperienza del Contratto di Rete in Provincia di Varese
 La connessione ecologica per la biodiversità, il LIFE + TIB (Trans Insubria Bionet) e l esperienza del Contratto di Rete in Provincia di Varese Massimo Soldarini LIPU-BirdLife Italia Milano, 12 marzo 2012
La connessione ecologica per la biodiversità, il LIFE + TIB (Trans Insubria Bionet) e l esperienza del Contratto di Rete in Provincia di Varese Massimo Soldarini LIPU-BirdLife Italia Milano, 12 marzo 2012
UTOE 7 Cisanello Parco Centrale S.N. 7.5
 UTOE 7 Cisanello Parco Centrale S.N. 7.5 QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione dell area... 2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e
UTOE 7 Cisanello Parco Centrale S.N. 7.5 QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione dell area... 2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e
Strumenti di finanziamento europei per la conservazione della biodiversità. Patrizia Rossi Responsabile Agricoltura LIPU BirdLife Italia
 Strumenti di finanziamento europei per la conservazione della biodiversità Patrizia Rossi Responsabile Agricoltura LIPU BirdLife Italia Crisi della biodiversità nel mondo, in Europa e in Italia In Europa
Strumenti di finanziamento europei per la conservazione della biodiversità Patrizia Rossi Responsabile Agricoltura LIPU BirdLife Italia Crisi della biodiversità nel mondo, in Europa e in Italia In Europa
Capitolo 3 Caratterizzazione delle aree protette
 Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali Bacino dello slizza Capitolo 3 I INDICE 3. CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE... 1 3.1. AREE PER L ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali Bacino dello slizza Capitolo 3 I INDICE 3. CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE... 1 3.1. AREE PER L ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
Censimenti e piani di prelievo
 Censimenti e piani di prelievo Regolamento Regionale 27 luglio 1999, n 23 Gestione faunistico-venatoria dei Cervidi e Bovidi Art. 1 - Finalità Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria
Censimenti e piani di prelievo Regolamento Regionale 27 luglio 1999, n 23 Gestione faunistico-venatoria dei Cervidi e Bovidi Art. 1 - Finalità Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria
INDICE. Bacino dello Slizza I
 Bacino dello Slizza I INDICE 5.1. OBIETTIVI AMBIENTALI PER LE ACQUE SUPERFICIALI... 1 5.1.2. Proroga dei termini fissati dall articolo 4, comma 1, della Direttiva 2000/60/CE allo scopo del graduale conseguimento
Bacino dello Slizza I INDICE 5.1. OBIETTIVI AMBIENTALI PER LE ACQUE SUPERFICIALI... 1 5.1.2. Proroga dei termini fissati dall articolo 4, comma 1, della Direttiva 2000/60/CE allo scopo del graduale conseguimento
PROGETTO GLORIA : LA VEGETAZIONE DI ALTA QUOTA PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
 PROGETTO GLORIA : LA VEGETAZIONE DI ALTA QUOTA PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI Gli ecosistemi montani rappresentano l unica unità biogeografica terrestre distribuita su tutto
PROGETTO GLORIA : LA VEGETAZIONE DI ALTA QUOTA PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI Gli ecosistemi montani rappresentano l unica unità biogeografica terrestre distribuita su tutto
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione
 La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
La biosfera e gli ecosistemi
 La biosfera e gli ecosistemi La biosfera: l insieme di tutti gli ecosistemi L ecologia studia le interazioni tra gli organismi viventi e il loro ambiente a vari livelli: ECOSISTEMA COMUNITA POPOLAZIONE
La biosfera e gli ecosistemi La biosfera: l insieme di tutti gli ecosistemi L ecologia studia le interazioni tra gli organismi viventi e il loro ambiente a vari livelli: ECOSISTEMA COMUNITA POPOLAZIONE
CORSO DI. Prof. Bernardino Ragni Dipartimento di Chimica, Biologia, Biotecnologie UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
 CORSO DI ZOOLOGIA AMBIENTALE Prof. Bernardino Ragni Dipartimento di Chimica, Biologia, Biotecnologie UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA Università degli Studi di Perugia Anno Accademico 2013-2014 Prof.
CORSO DI ZOOLOGIA AMBIENTALE Prof. Bernardino Ragni Dipartimento di Chimica, Biologia, Biotecnologie UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA Università degli Studi di Perugia Anno Accademico 2013-2014 Prof.
Regione Siciliana PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA MONITORAGGIO. (Misure adottate in merito al monitoraggio art.
 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA MONITORAGGIO (Misure adottate in merito al monitoraggio art. 10) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (Dir. 42/2001/CE) 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO
PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA MONITORAGGIO (Misure adottate in merito al monitoraggio art. 10) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (Dir. 42/2001/CE) 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO
AREE IMPORTANTI PER L AVIFAUNA NEL FIUME ARNO (PROV. DI FIRENZE): INDIVIDUAZIONE DELLE EMERGENZE E PROSPETTIVE DI TUTELA
 AREE IMPORTANTI PER L AVIFAUNA NEL FIUME ARNO (PROV. DI FIRENZE): INDIVIDUAZIONE DELLE EMERGENZE E PROSPETTIVE DI TUTELA MICHELE GIUNTI & PAOLO SPOSIMO * c/o Nemo srl, via Giotto 33 50121, Firenze 055/674223
AREE IMPORTANTI PER L AVIFAUNA NEL FIUME ARNO (PROV. DI FIRENZE): INDIVIDUAZIONE DELLE EMERGENZE E PROSPETTIVE DI TUTELA MICHELE GIUNTI & PAOLO SPOSIMO * c/o Nemo srl, via Giotto 33 50121, Firenze 055/674223
28) CALAMBRONE STELLA MARIS
 28) CALAMBRONE STELLA MARIS QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione... 2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione... 6 Clima
28) CALAMBRONE STELLA MARIS QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione... 2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione... 6 Clima
I grandi biomi terrestri
 I grandi biomi terrestri BIOMA: complesso di ecosistemi di un area geografica caratterizzato dalla vegetazione dominate. Si distinguono per alcune caratteristiche delle piante quali struttura (le forme
I grandi biomi terrestri BIOMA: complesso di ecosistemi di un area geografica caratterizzato dalla vegetazione dominate. Si distinguono per alcune caratteristiche delle piante quali struttura (le forme
RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL FAGIANO DI MONTE IN ALTO ADIGE
 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL FAGIANO DI MONTE IN ALTO ADIGE Foto: Alfred Hinteregger Luglio 2014 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL FAGIANO DI MONTE IN ALTO ADIGE 2014 1. Gruppi montuosi Unità gestionali Pagina
RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL FAGIANO DI MONTE IN ALTO ADIGE Foto: Alfred Hinteregger Luglio 2014 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL FAGIANO DI MONTE IN ALTO ADIGE 2014 1. Gruppi montuosi Unità gestionali Pagina
Gli anfibi Dominio Regno Phylum Subphilum Superclasse Classe Ordini Famiglie Specie
 Dominio: eucarioti Regno: animali Phylum: cordati Subphilum: vertebrati Superclasse: tetrapodi Classe: anfibi Ordini: 3 Famiglie: 44 Specie: circa 5000 Gli anfibi Introduzione Gli anfibi si sono resi indipendenti
Dominio: eucarioti Regno: animali Phylum: cordati Subphilum: vertebrati Superclasse: tetrapodi Classe: anfibi Ordini: 3 Famiglie: 44 Specie: circa 5000 Gli anfibi Introduzione Gli anfibi si sono resi indipendenti
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI COMPONENTE FORESTALE
 REGIONE BASILICATA Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità Nome del Sito Codice SIC Serra di Calvello IT9210240 RETE NATURA 2000 Rilevatori / data Falconeri Giuseppe, Ferraro Luciano
REGIONE BASILICATA Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità Nome del Sito Codice SIC Serra di Calvello IT9210240 RETE NATURA 2000 Rilevatori / data Falconeri Giuseppe, Ferraro Luciano
RELAZIONE PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE & PIANO DI GESTIONE DEL SIC/ZPS IT DOLOMITI FRIULANE
 RELAZIONE PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE & PIANO DI GESTIONE DEL SIC/ZPS IT3310001 DOLOMITI FRIULANE Due diverse normative: -Piano di Conservazione e Sviluppo: -Piano
RELAZIONE PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE & PIANO DI GESTIONE DEL SIC/ZPS IT3310001 DOLOMITI FRIULANE Due diverse normative: -Piano di Conservazione e Sviluppo: -Piano
LE SCIENZE NATURALI IN PIEMONTE ASTI, 12 NOVEMBRE 2016
 LE SCIENZE NATURALI IN PIEMONTE ASTI, 12 NOVEMBRE 2016 Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte: una risorsa per la biodiversità? Il punto di vista di agricoltori e ornitologi. Bruno e Gabriella
LE SCIENZE NATURALI IN PIEMONTE ASTI, 12 NOVEMBRE 2016 Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte: una risorsa per la biodiversità? Il punto di vista di agricoltori e ornitologi. Bruno e Gabriella
CONTRATTO DI FIUME "Arielli"
 CONTRATTO DI FIUME "Arielli" Ortona a Mare, Tollo, Canosa Sannita, Crecchio, Arielli, Poggiofiorito e Orsogna (Provincia di Chieti) Primo Programma d'azione Ottobre 2014 Il primo programma d'azione del
CONTRATTO DI FIUME "Arielli" Ortona a Mare, Tollo, Canosa Sannita, Crecchio, Arielli, Poggiofiorito e Orsogna (Provincia di Chieti) Primo Programma d'azione Ottobre 2014 Il primo programma d'azione del
Regione. Regione Calabria. Comune Comune di Rogliano di (CS) ... PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO MINIEOLICO EX SCUOLA MATERNA "POVERELLA"
 POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL AMBITO DELL EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE
POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL AMBITO DELL EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE
14. BONIFICA DEI SITI INQUINATI
 14. BONIFICA DEI SITI INQUINATI Piano Provinciale Gestione Rifiuti Pag. 349 Piano Provinciale Gestione Rifiuti Pag. 350 Il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti contiene anche il Piano di Bonifica
14. BONIFICA DEI SITI INQUINATI Piano Provinciale Gestione Rifiuti Pag. 349 Piano Provinciale Gestione Rifiuti Pag. 350 Il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti contiene anche il Piano di Bonifica
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Dipartimento di Scienze della terra e dell ambiente Corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie per la Natura Uso delle aree aperte da parte di medio mammiferi nel
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Dipartimento di Scienze della terra e dell ambiente Corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie per la Natura Uso delle aree aperte da parte di medio mammiferi nel
03) Via Frascani QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO. Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2
 03) Via Frascani QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...6 Clima acustico e piano
03) Via Frascani QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...6 Clima acustico e piano
Tematismi e Cartografie del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione e del Piano Provinciale di Emergenza.
 Tematismi e Cartografie del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione e del Piano Provinciale di Emergenza Tematismi importanti Rischio Idraulico - Censimento degli eventi di esondazione interessanti
Tematismi e Cartografie del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione e del Piano Provinciale di Emergenza Tematismi importanti Rischio Idraulico - Censimento degli eventi di esondazione interessanti
INDAGINI GEO-ELETTRICHE
 INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
La Rete Natura 2000 in Sicilia: tra tutela e sviluppo PALERMO, 28 NOVEMBRE 2007
 La Rete Natura 2000 in Sicilia: tra tutela e sviluppo PALERMO, 28 NOVEMBRE 2007 La Rete Natura 2000 nel nuovo ciclo di programmazione 2007-2013: quali opportunità? Il Programma Operativo FESR dott.ssa
La Rete Natura 2000 in Sicilia: tra tutela e sviluppo PALERMO, 28 NOVEMBRE 2007 La Rete Natura 2000 nel nuovo ciclo di programmazione 2007-2013: quali opportunità? Il Programma Operativo FESR dott.ssa
FAUNA MINORE in Emilia-Romagna (gli organismi acquatici)
 FAUNA MINORE in Emilia-Romagna (gli organismi acquatici) Le specie Le minacce La salvaguardia testi e fotografie di Giancarlo Tedaldi PERCHE LA FAUNA ACQUATICA E IMPORTANTE La maggior parte della piccola
FAUNA MINORE in Emilia-Romagna (gli organismi acquatici) Le specie Le minacce La salvaguardia testi e fotografie di Giancarlo Tedaldi PERCHE LA FAUNA ACQUATICA E IMPORTANTE La maggior parte della piccola
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E PIANI DI GESTIONE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 DELLA MONTAGNA PIACENTINA
 Acqua - Incontro tematico Piacenza, 19 giugno 2012 MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E PIANI DI GESTIONE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 DELLA MONTAGNA PIACENTINA Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura
Acqua - Incontro tematico Piacenza, 19 giugno 2012 MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E PIANI DI GESTIONE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 DELLA MONTAGNA PIACENTINA Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura
LEZIONE N. 4 SCIENZE MISURA DELLA CIRCONFERENZA TERRESTRE
 Date: 13 e 27 ottobre 2015 Docente: Claudio Lancini LEZIONE N. 4 SCIENZE MISURA DELLA CIRCONFERENZA TERRESTRE Già al tempo degli antichi Egizi, molti scienziati avevano capito che la Terra non era piatta
Date: 13 e 27 ottobre 2015 Docente: Claudio Lancini LEZIONE N. 4 SCIENZE MISURA DELLA CIRCONFERENZA TERRESTRE Già al tempo degli antichi Egizi, molti scienziati avevano capito che la Terra non era piatta
UTOE 38 Marina di Pisa Via CIURINI
 UTOE 38 Marina di Pisa Via CIURINI QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione... 2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione... 6
UTOE 38 Marina di Pisa Via CIURINI QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione... 2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione... 6
La Rete Natura 2000 in Piemonte
 Il PSR per la tutela della biodiversità La in Piemonte Marina Cerra Torino, 13 dicembre 2010 Settore Pianificazione e Gestione Aree naturali protette Conservazione della natura approcci diversi nel tempo
Il PSR per la tutela della biodiversità La in Piemonte Marina Cerra Torino, 13 dicembre 2010 Settore Pianificazione e Gestione Aree naturali protette Conservazione della natura approcci diversi nel tempo
La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda.
 La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda. paesaggio alpino = verde paesaggio appenninico = rosso paesaggio padano = giallo paesaggio
La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda. paesaggio alpino = verde paesaggio appenninico = rosso paesaggio padano = giallo paesaggio
Distretto Idrografico dell Appennino Meridionale
 1.1 IL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE Le aree naturali protette costituiscono una delle tipologie di aree di cui al Registro delle aree protette: Aree designate per la protezione degli habitat e
1.1 IL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE Le aree naturali protette costituiscono una delle tipologie di aree di cui al Registro delle aree protette: Aree designate per la protezione degli habitat e
Dighe ed ecologia delle acque
 HYDROS e SE Hydropower Gruppo SEL Dighe ed ecologia delle acque Bolzano, 15 maggio 2014 Vito Adami Laghi artificiali Dal punto di vista qualitativo, ecologico e funzionale, i laghi artificiali non possono
HYDROS e SE Hydropower Gruppo SEL Dighe ed ecologia delle acque Bolzano, 15 maggio 2014 Vito Adami Laghi artificiali Dal punto di vista qualitativo, ecologico e funzionale, i laghi artificiali non possono
Gli anfibi sono i primi vertebrati che hanno colonizzato la terra ferma, tuttavia hanno un ciclo di vita strettamente legato alla vita acquatica.
 GLI ANFIBI Gli anfibi sono i primi vertebrati che hanno colonizzato la terra ferma, tuttavia hanno un ciclo di vita strettamente legato alla vita acquatica. Il termine anfibio è di origine greca e significa
GLI ANFIBI Gli anfibi sono i primi vertebrati che hanno colonizzato la terra ferma, tuttavia hanno un ciclo di vita strettamente legato alla vita acquatica. Il termine anfibio è di origine greca e significa
Progetto GESPO: L importanza della vegetazione ripariale per la conservazione dei Chirotteri. Paolo Agnelli & Giacomo Maltagliati
 Progetto GESPO: Palazzo Medici Riccardi, via Cavour, Firenze 19 Marzo 2014 L importanza della vegetazione ripariale per la conservazione dei Chirotteri Paolo Agnelli & Giacomo Maltagliati Sezione di Zoologia
Progetto GESPO: Palazzo Medici Riccardi, via Cavour, Firenze 19 Marzo 2014 L importanza della vegetazione ripariale per la conservazione dei Chirotteri Paolo Agnelli & Giacomo Maltagliati Sezione di Zoologia
Modulo Operatore Censimento (muflone)
 Modulo Operatore Censimento (muflone) Abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico venatoria degli ungulati Regolamento Regionale n.3/12 Disciplina per la gestione degli ungulati
Modulo Operatore Censimento (muflone) Abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico venatoria degli ungulati Regolamento Regionale n.3/12 Disciplina per la gestione degli ungulati
7.1 Aree protette. La protezione della natura viene realizzata mediante. l istituzione di diverse tipologie di aree protette:
 NATURA Pagina 200.1 Aree protette Figura.1 Grado di urbanizzazione dei comuni della provincia di Lecco 200 L istituzione di aree protette in provincia di Lecco deve tener conto della diversa situazione
NATURA Pagina 200.1 Aree protette Figura.1 Grado di urbanizzazione dei comuni della provincia di Lecco 200 L istituzione di aree protette in provincia di Lecco deve tener conto della diversa situazione
Capitolo 3 IL PROGETTO LA CONNESSIONE ECOLOGICA PER LA BIODIVERSITÀ
 Capitolo 3 IL PROGETTO LA CONNESSIONE ECOLOGICA PER LA BIODIVERSITÀ Capitolo 3 - Il progetto la connessione ecologica per la biodiversità Nel corso del biennio 2008-2009 LIPU BirdLife Italia e Provincia
Capitolo 3 IL PROGETTO LA CONNESSIONE ECOLOGICA PER LA BIODIVERSITÀ Capitolo 3 - Il progetto la connessione ecologica per la biodiversità Nel corso del biennio 2008-2009 LIPU BirdLife Italia e Provincia
- Censimento degli alberi monumentali - Uso del suolo
 Dott. Marco Bagnoli - Censimento degli alberi monumentali - Uso del suolo ALBERI MONUMENTALI Quadro normativo: - la legge n. 60 del 1998 della Regione Toscana definisce alberi monumentali di alto pregio
Dott. Marco Bagnoli - Censimento degli alberi monumentali - Uso del suolo ALBERI MONUMENTALI Quadro normativo: - la legge n. 60 del 1998 della Regione Toscana definisce alberi monumentali di alto pregio
Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione
 Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione Regione Toscana Giornata di Partecipazione e Consultazione Pubblica ai fini della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del
Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione Regione Toscana Giornata di Partecipazione e Consultazione Pubblica ai fini della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del
8.8 Area Sardegna. Di seguito si riporta la lista degli interventi previsti nell Area Sardegna per i quali sono state sviluppate le schede intervento:
 8.8 Area Sardegna Di seguito si riporta la lista degli interventi previsti nell Area Sardegna per i quali sono state sviluppate le schede intervento: - Rete AT provincia Carbonia-Iglesias. Sezione I -
8.8 Area Sardegna Di seguito si riporta la lista degli interventi previsti nell Area Sardegna per i quali sono state sviluppate le schede intervento: - Rete AT provincia Carbonia-Iglesias. Sezione I -
AGGIORNAMENTO ALLEGATI CARTOGRAFICI
 REGIONE SICILIANA COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE STUDIO ECOLOGICO TERRITORIALE A SUPPORTO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE
REGIONE SICILIANA COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE STUDIO ECOLOGICO TERRITORIALE A SUPPORTO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE
Convegno Internazionale Progetto LIFE Arupa
 Convegno Internazionale Progetto LIFE Arupa Interventi di Conservazione dell Erpetofauna nell ambito dei progetti Life in corso di realizzazione nella Provincia di Foggia Mediateca Provinciale - Matera,
Convegno Internazionale Progetto LIFE Arupa Interventi di Conservazione dell Erpetofauna nell ambito dei progetti Life in corso di realizzazione nella Provincia di Foggia Mediateca Provinciale - Matera,
Inquadramento ittiofaunistico
 Dicembre 2014 CARATTERIZZAZIONE DELL ITTIOFAUNA E VERIFICA DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE NECESSARIE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PASSAGGIO PER PESCI SU UN OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TOSSIET (BACINO
Dicembre 2014 CARATTERIZZAZIONE DELL ITTIOFAUNA E VERIFICA DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE NECESSARIE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PASSAGGIO PER PESCI SU UN OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TOSSIET (BACINO
Salamandre, geotritoni, ululoni e rane: i soliti ignoti. Endemismi appenninici in Umbria
 Salamandre, geotritoni, ululoni e rane: i soliti ignoti. Endemismi appenninici in Umbria Cristiano Spilinga 1,2, Silvia Carletti 1,2, Francesca Montioni 1,2, Emi Petruzzi 1,2, Bernardino Ragni 1 1 Dipartimento
Salamandre, geotritoni, ululoni e rane: i soliti ignoti. Endemismi appenninici in Umbria Cristiano Spilinga 1,2, Silvia Carletti 1,2, Francesca Montioni 1,2, Emi Petruzzi 1,2, Bernardino Ragni 1 1 Dipartimento
CESENA Turdus pilaris. Stato giuridico. Stato di conservazione. Convenzione di Berna. Allegato III. Convenzione di Bonn.
 CESENA Turdus pilaris Distribuzione nel Paleartico occidentale Areale di svernamento Areale di presenza stabile Areale di nidificazione Stato giuridico Convenzione di Berna Convenzione di Bonn Direttiva
CESENA Turdus pilaris Distribuzione nel Paleartico occidentale Areale di svernamento Areale di presenza stabile Areale di nidificazione Stato giuridico Convenzione di Berna Convenzione di Bonn Direttiva
DESCRIZIONE QUALI- QUANTITATIVA DELLE PARTICELLE FORESTALI
 DESCRIZIONE QUALI- QUANTITATIVA DELLE PARTICELLE FORESTALI Che cosa è la descrizione particellare? Insieme dei rilievi effettuati per acquisire le informazioni necessarie per la pianificazione della gestione
DESCRIZIONE QUALI- QUANTITATIVA DELLE PARTICELLE FORESTALI Che cosa è la descrizione particellare? Insieme dei rilievi effettuati per acquisire le informazioni necessarie per la pianificazione della gestione
10) Via di Gello QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO. Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2
 10) Via di Gello QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...7 Clima acustico e piano
10) Via di Gello QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...7 Clima acustico e piano
RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA
 RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA SETTEMBRE 2015 Indice 1. Andamento meteorologico mensile... 2 2. Mappe dei principali parametri meteorologici... 3 2.1. Temperature... 3 2.2. Precipitazioni...
RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA SETTEMBRE 2015 Indice 1. Andamento meteorologico mensile... 2 2. Mappe dei principali parametri meteorologici... 3 2.1. Temperature... 3 2.2. Precipitazioni...
Dall incarico all autorizzazione dell intervento
 A.A. 2012/2013 Cantieri forestali Dall incarico all autorizzazione dell intervento Dott. for. Luca Calienno Email: calienno.luca@gmail.com Primo contatto informale Visure catastali per nominativo ed eventuale
A.A. 2012/2013 Cantieri forestali Dall incarico all autorizzazione dell intervento Dott. for. Luca Calienno Email: calienno.luca@gmail.com Primo contatto informale Visure catastali per nominativo ed eventuale
27) Calambrone Ospedale
 27) Calambrone Ospedale QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione... 2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione... 5 Clima acustico
27) Calambrone Ospedale QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione... 2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione... 5 Clima acustico
Via Milazzo sud QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO. Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2
 Via Milazzo sud QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...6 Clima acustico e piano
Via Milazzo sud QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...6 Clima acustico e piano
Le misure del Piano di Gestione delle Acque per i corpi idrici in relazione all uso idroelettrico
 Le misure del Piano di Gestione delle Acque per i corpi idrici in relazione all uso idroelettrico Andrea Braidot Autorità di Bacino fiumi Alto Adriatico Tolmezzo, 5 maggio 2015 Altre misure di base (art.
Le misure del Piano di Gestione delle Acque per i corpi idrici in relazione all uso idroelettrico Andrea Braidot Autorità di Bacino fiumi Alto Adriatico Tolmezzo, 5 maggio 2015 Altre misure di base (art.
Spesso la pianura è attraversata da corsi d'acqua e per questo è un ambiente favorevole a molte attività umane e soprattutto all'agricoltura.
 LA PIANURA La pianura ha un'altitudine inferiore a 200 metri. In pianura non ci sono i rilievi. Le strade sono comode, molto trafficate, poco tortuose e prive ripide salite e discese. Ci sono autostrade,
LA PIANURA La pianura ha un'altitudine inferiore a 200 metri. In pianura non ci sono i rilievi. Le strade sono comode, molto trafficate, poco tortuose e prive ripide salite e discese. Ci sono autostrade,
Dott. Nat. Vito Santarcangelo Phd. Ingegneria del Territorio e dell Ambiente Agro-Forestale
 Dott. Nat. Vito Santarcangelo Phd. Ingegneria del Territorio e dell Ambiente Agro-Forestale Parco della Murgia materana - ZSC «Gravine di Matera» LIFE ARUPA Azioni preparatorie A4: Realizzazione di studi
Dott. Nat. Vito Santarcangelo Phd. Ingegneria del Territorio e dell Ambiente Agro-Forestale Parco della Murgia materana - ZSC «Gravine di Matera» LIFE ARUPA Azioni preparatorie A4: Realizzazione di studi
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Regolamento Tagli Boschivi Deliberazione commissariale 11 settembre 2007 n.
 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Regolamento Tagli Boschivi Deliberazione commissariale 11 settembre 2007 n. 19 VISTE La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree Protette
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Regolamento Tagli Boschivi Deliberazione commissariale 11 settembre 2007 n. 19 VISTE La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree Protette
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA COMUNI DI ORANI E SARULE
 0 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA COMUNI DI ORANI E SARULE PIANO DI GESTIONE DEL SIC MONTE GONARE ITB021156 A CURA DI PROF. IGNAZIO CAMARDA (COORDINATORE, ASPETTI BOTANICI) ING. SEBASTIANO CARTA (PIANIFICAZIONE)
0 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA COMUNI DI ORANI E SARULE PIANO DI GESTIONE DEL SIC MONTE GONARE ITB021156 A CURA DI PROF. IGNAZIO CAMARDA (COORDINATORE, ASPETTI BOTANICI) ING. SEBASTIANO CARTA (PIANIFICAZIONE)
Dichiarazione tecnica allegata all'istanza di compatibilità paesaggistica (sanatoria)
 In allegato alla dichiarazione di Codice fiscale Dichiarazione tecnica allegata all'istanza di compatibilità paesaggistica (sanatoria) Ai sensi dell'articolo 167 del Decreto Legislativo 22/01/2004 Il sottoscritto
In allegato alla dichiarazione di Codice fiscale Dichiarazione tecnica allegata all'istanza di compatibilità paesaggistica (sanatoria) Ai sensi dell'articolo 167 del Decreto Legislativo 22/01/2004 Il sottoscritto
Status della popolazione di camoscio del Parco Nazionale della Val Grande. Guido Tosi ed Eugenio Carlini
 Status della popolazione di camoscio del Parco Nazionale della Val Grande Guido Tosi ed Eugenio Carlini Supervisione scientifica di: Guido Tosi e Adriano Martinoli A cura di: Eugenio Carlini, Barbara Chiarenzi,
Status della popolazione di camoscio del Parco Nazionale della Val Grande Guido Tosi ed Eugenio Carlini Supervisione scientifica di: Guido Tosi e Adriano Martinoli A cura di: Eugenio Carlini, Barbara Chiarenzi,
RELAZIONE GENERALE: IL PROGETTO ARUPA
 PROGETTO ARUPA CONVEGNO INTERNAZIONALE CONCLUSIVO RELAZIONE GENERALE: IL PROGETTO ARUPA Prof. Ing. Pietro PICUNO Università degli Studi della Basilicata Il Progetto ARUPA Il Progetto ARUPA AZIONI URGENTI
PROGETTO ARUPA CONVEGNO INTERNAZIONALE CONCLUSIVO RELAZIONE GENERALE: IL PROGETTO ARUPA Prof. Ing. Pietro PICUNO Università degli Studi della Basilicata Il Progetto ARUPA Il Progetto ARUPA AZIONI URGENTI
UTOE 30 Putignano Via Ximenes - servizi
 UTOE 30 Putignano Via Ximenes - servizi QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Localizzazione, descrizione dell area... 2 Pericolosità idraulica... 5 Clima acustico e piano comunale di classificazione acustica...
UTOE 30 Putignano Via Ximenes - servizi QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Localizzazione, descrizione dell area... 2 Pericolosità idraulica... 5 Clima acustico e piano comunale di classificazione acustica...
Rifugio Escursionistico Riserva Naturale del Pigelleto Monte Amiata -
 La Riserva Naturale del Pigelleto La Riserva Naturale del Pigelleto, istituita dalla provincia di Siena nel 1996, è collocata sul versante sud occidentale del Monte Amiata e si estende per 862 Ha ad una
La Riserva Naturale del Pigelleto La Riserva Naturale del Pigelleto, istituita dalla provincia di Siena nel 1996, è collocata sul versante sud occidentale del Monte Amiata e si estende per 862 Ha ad una
Gestione dei popolamenti ittici selvatici
 Gestione dei popolamenti ittici selvatici Argomenti Importanza della gestione Ripopolamenti Introduzione di specie ittiche non indigene (NIS) Inquinamento genetico Recupero dei ceppi autoctoni Gestione
Gestione dei popolamenti ittici selvatici Argomenti Importanza della gestione Ripopolamenti Introduzione di specie ittiche non indigene (NIS) Inquinamento genetico Recupero dei ceppi autoctoni Gestione
Dentro, intorno e lungo il fiume: di acque, di erbe e di animali
 Dentro, intorno e lungo il fiume: di acque, di erbe e di animali Calvatone Sede Parco Oglio Sud 13 marzo 2015 ore 21.00 Presentazione dei dati dei censimenti: farnie, rana di lataste, avifauna acquatici
Dentro, intorno e lungo il fiume: di acque, di erbe e di animali Calvatone Sede Parco Oglio Sud 13 marzo 2015 ore 21.00 Presentazione dei dati dei censimenti: farnie, rana di lataste, avifauna acquatici
Gli aspetti di sistemazione idrogeologica e idraulica nel loro rapporto con il PdG Po. Ing. Lorenzo Masoero Geol. Giorgio Gaido
 Gli aspetti di sistemazione idrogeologica e idraulica nel loro rapporto con il PdG Po Ing. Lorenzo Masoero Geol. Giorgio Gaido SCALETTA INTERVENTO principali strumenti di pianificazione ed i loro obiettivi
Gli aspetti di sistemazione idrogeologica e idraulica nel loro rapporto con il PdG Po Ing. Lorenzo Masoero Geol. Giorgio Gaido SCALETTA INTERVENTO principali strumenti di pianificazione ed i loro obiettivi
3.2 Descrizione di eventuali impatti ambientali dovuti all opera e misure compensative da prevedersi
 3.2 Descrizione di eventuali impatti ambientali dovuti all opera e misure compensative da prevedersi 3.2.1 Verifica della compatibilità dell opera con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione
3.2 Descrizione di eventuali impatti ambientali dovuti all opera e misure compensative da prevedersi 3.2.1 Verifica della compatibilità dell opera con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione
LIFE14 IPE/IT/018 - GESTIRE 2020
 LIFE14 IPE/IT/018 - GESTIRE 2020 Andrea Agapito Ludovici WWF Italia 20 e 21 luglio 2016 Conferenza iniziale del progetto Stia (Ar) LIFE 14 NAT IT 000759 WetFlyAmphibia Project leader: Regione Lombardia
LIFE14 IPE/IT/018 - GESTIRE 2020 Andrea Agapito Ludovici WWF Italia 20 e 21 luglio 2016 Conferenza iniziale del progetto Stia (Ar) LIFE 14 NAT IT 000759 WetFlyAmphibia Project leader: Regione Lombardia
UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI D ACQUA E STRUMENTO DI MONITORAGGIO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
 2 Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale Riqualificazione fluviale e gestione del territorio 6-7 novembre 2012, Bolzano UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI
2 Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale Riqualificazione fluviale e gestione del territorio 6-7 novembre 2012, Bolzano UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI
Francesca Ossola ERSAF Lombardia. ERSAF Ente regionale per i servizi all agricoltura e alle foreste
 EXPERIENCES OF CONSERVATION AND INCREASE OF BIODIVERSITY IN FOREST PLANT PRODUCTION IN LOMBARDIA REGION CENTRO VIVAISTICO FORESTALE REGIONALE DI CURNO per la conservazione della biodiversità forestale
EXPERIENCES OF CONSERVATION AND INCREASE OF BIODIVERSITY IN FOREST PLANT PRODUCTION IN LOMBARDIA REGION CENTRO VIVAISTICO FORESTALE REGIONALE DI CURNO per la conservazione della biodiversità forestale
PIANO DI ASSESTAMENTO E GESTIONE FORESTALE
 PIANO DI ASSESTAMENTO E GESTIONE FORESTALE Il piano di gestione e assestamento forestale (PGAF) è un documento tecnico a validità pluriennale (10-20 anni) con il quale vengono definiti gli obiettivi che
PIANO DI ASSESTAMENTO E GESTIONE FORESTALE Il piano di gestione e assestamento forestale (PGAF) è un documento tecnico a validità pluriennale (10-20 anni) con il quale vengono definiti gli obiettivi che
Varallo 25 Febbraio I siti della Rete Natura 2000 in Valsesia e La procedura di valutazione di incidenza
 Varallo 25 Febbraio 2016 I siti della Rete Natura 2000 in Valsesia e La procedura di valutazione di incidenza I siti della Rete Natura 2000 in Valsesia: S.I.C. IT1120028 Alta Valsesia ZPS IT 1120027 Alta
Varallo 25 Febbraio 2016 I siti della Rete Natura 2000 in Valsesia e La procedura di valutazione di incidenza I siti della Rete Natura 2000 in Valsesia: S.I.C. IT1120028 Alta Valsesia ZPS IT 1120027 Alta
alla Provincia di Foggia Settore Servizi Geologici, Politiche delle Risorse Idriche e Protezione Civile via Telesforo, Foggia
 alla Provincia di Foggia Settore Servizi Geologici, Politiche delle Risorse Idriche e Protezione Civile via Telesforo, 25 71122 Foggia Domanda di autorizzazione alla escavazione di un pozzo a scopo di
alla Provincia di Foggia Settore Servizi Geologici, Politiche delle Risorse Idriche e Protezione Civile via Telesforo, 25 71122 Foggia Domanda di autorizzazione alla escavazione di un pozzo a scopo di
Oggetto: aree umide del Comune di Fossano ricadenti nella ZPS IT ; segnalazione grave stato di abbandono, minacce e danni.
 Alla Regione Piemonte Pianificazione Aree Protette Via Nizza 18 10125 Torino c.a. dott. Ermanno De Biaggi Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Prov. le Via Gobetti 18 12100 Cuneo e p.c. al Comune
Alla Regione Piemonte Pianificazione Aree Protette Via Nizza 18 10125 Torino c.a. dott. Ermanno De Biaggi Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Prov. le Via Gobetti 18 12100 Cuneo e p.c. al Comune
Capo I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto
 Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dimesse o in abbandono e di riutilizzo
Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dimesse o in abbandono e di riutilizzo
Servizio Territoriale di Sassari
 Servizio Territoriale di Sassari PIANO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE (Sus scrofa meridionalis) NEL PARCO REGIONALE DI PORTO CONTE. Risultati del censimento pre-catture Piano 2011-2013 [6,
Servizio Territoriale di Sassari PIANO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE (Sus scrofa meridionalis) NEL PARCO REGIONALE DI PORTO CONTE. Risultati del censimento pre-catture Piano 2011-2013 [6,
Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche. a) Relazione b) Norme di attuazione
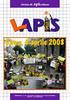 Provincia Autonoma di Trento Assessorato all Urbanistica, Ambiente e Lavori pubblici Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche a) Relazione
Provincia Autonoma di Trento Assessorato all Urbanistica, Ambiente e Lavori pubblici Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche a) Relazione
UTOE 3 Via Bonanno QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO. Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2
 UTOE 3 Via Bonanno QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...5 Clima acustico e
UTOE 3 Via Bonanno QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...5 Clima acustico e
Glossario e architettura del piano
 Ing. Andrea Braidot dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- Bacchiglione dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del fiume Adige Glossario essenziale del piano dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del
Ing. Andrea Braidot dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- Bacchiglione dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del fiume Adige Glossario essenziale del piano dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del
CAMOSCIO (Rupicapra rupicapra)
 CAMOSCIO (Rupicapra rupicapra) I censimenti di camosci nel PAVPT, a partire dal 1981, sono stati realizzati dal personale di vigilanza, con il coordinamento dello scrivente, mediante metodologia approvata
CAMOSCIO (Rupicapra rupicapra) I censimenti di camosci nel PAVPT, a partire dal 1981, sono stati realizzati dal personale di vigilanza, con il coordinamento dello scrivente, mediante metodologia approvata
Il risanamento ambientale del lago di Viverone: un obiettivo per la Provincia di Biella, possibilità di utilizzo delle fasce tampone
 Il risanamento ambientale del lago di Viverone: un obiettivo per la Provincia di Biella, possibilità di utilizzo delle fasce tampone Matteo Massara Biella, 28 settembre 2007 Il lago di Viverone è un importante
Il risanamento ambientale del lago di Viverone: un obiettivo per la Provincia di Biella, possibilità di utilizzo delle fasce tampone Matteo Massara Biella, 28 settembre 2007 Il lago di Viverone è un importante
COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA VALLE DI SCALVE
 COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA VALLE DI SCALVE 166 Comprensorio Alpino di Caccia Val di Scalve Comuni appartenenti all ambito. Caratteristiche ambientali Vocazioni e potenzialità faunistiche del territorio
COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA VALLE DI SCALVE 166 Comprensorio Alpino di Caccia Val di Scalve Comuni appartenenti all ambito. Caratteristiche ambientali Vocazioni e potenzialità faunistiche del territorio
Gamberi di fiume alieni invasivi nel Veronese Pordenone, 19 giugno 2014
 Ivano Confortini Provincia di Verona Gamberi di fiume alieni invasivi nel Veronese Pordenone, 19 giugno 2014 Reticolo idrografico della provincia di Verona In provincia di Verona vi sono circa 800 corsi
Ivano Confortini Provincia di Verona Gamberi di fiume alieni invasivi nel Veronese Pordenone, 19 giugno 2014 Reticolo idrografico della provincia di Verona In provincia di Verona vi sono circa 800 corsi
Il progetto GESPO: Linee guida per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica
 19 marzo 2014 Firenze Palazzo Medici Riccardi Sala Pistelli Il progetto GESPO: Linee guida per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica
19 marzo 2014 Firenze Palazzo Medici Riccardi Sala Pistelli Il progetto GESPO: Linee guida per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica
14) San Piero a Grado
 14) San Piero a Grado QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...6 Clima acustico
14) San Piero a Grado QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...6 Clima acustico
IL RUOLO DEL POLITICA REGIONALE PER LA TUTELA DELLA DELLE ACQUE
 IL RUOLO DEL MONITORAGGIO NELLA POLITICA REGIONALE PER LA TUTELA DELLA DELLE ACQUE Bari, novembre 2010 Regione Puglia Servizio Tutela delle Acque Dott.ssa M.A. Iannarelli LA TUTELA DELLE ACQUE ANALISI
IL RUOLO DEL MONITORAGGIO NELLA POLITICA REGIONALE PER LA TUTELA DELLA DELLE ACQUE Bari, novembre 2010 Regione Puglia Servizio Tutela delle Acque Dott.ssa M.A. Iannarelli LA TUTELA DELLE ACQUE ANALISI
ODONATA.IT SOCIETA ITALIANA PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DELLE LIBELLULE
 ODONATA.IT SOCIETA ITALIANA PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DELLE LIBELLULE Stefano Aguzzi CHI SIAMO Associazione scientifica che promuove la ricerca odonatologica di base e applicata, la divulgazione
ODONATA.IT SOCIETA ITALIANA PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DELLE LIBELLULE Stefano Aguzzi CHI SIAMO Associazione scientifica che promuove la ricerca odonatologica di base e applicata, la divulgazione
LIFE IP GESTIRE 2020: azioni di tutela della biodiversità forestale
 LIFE IP GESTIRE 2020: azioni di tutela della biodiversità forestale CONSERVAZIONE BIODIVERSITA FORESTALE In Lombardia la superfice forestale è circa 626.000 ha (Rapporto Stato Foreste 2015) Il 19% (circa
LIFE IP GESTIRE 2020: azioni di tutela della biodiversità forestale CONSERVAZIONE BIODIVERSITA FORESTALE In Lombardia la superfice forestale è circa 626.000 ha (Rapporto Stato Foreste 2015) Il 19% (circa
