APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE DI TELERILEVAMENTO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL VIGNETO
|
|
|
- Amerigo Rossa
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PERRIA ET AL., APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE DI TELERILEVAMENTO NELLA GESTIONE DEL VIGNETO, PAG. 1 APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE DI TELERILEVAMENTO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL VIGNETO Rita PERRIA, Paolo STORCHI CRA - VIC Unità di ricerca per la Viticoltura Via Romea, Arezzo rita.perria@entecra.it Lavoro presentato alla 7^ edizione di Enoforum, Arezzo, 3-5 maggio 2011 Introduzione La viticoltura convenzionale sottopone uno stesso appezzamento alle stesse tecniche colturali, tuttavia una gestione ottimale dovrebbe tener conto delle differenze che le variabili chimico-fisico e biologiche esprimono su un agro ecosistema; è definita agricoltura di precisione la gestione agricola che tiene conto della variabilità intrinseca e indotta del suolo e delle specifiche esigenze delle colture al fine di migliorare la produzione, minimizzare i danni ambientali ed elevare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli (Pierce e Nowak, 1990). Tale gestione si avvale di metodi e tecnologie che sono in grado di apprezzare la variabilità su un area agricola, di conoscere lo stato e le necessità fisiologiche di ogni singola pianta, e di macchine operatrici adatte alla distribuzione differenziata dei fattori di produzione in relazione alle reali esigenze e alla variabilità spaziale e temporale. Col termine viticoltura di precisione ci si riferisce alla gestione informatizzata di tutte le conocenze relative a porzioni sempre più piccole di un appezzamento fino ad arrivare alla singola pianta (Dosso e Spezia, 2006) e che prevede l uso di macchine in grado di relazionarsi col GIS aziendale (Spezia, 2006). Le tecniche della viticoltura di precisione possono essere suddivise in tecniche di acquisizione di informazioni, gestione ed elaborazione delle informazioni acquisite, trasferimento delle informazioni alle macchine operatrici. Questo lavoro sarà incentrato sul ruolo che le tecniche di rilevamento aereo hanno nell acquisizione di informazioni utili alla gestione differenziata del vigneto. I dati acquisiti su singole piante in campo offrono informazioni puntuali che possono essere spazializzate grazie alle relazioni esistenti fra questi parametri e i dati multispettrali telerilevati consentendo la creazione di mappe relative a diversi parametri del vigneto (Dabas et al., 2001, Hall et al., 2003, Da Costa et al., 2006). Fino a non molti anni fa i costi di acquisizione di immagini da aereo o da satellite erano molto alti impedendo di fatto la diffusione della tecnica, negli anni questi costi si sono notevolmente abbassati rendendo più semplice anche per la singola azienda l acquisizione di mappe multispettrali da cui ottenere mappe tematiche di interesse per l agricoltore, a dettaglio sempre maggiore, gestibili da macchine operatrici a rateo variabile a controllo GPRS, anche queste sempre maggiormente diffuse. Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare la relazione esistente fra i parametri fisiologici, produttivi ed enologici rilevati e i dati telerilevati, per evidenziare e valorizzare la variabilità esistente all interno dei vigneti situati in due diverse aziende del Chianti Classico con due finalità diverse, in una situazione l obiettivo aziendale è quello di individuare zone produttive di maggior qualità allo scopo di produrre vini di pregio da determinate aree e integrare con i risultati del telerilevamento il progetto di zonazione vinicola aziendale, nella seconda azienda la finalità ultima del lavoro è stata quella di individuare zone a diversa vigoria per una gestione del vigneto con macchine a rateo variabile e quindi adottare una gestione di precisione in azienda. Materiali e metodi Oggetto di studio sono stati due vigneti uno denominato Torricella, l altro denominato San Giusto di pertinenza di due diverse aziende ricadenti nella zona di produzione del Chianti Classico. Entrambi i vigneti sono coltivati a Sangiovese potato a cordone speronato, innestato su 110 Richter nel vigneto Torricella e su 420 A nel vigneto San Giusto. Il vigneto Torricella si estende
2 PERRIA ET AL., APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE DI TELERILEVAMENTO NELLA GESTIONE DEL VIGNETO, PAG. 2 per 14 ha nel comune di Gaiole in Chianti, situato a 345 m s.l.m, è stato impiantato nel 2000 ed è gestito con inerbimento spontaneo a file alterne, il sesto d impianto è di 2,10 tra le file e 0,80 sulla fila. Il vigneto San Giusto ha un estensione di circa 10 ha, nel comune di Castelnuovo Berardenga, a circa 315 m s.l.m., è stato impiantato nel 2000, ha un sesto d impianto di 2,50 tra le file e 0,8 sulla fila, il terreno viene lavorato nell interfilare. Sui vigneti, nel 2010, sono stati rilevati alcuni parametri vegeto produttivi in corrispondenza delle date di acquisizione dei dati tele rilevati e i parametri produttivi al momento della vendemmia, considerando come momento della vendemmia quello deciso dall organizzazione aziendale. I voli per l acquisizione dei dati sono stati effettuati nei mesi di giugno, luglio e agosto utilizzando un sistema DFR in grado di registrare immagini in colori reali, falsi colori e termiche. Lo schema di campionamento nei due vigneti è stato adeguato alle ricerche già in corso. Nel vigneto Torricella sono installati da alcuni anni dei punti di monitoraggio dell umidità del suolo con il sistema FDR (Frequency Dominance Reflectometry) (Perria et al. 2009) pertanto le aree indagate in modo puntuale sono quelle intorno ai pozzetti dell FDR, si tratta di 4 aree costituite da tre filari contigui per 10 piante sul filare. All interno di quest area sono state eseguiti i rilievi utilizzando i tre filari come ripetizioni. Nel vigneto San Giusto le aree da indagare in modo puntuale sono state scelte in base a un precedente indagine geoelettrica per lo studio delle caratteristiche del suolo (Tabbagh et al., 2000), che ha individuato 5 aree a diversa resistività (Vieri et al., 2010), nelle quali sono stati eseguiti rilievi sullo stato idrico della pianta su 5 ripetizioni e sulla produzione su 3 ripetizioni per area. Nel vigneto Torricella è stato misurato l allungamento dei germogli dalla data di germogliamento al 4 giugno, cioè prima della prima cimatura effettuata a metà giugno; sono stati rilevati potenziali idrici fogliari con camera a pressione di Scholander secondo la metodologia indicata in Chone et al. (2001) durante la stagione estiva. A causa dell andamento climatico, che nell estate 2010 è stato particolarmente piovoso, è stato possibile effettuare solo due misure di potenziale idrico fogliare che evidenziasse differenze significative fra le aree. Nel vigneto San Giusto è stato possibile effettuare 3 misure del potenziale idrico fogliare. In entrambi i vigneti, in corrispondenza del secondo volo, sono state prelevate le foglie per la valutazione del contenuto in clorofilla tramite estrazione in metanolo e misura dell estratto con lo spettrofotometro. Alla vendemmia su entrambi i vigneti è stata pesata la produzione totale per pianta per un totale di 5 piante a ripetizione, e il numero di grappoli per pianta; inoltre sono stati raccolti dei campioni d uva per effettuare le analisi tecnologiche sul mosto (contenuto in zuccheri, acidità, ph). Fig. 1 Componenti del sistema DFR: GPS, INS/GPS, camera multispettrale, camera termica, camera digitale, altimetro laser. Tutti i dati raccolti sono stati messi in relazione con i dati telerilevati con il sistema DFR, cioè con un sistema di telerilevamento multi spettrale sviluppato da Terrasystem s.r.l. (Spin off dell Università della Tuscia di Viterbo) che acquisisce nelle bande del visibile, del vicino infrarosso e termico, è composto da camere multi spettrali e termiche, sistemi GPS e GPS/INS, altimetro laser (fig. 1), integrati in un unico sistema di acquisizione. Da tutte le immagini acquisite sono state selezionate quelle più adatte, sono state corrette le deformazioni e riportate il coordinate WGS84 UTM32, i dati sono stati rielaborati, dal dato termico è stata ottenuta la stima della temperatura superficiale. Sono state elaborate le immagini dell indice di vegetazione NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) combinando le bande del rosso e dell infrarosso per ottenere poi le mappe di vigore in cui i valori sono stati riclassificati in tre classi di alta, media e bassa vigoria.
3 PERRIA ET AL., APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE DI TELERILEVAMENTO NELLA GESTIONE DEL VIGNETO, PAG. 3 Oltre alle mappe di vigoria sono state ottenute delle mappe di stress idrico potenziale calcolando il WDI (Water Deficit Index) (Moran et al., 1994), indice legato al contenuto di umidità del suolo e allo stato idrico delle colture. Il calcolo del WDI si basa sulla definizione di due stati potenziali estremi (wet e dry conditions), dalle posizione relativa rispetto a questi due stati dipende il WDI che cresce da 0 a 1 al crescere delle condizioni di stress idrico. La mappa di WDI ottenuta è stata suddivisa in tre classi: stress assente, medio, alto. La relazione fra dati campionati in campo e telerilevati è stata valutata mediante analisi di regressione semplice. Risultati e conclusioni Dalla correlazione significativa riscontrata fra le mappe di NDVI e i dati derivanti dai campionamenti sono state ottenute le mappe di stima dei parametri enologici (fig. 2), raggruppando per classe di vigoria i dati medi dei parametri vegeto produttivi ed enologici. Fig. 2 Mappa derivata del contenuto medio in zuccheri riduttori, suddivisa in 5 classi. Le regressioni lineari maggiormente significative riscontrate fra parametri rilevati in campo e NDVI sono riportate in tab. 1 per il vigneto San Giusto e in tab. 2 per il vigneto Torricella. Come ci si attendeva la migliore correlazione è stata ottenuta con il contenuto in clorofilla nelle foglie, si riporta a titolo di esempio il grafico relativo al contenuto in clorofilla A (R 2 = 0.9 p-value = 0.00) (fig. 3). Considerando il contenuto idrico del suolo e lo stato idrico della pianta risulta che il potenziale idrico fogliare espresso in MPa è significativamente correlato con la il WDI determinato col volo di agosto e l umidità del suolo nello strato superficiale con il WDI determinato a luglio nel vigneto Torricella, nel vigneto San Giusto la correlazione fra potenziale idrico fogliare e indice WDI determinati nelle stesse date è stata sempre significativa. Fig. 3 Grafico a dispersione della relazione esistente fra contenuto in clorofilla A nelle foglie determinato con misura allo spettrofotometro dell estratto in metanolo.
4 PERRIA ET AL., APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE DI TELERILEVAMENTO NELLA GESTIONE DEL VIGNETO, PAG. 4 Ac. Titolabile Contenuto in polifenoli nelle uve Produzione per pianta Antociani estraibili Peso medio degli acini WDI agosto e agosto NDVI agosto Tab. 1 - Relazioni fra parametri rilevati in campo e NDVI derivati dai dati telerilevati (vigneto San Giusto). Ac. Titolabile Azoto prontamente e assimilabile agosto Contenuto in zuccheri riduttori Contenuto in clorofilla A Lunghezza del germoglio N. grappoli/pianta NDVI agosto Il lavoro, pur nella sua prima fase, essendo riferito a un solo anno di studio, conferma che le tecniche di indagine multispettrale, integrate da una base informativa tradizionale, possono essere applicate alla gestione differenziata del vigneto. In particolare nelle situazioni qui riportate la creazione di mappe relative allo stato di vigoria del vigneto, allo stato idrico della coltura e di mappe tematiche relative ai parametri qualitativi delle uve fa da supporto decisionale alla produzione di vini da zone diverse a livello aziendale, consentendo inoltre una diversa gestione delle aree in relazione anche alla qualità del prodotto che si vuole ottenere. L indagine proseguirà per valutare la ripetibilità dei risultati in diverse annate. Il presente studio dovrà essere ulteriormente approfondito valutando l efficacia che l utilizzo delle tecniche dell agricoltura di precisione hanno nel migliorare la competitività delle aziende agricole. Tab. 2 - Relazioni fra parametri rilevati in campo e NDVI derivati dai dati tele rilevati (vigneto Torricella). Ringraziamenti Lo studio è stato possibile grazie al finanziamento ricevuto dalla Regione Toscana nell ambito del progetto IMViTo. Gli autori ringraziano i partner del progetto che hanno collaborato a questa fase, in particolare il prof. Marco Vieri dell Università degli Studi di Firenze, i colleghi del CRA-VIC che hanno partecipato ai rilievi. Si ringraziano inoltre le aziende nelle quali è stato possibile svolgere la ricerca: Az. Agricola Barone Ricasoli S.p.A. di Gaiole in Chianti (SI) e MPS Tenimenti Poggio Bonelli e Chigi Saracini Società Agricola - S.p.A. di Castelnuovo Berardenga (SI). Bibliografia Choné X., Van Leeuwen C., Dubourdieu D., Gaudillère J.P Stem water potential is a sensitive indicator of grapevine water status. Annals of Botany, 87 (4), Dabas M., Tabbagh J., Boisgontier D Multi-depth continuous electrical profiling (MuCep) for characterization of in-field variability. In: Grenier G, Blackmore S (eds) Proceedings of the 3 rd European conference on precision agriculture, Montpellier, France, Da Costa J.P., Michelet F., Germain C., Lavialle O., Grenier G Delineation of vine parcels by segmentation of high resolution remote sensed images. Precision Agricolture. 8, Dosso P Viticoltura di precisione: ritorno al passato? VQ. 3, Dosso P., Spezia G Viticoltura di precision grande risorsa per il future. Informatore agrario. 24, Hall A., Louis J., Lamb D.W Characterizing and mapping vineyard canopy using high spatial resolution aerial multispectral images. Comput Geosci 29 (7), Moran M.S., Clarke T. R., Inoue Y., Vidal A Estimating crop water deficit using the relation between surface-air temperature and spectral vegetation index. Remote Sensing of Environment. 46, Perria R. Agnelli A. E., Costantini E.A.C Calibrazione in campo del Diviner 2000, per la stima dell umidità del suolo. Convegno Nazionale della Società Italiana di Scienza del Suolo. Perugia 17-19
5 PERRIA ET AL., APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE DI TELERILEVAMENTO NELLA GESTIONE DEL VIGNETO, PAG. 5 Giugno. Pierce F.S., Nowak P., Aspects of precision agriculture. Advances in Agronomy. 67, Tabbagh M., Dabas A., Hesse C. Panissod C. 2000: Soil resistivity: a non-invasive tool to map soil structure horizon, Geoderma. 97, Vieri M., Spezia G., Pagni P Ingegneria delle produzioni viticole: stato dell arte e future applicazioni. Italus Hortus. 17 (1), Riassunto Le esigenze di orientare l agricoltura verso interventi di maggiore sostenibilità, e di economicità di gestione e la necessità di ottenere elevati standard qualitativi, possono ricevere nuovi impulsi dall applicazione delle tecnologie di telerilevamento. Nel presente lavoro vengono esposti i risultati ottenuti da uno studio svoltosi nel Chianti Classico, su due vigneti di Sangiovese. I dati telerilevati sono stati acquisiti con sensori DFR nelle bande del visibile, del vicino infrarosso e del termico; sono stati corretti radiometricamente, ortoproiettati ed elaborati in indici di vegetazione multispettrali. Sono stati effettuati tre voli durante la stagione vegetativa e contemporaneamente sono stati rilevati diversi parametri sulle viti: lunghezza dei germogli; contenuto in clorofilla e potenziale idrico fogliare; alla vendemmia sono stati eseguiti controlli sulla produzione e sulle caratteristiche chimiche delle uve. Dall analisi statistica delle relazioni fra parametri rilevati in campo e variabili telerilevate sono poi state elaborate diverse mappe. I risultati ottenuti permettono alle aziende di razionalizzare gli interventi nei vigneti per limitare le differenze interne dovute a fattori ambientali, ed allo stesso tempo individuare porzioni di vigneto da destinare alla produzione di cru di livello superiore.
Workshop NutriVigna Strumenti e servizi innovativi per la nutrizione minerale di precisione del vigneto
 Workshop NutriVigna Strumenti e servizi innovativi per la nutrizione minerale di precisione del vigneto Tecniche di precisione per la fertilizzazione del vigneto Matteo Gatti Crast UCSC Laboratori partner
Workshop NutriVigna Strumenti e servizi innovativi per la nutrizione minerale di precisione del vigneto Tecniche di precisione per la fertilizzazione del vigneto Matteo Gatti Crast UCSC Laboratori partner
Risultati Progetti su irrigazione, olivo, agricoltura biologica e germoplasma orticole IRRIGAZIONE DELLA VITE NELLE MARCHE
 UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI AGRARIA Risultati Progetti su irrigazione, olivo, agricoltura biologica e germoplasma orticole RIGAZIONE DELLA VITE NELLE MARCHE Microirrigazione: progetti
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI AGRARIA Risultati Progetti su irrigazione, olivo, agricoltura biologica e germoplasma orticole RIGAZIONE DELLA VITE NELLE MARCHE Microirrigazione: progetti
Una viticoltura sostenibile con l applicazione delle tecniche di viticoltura di precisione
 Una viticoltura sostenibile con l applicazione delle tecniche di viticoltura di precisione LE NUOVE PAROLE GUIDA PER LA VITICOLTURA DI DOMANI SARANNO Sostenibilità economica Compatibilità ambientale Multifunzionalità
Una viticoltura sostenibile con l applicazione delle tecniche di viticoltura di precisione LE NUOVE PAROLE GUIDA PER LA VITICOLTURA DI DOMANI SARANNO Sostenibilità economica Compatibilità ambientale Multifunzionalità
GIS e GPS a supporto dell'agricoltura di precisione
 Roma 15-16 Aprile 2015 Ergife Palace Hotel GIS e GPS a supporto dell'agricoltura di precisione Ing. Guido Fastellini, PhD. Topcon Positioning Italy AGRICOLTURA DI PRECISIONE E FINITA L ERA DEL MODELLO
Roma 15-16 Aprile 2015 Ergife Palace Hotel GIS e GPS a supporto dell'agricoltura di precisione Ing. Guido Fastellini, PhD. Topcon Positioning Italy AGRICOLTURA DI PRECISIONE E FINITA L ERA DEL MODELLO
LA GESTIONE DEL VIGNETO: LA POTATURA SECCA
 LA GESTIONE DELLA CHIOMA E LA QUALITÀ DELL UVA LA GESTIONE DEL VIGNETO: LA POTATURA SECCA Rosario Di Lorenzo Dipartimento di Colture Arboree Palermo EQUILIBRIO Relazione tra quantità e qualità dell uva
LA GESTIONE DELLA CHIOMA E LA QUALITÀ DELL UVA LA GESTIONE DEL VIGNETO: LA POTATURA SECCA Rosario Di Lorenzo Dipartimento di Colture Arboree Palermo EQUILIBRIO Relazione tra quantità e qualità dell uva
IL PARTENARIATO PER L INNOVAZIONE NEL SISTEMA AGROALIMENTARE
 IL PARTENARIATO PER L INNOVAZIONE NEL SISTEMA AGROALIMENTARE AGRICOLTURA DI PRECISIONE Ancona, 27 Febbraio 2015 Graziano Brandoni AGRICOLTURA 2020 LA NUOVA PAC 2014-2020 PRODUTTIVITA COMPETITIVITA SOSTENIBILITA
IL PARTENARIATO PER L INNOVAZIONE NEL SISTEMA AGROALIMENTARE AGRICOLTURA DI PRECISIONE Ancona, 27 Febbraio 2015 Graziano Brandoni AGRICOLTURA 2020 LA NUOVA PAC 2014-2020 PRODUTTIVITA COMPETITIVITA SOSTENIBILITA
L impiego in viticoltura
 CONTOTERZISMO E APPLICAZIONE DEI DRONI IN AGRICOLTURA CONVEGNO INFORMATIVO PER GLI AGROMECCANICI L impiego in viticoltura Colture agrarie Elevata eterogeneità delle risposte produttive Le grandezze che
CONTOTERZISMO E APPLICAZIONE DEI DRONI IN AGRICOLTURA CONVEGNO INFORMATIVO PER GLI AGROMECCANICI L impiego in viticoltura Colture agrarie Elevata eterogeneità delle risposte produttive Le grandezze che
Risultati della Ricerca
 Risultati della Ricerca Titolo Relazioni tra indici di vegetazione e misure a terra Descrizione estesa del risultato Nel corso del progetto AQUATER sono state acquisite diverse immagini da satellite e
Risultati della Ricerca Titolo Relazioni tra indici di vegetazione e misure a terra Descrizione estesa del risultato Nel corso del progetto AQUATER sono state acquisite diverse immagini da satellite e
Misurare dallo spazio la produttività di foreste e colture agricole
 Misurare dallo spazio la produttività di foreste e colture agricole Perchè e come si fa? Federico Magnani Dipartimento di Scienze Agrarie Alma Mater - Università di Bologna Perchè misurare la produttività
Misurare dallo spazio la produttività di foreste e colture agricole Perchè e come si fa? Federico Magnani Dipartimento di Scienze Agrarie Alma Mater - Università di Bologna Perchè misurare la produttività
Impiego di droni in agricoltura: opportunità e sfide di oggi
 Impiego di droni in agricoltura: opportunità e sfide di oggi Ing. Andrea Berton Sigma Ingegneria CNR Ing. Vittorio Cipolla Zefiro Ricerca & Innovazione Conferenza «Tecnologie e innovazione per una gestione
Impiego di droni in agricoltura: opportunità e sfide di oggi Ing. Andrea Berton Sigma Ingegneria CNR Ing. Vittorio Cipolla Zefiro Ricerca & Innovazione Conferenza «Tecnologie e innovazione per una gestione
MICROCLIMA ED INERBIMENTO NEL VIGNETO
 4 febbraio 2016 FIERAGRICOLA - Verona Ing. Nicola Vicino MICROCLIMA ED INERBIMENTO NEL VIGNETO WORKSHOP ENOVITIS Viticoltura di precisione per la gestione della fertilità copyright 2016 cet electronics
4 febbraio 2016 FIERAGRICOLA - Verona Ing. Nicola Vicino MICROCLIMA ED INERBIMENTO NEL VIGNETO WORKSHOP ENOVITIS Viticoltura di precisione per la gestione della fertilità copyright 2016 cet electronics
DOTT. LUCA CAVALLARO TENUTE RUFFINO
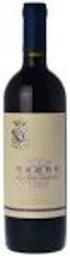 Workshop Innovation DOTT. LUCA CAVALLARO TENUTE RUFFINO Utilizzo delle tecniche della viticoltura di precisione per le scelte vendemmiali nell area del Chianti Classico. Luca Cavallaro, Tenute Ruffino
Workshop Innovation DOTT. LUCA CAVALLARO TENUTE RUFFINO Utilizzo delle tecniche della viticoltura di precisione per le scelte vendemmiali nell area del Chianti Classico. Luca Cavallaro, Tenute Ruffino
Dalle immagini telerilevate. alle mappe
 telerilevate A) delle immagini (identificazione di anomalie) B) Mappe della tipologia e distribuzione della categorie al suolo () C) Mappe di (Concentrazione Clorofille, contenuto d acqua, LAI etc.) telerilevate
telerilevate A) delle immagini (identificazione di anomalie) B) Mappe della tipologia e distribuzione della categorie al suolo () C) Mappe di (Concentrazione Clorofille, contenuto d acqua, LAI etc.) telerilevate
Potenzialità dei droni in applicazioni di monitoraggio. Dott. Aldo Calcante
 Potenzialità dei droni in applicazioni di monitoraggio Dott. Aldo Calcante Premessa "Agriculture is a very sophisticated industry and farmers are very data hungry and they have not been well served, historically,
Potenzialità dei droni in applicazioni di monitoraggio Dott. Aldo Calcante Premessa "Agriculture is a very sophisticated industry and farmers are very data hungry and they have not been well served, historically,
Risultati della Ricerca
 Risultati della Ricerca Titolo Mappe tematiche Descrizione estesa del risultato Utilizzando il Sistema Geografico Informativo realizzato, e con l ausilio di immagini telerilevate, sono state realizzate
Risultati della Ricerca Titolo Mappe tematiche Descrizione estesa del risultato Utilizzando il Sistema Geografico Informativo realizzato, e con l ausilio di immagini telerilevate, sono state realizzate
Telerilevamento di prossimità per l Agricoltura
 NDVI srls: Pzza Mani fattura,1 38068 Rovereto TN Ivan Ianniello 344/1661871 Marco Pandini 339/8036183 Mail: ndvi@pec.it Web: www.ndvi.i t P.iva. 02391630221 Telerilevamento di prossimità per l Agricoltura
NDVI srls: Pzza Mani fattura,1 38068 Rovereto TN Ivan Ianniello 344/1661871 Marco Pandini 339/8036183 Mail: ndvi@pec.it Web: www.ndvi.i t P.iva. 02391630221 Telerilevamento di prossimità per l Agricoltura
5.4. La matrice di correlazione
 6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
Stato dell arte nell uso dei sensori per la diagnostica colturale
 Stato dell arte nell uso dei sensori per la diagnostica colturale Martina Corti martina.corti@unimi.it Sensore Impiegato Tecnica di acquisizione Elaborazione Dato Camera Digitale Camera Termica Satellite
Stato dell arte nell uso dei sensori per la diagnostica colturale Martina Corti martina.corti@unimi.it Sensore Impiegato Tecnica di acquisizione Elaborazione Dato Camera Digitale Camera Termica Satellite
L'esperienza dell'arpa Sardegna: applicazione a livello regionale delle mappe di first guess
 DELL AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS L'esperienza dell'arpa Sardegna: applicazione a livello regionale delle mappe di first guess a cura di Paolo Capece Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico
DELL AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS L'esperienza dell'arpa Sardegna: applicazione a livello regionale delle mappe di first guess a cura di Paolo Capece Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico
Convegno: IL VIGNETO IN UN CLIMA CHE CAMBIA: LE PRATICHE DEL BIOLOGICO PER AFFRONTARE L INCERTEZZA CLIMATICA
 Convegno: IL VIGNETO IN UN CLIMA CHE CAMBIA: LE PRATICHE DEL BIOLOGICO PER AFFRONTARE L INCERTEZZA CLIMATICA Dott. Agr. Giovanni Bigot Azienda AMASTUOLA Venerdì 17 giugno ore 9,30 11,30 AREA CONVEGNI,
Convegno: IL VIGNETO IN UN CLIMA CHE CAMBIA: LE PRATICHE DEL BIOLOGICO PER AFFRONTARE L INCERTEZZA CLIMATICA Dott. Agr. Giovanni Bigot Azienda AMASTUOLA Venerdì 17 giugno ore 9,30 11,30 AREA CONVEGNI,
Valutazione degli effetti della concimazione eseguita con Phenix e Auxym su Cabernet Sauvignon. A cura dell UFFICIO AGRONOMICO ITALPOLLINA SPA
 Valutazione degli effetti della concimazione eseguita con Phenix e Auxym su Cabernet Sauvignon A cura dell UFFICIO AGRONOMICO ITALPOLLINA SPA COS E AUXYM AUXYM è un complesso di estratti vegetali naturali
Valutazione degli effetti della concimazione eseguita con Phenix e Auxym su Cabernet Sauvignon A cura dell UFFICIO AGRONOMICO ITALPOLLINA SPA COS E AUXYM AUXYM è un complesso di estratti vegetali naturali
Applicazioni di Telerilevamento per studi agronomici
 Applicazioni di Telerilevamento per studi agronomici Dott. Mirco Boschetti 1 parte TLR Risposta spettrali della superfici Il comportamento della Influenza dei biofisici 2 parte Cos è un immagine Visualizzazione
Applicazioni di Telerilevamento per studi agronomici Dott. Mirco Boschetti 1 parte TLR Risposta spettrali della superfici Il comportamento della Influenza dei biofisici 2 parte Cos è un immagine Visualizzazione
Possibilità di utilizzo dei droni in agricoltura. Dott. Aldo Calcante
 Possibilità di utilizzo dei droni in agricoltura Dott. Aldo Calcante Premessa "Agriculture is a very sophisticated industry and farmers are very data hungry and they have not been well served, historically,
Possibilità di utilizzo dei droni in agricoltura Dott. Aldo Calcante Premessa "Agriculture is a very sophisticated industry and farmers are very data hungry and they have not been well served, historically,
SVILUPPO DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE DELLE D.O. FRANCIACORTA progetto n.441
 SVILUPPO DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE DELLE D.O. FRANCIACORTA progetto n.441 ENTI COINVOLTI : Consorzio Tutela Franciacorta (beneficiario) Provincia di Brescia - Centro Vitivinicolo Provinciale
SVILUPPO DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE DELLE D.O. FRANCIACORTA progetto n.441 ENTI COINVOLTI : Consorzio Tutela Franciacorta (beneficiario) Provincia di Brescia - Centro Vitivinicolo Provinciale
«Gestione agronomica più efficiente con l agricoltura di precisione: esempi pratici in Italia»
 http://www.ermes-fp7space.eu/ «Gestione agronomica più efficiente con l agricoltura di precisione: esempi pratici in Italia» Telerilevamento, modellistica e smart app a servizio dell'agricoltura, il progetto
http://www.ermes-fp7space.eu/ «Gestione agronomica più efficiente con l agricoltura di precisione: esempi pratici in Italia» Telerilevamento, modellistica e smart app a servizio dell'agricoltura, il progetto
IL TELERILEVAMENTO AEREO A SUPPORTO DELLA VITICOLTURA DI PRECISIONE
 L ENOLOGO MAGGIO 2010 DOCUMENTO TECNICO *Gianluca Tramontana *Dario Papale *Filippo Girard **Claudio Belli ***Domenico Tiberi ***Maria C. Comandini ***Paolo Pietromarchi * DISAFRI Dip. di Scienze dell
L ENOLOGO MAGGIO 2010 DOCUMENTO TECNICO *Gianluca Tramontana *Dario Papale *Filippo Girard **Claudio Belli ***Domenico Tiberi ***Maria C. Comandini ***Paolo Pietromarchi * DISAFRI Dip. di Scienze dell
Metodologia per la stima dei carichi di azoto (N) di origine agricola della Regione Veneto
 Metodologia per la stima dei carichi di azoto (N) di origine agricola della Regione Veneto La stima dei carichi azotati di origine agricola derivanti dagli apporti delle concimazioni organiche e minerali
Metodologia per la stima dei carichi di azoto (N) di origine agricola della Regione Veneto La stima dei carichi azotati di origine agricola derivanti dagli apporti delle concimazioni organiche e minerali
FILIERA UVA. Analisi del processo di vinificazione attraverso sistemi innovativi (obiettivo 3.4).
 FILIERA UVA Consolidamento di tecniche innovative per la qualificazione delle uve al conferimento presso le cantine e per il controllo del processo di vinificazione Analisi del processo di vinificazione
FILIERA UVA Consolidamento di tecniche innovative per la qualificazione delle uve al conferimento presso le cantine e per il controllo del processo di vinificazione Analisi del processo di vinificazione
«Nuove tecnologie per una risicoltura più attenta» Esperienze pratiche nell ambito del progetto ERMES Alberto Crema IREA-CNR
 http://www.ermes-fp7space.eu/ «Nuove tecnologie per una risicoltura più attenta» Esperienze pratiche nell ambito del progetto ERMES Alberto Crema IREA-CNR Telerilevamento Sensori Ottici Il telerilevamento
http://www.ermes-fp7space.eu/ «Nuove tecnologie per una risicoltura più attenta» Esperienze pratiche nell ambito del progetto ERMES Alberto Crema IREA-CNR Telerilevamento Sensori Ottici Il telerilevamento
La gestione della concimazione azotata nell agricoltura di precisione Un esempio applicativo nel mais
 La gestione della concimazione azotata nell agricoltura di precisione Un esempio applicativo nel mais Raffaele Casa, Andrea Cavalieri, Benedetto Lo Cascio Dipartimento di Produzione Vegetale, Università
La gestione della concimazione azotata nell agricoltura di precisione Un esempio applicativo nel mais Raffaele Casa, Andrea Cavalieri, Benedetto Lo Cascio Dipartimento di Produzione Vegetale, Università
Gruppo di distribuzione per colture arboree: ELI VOLPE
 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DELLA SICUREZZA DELLE MACCHINE AGRICOLE Gruppo di distribuzione per colture arboree: ELI VOLPE Centro prova: Ditta costruttrice: ELIVENT Srl
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DELLA SICUREZZA DELLE MACCHINE AGRICOLE Gruppo di distribuzione per colture arboree: ELI VOLPE Centro prova: Ditta costruttrice: ELIVENT Srl
Prospettive per il monitoraggio colturale con i droni e imaging multi e iperspettrali
 Prospettive per il monitoraggio colturale con i droni e imaging multi e iperspettrali Martina Corti, Giovanni Cabassi (CRA-FLC), Daniele Cavalli, Luca Bechini, Pietro Marino Gallina, Lamberto Borrelli
Prospettive per il monitoraggio colturale con i droni e imaging multi e iperspettrali Martina Corti, Giovanni Cabassi (CRA-FLC), Daniele Cavalli, Luca Bechini, Pietro Marino Gallina, Lamberto Borrelli
RELAZIONE APPLICAZIONE DI XURIAN OPTIMUM NEI VIGNETI IN PRODUZIONE
 Casarsa 28 ottobre 2010 RELAZIONE APPLICAZIONE DI XURIAN OPTIMUM NEI VIGNETI IN PRODUZIONE Terzo anno di prove con applicazione di XURIAN nei terreni della cantina sociale. La prova è continuata presso
Casarsa 28 ottobre 2010 RELAZIONE APPLICAZIONE DI XURIAN OPTIMUM NEI VIGNETI IN PRODUZIONE Terzo anno di prove con applicazione di XURIAN nei terreni della cantina sociale. La prova è continuata presso
Trasferimento di innovazioni nella gestione agronomica dell oliveto
 PSR 2007-2013 Regione Toscana - Progetto Integrato di Filiera Un Filo d Olio Giornata di presentazione dei risultati finali del Progetto Misura 124 MODOLIVI 10 marzo 2015 Trasferimento di innovazioni nella
PSR 2007-2013 Regione Toscana - Progetto Integrato di Filiera Un Filo d Olio Giornata di presentazione dei risultati finali del Progetto Misura 124 MODOLIVI 10 marzo 2015 Trasferimento di innovazioni nella
POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2014
 C.E.C.A.T. Castelfranco V.to COMUNICATO TECNICO n 1/2014 (9-01-2014) CANTINA PRODUTTORI VALDOBBIADENE POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2014 Per ottenere dal vigneto il risultato migliore intermini
C.E.C.A.T. Castelfranco V.to COMUNICATO TECNICO n 1/2014 (9-01-2014) CANTINA PRODUTTORI VALDOBBIADENE POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2014 Per ottenere dal vigneto il risultato migliore intermini
Uso di dati satellitari per la caratterizzazione e il monitoraggio della siccità
 ITHACA EARLY WARNING Uso di dati satellitari per la caratterizzazione e il monitoraggio della siccità Francesca Perez DITAG - Politecnico di Torino francesca.perez@ithaca.polito.it ITHACA Information Technology
ITHACA EARLY WARNING Uso di dati satellitari per la caratterizzazione e il monitoraggio della siccità Francesca Perez DITAG - Politecnico di Torino francesca.perez@ithaca.polito.it ITHACA Information Technology
Applicazione WEB-GIS per il Consorzio e per i Produttori
 Progetto misura 124 PSR 2007 2013 Regione Toscana L ORO DOP DEL CHIANTI CLASSICO FIZONACLASSICO Filtrazione in linea e zonazione olivicola per ottimizzare e diversificare la qualità Applicazione WEB-GIS
Progetto misura 124 PSR 2007 2013 Regione Toscana L ORO DOP DEL CHIANTI CLASSICO FIZONACLASSICO Filtrazione in linea e zonazione olivicola per ottimizzare e diversificare la qualità Applicazione WEB-GIS
della Radiazione Solare nel Sorgo da Biomassa
 XXXIX Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia Roma, 20-22 settembre 2010 L Efficienza d Uso d della Radiazione Solare nel Sorgo da Biomassa Pasquale Garofalo,, Alessandro Vittorio Vonella,
XXXIX Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia Roma, 20-22 settembre 2010 L Efficienza d Uso d della Radiazione Solare nel Sorgo da Biomassa Pasquale Garofalo,, Alessandro Vittorio Vonella,
Mais e vite: Tecniche di coltivazione
 Mais e vite: Tecniche di coltivazione TECNICA TRADIZIONALE DI COLTIVAZIONE DEL MAIS SCELTA DELLA VARIETÀ La scelta della varietà è una delle più importanti condizioni dalle quali dipende il successo della
Mais e vite: Tecniche di coltivazione TECNICA TRADIZIONALE DI COLTIVAZIONE DEL MAIS SCELTA DELLA VARIETÀ La scelta della varietà è una delle più importanti condizioni dalle quali dipende il successo della
Introduzione al TELERILEVAMENTO. (Remote Sensing) Docente: Andrea Piemonte
 Introduzione al TELERILEVAMENTO (Remote Sensing) Slide 1 COS È È una disciplina del rilevamento che ha come scopo la produzione di mappe tematiche o comunque l estrazione di un certo tipo di informazioni
Introduzione al TELERILEVAMENTO (Remote Sensing) Slide 1 COS È È una disciplina del rilevamento che ha come scopo la produzione di mappe tematiche o comunque l estrazione di un certo tipo di informazioni
Report pluviometrico
 Report pluviometrico Dati scaricabili sul sito http://www.sir.toscana.it PREMESSA Al fine di valutare l entità gli apporti pluviometrici, sono state considerate tutte le stazioni automatiche (oltre 400
Report pluviometrico Dati scaricabili sul sito http://www.sir.toscana.it PREMESSA Al fine di valutare l entità gli apporti pluviometrici, sono state considerate tutte le stazioni automatiche (oltre 400
Istituto di Ingegneria Agraria di Milano
 Il telerilevamento per un agricoltura sostenibile Piacenza, 20 aprile 2006 Roberto Oberti Luigi Bodria Istituto di Ingegneria Agraria di Milano Difesa di precisione delle colture Il problema: applicazione
Il telerilevamento per un agricoltura sostenibile Piacenza, 20 aprile 2006 Roberto Oberti Luigi Bodria Istituto di Ingegneria Agraria di Milano Difesa di precisione delle colture Il problema: applicazione
Tecnologie Aerospaziali a supporto delle investigazioni per illeciti ambientali
 Tecnologie Aerospaziali a supporto delle investigazioni per illeciti ambientali Il Progetto IDES: Intelligent Data Extraction System P. Schiano G. Persechino L'AEROSPAZIO Roma, Casa dell Aviatore, 9 Ottobre
Tecnologie Aerospaziali a supporto delle investigazioni per illeciti ambientali Il Progetto IDES: Intelligent Data Extraction System P. Schiano G. Persechino L'AEROSPAZIO Roma, Casa dell Aviatore, 9 Ottobre
Esperienze di ricerca nel Sud Italia sull Agricoltura Conservativa e di Precisione
 Esperienze di ricerca nel Sud Italia sull Agricoltura Conservativa e di Precisione I Progetti SICERME e STRATEGA Michele Rinaldi Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l Analisi dell Economia Agraria
Esperienze di ricerca nel Sud Italia sull Agricoltura Conservativa e di Precisione I Progetti SICERME e STRATEGA Michele Rinaldi Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l Analisi dell Economia Agraria
MECCANISMI D AZIONE DELLE ESPOSIZIONI AMBIENTALI ED OCCUPAZIONALI A CAMPI MAGNETICI ELF: VALUTAZIONE DELLE HSP IN PBL DI SOGGETTI ESPOSTI
 MECCANISMI D AZIONE DELLE ESPOSIZIONI AMBIENTALI ED OCCUPAZIONALI A CAMPI MAGNETICI ELF: VALUTAZIONE DELLE HSP IN PBL DI SOGGETTI ESPOSTI HEAT SHOCK PROTEINS (HSP70): SONO PROTEINE COINVOLTE NELLA RISPOSTA
MECCANISMI D AZIONE DELLE ESPOSIZIONI AMBIENTALI ED OCCUPAZIONALI A CAMPI MAGNETICI ELF: VALUTAZIONE DELLE HSP IN PBL DI SOGGETTI ESPOSTI HEAT SHOCK PROTEINS (HSP70): SONO PROTEINE COINVOLTE NELLA RISPOSTA
Water2Adapt: resilience enhancement and water demand management for climate change adaptation
 Water2Adapt: resilience enhancement and water demand management for climate change adaptation Maria De Salvo, Isola di San Giorgio, Venezia, 26 settembre 2012 Fondazione Eni Enrico Mattei Università degli
Water2Adapt: resilience enhancement and water demand management for climate change adaptation Maria De Salvo, Isola di San Giorgio, Venezia, 26 settembre 2012 Fondazione Eni Enrico Mattei Università degli
Telerilevamento: una panoramica sui sistemi
 Telerilevamento: una panoramica sui sistemi Il telerilevamento: cos è? Il telerilevamento è la scienza (o l arte) di ottenere informazioni riguardanti un oggetto, un area o un fenomeno utilizzando dati
Telerilevamento: una panoramica sui sistemi Il telerilevamento: cos è? Il telerilevamento è la scienza (o l arte) di ottenere informazioni riguardanti un oggetto, un area o un fenomeno utilizzando dati
AREE IMPORTANTI PER L AVIFAUNA NEL FIUME ARNO (PROV. DI FIRENZE): INDIVIDUAZIONE DELLE EMERGENZE E PROSPETTIVE DI TUTELA
 AREE IMPORTANTI PER L AVIFAUNA NEL FIUME ARNO (PROV. DI FIRENZE): INDIVIDUAZIONE DELLE EMERGENZE E PROSPETTIVE DI TUTELA MICHELE GIUNTI & PAOLO SPOSIMO * c/o Nemo srl, via Giotto 33 50121, Firenze 055/674223
AREE IMPORTANTI PER L AVIFAUNA NEL FIUME ARNO (PROV. DI FIRENZE): INDIVIDUAZIONE DELLE EMERGENZE E PROSPETTIVE DI TUTELA MICHELE GIUNTI & PAOLO SPOSIMO * c/o Nemo srl, via Giotto 33 50121, Firenze 055/674223
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM PER L ANALISI AMBIENTALE. Nicola Gilio. Dott. Nicola Gilio
 Nicola Nicola Gilio Gili GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM PER L ANALISI AMBIENTALE Dott. Nicola Gilio Un sistema informatizzato in grado di immagazzinare dati descrittivi della superficie terrestre Definizioni
Nicola Nicola Gilio Gili GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM PER L ANALISI AMBIENTALE Dott. Nicola Gilio Un sistema informatizzato in grado di immagazzinare dati descrittivi della superficie terrestre Definizioni
FILIERA MELA. Ottimizzazione della gestione dei frutti in fase di post-raccolta a garanzia della prossima denominazione IGP.
 FILIERA MELA Ottimizzazione della gestione dei frutti in fase di post-raccolta a garanzia della prossima denominazione IGP. Identificazione del profilo qualitativo e nutraceutico delle mele con tecniche
FILIERA MELA Ottimizzazione della gestione dei frutti in fase di post-raccolta a garanzia della prossima denominazione IGP. Identificazione del profilo qualitativo e nutraceutico delle mele con tecniche
TELERILEVAMENTO DA DRONI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO:
 TELERILEVAMENTO DA DRONI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO: CONOSCENZA, MONITORAGGIO ED EMERGENZA ELENA CANDIGLIOTA - FRANCESCO IMMORDINO UTSISM, Unità Tecnica di Ingegneria Sismica,
TELERILEVAMENTO DA DRONI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO: CONOSCENZA, MONITORAGGIO ED EMERGENZA ELENA CANDIGLIOTA - FRANCESCO IMMORDINO UTSISM, Unità Tecnica di Ingegneria Sismica,
POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2013
 C.E.C.A.T. Castelfranco V.to COMUNICATO TECNICO n 1/2013 (9-01-2013) CANTINA PRODUTTORI VALDOBBIADENE POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2013 Per ottenere dal vigneto il risultato migliore intermini
C.E.C.A.T. Castelfranco V.to COMUNICATO TECNICO n 1/2013 (9-01-2013) CANTINA PRODUTTORI VALDOBBIADENE POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2013 Per ottenere dal vigneto il risultato migliore intermini
I consorzi di bonifica tra difesa idraulica e gestione multifunzionale dell acqua. Marco Bottino presidente ANBI Toscana
 I consorzi di bonifica tra difesa idraulica e gestione multifunzionale dell acqua Marco Bottino presidente ANBI Toscana I Consorzi di Bonifica in Toscana Toscana Nord Basso Valdarno Toscana Costa Medio
I consorzi di bonifica tra difesa idraulica e gestione multifunzionale dell acqua Marco Bottino presidente ANBI Toscana I Consorzi di Bonifica in Toscana Toscana Nord Basso Valdarno Toscana Costa Medio
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE E FORESTALE
 Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale (IBAF) Unità Operativa di Supporto di Legnaro Borsa relativa al bando n IBAF.BS.01/2013.PD Borsista: Penelope Zanolli RELAZIONE DI FINE ANNO DI BORSA DI
Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale (IBAF) Unità Operativa di Supporto di Legnaro Borsa relativa al bando n IBAF.BS.01/2013.PD Borsista: Penelope Zanolli RELAZIONE DI FINE ANNO DI BORSA DI
Bollettino agrometeorologico regionale mensile Mese di aprile 2003
 REGIONE SICILIANA Assessorato Agricoltura e Foreste Servizio IX - Assistenza Tecnica, Sperimentazione, Ricerca Applicata e Divulgazione Unità Operativa 5 SIAS - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano
REGIONE SICILIANA Assessorato Agricoltura e Foreste Servizio IX - Assistenza Tecnica, Sperimentazione, Ricerca Applicata e Divulgazione Unità Operativa 5 SIAS - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano
NUOVE TECNICHE DI INDAGINE MULTISCALA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ IN VIGNETO
 DI BLASI ET AL., NUOVE TECNICHE DI INDAGINE MULTISCALA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ IN VIGNETO, PAG.1 NUOVE TECNICHE DI INDAGINE MULTISCALA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ IN VIGNETO DI BLASI S. a,
DI BLASI ET AL., NUOVE TECNICHE DI INDAGINE MULTISCALA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ IN VIGNETO, PAG.1 NUOVE TECNICHE DI INDAGINE MULTISCALA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ IN VIGNETO DI BLASI S. a,
POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2015
 C.E.C.A.T. Castelfranco V.to COMUNICATO TECNICO n 1/2015 (14-01-2015) CANTINA PRODUTTORI VALDOBBIADENE POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2015 Per ottenere dal vigneto il risultato migliore
C.E.C.A.T. Castelfranco V.to COMUNICATO TECNICO n 1/2015 (14-01-2015) CANTINA PRODUTTORI VALDOBBIADENE POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2015 Per ottenere dal vigneto il risultato migliore
Mappatura 2013 delle superfici coltivate a pomodoro da industria nel centro-sud Italia
 ANICAV Il Filo Rosso del Pomodoro Foggia 26/11/2013 Mappatura 2013 delle superfici coltivate a pomodoro da industria nel centro-sud Italia Metodologia, attività e risultati del telerilevamento Claudio
ANICAV Il Filo Rosso del Pomodoro Foggia 26/11/2013 Mappatura 2013 delle superfici coltivate a pomodoro da industria nel centro-sud Italia Metodologia, attività e risultati del telerilevamento Claudio
Maturazione delle olive Frantoio: campagna di monitoraggio 2009
 Maturazione delle olive Frantoio: campagna di monitoraggio 2009 Gruppo di lavoro: Luca Sebastiani, Susanna Marchi e Chiara Michelazzo (Scuola Superiore Sant Anna Pisa), Diego Guidotti (Aedit s.r.l. Pontedera),
Maturazione delle olive Frantoio: campagna di monitoraggio 2009 Gruppo di lavoro: Luca Sebastiani, Susanna Marchi e Chiara Michelazzo (Scuola Superiore Sant Anna Pisa), Diego Guidotti (Aedit s.r.l. Pontedera),
I sensori, in quanto interfaccia tra l ambiente esterno e i sistemi di. elaborazione e gestione, hanno un profondo impatto su prodotti di larga
 CAPITOLO 1 INTRODUZIONE AI SENSORI IN FIBRA OTTICA 1.1 La sensoristica 1.1.1. Generalità I sensori, in quanto interfaccia tra l ambiente esterno e i sistemi di elaborazione e gestione, hanno un profondo
CAPITOLO 1 INTRODUZIONE AI SENSORI IN FIBRA OTTICA 1.1 La sensoristica 1.1.1. Generalità I sensori, in quanto interfaccia tra l ambiente esterno e i sistemi di elaborazione e gestione, hanno un profondo
U7- Unità di ricerca per lo studio dei sistemi colturali (Metaponto)
 Effetti dello stress idrico e salino sulla produzione quantiqualitativa di due colture tipiche dell area metapontina ed evoluzione dei parametri fisico-chimici del suolo U7- Unità di ricerca per lo studio
Effetti dello stress idrico e salino sulla produzione quantiqualitativa di due colture tipiche dell area metapontina ed evoluzione dei parametri fisico-chimici del suolo U7- Unità di ricerca per lo studio
Osservazione della terra e agricoltura: i vari modi di declinare la parola TEMPO
 Osservazione della terra e agricoltura: i vari modi di declinare la parola TEMPO Immagine a falsi colori COSMO-SkyMed sulle aree agricole pavesi, elaborata da CNR-IREA (Copyright e-geos an ASI / Telespazio
Osservazione della terra e agricoltura: i vari modi di declinare la parola TEMPO Immagine a falsi colori COSMO-SkyMed sulle aree agricole pavesi, elaborata da CNR-IREA (Copyright e-geos an ASI / Telespazio
POTATURA MECCANICA DEL VIGNETO L ESPERIENZA REGGIANA
 POTATURA MECCANICA DEL VIGNETO L ESPERIENZA REGGIANA Dott. Stefano Meglioraldi Dott. Matteo Storchi Situazione provinciale potato a macchina Cosa ci si aspetta? Produzione e grado almeno equivalenti Risparmio
POTATURA MECCANICA DEL VIGNETO L ESPERIENZA REGGIANA Dott. Stefano Meglioraldi Dott. Matteo Storchi Situazione provinciale potato a macchina Cosa ci si aspetta? Produzione e grado almeno equivalenti Risparmio
COME EFFETTUARE L ANALISI DELLA CONCORRENZA
 Aprile Inserto di Missione Impresa dedicato allo sviluppo pratico di progetti finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese. COME EFFETTUARE L ANALISI DELLA CONCORRENZA QUAL E L UTILITA DI ANALIZZARE
Aprile Inserto di Missione Impresa dedicato allo sviluppo pratico di progetti finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese. COME EFFETTUARE L ANALISI DELLA CONCORRENZA QUAL E L UTILITA DI ANALIZZARE
AGRICOLTURA DI PRECISIONE: COME CAMBIANO LE TECNOLOGIE AGRARIE?
 UNIVERSITÀ di PERUGIA Dip. Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali AGRICOLTURA DI PRECISIONE: COME CAMBIANO LE TECNOLOGIE AGRARIE? Michela Farneselli, Paolo Benincasa UR Agronomia e coltivazioni erbacee,
UNIVERSITÀ di PERUGIA Dip. Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali AGRICOLTURA DI PRECISIONE: COME CAMBIANO LE TECNOLOGIE AGRARIE? Michela Farneselli, Paolo Benincasa UR Agronomia e coltivazioni erbacee,
LA FILIERA AGRO-ENERGETICA DA COLTURE DEDICATE: ANALISI TERMO-ECONOMICA DI SISTEMI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA. Mirko Morini, Ph.D.
 Biomasse: prospettive di uso energetico in Emilia-Romagna e sistemi di calcolo e monitoraggio su GIS 25 Novembre 2010, Bologna LA FILIERA AGRO-ENERGETICA DA COLTURE DEDICATE: ANALISI TERMO-ECONOMICA DI
Biomasse: prospettive di uso energetico in Emilia-Romagna e sistemi di calcolo e monitoraggio su GIS 25 Novembre 2010, Bologna LA FILIERA AGRO-ENERGETICA DA COLTURE DEDICATE: ANALISI TERMO-ECONOMICA DI
Il telerilevamento in agricoltura: nuove prospettive dai sistemi UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
 Il telerilevamento in agricoltura: nuove prospettive dai sistemi UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Alessandro Matese, Jacopo Primicerio WORKSHOP SISTEMI INNOVATIVI PER IL FLOROVIVAISMO E UN AGRICOLTURA DI
Il telerilevamento in agricoltura: nuove prospettive dai sistemi UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Alessandro Matese, Jacopo Primicerio WORKSHOP SISTEMI INNOVATIVI PER IL FLOROVIVAISMO E UN AGRICOLTURA DI
CICLO XXIII. Smart Vineyard. Nuove tecnologie per la sostenibilità ambientale dell agricoltura: un applicazione in viticoltura di precisione
 I U A V UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA SCUOLA DI DOTTORATO DOTTORATO DI RICERCA IN NUOVE TECNOLOGIE E INFORMAZIONE TERRITORIO - AMBIENTE CICLO XXIII Smart Vineyard Nuove tecnologie per la sostenibilità ambientale
I U A V UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA SCUOLA DI DOTTORATO DOTTORATO DI RICERCA IN NUOVE TECNOLOGIE E INFORMAZIONE TERRITORIO - AMBIENTE CICLO XXIII Smart Vineyard Nuove tecnologie per la sostenibilità ambientale
UTILIZZO DELL INDICE NDVI
 UTILIZZO DELL INDICE NDVI Giorno 09/06/2016 è stato effettuato il sorvolo su due agrumeti con S.A.P.R. (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) con apposito sensore costituito da macchina fotografica con
UTILIZZO DELL INDICE NDVI Giorno 09/06/2016 è stato effettuato il sorvolo su due agrumeti con S.A.P.R. (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) con apposito sensore costituito da macchina fotografica con
Il ruolo della modellistica di simulazione e delle smart app
 Nuove tecnologie per lo sviluppo di servizi in agricoltura Il ruolo della modellistica di simulazione e delle smart app Roberto Confalonieri Università degli Studi di Milano Cassandra lab roberto.confalonieri@unimi.it
Nuove tecnologie per lo sviluppo di servizi in agricoltura Il ruolo della modellistica di simulazione e delle smart app Roberto Confalonieri Università degli Studi di Milano Cassandra lab roberto.confalonieri@unimi.it
IL RUOLO DEL VIGNETO NELLA PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
 IL RUOLO DEL VIGNETO NELLA PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni Dipartimento di Scienze della Terra e dell Ambiente Università di Pavia claudia.meisina@unipv.it
IL RUOLO DEL VIGNETO NELLA PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni Dipartimento di Scienze della Terra e dell Ambiente Università di Pavia claudia.meisina@unipv.it
PROVA di FERTIRRIGAZIONE su POMODORO da INDUSTRIA - Anno 2008 Arsia Regione Toscana - Pavoni S.p.a. Caratteristiche della prova
 PROVA di FERTIRRIGAZIONE su POMODORO da INDUSTRIA - Anno 2008 Arsia Regione Toscana - Pavoni S.p.a. Caratteristiche della prova La prova ha previsto il confronto, a parità di unità fertilizzanti, tra alcune
PROVA di FERTIRRIGAZIONE su POMODORO da INDUSTRIA - Anno 2008 Arsia Regione Toscana - Pavoni S.p.a. Caratteristiche della prova La prova ha previsto il confronto, a parità di unità fertilizzanti, tra alcune
APR: Possibilità di utilizzo in agricoltura
 Mail: francesco.marinello@unipd.it APR: Possibilità di utilizzo in agricoltura Francesco Marinello, Luigi Sartori Milano 26/09/2015 Breakthrough technology Il MIT ha messo i droni come la prima delle 10
Mail: francesco.marinello@unipd.it APR: Possibilità di utilizzo in agricoltura Francesco Marinello, Luigi Sartori Milano 26/09/2015 Breakthrough technology Il MIT ha messo i droni come la prima delle 10
Edizioni L Informatore Agrario
 www.informatoreagrario.it Edizioni L Informatore Agrario Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest opera per usi diversi
www.informatoreagrario.it Edizioni L Informatore Agrario Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest opera per usi diversi
VALUTAZIONE DI SISTEMI OTTICI PER LA DIAGNOSI DI PERONOSPORA SU PIANTE DI VITIS VINIFERA L.
 Convegno di Medio Termine dell Associazione Italiana di Ingegneria Agraria Belgirate, 22-24 settembre 2011 memoria n. VALUTAZIONE DI SISTEMI OTTICI PER LA DIAGNOSI DI PERONOSPORA SU PIANTE DI VITIS VINIFERA
Convegno di Medio Termine dell Associazione Italiana di Ingegneria Agraria Belgirate, 22-24 settembre 2011 memoria n. VALUTAZIONE DI SISTEMI OTTICI PER LA DIAGNOSI DI PERONOSPORA SU PIANTE DI VITIS VINIFERA
Analisi della risposta spettrale di paesi abbandonati del Friuli mediante la trasformata Tasseled Cap (Kauth Thomas) applicata alle immagini Landsat
 Analisi della risposta spettrale di paesi abbandonati del Friuli mediante la trasformata Tasseled Cap (Kauth Thomas) applicata alle immagini Landsat Altobelli A. 1, Bincoletto L. 2, Fantini M. 2,Geppini
Analisi della risposta spettrale di paesi abbandonati del Friuli mediante la trasformata Tasseled Cap (Kauth Thomas) applicata alle immagini Landsat Altobelli A. 1, Bincoletto L. 2, Fantini M. 2,Geppini
Confronto tra suolo degradato e suolo ricostituito per la produzione di pomodoro
 Confronto tra suolo degradato e suolo ricostituito per la produzione di pomodoro Paolo Manfredi1, Chiara Cassinari2, Marco Trevisan2 1m.c.m. Ecosistemi s.r.l., Gariga di Podenzano, Piacenza 2Istituto di
Confronto tra suolo degradato e suolo ricostituito per la produzione di pomodoro Paolo Manfredi1, Chiara Cassinari2, Marco Trevisan2 1m.c.m. Ecosistemi s.r.l., Gariga di Podenzano, Piacenza 2Istituto di
ALLEGATO A. Classificazione delle varietà di vite per la produzione di uve da vino nella Regione Liguria
 ALLEGATO A Classificazione delle varietà di vite per la produzione di uve da vino nella Regione Liguria 1. Generalità La classificazione delle varietà di vite per la produzione di uve da vino, di seguito
ALLEGATO A Classificazione delle varietà di vite per la produzione di uve da vino nella Regione Liguria 1. Generalità La classificazione delle varietà di vite per la produzione di uve da vino, di seguito
Elena Gottardini* Fabiana Cristofolini* José Antonio Oteros Moreno. *Fondazione E. Mach Università degli Studi di Monaco
 Elena Gottardini* Fabiana Cristofolini* José Antonio Oteros Moreno *Fondazione E. Mach Università degli Studi di Monaco Centro di monitoraggio aerobiologico Campionamento L attività del Centro Analisi
Elena Gottardini* Fabiana Cristofolini* José Antonio Oteros Moreno *Fondazione E. Mach Università degli Studi di Monaco Centro di monitoraggio aerobiologico Campionamento L attività del Centro Analisi
Dati di Campo (ogni questionario si riferisce ad una specie di coltura coltivata per campo) pesche albicocche nettarine prugne
 Questionario di Campionamento Dati di Campo (ogni questionario si riferisce ad una specie di coltura coltivata per campo) delle Potature Comune: : Villanueva de los Infantes Latitudine : 38.729572 Longitudine
Questionario di Campionamento Dati di Campo (ogni questionario si riferisce ad una specie di coltura coltivata per campo) delle Potature Comune: : Villanueva de los Infantes Latitudine : 38.729572 Longitudine
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO
 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE TESI DI LAUREA Analisi dei dati di due campagne
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE TESI DI LAUREA Analisi dei dati di due campagne
Bollettino Agrometeorologico. e altri prodotti. Produzione Integrata
 e altri prodotti per la Produzione Integrata Che tempo farà? : da 1 ora a tre mesi Alcune previsioni utili alla Produzione Integrata sul sito del Servizio IdroMeteoClima. www.arpa.emr.it/sim Che tempo
e altri prodotti per la Produzione Integrata Che tempo farà? : da 1 ora a tre mesi Alcune previsioni utili alla Produzione Integrata sul sito del Servizio IdroMeteoClima. www.arpa.emr.it/sim Che tempo
VALIDAZIONE DEI METODI RADIOCHIMICI. Analisi di alcuni aspetti: 1. Taratura. 2. Ripetibilità. Dott. Maurizio Bettinelli.
 VALIDAZIONE DEI METODI RADIOCHIMICI Analisi di alcuni aspetti: 1. Taratura (verifica di Linearità) 2. Ripetibilità Dott. Maurizio Bettinelli 29 settembre 2011 www.kosmosnet.it 1 www.kosmosnet.it 2 www.kosmosnet.it
VALIDAZIONE DEI METODI RADIOCHIMICI Analisi di alcuni aspetti: 1. Taratura (verifica di Linearità) 2. Ripetibilità Dott. Maurizio Bettinelli 29 settembre 2011 www.kosmosnet.it 1 www.kosmosnet.it 2 www.kosmosnet.it
POMPEI, FABBRICA DELLA CONOSCENZA
 POMPEI, FABBRICA DELLA CONOSCENZA CAMPANIA, RETE GEODETICA DEL BENECON Pompei, Palazzo municipale. Antenna Geodetica Benecon Monografie GNSS WGS84 delle stazioni geodetiche di Pompei e Frignano, Laboratorio
POMPEI, FABBRICA DELLA CONOSCENZA CAMPANIA, RETE GEODETICA DEL BENECON Pompei, Palazzo municipale. Antenna Geodetica Benecon Monografie GNSS WGS84 delle stazioni geodetiche di Pompei e Frignano, Laboratorio
POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2015
 C.E.C.A.T. Castelfranco V.to COMUNICATO TECNICO n 1/2015 (14-01-2015) PROGETTO VITE POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2015 Per ottenere dal vigneto il risultato migliore intermini di qualità
C.E.C.A.T. Castelfranco V.to COMUNICATO TECNICO n 1/2015 (14-01-2015) PROGETTO VITE POTATURA DELLA VITE QUANTE GEMME LASCIARE NEL 2015 Per ottenere dal vigneto il risultato migliore intermini di qualità
Progetto Energia Alta Val di Non. David Moser Coordinatore del gruppo Sistemi Fotovoltaici
 Progetto Energia Alta Val di Non David Moser Coordinatore del gruppo Sistemi Fotovoltaici www.eurac.edu Catasto Solare 2 Agenda - Modello Digitale del Terreno (DTM) - Calcolo del Potenziale Solare - Classificazione
Progetto Energia Alta Val di Non David Moser Coordinatore del gruppo Sistemi Fotovoltaici www.eurac.edu Catasto Solare 2 Agenda - Modello Digitale del Terreno (DTM) - Calcolo del Potenziale Solare - Classificazione
Ottimizziamo la melicoltura con la frutticoltura di precisione
 Ottimizziamo la melicoltura con la frutticoltura di precisione Luca Corelli Grappadelli, Luigi Manfrini Dipartimento Colture Arboree Università di Bologna Frutticoltura di precisione significa: Applicare
Ottimizziamo la melicoltura con la frutticoltura di precisione Luca Corelli Grappadelli, Luigi Manfrini Dipartimento Colture Arboree Università di Bologna Frutticoltura di precisione significa: Applicare
Con l avvento della VITICOLTURA DI PRECISIONE: OBIETTIVI E APPLICAZIONI SITO SPECIFICHE TECNICA/ VIGNETO <<
 VITICOLTURA DI PRECISIONE: OBIETTIVI E APPLICAZIONI SITO SPECIFICHE di Paolo Carnevali (1), Jacopo Cricco (2), Luca Toninato (2), Lucio Brancadoro (1) 1) Di.pro.Ve., Università di Milano 2)Ager s.c. Agricoltura
VITICOLTURA DI PRECISIONE: OBIETTIVI E APPLICAZIONI SITO SPECIFICHE di Paolo Carnevali (1), Jacopo Cricco (2), Luca Toninato (2), Lucio Brancadoro (1) 1) Di.pro.Ve., Università di Milano 2)Ager s.c. Agricoltura
Teoria e tecniche dei test
 Teoria e tecniche dei test Lezione 9 LA STANDARDIZZAZIONE DEI TEST. IL PROCESSO DI TARATURA: IL CAMPIONAMENTO. Costruire delle norme di riferimento per un test comporta delle ipotesi di fondo che è necessario
Teoria e tecniche dei test Lezione 9 LA STANDARDIZZAZIONE DEI TEST. IL PROCESSO DI TARATURA: IL CAMPIONAMENTO. Costruire delle norme di riferimento per un test comporta delle ipotesi di fondo che è necessario
L annata viticola 2003, in primo piano l acqua.
 L annata viticola 2003, in primo piano l acqua. La vite è in grado di convivere con disponibilità idriche moderate, ma la stagione viticola 2003 è stata in assoluto la più secca e calda da quando esistono
L annata viticola 2003, in primo piano l acqua. La vite è in grado di convivere con disponibilità idriche moderate, ma la stagione viticola 2003 è stata in assoluto la più secca e calda da quando esistono
SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE
 Assessorato Scuola. Formazione professionale. Università e ricerca. Lavoro SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE SCHEDA DESCRITTIVA STANDARD PROFESSIONALI DELLA QUALIFICA AREA PROFESSIONALE Allegato 1) SVILUPPO
Assessorato Scuola. Formazione professionale. Università e ricerca. Lavoro SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE SCHEDA DESCRITTIVA STANDARD PROFESSIONALI DELLA QUALIFICA AREA PROFESSIONALE Allegato 1) SVILUPPO
L AGRICOLTURA SALVA L ACQUA GIOELE CHIARI - STEFANO ANCONELLI
 L AGRICOLTURA SALVA L ACQUA GIOELE CHIARI - STEFANO ANCONELLI TRASFERIMENTO DELL INNOVAZIONE ALLE IMPRESE DALL EMPIRISMO AL CALCOLO IL BILANCIO IDRICO PIOGGIA TRASPIRAZIONE IRRIGAZIONE EVAPORAZIONE RUSCELLAMENTO
L AGRICOLTURA SALVA L ACQUA GIOELE CHIARI - STEFANO ANCONELLI TRASFERIMENTO DELL INNOVAZIONE ALLE IMPRESE DALL EMPIRISMO AL CALCOLO IL BILANCIO IDRICO PIOGGIA TRASPIRAZIONE IRRIGAZIONE EVAPORAZIONE RUSCELLAMENTO
Filiera cipolla bianca di Pompei Individuazione del fabbisogno di azoto in funzione del biotipo e della destinazione commerciale.
 Attività 2013-2014 del Centro Orticolo Campano Area Tematica Messa a punto di tecniche colturali ecosostenibili Filiera cipolla bianca di Pompei 2.2.1. Individuazione del fabbisogno di azoto in funzione
Attività 2013-2014 del Centro Orticolo Campano Area Tematica Messa a punto di tecniche colturali ecosostenibili Filiera cipolla bianca di Pompei 2.2.1. Individuazione del fabbisogno di azoto in funzione
Caratterizzazione dei vini e protezione del suolo nella viticoltura della Riserva del Piacenziano in Provincia di Piacenza.
 Progetto di ricerca Provincia di Piacenza Università Cattolica Riserva Geologica del Piacenziano Lugagnano 17 gennaio 2009 Caratterizzazione dei vini e protezione del suolo nella viticoltura della Riserva
Progetto di ricerca Provincia di Piacenza Università Cattolica Riserva Geologica del Piacenziano Lugagnano 17 gennaio 2009 Caratterizzazione dei vini e protezione del suolo nella viticoltura della Riserva
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI
 SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
9 LA QUALITA DELL ARIA NEL COMUNE DI VERONA
 9 LA QUALITA DELL ARIA NEL COMUNE DI VERONA 9.1 Introduzione La rete comunale della qualità dell aria della città di Verona è stata realizzata realizzata in base al D.M. 2/5/91 che stabilisce i criteri
9 LA QUALITA DELL ARIA NEL COMUNE DI VERONA 9.1 Introduzione La rete comunale della qualità dell aria della città di Verona è stata realizzata realizzata in base al D.M. 2/5/91 che stabilisce i criteri
Cereali biologici di qualità
 Cereali biologici di qualità Scelta varietale ed interventi agronomici per il miglioramento quanti-qualitativo e la valorizzazione della produzione cerealicola biologica marchigiana e dei prodotti derivati.
Cereali biologici di qualità Scelta varietale ed interventi agronomici per il miglioramento quanti-qualitativo e la valorizzazione della produzione cerealicola biologica marchigiana e dei prodotti derivati.
I contenuti di questa presentazione sono riservati e non possono essere divulgati a terzi senza l espressa autorizzazione da parte dell autore
 Esperienze applicative in Toscana Il progetto di monitoraggio della maturazione delle olive della varietà Frantoio in Toscana Luca Sebastiani Scuola Superiore Sant Anna, Pisa I contenuti di questa presentazione
Esperienze applicative in Toscana Il progetto di monitoraggio della maturazione delle olive della varietà Frantoio in Toscana Luca Sebastiani Scuola Superiore Sant Anna, Pisa I contenuti di questa presentazione
Edizioni L Informatore Agrario
 www.informatoreagrario.it Edizioni L Informatore Agrario Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest opera per usi diversi
www.informatoreagrario.it Edizioni L Informatore Agrario Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest opera per usi diversi
Valutazione rapida del grado di maturità tecnologica e fenolica del nebbiolo di Valtellina mediante spettroscopia FT-NIR *
 Valutazione rapida del grado di maturità tecnologica e fenolica del nebbiolo di Valtellina mediante spettroscopia FT-NIR * E. Casiraghi ( ), N. Sinelli ( ), G. Cabassi ( 2 ), R. Beghi ( 3 ) DiSTAM, Università
Valutazione rapida del grado di maturità tecnologica e fenolica del nebbiolo di Valtellina mediante spettroscopia FT-NIR * E. Casiraghi ( ), N. Sinelli ( ), G. Cabassi ( 2 ), R. Beghi ( 3 ) DiSTAM, Università
