NaM on Paper. Un degno avversario. Marcello Bergamini. Pediatra di Famiglia, Ferrara
|
|
|
- Leo Bertoni
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Un degno avversario Bieber et al. Efficacy and safety of methylprednisolone aceponate ointment 0.1% compared to tacrolimus 0.03% in children and adolescents with an acute flare of severe atopic dermatitis. Allergy 2007;62:184-9 Marcello Bergamini Pediatra di Famiglia, Ferrara Un folto numero di dermatologi tedeschi, italiani e spagnoli ha di recente pubblicato su Allergy 1, gli estremi bibliografici sono posti sotto il titolo, uno studio multicentrico randomizzato controllato (RCT) di comparazione in doppio cieco fra l efficacia a breve termine del trattamento della cute con due tipi di unguento durante riacutizzazioni (flares) della dermatite atopica (DA) in bambini da 2 a 15 anni: i farmaci testati erano il metilprednisolone aceponato 0,1% (MPA-Intendis, un corticosteroide topico [CST] di media potenza, dotato di un buon indice terapeutico) ed il tacrolimus 0,03% (Protopic - Fujisawa, molecola ad azione immunomodulatrice appartenente alla categoria degli inibitori della calcineurina). La decisione di confrontare l efficacia del tacrolimus con quella di un diverso intervento farmacologico e non con il solo placebo, è indubbiamente lecita, anzi è molto opportuna, essendo i CST riconosciuti come il gold standard nella terapia della DA. Questo di Bieber e colleghi rappresenta, ed è un merito, il primo RCT pediatrico nel quale il tacrolimus sia stato confrontato con uno steroide topico più potente dell idrocortisone acetato 1%, cortisonico topico debole e molto poco usato nella pratica clinica quotidiana. Nei confronti precedenti, appunto con l idrocortisone acetato 2 3, i risultati erano stati favorevoli al tacrolimus. È dunque importante analizzare la validità di questo recente studio, la rilevanza dei suoi risultati, insomma verificare come se la cava il tacrolimus contro un cortisonico topico più potente e di uso abituale. Il disegno dello studio 266 bambini fra i 2 e i 15 anni furono reclutati in 25 centri dermatologici. Uno solo di essi fu escluso per mancato rispetto dei criteri di inclusione/esclusione. Ne furono randomizzati 129 nel gruppo MPA e 136 nel gruppo tacrolimus. Il più importante criterio d inclusione fu la severità (giudicata dai medici) del quadro clinico di presentazione, che doveva essere quantomeno severo, cioè almeno livello 5 o livello 6 della scala di valutazione Investigator s Global Assessment, IGA 4 5, uno score a 6 livelli molto utilizzato in vari tipi di patologie dermatologiche, il cui primo livello corrisponde a cute integra o clear, e il sesto livello ad un giudizio very severe (i livelli intermedi sono: almost clear, mild, moderate and severe ). Ulteriori criteri di inclusione furono la cronicità della DA e la sua estensione che, durante l episodio, doveva interessare almeno il 5% della superficie corporea totale (Body Surface Area o BSA). Il valore medio iniziale della BSA interessata fu del 29% circa. I criteri di esclusione furono molteplici, dalle recenti terapie locali con steroidi topici o con inibitori della calcineurina, alle terapie sistemiche o fisiche, a svariati tipi di patologie acute e croniche, ad un intolleranza manifestata in altre occasioni nei confronti delle due molecole da testare. I pazienti dovevano essere trattati con l applicazione degli unguenti, MAP 0,1% oppure tacrolimus 0,03%, in 2 somministrazioni (una delle quali nel gruppo MAP era costituita dal solo emolliente base); vedre- 25
2 mo più sotto, al paragrafo relativo alla cecità, le prerogative dei prodotti usati. Altri emollienti topici e bagni oleosi erano consentiti, qualora ne fosse percepita la necessità. Oltre alla valutazione clinica iniziale furono previste visite in 4 a, 7 a, 14 a e 21 a giornata d intervento; in tali occasioni venivano registrati gli indicatori d esito prescelti, primari e secondari. L indicatore d esito (o outcome) primario che Bieber e colleghi scelsero di utilizzare per meglio verificare l efficacia dei due tipi di intervento fu la modificazione dell IGA al termine dei 21 giorni di durata dello studio. Per rendere binomiali (cioè, successo o insuccesso) i risultati di questo outcome, gli Autori optarono per l attribuzione di un risultato positivo (successo) alle valutazioni di cute integra e cute quasi integra, e di un risultato negativo (insuccesso) alle valutazioni di livello peggiore, fino a quella di very severe. Gli indicatori d esito (o outcomes) secondari del lavoro furono numerosi. Ecco i principali di essi: - le modificazioni, valutate dai medici, dell EASI (Eczema Area and Severity Index); - le variazioni nella valutazione del prurito e della qualità del sonno da parte dei genitori, o dei pazienti di età più elevata, attraverso specifiche Visual Analogue Scale (VAS) di 100 mm di lunghezza; - le variazioni percentuali della BSA interessata dal flare; - il costo della terapia; - gli effetti avversi. Alla descrizione del trial non possono infine mancare le seguenti segnalazioni, importanti al fine di acquisire più elementi di giudizio (ognuno si farà il proprio, ovviamente) sull indipendenza degli esecutori del trial e sulla conseguente trasparenza dei risultati: Barche di pescatori a Quinto (GE) - Michele Fiore - il secondo nome fra i sette Autori dell articolo (K. Vick) era un ricercatore della Intendis GmbH di Berlino, la ditta che produce Advantan 0,1% (MPA); - la stessa Intendis GmbH ha sponsorizzato, a quanto sembra per intero, lo svolgimento del trial; - nel testo non vi è alcun accenno riguardo alle eventuali possibilità di accesso ai dati da parte dei ricercatori laici ; - nel testo non è esplicitato chi si incaricò dell elaborazione definitiva dei dati. Analisi critica secondo le User s Guides to the Medical Literature per i lavori di intervento 6 1. I risultati di questo studio sono validi? Criteri maggiori (bontà della randomizzazione e del follow-up) Si tratta di un trial clinico randomizzato: fu attuata una randomizzazione in blocchi, metodo utile al fine di mantenere il numero dei partecipanti in ogni gruppo il più omogeneo possibile. Si ottiene creando blocchi di sequenze in grado di assicurare che, all interno di ogni blocco, risulti distribuito lo stesso numero di partecipanti per i vari gruppi studiati. In linea di massima questo metodo dovrebbe consentire di mantenere occulte le liste agli investigatori (allocation concealment), ma questo problema non è dibattuto nel testo. Il follow-up fu sufficientemente lungo e completo: solo 2 pazienti, uno per gruppo, risultarono persi al follow-up, altri 6 non completarono il protocollo di studio (perdita complessiva del 3%, ampiamente inferiore al 5%, soglia al di sotto della quale i risultati dello studio in questione possono essere accettati con fiducia). Al termine del periodo d intervento tutti i pazienti furono correttamente analizzati nei rispettivi gruppi di randomizzazione (analisi Intention To Treat, ITT), perlomeno per quanto riguardava l outcome primario, rappresentato dai punteggi IGA al 21 giorno. Per gli outcomes secondari invece non è chiaro quanti pazienti fossero volta a volta analizzati ai giorni 4, 7, 14 e 21. Gli Autori poi riferiscono di aver sempre effettuato anche le analisi per protocollo (PP) e che esse avevano fornito risultati congruenti con quelli delle analisi ITT; piccolo neo, gli Autori non forniscono dati numerici al riguardo delle analisi PP. Criteri minori (bontà della cecità e dei co-trattamenti) Lo studio prevedeva la cecità dei genitori che somministravano i trattamenti, cecità garantita dalla perfetta somiglianza delle confezioni e degli stessi unguenti usati; in più, ai pazienti del gruppo MPA veni- 26
3 va somministrato al mattino un unguento base, del tutto identico a quello della sera, ma privo di attività farmacologica. Erano ciechi pure i medici (doppia cecità) e, anche se gli Autori non chiariscono se i medici arruolatori fossero i medesimi che poi valutavano i pazienti, non abbiamo motivo di dubitare di questa duplice cecità. L articolo è fornito della classica Tabella I, dalla quale emerge la sovrapponibilità delle caratteristiche di partenza dei pazienti nei due gruppi per quanto riguardava età, sesso, etnia, punteggi medi dell EASI, punteggi medi delle scale VAS per prurito e per qualità del sonno, percentuali medie delle BSA. L omogeneità dei punteggi IGA iniziali era già garantita dall arruolamento dei soli bambini con IGA di livello severe o very severe. Co-trattamenti: oltre alle terapie oggetto dello studio i pazienti venivano trattati in modo identico per quanto riguardava follow-up e prodotti topici supplementari. La possibile variabile legata ad un diverso uso, in termini quantitativi di questi ultimi, in forma di creme unguenti o bagni, non fu studiata, ma questa mancata valutazione non è da ritenere rilevante. In conclusione uno studio abbastanza valido almeno per quanto visto finora. 2. Quali sono i risultati del trial? Quanto sono importanti? 1 a premessa: per tutti gli outcomes di efficacia ci furono risultati favorevoli al trattamento, sia nel gruppo MPA che nel gruppo tacrolimus. 2 a premessa: la scelta dell outcome primario effettuata dagli Autori è a mio giudizio criticabile in quanto l Investigator s Global Assessment rappresenta una scala soggettiva, esclusivamente basata sulla valutazione globale della cute da parte dell esaminatore, valutazione che di fatto esclude sia il prurito sia la qualità di vita durante il sonno e negli altri momenti della giornata 7. Esistono, nella letteratura dermatologica ed in quella pediatrica, altre più complesse scale di valutazione clinica della DA. Alcune comprendono soltanto parametri oggettivi legati alle caratteristiche qualitative e quantitative delle lesioni cutanee (EASI, SASSAD), altre risultano dalla combinazione dei parametri oggettivi con importanti parametri soggettivi quali il prurito e la qualità del sonno (Costa s score, ADASI, SCORAD Index, modified-easi). Gli ultimi due Scoring Systems citati (SCORAD Index, modified-easi) sembrerebbero da preferire in quanto, più modernamente, offrono la possibilità di una valutazione globale ed appropriata della patologia 7. Come abbiamo visto, Bieber e collaboratori preferirono scegliere come indicatore primario uno score puramente oggettivo, aggiungendo poi EASI, m-easi e scale VAS per il prurito e per il sonno fra i numerosi indicatori secondari. Fatte salve le precedenti considerazioni, Bieber et al. giungono finalmente a comunicarci che la frequenza dei successi (intesi come somma delle frequenze dei livelli clear e almost clear all Investigator Global Assessment) risultò molto simile nei due gruppi di intervento, tant è vero che la differenza fra tali percentuali alla 21 a giornata fu solo dello 0,3% in più nel gruppo trattato con tacrolimus (66,9% vs. 66,6%), con una totale assenza di significatività (p = 0,9314). Box 1. La scelta dell outcome primario. La questione della scelta dell outcome primario non è di lana caprina, come si sarebbe tentati a pensare vedendo, ad esempio nell articolo che stiamo esaminando, che alcuni parametri importanti furono comunque inseriti fra gli indicatori d esito secondari. E i motivi principali sono due: il primo è che, in genere, gli Autori di un trial calcolano la numerosità campionaria necessaria per ottenere risultati statisticamente significativi, sulla base dell outcome primario prescelto e delle ipotetiche differenze fra i risultati che essi prevedono di riscontrare nei due gruppi alla fine dello studio; come conseguenza, le analisi statistiche eseguite sugli outcome secondari potranno essere soltanto di tipo esplorativo, ovvero destinate alla verifica di una eventuale significatività delle differenze fra i risultati. Ciò comporta che un mancato riscontro di significatività negli outcome secondari può essere attribuito, solo e sfortunatamente, all inadeguato numero di pazienti arruolati, finendo così per sminuire, di fatto, la potenziale rilevanza dei risultati dello studio. La seconda ragione per porre grande attenzione alla scelta dell outcome primario è che sarebbe fondamentale, nei trial di intervento, l individuazione di un indicatore d esito non solo robusto, ossia molto rilevante dal punto di vista clinico, ma anche solido (hard), ossia di sicura quantificazione; molto spesso invece si assiste, come nel caso dell articolo qui esaminato, all opinabile decisione di scegliere un indicatore sfumato, o leggero (soft), di difficile quantificazione o, comunque, poco riproducibile in ambito sperimentale 8. Tab. I. Outcome primario (IGA a 21 giorni) Successi Insuccessi Totale MPA 0,1% Tacrolimus Totale
4 Tutto finito? No di certo. Vediamo ora i risultati dei principali outcomes secondari, per i quali, come detto in precedenza, furono approntate delle analisi statistiche esplorative. Box 2. La scelta della modalità di presentazione dei risultati. Mentre per l indicatore d esito principale i dati sono stati opportunamente presentati sotto forma di proporzioni (% di pazienti migliorati, sul totale), per gli indicatori secondari gli Autori hanno scelto di utilizzare delle semplici misure lineari di alcuni parametri clinici. Questa strategia consente di ottenere con maggiore facilità risultati statisticamente significativi, ma la qualità di detti risultati in termini di applicazione clinica è sempre piuttosto scarsa, poiché non permette il rilevamento degli indici assoluti di efficacia di un intervento, in particolare del numero complessivo di pazienti da trattare per ottenere in uno di essi un risultato positivo proprio grazie al farmaco studiato (il famoso NNT). Punteggio EASI : gli Autori presentano i dati sotto forma di variazioni percentuali medie del punteggio nei due gruppi e ci dicono che le differenze fra queste variazioni percentuali rispetto alla situazione di partenza risultarono significativamente favorevoli al trattamento con il metilprednisolone aceponato in 7 a e 14 a giornata. A vedere il grafico relativo ci si rende conto che la differenza tra i due trattamenti, pur se significativa, è clinicamente poco rilevante. Miglioramento del prurito e della qualità del sonno : i risultati di questi outcomes secondari vengono presentati come differenze medie del numero di millimetri sulle scale VAS da 0 mm a 100 mm (rispettivamente da no itch a worst itch imaginable e da slept well a slept badly). Anche queste differenze si dimostrarono statisticamente significative, e sempre a favore del trattamento con MPA, nelle giornate 14 a e 21 a per tutti e due gli outcomes, e nelle giornate 4 a e 7 a per la sola intensità del prurito. Guardando i due grafici ci si accorge che le differenze ivi rappresentate non arrivavano mai a superare i 7,5 millimetri (valore alla 21 a giornata), quando la condizione VAS di partenza era attorno ai 65 mm nei due gruppi (poco più del 10% di differenza). Quindi, come sopra, differenze significative ma poco rilevanti clinicamente, almeno a mio parere. Altri outcome, non valutati statisticamente, furono: - la riduzione della Body Surface Area colpita, che risultò paragonabile nei due gruppi, con una differenza del solo 2,8% a favore del MPA 0,1%; - il costo dei farmaci consumati, che risultò 7 volte superiore nel gruppo tacrolimus ; - gli effetti avversi direttamente correlabili al trattamento in uso, che si documentarono solo nel gruppo tacrolimus (li presentarono 4 pazienti su 136). Quale fu la precisione delle stime? Questa valutazione è possibile solo per l outcome primario, per il quale è stata adottata una stima dell effetto aritmeticamente misurabile; ciò non riveste importanza all atto pratico in quanto il risultato non fu statisticamente significativo (gli intervalli di confidenza 95% erano al di sotto e al di sopra dello 0). Per gli outcome secondari è stata adottata, come abbiamo visto, un analisi probabilistica, nota per non essere in grado di quantificare la precisione delle stime. 3. Potranno i risultati di questo studio aiutarmi nella pratica quotidiana? Possono essere applicati alla cura di un mio paziente? Volendo sì, i pazienti erano tutti pediatrici. Ma essi furono arruolati durante esacerbazioni acute di DA piuttosto severe, cosa resa possibile dal fatto che i centri partecipanti erano tutti dermatologici e, come abbiamo visto, il tacrolimus non ha dimostrato vantaggi, comportando peraltro una maggiore spesa economica. Cosa succederebbe se i bambini avessero una DA di minore gravità, come per esempio i bambini abitualmente gestiti in prima persona da me, che sono un pediatra di famiglia? Il tacrolimus agirebbe come, meglio o peggio del MPA? Non si sa, il confronto in precedenza è stato attuato solamente con l idrocortisone acetato, che non si adopera oramai quasi più, almeno in Italia. Quindi, strettamente per i miei pazienti, quelli di un pediatra di famiglia, i risultati dello studio di Bieber et al sono di rara applicabilità. Sono stati considerati tutti gli outcomes importanti? Non del tutto. È pur vero che tutti i parametri clinici della malattia, alla fine, erano stati inseriti come indicatori (l evitamento di un ricovero durante una riesacerbazione, l outcome più robusto in assoluto e molto meno frequente, avrebbe comportato il reclutamento di una coorte di pazienti enorme). Ma fin dall inizio di questa analisi critica abbiamo parlato della possibilità di utilizzare come outcome diversi tipi di scores. Il dubbio rimane quindi se preferire come outcome primari gli scores combinati o una sommatoria di più scores dedicati ad uno o più parametri clinici. Inoltre, Bieber e collaboratori non si sono preoccupati di rilevare né di quantificare l interessamento delle aree cutanee del collo e del viso dei loro pazienti, mentre è noto che una delle indicazioni principali degli esperti per l uso del tacrolimus è proprio il trattamento di quelle zone. Infine, la sicurezza dei due farmaci nel lungo termine non fu testata, a causa del fatto che sarebbe stato comunque impossibile protrarre il trattamento con tacrolimus oltre le tre settimane, come da scheda tecnica. 28
5 I potenziali vantaggi della terapia bilanciano i rischi ed i costi ad essa collegati? Questa domanda presuppone che, nell ambito di un RCT, una terapia prevalga su di un altra e che quindi della vincitrice si valuti un bilancio tra vantaggi e svantaggi. In questo caso non abbiamo un vero vincitore, i due contendenti hanno chiuso in parità. A questo punto, se i trattamenti si equivalgono, nella decisione clinica potrebbe contare il costo economico, che è risultato 7 volte superiore nel caso del tacrolimus. Conclusioni L articolo di Bieber et al. ha dalla sua, e non è poco, la primogenitura di un confronto tra tacrolimus e un valido avversario quanto a cortisonico topico, il MPA. Qualche scelta metodologica non è stata da me condivisa, ma rimane uno studio valido e che fornisce informazioni utilizzabili, anche se forse non propriamente da un pediatra di famiglia per i suoi abituali bambini con DA. In ogni caso da questo studio emerge una sostanziale parità di efficacia di MPA e tacrolimus nel trattamento delle esacerbazioni acute di DA in età pediatrica. I costi sono decisamente sfavorevoli al tacrolimus. Per chiudere, sarebbe molto interessante leggere anche di confronti con altri steroidi topici dotati di un buon indice terapeutico e già testati sul fronte della sicurezza nella prima infanzia, quale ad esempio il fluticasone propinato, magari con un periodo di osservazione ben più lungo di quello messo in atto da Bieber et al. Bibliografia 1 Bieber T, Vick K, Folster-Holst R, Belloni-Fortina A, Stodtler G, Worm M, et al. Efficacy and safety of methylprednisolone aceponate ointment 0.1% compared to tacrolimus 0.03% in children and adolescents with an acute flare of severe atopic dermatitis. Allergy 2007;62: Reitamo S, Van Leent EJM, Ho V, Harper J, Ruzicka T, Kalimo K, et al. Efficacy and safety of tacrolimus ointment compared with that of hydrocortisone acetate ointment in children with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2002;109: Reitamo S, Harper J, Bos JD, Cambazard F, Bruijnzeel Koomen CA, Valk P, et al. 0.03% Tacrolimus ointment applied once or twice daily is more efficacious than 1% hydrocortisone acetate in children with moderate to severe atopic dermatitis: results of a randomized double-blind controlled trial. Br J Dermatol 2004;150: Jorizzo J, Levy M, Lucky A, Shavin J, Goldberg G, Dunlap F, et al. Multicenter trial for long-term safety and efficacy comparison of 0.05% desonide and 1% hydrocortisone ointments in the treatment of atopic dermatitis in pediatric patients. J Am Acad Dermatol 1995;33: Eichenfeld LF, Lucky AW, Boguniewicz M, Langley RGB, Cherill R, Marshall K, et al. Safety and efficacy of pimecrolimus (ASM 981) cream 1% in the treatment of mild and moderate atopic dermatitis in children and adolescents. J Am Acad Dermatol 2002;46: Guyatt GH, Sackett D, Cook DJ, for the Evidence Based Medicine Working Group. How to Use an Article About Therapy or Prevention. JAMA 1993;270: Gelmetti C, Colonna C. The value of SCORAD and beyond. Towards a standardized evaluation of severity? Allergy 2004;59(Suppl. 78): Buzzetti R, Mastroiacovo P. Le prove di efficacia in pediatria. UTET Periodici 2000, p. 14. Particolare della facciata del Santuario della Beata Vergine delle Lacrime (Treviglio) - Francesca Valerio Cattedrale, Otranto - Daniele Bove 29
Principali criteri per valutare la qualità di una revisione sistematica
 Principali criteri per valutare la qualità di una revisione sistematica A cura di Luca Ronfani Adattato da: Oxman AD, et al. Users' guides to the medical literature. VI. How to use an overview. JAMA 1994;
Principali criteri per valutare la qualità di una revisione sistematica A cura di Luca Ronfani Adattato da: Oxman AD, et al. Users' guides to the medical literature. VI. How to use an overview. JAMA 1994;
Principali aspetti da considerare nella lettura critica di un RCT (materiali e metodi)
 L utilità clinica delle informazioni che uno studio fornisce dipende anche dalla sua qualità metodologica: è stato condotto bene? è stato presentato bene? I lavori vanno SEMPRE letti in maniera critica
L utilità clinica delle informazioni che uno studio fornisce dipende anche dalla sua qualità metodologica: è stato condotto bene? è stato presentato bene? I lavori vanno SEMPRE letti in maniera critica
CONSORT statement: raccomandazioni per migliorare la qualità della presentazione dei RCT
 CONSORT statement: raccomandazioni per migliorare la qualità della presentazione dei RCT 1997: di 122 RCTs pubblicati su efficacia di un farmaco per la depressione (inibitori selettivi del reuptake della
CONSORT statement: raccomandazioni per migliorare la qualità della presentazione dei RCT 1997: di 122 RCTs pubblicati su efficacia di un farmaco per la depressione (inibitori selettivi del reuptake della
Come utilizzare la scala di Jadad
 Scala di Jadad La scala di Jadad è uno strumento validato che serve per valutare la qualità metodologica di un RCT. Analizza l adeguatezza di randomizzazione, doppio cieco e perdita al follow up. Lo score
Scala di Jadad La scala di Jadad è uno strumento validato che serve per valutare la qualità metodologica di un RCT. Analizza l adeguatezza di randomizzazione, doppio cieco e perdita al follow up. Lo score
Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 1. L analisi statistica
 Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 1 L analisi statistica Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 2 Esempio (de Gans et al. NEJM 2002, 347: 1549-56) Esito Desametazone Trattamento
Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 1 L analisi statistica Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 2 Esempio (de Gans et al. NEJM 2002, 347: 1549-56) Esito Desametazone Trattamento
Ricette di ricerca Come fare una ricerca bibliografica di successo ADE. Corso di laurea B a.a. 2013/2014
 Ricette di ricerca Come fare una ricerca bibliografica di successo ADE Corso di laurea B a.a. 2013/2014 Prof. V. Trischitta Dott. E. Giannetta RICERCA BIBLIOGRAFICA 1.QUESITO CLINICO: Effetti del sildenafil
Ricette di ricerca Come fare una ricerca bibliografica di successo ADE Corso di laurea B a.a. 2013/2014 Prof. V. Trischitta Dott. E. Giannetta RICERCA BIBLIOGRAFICA 1.QUESITO CLINICO: Effetti del sildenafil
TUTORATO 2 Test di significatività e intervalli di confidenza
 TUTORATO 2 Test di significatività e intervalli di confidenza 1) Nel corso della sperimentazione del farmaco si rilevò la frequenza cardiaca in 9 pazienti, prima e dopo il trattamento, riscontrando i valori
TUTORATO 2 Test di significatività e intervalli di confidenza 1) Nel corso della sperimentazione del farmaco si rilevò la frequenza cardiaca in 9 pazienti, prima e dopo il trattamento, riscontrando i valori
Criteri per valutare la validità di una revisione sistematica
 Criteri per valutare la validità di una revisione sistematica 1. La revisione risponde ad un quesito clinico chiaro e ben definito? 2. I criteri di selezione degli articoli (inclusione/esclusione) sono
Criteri per valutare la validità di una revisione sistematica 1. La revisione risponde ad un quesito clinico chiaro e ben definito? 2. I criteri di selezione degli articoli (inclusione/esclusione) sono
Elementi di Epidemiologia per la Valutazione Comparativa di Esito
 Elementi di Epidemiologia per la Valutazione Comparativa di Esito La valutazione della qualità dell assistenza: quali domande? L incidenza di alcuni esiti negativi dell assistenza ospedaliera (come la
Elementi di Epidemiologia per la Valutazione Comparativa di Esito La valutazione della qualità dell assistenza: quali domande? L incidenza di alcuni esiti negativi dell assistenza ospedaliera (come la
Lezione 2 Come leggere l articolo scientifico
 Analisi critica della letteratura scientifica Lezione 2 Come leggere l articolo scientifico Struttura dell articolo Introduzione Metodi Risultati e Discussione Perché è stato fatto? Come è stato condotto?
Analisi critica della letteratura scientifica Lezione 2 Come leggere l articolo scientifico Struttura dell articolo Introduzione Metodi Risultati e Discussione Perché è stato fatto? Come è stato condotto?
Quanti soggetti devono essere selezionati?
 Quanti soggetti devono essere selezionati? Determinare una appropriata numerosità campionaria già in fase di disegno dello studio molto importante è molto Studi basati su campioni troppo piccoli non hanno
Quanti soggetti devono essere selezionati? Determinare una appropriata numerosità campionaria già in fase di disegno dello studio molto importante è molto Studi basati su campioni troppo piccoli non hanno
Una dermatite destinata a non finire mai
 Una dermatite destinata a non finire mai Massimo Gola S.A.S. Dermatologia Allergologica e Professionale e Ambulatorio Dermatologico della Mano, Università e Azienda Sanitaria di Firenze, Presidio Ospedaliero
Una dermatite destinata a non finire mai Massimo Gola S.A.S. Dermatologia Allergologica e Professionale e Ambulatorio Dermatologico della Mano, Università e Azienda Sanitaria di Firenze, Presidio Ospedaliero
Epidemiologia e disegni di studio
 Epidemiologia e disegni di studio L epidemiologia valuta le associazioni tra fattori di esposizione ed esiti di salute all interno di predefinite cornici logico-formali Esposizione X Malattia Y Tali cornici
Epidemiologia e disegni di studio L epidemiologia valuta le associazioni tra fattori di esposizione ed esiti di salute all interno di predefinite cornici logico-formali Esposizione X Malattia Y Tali cornici
Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 1. L analisi dei dati
 Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 1 L analisi dei dati Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 2 Quali soggetti analizzare? Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 3
Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 1 L analisi dei dati Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 2 Quali soggetti analizzare? Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 3
Dermatite atopica e medicina low dose
 XXV CONGRESSO NAZIONALE SIPPS REGALIAMO FUTURO Bari 12-14 settembre 2013 Dermatite atopica e medicina low dose Pediatra, Esperta in CAM La dermatite atopica fa parte del gruppo degli eczemi ECZEMA Patologia
XXV CONGRESSO NAZIONALE SIPPS REGALIAMO FUTURO Bari 12-14 settembre 2013 Dermatite atopica e medicina low dose Pediatra, Esperta in CAM La dermatite atopica fa parte del gruppo degli eczemi ECZEMA Patologia
Come si legge una meta-analisi. Giuseppe Pingitore (settembre 2011)
 Come si legge una meta-analisi Giuseppe Pingitore (settembre 2011) Meta-analisi La meta-analisi è una tecnica clinico-statistica, che consente di assemblare i risultati di più trial di uno stesso trattamento
Come si legge una meta-analisi Giuseppe Pingitore (settembre 2011) Meta-analisi La meta-analisi è una tecnica clinico-statistica, che consente di assemblare i risultati di più trial di uno stesso trattamento
1. Introduzione ai disegni sperimentali. 5. Analisi della regressione lineare. 6. Confronto tra proporzioni di due o più campioni indipendenti
 BIOSTATISTICA 1. Introduzione ai disegni sperimentali 2. Un carattere quantitativo misurato in un campione: elementi di statistica descrittiva e inferenziale 3. Confronto tra medie di due campioni indipendenti
BIOSTATISTICA 1. Introduzione ai disegni sperimentali 2. Un carattere quantitativo misurato in un campione: elementi di statistica descrittiva e inferenziale 3. Confronto tra medie di due campioni indipendenti
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L INSERIMENTO DI FARMACI NON PRESENTI NEL PTR
 RICHIESTA DI INSERIMENTO IN PTR DI METILAMINOLEVULINATO L01XD (Metvix ) Presentata da Commissione Terapeutica Provinciale di Cagliari In data novembre 2008 Per le seguenti motivazioni: Terapia delle neoplasie
RICHIESTA DI INSERIMENTO IN PTR DI METILAMINOLEVULINATO L01XD (Metvix ) Presentata da Commissione Terapeutica Provinciale di Cagliari In data novembre 2008 Per le seguenti motivazioni: Terapia delle neoplasie
Test d Ipotesi Introduzione
 Test d Ipotesi Introduzione Uno degli scopi più importanti di un analisi statistica è quello di utilizzare i dati provenienti da un campione per fare inferenza sulla popolazione da cui è stato estratto
Test d Ipotesi Introduzione Uno degli scopi più importanti di un analisi statistica è quello di utilizzare i dati provenienti da un campione per fare inferenza sulla popolazione da cui è stato estratto
Le principali tappe dell EBM
 Le principali tappe dell EBM 1. La formulazione del quesito clinico in termini chiari; 2. La ricerca sistematica ed esaustiva delle prove nella letteratura medica, 3. La loro interpretazione critica, 4.
Le principali tappe dell EBM 1. La formulazione del quesito clinico in termini chiari; 2. La ricerca sistematica ed esaustiva delle prove nella letteratura medica, 3. La loro interpretazione critica, 4.
Commissione Regionale Farmaco LAPATINIB
 Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1540/2006 e D.G.R. 490 dell 11 aprile 2011) Documento relativo a: LAPATINIB Settembre 2011 Indicazioni registrate Lapatinib Il lapatinib ha ricevuto la seguente estensione
Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1540/2006 e D.G.R. 490 dell 11 aprile 2011) Documento relativo a: LAPATINIB Settembre 2011 Indicazioni registrate Lapatinib Il lapatinib ha ricevuto la seguente estensione
Commento a cura di Giovanni Simeone - Pediatra di Famiglia - (Mesagne-BR)
 Nei lattanti non allattati al seno, affetti da DA lieve o moderata, l'utilizzo dei latti parzialmente idrolizzati ( Latti HA) è in grado di ridurre la gravità clinica della malattia. Articolo originale:
Nei lattanti non allattati al seno, affetti da DA lieve o moderata, l'utilizzo dei latti parzialmente idrolizzati ( Latti HA) è in grado di ridurre la gravità clinica della malattia. Articolo originale:
Confronto fra soggetti o entro soggetti?
 Confronto fra soggetti o entro soggetti? Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 2 Gli studi crossover Periodo 1 Periodo 2 R A N D O M A B A B Valutazione Tempo 1 0 1 1 2 0 2 1 Metodo epidemiologici
Confronto fra soggetti o entro soggetti? Metodo epidemiologici per la clinica _efficacia / 2 Gli studi crossover Periodo 1 Periodo 2 R A N D O M A B A B Valutazione Tempo 1 0 1 1 2 0 2 1 Metodo epidemiologici
EFFICACIA DI DULOXETINA E PREGABALIN NELLA TERAPIA A BREVE TERMINE DELLA NEUROPATIA DIABETICA
 EFFICACIA DI DULOXETINA E PREGABALIN NELLA TERAPIA A BREVE TERMINE DELLA NEUROPATIA DIABETICA In Italia sono attualmente approvati per il trattamento del DPNP soltanto tre farmaci; tra questi i due più
EFFICACIA DI DULOXETINA E PREGABALIN NELLA TERAPIA A BREVE TERMINE DELLA NEUROPATIA DIABETICA In Italia sono attualmente approvati per il trattamento del DPNP soltanto tre farmaci; tra questi i due più
PAZIENTI AMBULATORIALI VIA LIVIGNO A.O. ICP MI - PAD. C A.O. SAN GERARDO 1 SETTEMBRE NOVEMBRE 2013
 PAZIENTI AMBULATORIALI VIA LIVIGNO A.O. ICP MI - PAD. C A.O. SAN GERARDO 1 SETTEMBRE 2013-15 NOVEMBRE 2013 PAZIENTI DERMATOLOGICI TOTALI 981 : 432 MASCHI E 549 FEMMINE PAZIENTI AFFETTI DA PSORIASI 71:
PAZIENTI AMBULATORIALI VIA LIVIGNO A.O. ICP MI - PAD. C A.O. SAN GERARDO 1 SETTEMBRE 2013-15 NOVEMBRE 2013 PAZIENTI DERMATOLOGICI TOTALI 981 : 432 MASCHI E 549 FEMMINE PAZIENTI AFFETTI DA PSORIASI 71:
29 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELLA PSORIASI. Stefano Catrani Azienda USL della Romagna Rimini
 29 OTTOBRE 2016 - GIORNATA MONDIALE DELLA PSORIASI Stefano Catrani Azienda USL della Romagna Rimini 29 OTTOBRE 2016 - GIORNATA MONDIALE DELLA PSORIASI Stefano Catrani Azienda USL della Romagna Rimini Psoriasi
29 OTTOBRE 2016 - GIORNATA MONDIALE DELLA PSORIASI Stefano Catrani Azienda USL della Romagna Rimini 29 OTTOBRE 2016 - GIORNATA MONDIALE DELLA PSORIASI Stefano Catrani Azienda USL della Romagna Rimini Psoriasi
RICHIESTA DI PARERE SU SPERIMENTAZIONE CLINICA DI DISPOSITIVO MEDICO
 COMITATO ETICO INTERAZIENDALE (istituito con Delibera n. 236 del 10/09/13 e successiva Delibera n. 267 del 25/10/13 ed iscritto al Registro Regionale al n. 2) Sede: Via Venezia n.16, 15121 tel.0131206974-6651
COMITATO ETICO INTERAZIENDALE (istituito con Delibera n. 236 del 10/09/13 e successiva Delibera n. 267 del 25/10/13 ed iscritto al Registro Regionale al n. 2) Sede: Via Venezia n.16, 15121 tel.0131206974-6651
JOURNAL CLUB 8 Maggio Marco Armando, Maria Pontillo Protocollo UHR/Esordi Psicotici
 JOURNAL CLUB 8 Maggio 2014 Marco Armando, Maria Pontillo Protocollo UHR/Esordi Psicotici 2 Background Farmaci antipsicotici prima linea d intervento nella Schizofrenia Vantaggi: -Riduzione sintomatologia
JOURNAL CLUB 8 Maggio 2014 Marco Armando, Maria Pontillo Protocollo UHR/Esordi Psicotici 2 Background Farmaci antipsicotici prima linea d intervento nella Schizofrenia Vantaggi: -Riduzione sintomatologia
Screening, sensibilità e specificità di un test diagnostico, curve R.O.C., teorema di Bayes
 Screening, sensibilità e specificità di un test diagnostico, curve R.O.C., teorema di Bayes Prof. Giuseppe Verlato Sezione di Epidemiologia e Statistica Medica, Università di Verona Storia naturale di
Screening, sensibilità e specificità di un test diagnostico, curve R.O.C., teorema di Bayes Prof. Giuseppe Verlato Sezione di Epidemiologia e Statistica Medica, Università di Verona Storia naturale di
La dermatologia pediatrica ambulatoriale attraverso casi clinici vissuti. Giuseppe Ruggiero
 La dermatologia pediatrica ambulatoriale attraverso casi clinici vissuti. Giuseppe Ruggiero La dermatologia pediatrica ambulatoriale attraverso casi clinici vissuti Uso dei cortisonici topici in età pediatrica:
La dermatologia pediatrica ambulatoriale attraverso casi clinici vissuti. Giuseppe Ruggiero La dermatologia pediatrica ambulatoriale attraverso casi clinici vissuti Uso dei cortisonici topici in età pediatrica:
IN THE LA SOLUZIONE RAPIDA PER I SINTOMI DELL HERPES GENITALE
 HERPES IN THE CITY? NOVITÀ LA SOLUZIONE RAPIDA PER I SINTOMI DELL HERPES GENITALE Riduce sin dai primi giorni di applicazione i sintomi dolorosi dell Herpes Riduce gli altri sintomi soggettivi dell Herpes
HERPES IN THE CITY? NOVITÀ LA SOLUZIONE RAPIDA PER I SINTOMI DELL HERPES GENITALE Riduce sin dai primi giorni di applicazione i sintomi dolorosi dell Herpes Riduce gli altri sintomi soggettivi dell Herpes
Farmaci biologici nel trattamento della psoriasi: differenze nei criteri di valutazione tra USA e UE.
 Farmaci biologici nel trattamento della psoriasi: differenze nei criteri di valutazione tra USA e UE. Renato Bertini Malgarini, Giuseppe Pimpinella, Luca Pani 10 dicembre 2012- Istituto Superiore di Sanità
Farmaci biologici nel trattamento della psoriasi: differenze nei criteri di valutazione tra USA e UE. Renato Bertini Malgarini, Giuseppe Pimpinella, Luca Pani 10 dicembre 2012- Istituto Superiore di Sanità
MODELLO DI COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DELLA DECISIONE DEL COMITATO ETICO RELATIVA AL PARERE UNICO 1
 Appendice 6 MODELLO DI COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DELLA DECISIONE DEL COMITATO ETICO RELATIVA AL PARERE UNICO 1 Il presente parere del comitato etico è stato compilato e stampato dal sito internet dell
Appendice 6 MODELLO DI COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DELLA DECISIONE DEL COMITATO ETICO RELATIVA AL PARERE UNICO 1 Il presente parere del comitato etico è stato compilato e stampato dal sito internet dell
Analisi della varianza
 Università degli Studi di Padova Facoltà di Medicina e Chirurgia Facoltà di Medicina e Chirurgia - A.A. 2009-10 Scuole di specializzazione Lezioni comuni Disciplina: Statistica Docente: dott.ssa Egle PERISSINOTTO
Università degli Studi di Padova Facoltà di Medicina e Chirurgia Facoltà di Medicina e Chirurgia - A.A. 2009-10 Scuole di specializzazione Lezioni comuni Disciplina: Statistica Docente: dott.ssa Egle PERISSINOTTO
Report - ESPERIENZA PRATICA NELL APPLICAZIONE DI DERMASILK SU BAMBINI CON DERMATITE ATOPICA
 Report - ESPERIENZA PRATICA NELL APPLICAZIONE DI DERMASILK SU BAMBINI CON DERMATITE ATOPICA Dr. Kristin Kernland Lang, Dirigente Medico e Consulente di Dermatologia pediatrica, Clinica Dermatologica Universitaria,
Report - ESPERIENZA PRATICA NELL APPLICAZIONE DI DERMASILK SU BAMBINI CON DERMATITE ATOPICA Dr. Kristin Kernland Lang, Dirigente Medico e Consulente di Dermatologia pediatrica, Clinica Dermatologica Universitaria,
Colchicina nella prevenzione degli eventi cardiovascolari
 Revisione Cochrane 2016 Colchicina nella prevenzione degli eventi cardiovascolari Hemkens LG, Ewald H, Gloy VL, et al. Colchicine for prevention of cardiovascular events. Cochrane Database Syst Rev 2016;1:CD011047.
Revisione Cochrane 2016 Colchicina nella prevenzione degli eventi cardiovascolari Hemkens LG, Ewald H, Gloy VL, et al. Colchicine for prevention of cardiovascular events. Cochrane Database Syst Rev 2016;1:CD011047.
L aggiornamento pubblicato nel marzo del 2007 è stato integrato con la pubblicazione della prima lista di farmaci essenziali ad uso pediatrico
 Nel 1977, l Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblica il primo report sui farmaci essenziali. Indicato con l acronimo WHO TRS 615, il report tecnico costituisce la prima lista di farmaci essenziali
Nel 1977, l Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblica il primo report sui farmaci essenziali. Indicato con l acronimo WHO TRS 615, il report tecnico costituisce la prima lista di farmaci essenziali
Aderenza e appropriatezza terapeutica: il punto di vista del MMG
 Aderenza e appropriatezza terapeutica: il punto di vista del MMG Maria Maddalena Matarazzo FIMMG ROMA Domus De Maria (CA) 5-10 ottobre 2015 Appropriatezza ASL PAZIENTE MEDICO Appropriatezza clinica L appropriatezza
Aderenza e appropriatezza terapeutica: il punto di vista del MMG Maria Maddalena Matarazzo FIMMG ROMA Domus De Maria (CA) 5-10 ottobre 2015 Appropriatezza ASL PAZIENTE MEDICO Appropriatezza clinica L appropriatezza
Produttività, capacità di attrarre risorse e trasferibilità
 Produttività, capacità di attrarre Trials clinici Anno 2008 Studio Gisas: aripiprazolo, olanzapina e aloperidolo nel trattamento a lungo termine della schizofrenia Lo studio si propone di valutare l utilità
Produttività, capacità di attrarre Trials clinici Anno 2008 Studio Gisas: aripiprazolo, olanzapina e aloperidolo nel trattamento a lungo termine della schizofrenia Lo studio si propone di valutare l utilità
Università del Piemonte Orientale. Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Corso di Statistica Medica. I modelli di studio
 Università del Piemonte Orientale Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Corso di Statistica Medica I modelli di studio Corso di laurea in medicina e chirurgia - Statistica Medica Disegno dello studio
Università del Piemonte Orientale Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Corso di Statistica Medica I modelli di studio Corso di laurea in medicina e chirurgia - Statistica Medica Disegno dello studio
Metodi epidemiologici per la clinica _efficacia / 1. La valutazione dell efficacia: dalla domanda al disegno
 Metodi epidemiologici per la clinica _efficacia / 1 La valutazione dell efficacia: dalla domanda al disegno Metodi epidemiologici per la clinica _efficacia / 2 L effetto del trattamento non è misurabile
Metodi epidemiologici per la clinica _efficacia / 1 La valutazione dell efficacia: dalla domanda al disegno Metodi epidemiologici per la clinica _efficacia / 2 L effetto del trattamento non è misurabile
L analisi della distribuzione in quartili evidenzia come questa sia omogenea nei due sottogruppi simili (negativi vs positivi).
 L utilizzo di anticoagulanti maggiori in una popolazione sottoposta a ricerca del Sangue Occulto Fecale nell ambito dello screening del tumore colo-rettale: un analisi territoriale Marazza G., Rossetti
L utilizzo di anticoagulanti maggiori in una popolazione sottoposta a ricerca del Sangue Occulto Fecale nell ambito dello screening del tumore colo-rettale: un analisi territoriale Marazza G., Rossetti
IV CONGRESSO REGIONALE ADDIS (Napoli, 14 dicembre 2012)
 IV CONGRESSO REGIONALE ADDIS (Napoli, 14 dicembre 2012) Sostenibilità economica dell appropriatezza terapeutica: il caso delle statine e della terapia dell osteoporosi Luca Degli Esposti, Economista CliCon
IV CONGRESSO REGIONALE ADDIS (Napoli, 14 dicembre 2012) Sostenibilità economica dell appropriatezza terapeutica: il caso delle statine e della terapia dell osteoporosi Luca Degli Esposti, Economista CliCon
Scelta del disegno dello studio
 Scelta del disegno dello studio La scelta del disegno dipende da: 1) Tipo di domanda a cui vogliamo rispondere determinare il livello di malattia in una popolazione identificare cause di malattia o sottogruppi
Scelta del disegno dello studio La scelta del disegno dipende da: 1) Tipo di domanda a cui vogliamo rispondere determinare il livello di malattia in una popolazione identificare cause di malattia o sottogruppi
Fattori clinici e parametri funzionali associati allo status di frequente riacutizzatore nei pazienti con BPCO di grado severo
 Università degli Studi di Bari Aldo Moro Scuola di Specializzazione in Malattie dell Apparato Respiratorio Direttore : Prof. Onofrio Resta Fattori clinici e parametri funzionali associati allo status di
Università degli Studi di Bari Aldo Moro Scuola di Specializzazione in Malattie dell Apparato Respiratorio Direttore : Prof. Onofrio Resta Fattori clinici e parametri funzionali associati allo status di
IDENTIFICAZIONE DI UNA NUOVA SOGLIA CLINICO-DIAGNOSTICA PER LA PREVENZIONE TERAPEUTICA DI FRATTURE VERTEBRALI: LA PRE-FRATTURA VERTEBRALE
 IDENTIFICAZIONE DI UNA NUOVA SOGLIA CLINICO-DIAGNOSTICA PER LA PREVENZIONE TERAPEUTICA DI FRATTURE VERTEBRALI: LA PRE-FRATTURA VERTEBRALE Marco Ceccarelli 1, Nardo Letari 1, Claudia Davini 1, Daniela Melchiorrre
IDENTIFICAZIONE DI UNA NUOVA SOGLIA CLINICO-DIAGNOSTICA PER LA PREVENZIONE TERAPEUTICA DI FRATTURE VERTEBRALI: LA PRE-FRATTURA VERTEBRALE Marco Ceccarelli 1, Nardo Letari 1, Claudia Davini 1, Daniela Melchiorrre
Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1209/2002)
 Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1209/2002) Documento relativo a: BUDESONIDE + FORMOTEROLO SALMETEROLO XINAFOATO + FLUTICASONE PROPIONATO usi appropriati delle associazioni di farmaci steroidei e
Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1209/2002) Documento relativo a: BUDESONIDE + FORMOTEROLO SALMETEROLO XINAFOATO + FLUTICASONE PROPIONATO usi appropriati delle associazioni di farmaci steroidei e
Indicazioni metodologiche per la preparazione dei materiali da parte degli esperti
 Indicazioni metodologiche per la preparazione dei materiali da parte degli esperti Una revisione della letteratura verrà realizzata dal CeVEAS sulla base di indicazioni bibliografiche essenziali fornite
Indicazioni metodologiche per la preparazione dei materiali da parte degli esperti Una revisione della letteratura verrà realizzata dal CeVEAS sulla base di indicazioni bibliografiche essenziali fornite
Errori (o bias) negli studi epidemiologici
 Errori (o bias) negli studi epidemiologici Errore casuale o random: sono i più pericolosi perché i più difficili da individuare e per questo motivo non è possibile tenerne conto in fase di analisi Variazione
Errori (o bias) negli studi epidemiologici Errore casuale o random: sono i più pericolosi perché i più difficili da individuare e per questo motivo non è possibile tenerne conto in fase di analisi Variazione
Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie
 Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie Dr Marchi Rita Medico di Medicina Generale Presidente S.I.M.G di Ferrara 24 settembre 2016 Dati ISTAT 2012-2013,
Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie Dr Marchi Rita Medico di Medicina Generale Presidente S.I.M.G di Ferrara 24 settembre 2016 Dati ISTAT 2012-2013,
Indicatori di Posizione e di Variabilità. Corso di Laurea Specialistica in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE Statistica Medica
 Indicatori di Posizione e di Variabilità Corso di Laurea Specialistica in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE Statistica Medica Indici Sintetici Consentono il passaggio da una pluralità
Indicatori di Posizione e di Variabilità Corso di Laurea Specialistica in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE Statistica Medica Indici Sintetici Consentono il passaggio da una pluralità
Seconda Parte Specifica per la tipologia di scuola - Statistica sanitaria e Biometria - 22/07/2016
 Domande relative alla specializzazione in: Statistica sanitaria e Biometria Scenario 1: In uno studio prospettivo condotto per valutare la relazione tra l'uso di estrogeni e rischio di cancro alla mammella,
Domande relative alla specializzazione in: Statistica sanitaria e Biometria Scenario 1: In uno studio prospettivo condotto per valutare la relazione tra l'uso di estrogeni e rischio di cancro alla mammella,
SMID a.a. 2004/2005 Corso di Metodi Statistici in Biomedicina Prognosi clinica 28/2/2005
 SMID a.a. 2004/2005 Corso di Metodi Statistici in Biomedicina Prognosi clinica 28/2/2005 Formulazione La prognosi non è altro che la stima della probabilità di un certo esito Quando il medico fa una previsione
SMID a.a. 2004/2005 Corso di Metodi Statistici in Biomedicina Prognosi clinica 28/2/2005 Formulazione La prognosi non è altro che la stima della probabilità di un certo esito Quando il medico fa una previsione
Il metodo sperimentale
 STUDI SPERIMENTALI Studi sperimentali Il metodo sperimentale La validità nel metodo sperimentale risiede nel controllo diretto da parte del ricercatore sulla assegnazione dei soggetti ai gruppi di studio
STUDI SPERIMENTALI Studi sperimentali Il metodo sperimentale La validità nel metodo sperimentale risiede nel controllo diretto da parte del ricercatore sulla assegnazione dei soggetti ai gruppi di studio
Sommario. Capitolo 1 I dati e la statistica 1. Capitolo 2 Statistica descrittiva: tabelle e rappresentazioni grafiche 25
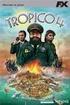 Sommario Presentazione dell edizione italiana Prefazione xv xiii Capitolo 1 I dati e la statistica 1 Statistica in pratica: BusinessWeek 1 1.1 Le applicazioni in ambito aziendale ed economico 3 Contabilità
Sommario Presentazione dell edizione italiana Prefazione xv xiii Capitolo 1 I dati e la statistica 1 Statistica in pratica: BusinessWeek 1 1.1 Le applicazioni in ambito aziendale ed economico 3 Contabilità
Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1540/2006 e D.G.R. 2330/2008) Documento relativo a: USTEKINUMAB
 Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1540/2006 e D.G.R. 2330/2008) Documento relativo a: USTEKINUMAB Giugno 2010 Assessorato Politiche per la salute Commissione Regionale del Farmaco Ustekinumab Indicazioni
Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1540/2006 e D.G.R. 2330/2008) Documento relativo a: USTEKINUMAB Giugno 2010 Assessorato Politiche per la salute Commissione Regionale del Farmaco Ustekinumab Indicazioni
PREMIO NAZIONALE SULLA RICERCA INFERMIERISTICA
 PREMIO NAZIONALE SULLA RICERCA INFERMIERISTICA INFERMIERA GEMMA CASTORINA Grosseto - 14 Maggio 2014 PROGETTO: L efficacia di un programma infermieristico di reminder sulla fiducia negli infermieri, l aderenza
PREMIO NAZIONALE SULLA RICERCA INFERMIERISTICA INFERMIERA GEMMA CASTORINA Grosseto - 14 Maggio 2014 PROGETTO: L efficacia di un programma infermieristico di reminder sulla fiducia negli infermieri, l aderenza
Simulazione di esercizi su test di significatività e 95%CI
 Simulazione di esercizi su test di significatività e 95%CI 1) In un trial clinico vennero trattati 10 pazienti ipertesi con un preparato di Rawolfia. I valori pressori (in mmhg) riscontrati prima del trattamento
Simulazione di esercizi su test di significatività e 95%CI 1) In un trial clinico vennero trattati 10 pazienti ipertesi con un preparato di Rawolfia. I valori pressori (in mmhg) riscontrati prima del trattamento
Cimino A, De Bigontina G, Fava D, Giorda C, Meloncelli I, Nicolucci A, Pellegrini F, Rossi MC, Vespasiani G
 Cimino A, De Bigontina G, Fava D, Giorda C, Meloncelli I, Nicolucci A, Pellegrini F, Rossi MC, Vespasiani G Numero di centri e di pazienti inclusi nelle elaborazioni nei diversi anni confrontati: Centri
Cimino A, De Bigontina G, Fava D, Giorda C, Meloncelli I, Nicolucci A, Pellegrini F, Rossi MC, Vespasiani G Numero di centri e di pazienti inclusi nelle elaborazioni nei diversi anni confrontati: Centri
EFFICACIA DI UN VIDEO INFORMATIVO NEL MIGLIORARE L'ASSISTENZA DEL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO IN FASE DI DIMISSIONE: UNO STUDIO PILOTA.
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA EFFICACIA DI UN VIDEO INFORMATIVO NEL MIGLIORARE L'ASSISTENZA DEL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO IN
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA EFFICACIA DI UN VIDEO INFORMATIVO NEL MIGLIORARE L'ASSISTENZA DEL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO IN
Takeda in cardiologia. Lo studio del Working Group della Società Italiana dell Ipertensione Arteriosa (SIIA) e della Fondazione SIIA (1)
 Takeda in cardiologia Lo studio del Working Group della Società Italiana dell Ipertensione Arteriosa (SIIA) e della Fondazione SIIA (1) Analisi disegnata per valutare la prevalenza, la consapevolezza,
Takeda in cardiologia Lo studio del Working Group della Società Italiana dell Ipertensione Arteriosa (SIIA) e della Fondazione SIIA (1) Analisi disegnata per valutare la prevalenza, la consapevolezza,
Per una Medicina Condivisa. Dott.ssa Elena Fachinat 2 aprile 2011
 Per una Medicina Condivisa Dott.ssa Elena Fachinat 2 aprile 2011 Per una Medicina Condivisa SULL EFFICACIA DI UNA TERAPIA SULLA SICUREZZA DI UNA TERAPIA SULL INUTILITA DI UNA TERAPIA CON LA DONNA IN GRAVIDANZA
Per una Medicina Condivisa Dott.ssa Elena Fachinat 2 aprile 2011 Per una Medicina Condivisa SULL EFFICACIA DI UNA TERAPIA SULLA SICUREZZA DI UNA TERAPIA SULL INUTILITA DI UNA TERAPIA CON LA DONNA IN GRAVIDANZA
Prima dei 15 anni il dosaggio di paracetamolo dipende dal peso del bambino e deve essere compreso tra i 10 e i 15 mg/kg/dose; l intervallo tra una
 1 2 Prima dei 15 anni il dosaggio di paracetamolo dipende dal peso del bambino e deve essere compreso tra i 10 e i 15 mg/kg/dose; l intervallo tra una dose e l altra deve essere sempre almeno di 4 ore.
1 2 Prima dei 15 anni il dosaggio di paracetamolo dipende dal peso del bambino e deve essere compreso tra i 10 e i 15 mg/kg/dose; l intervallo tra una dose e l altra deve essere sempre almeno di 4 ore.
Metodologia epidemiologica
 Università Cattolica del Sacro Cuore Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e Medicina Legale Anno accademico 2010/2011 Metodologia epidemiologica Bruno Federico Cattedra di Igiene
Università Cattolica del Sacro Cuore Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e Medicina Legale Anno accademico 2010/2011 Metodologia epidemiologica Bruno Federico Cattedra di Igiene
Allegato III Modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo
 Allegato III Modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo Nota: le modifiche di questo riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo sono
Allegato III Modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo Nota: le modifiche di questo riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo sono
Evidenze cliniche: punto d incontro fra ricercatore e clinico. 09/05/2004 Dr. Giovanni Filocamo Dipartimento di Neuroscienze - Aimef 1
 Evidenze cliniche: punto d incontro fra 09/05/2004 Dr. Giovanni Filocamo Dipartimento di Neuroscienze - Aimef 1 Obiettivi del ricercatore Valutare: 1.La storia naturale della malattia e la gravità della
Evidenze cliniche: punto d incontro fra 09/05/2004 Dr. Giovanni Filocamo Dipartimento di Neuroscienze - Aimef 1 Obiettivi del ricercatore Valutare: 1.La storia naturale della malattia e la gravità della
PER UNA MEDICINA PRUDENTE...
 Trento, 2 aprile 2011 PER UNA MEDICINA PRUDENTE... Dott.ssa Isabel Inama PER UNA MEDICINA PRUDENTE...! Esposizione ad esami radiologici e rischio di cancro! PPI e rischio di fratture! TOS e carcinoma della
Trento, 2 aprile 2011 PER UNA MEDICINA PRUDENTE... Dott.ssa Isabel Inama PER UNA MEDICINA PRUDENTE...! Esposizione ad esami radiologici e rischio di cancro! PPI e rischio di fratture! TOS e carcinoma della
Epidemiologia della Malattia Renale cronica. Strutture della Rete Nefrologica Piemontese. Attività
 Scheda Tecnica: dati 2012 Epidemiologia della Malattia Renale cronica Un recente studio della Società Italiana di Nefrologia (SIN), condotto in collaborazione con la Società Italiana di Medicina generale
Scheda Tecnica: dati 2012 Epidemiologia della Malattia Renale cronica Un recente studio della Società Italiana di Nefrologia (SIN), condotto in collaborazione con la Società Italiana di Medicina generale
Impatto economico e valutazione della qualità di vita dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson. Indagine su cinque realtà regionali.
 Impatto economico e valutazione della qualità di vita dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson. Indagine su cinque realtà regionali. Americo Cicchetti 1, Matteo Ruggeri 1, Silvia Coretti 1, Paola Codella
Impatto economico e valutazione della qualità di vita dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson. Indagine su cinque realtà regionali. Americo Cicchetti 1, Matteo Ruggeri 1, Silvia Coretti 1, Paola Codella
Il supporto alle decisioni: Il Sistema Nazionale Linee Guida. 16 giugno 2011 Roma
 Il supporto alle decisioni: Il Sistema Nazionale Linee Guida 16 giugno 2011 Roma Sistema Nazionale Linee Guida Definizione di Linea Guida e motivazione Metodologia di sviluppo Multidisciplinarietà Conflitto
Il supporto alle decisioni: Il Sistema Nazionale Linee Guida 16 giugno 2011 Roma Sistema Nazionale Linee Guida Definizione di Linea Guida e motivazione Metodologia di sviluppo Multidisciplinarietà Conflitto
DRGs: trasparenza, efficienza, qualità
 1 DRGs: trasparenza, efficienza, qualità Come noto il sistema dei DRGs (Diagnosis-related groups) è stato sviluppato agli inizi degli anni '70 da alcuni ricercatori dell'università di Yale, con l'obiettivo
1 DRGs: trasparenza, efficienza, qualità Come noto il sistema dei DRGs (Diagnosis-related groups) è stato sviluppato agli inizi degli anni '70 da alcuni ricercatori dell'università di Yale, con l'obiettivo
Studio PPP (Progetto Prevenzione Primaria)
 Studio PPP (Progetto Prevenzione Primaria) Lancet 2001; 387:89-95 Low-dose aspirin and vitamin E in people at cardiovascular risk: randomised trial in general practice. Piccole dosi di ASA e vitamina E
Studio PPP (Progetto Prevenzione Primaria) Lancet 2001; 387:89-95 Low-dose aspirin and vitamin E in people at cardiovascular risk: randomised trial in general practice. Piccole dosi di ASA e vitamina E
e-news Progetto MOND N.1 /2014 Update in BPCO I SINTOMI NELLA BPCO NUOVE EVIDENZE TERAPEUTICHE A cura del Board del Progetto MOND
 e-news Progetto MOND Update in BPCO N.1 /2014 I SINTOMI NELLA BPCO NUOVE EVIDENZE TERAPEUTICHE A cura del Board del Progetto MOND La BPCO è una malattia caratterizzata da una persistente e progressiva
e-news Progetto MOND Update in BPCO N.1 /2014 I SINTOMI NELLA BPCO NUOVE EVIDENZE TERAPEUTICHE A cura del Board del Progetto MOND La BPCO è una malattia caratterizzata da una persistente e progressiva
3.La valutazione dell assistenza pediatrica territoriale
 3.La valutazione dell assistenza pediatrica territoriale Prof.ssa Maria Pia Fantini Dott.ssa Lorenza Luciano Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica Alma Mater Studiorum Università di Bologna 21/03/2012
3.La valutazione dell assistenza pediatrica territoriale Prof.ssa Maria Pia Fantini Dott.ssa Lorenza Luciano Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica Alma Mater Studiorum Università di Bologna 21/03/2012
Tipi di variabili. Indici di tendenza centrale e di dispersione
 Tipi di variabili. Indici di tendenza centrale e di dispersione L. Boni Variabile casuale In teoria della probabilità, una variabile casuale (o variabile aleatoria o variabile stocastica o random variable)
Tipi di variabili. Indici di tendenza centrale e di dispersione L. Boni Variabile casuale In teoria della probabilità, una variabile casuale (o variabile aleatoria o variabile stocastica o random variable)
IL TRATTAMENTO DEL DOLORE AL TRIAGE SECONDO MTS PROCEDURE/PROTOCOLLI CHE DELINIANO IL TRATTAMENTO DEL DOLORE AL TRIAGE
 IL TRATTAMENTO DEL DOLORE AL TRIAGE :MTS COS'E' MTS CODICI COLORE/ OBIETTIVI CARDINI LA SCALA DEL DOLORE IL TRATTAMENTO DEL DOLORE AL TRIAGE SECONDO MTS NORMATIVE? PROCEDURE/PROTOCOLLI CHE DELINIANO IL
IL TRATTAMENTO DEL DOLORE AL TRIAGE :MTS COS'E' MTS CODICI COLORE/ OBIETTIVI CARDINI LA SCALA DEL DOLORE IL TRATTAMENTO DEL DOLORE AL TRIAGE SECONDO MTS NORMATIVE? PROCEDURE/PROTOCOLLI CHE DELINIANO IL
PROTOCOLLO DELLO STUDIO
 PROTOCOLLO DELLO STUDIO TITOLO DELLO STUDIO TRATTAMENTO CON IMMUNOGLOBULINE NELLA SINDROME POST-POLIO DISEGNO DELLO STUDIO Studio clinico randomizzato, in doppio cieco, a due bracci (trattamento vs placebo)
PROTOCOLLO DELLO STUDIO TITOLO DELLO STUDIO TRATTAMENTO CON IMMUNOGLOBULINE NELLA SINDROME POST-POLIO DISEGNO DELLO STUDIO Studio clinico randomizzato, in doppio cieco, a due bracci (trattamento vs placebo)
Le categorie di costo
 Le categorie di costo NB: Questi lucidi presentano solo parzialmente gli argomenti trattati ttati in classe. In particolare non contengono i modelli economici per i quali si rinvia direttamente al libro
Le categorie di costo NB: Questi lucidi presentano solo parzialmente gli argomenti trattati ttati in classe. In particolare non contengono i modelli economici per i quali si rinvia direttamente al libro
Concetti principale della lezione precedente
 Corso di Statistica medica e applicata 9 a Lezione Dott.ssa Donatella Cocca Concetti principale della lezione precedente I concetti principali che sono stati presentati sono: Variabili su scala nominale
Corso di Statistica medica e applicata 9 a Lezione Dott.ssa Donatella Cocca Concetti principale della lezione precedente I concetti principali che sono stati presentati sono: Variabili su scala nominale
IL PATCH TEST ANCHE NELLE ALLERGIE INALATORIE Prevalence of positive atopy patch test in an unselected pediatric population
 IL PATCH TEST ANCHE NELLE ALLERGIE INALATORIE Prevalence of positive atopy patch test in an unselected pediatric population Nicola Fuiano, Giuliana Diddi, Maurizio Delvecchio e Cristoforo Incorvaia C.
IL PATCH TEST ANCHE NELLE ALLERGIE INALATORIE Prevalence of positive atopy patch test in an unselected pediatric population Nicola Fuiano, Giuliana Diddi, Maurizio Delvecchio e Cristoforo Incorvaia C.
Low-Level Laser Terapia (LLLT)per il trattamento degli acufeni Teggi R Bellini C Bussi M IRCCS San Raffaele Milano Università Vita e Salute
 Low-Level Laser Terapia (LLLT)per il trattamento degli acufeni Teggi R Bellini C Bussi M IRCCS San Raffaele Milano Università Vita e Salute Precedenti esperienze Shiomi (1997): LLLT 40 mw, 830 nm, n=38
Low-Level Laser Terapia (LLLT)per il trattamento degli acufeni Teggi R Bellini C Bussi M IRCCS San Raffaele Milano Università Vita e Salute Precedenti esperienze Shiomi (1997): LLLT 40 mw, 830 nm, n=38
C.I. di Metodologia clinica
 C.I. di Metodologia clinica Modulo 5. I metodi per la sintesi e la comunicazione delle informazioni sulla salute Quali errori influenzano le stime? L errore casuale I metodi per la produzione delle informazioni
C.I. di Metodologia clinica Modulo 5. I metodi per la sintesi e la comunicazione delle informazioni sulla salute Quali errori influenzano le stime? L errore casuale I metodi per la produzione delle informazioni
Disegno dello studio
 Disegno dello studio Prof. Giuseppe Verlato Sezione di Epidemiologia e Statistica Medica Università degli studi di Verona ESPERIMENTO = Studio in cui le variabili in grado di determinare (causare) una
Disegno dello studio Prof. Giuseppe Verlato Sezione di Epidemiologia e Statistica Medica Università degli studi di Verona ESPERIMENTO = Studio in cui le variabili in grado di determinare (causare) una
Impatto delle diverse strategie sulla salute della popolazione
 Impatto delle diverse strategie sulla salute della popolazione I parametri che condizionano l uso di un vaccino Individuo Popolazione innocuità del vaccino efficacia del vaccino gravità dell infezione
Impatto delle diverse strategie sulla salute della popolazione I parametri che condizionano l uso di un vaccino Individuo Popolazione innocuità del vaccino efficacia del vaccino gravità dell infezione
Workshop Clinici Interattivi
 Associazione Medici Endocrinologi AME 2003-3 Congresso Nazionale Palermo, 7-9 novembre 2003 Workshop Clinici Interattivi Evidenze scientifiche e pratica clinica Interventi efficaci Zona grigia Interventi
Associazione Medici Endocrinologi AME 2003-3 Congresso Nazionale Palermo, 7-9 novembre 2003 Workshop Clinici Interattivi Evidenze scientifiche e pratica clinica Interventi efficaci Zona grigia Interventi
RIVISTA: lnt Journal of lmpotence Research (2006) 18, MJ. Dresser, D. Desai, S. Gidwani, AD. Seftel, NB. Modi O B I E T T I V I
 I D E N T I F I C A T I V O A R T I C O L O TITOLO: Dapoxetine, a novel treatment for premature ejaculation, does not have pharmacokinetic interactions with phosphodiesterase-5 inhibitors Dapoxetina, nuovo
I D E N T I F I C A T I V O A R T I C O L O TITOLO: Dapoxetine, a novel treatment for premature ejaculation, does not have pharmacokinetic interactions with phosphodiesterase-5 inhibitors Dapoxetina, nuovo
La valutazione del rischio nei caseifici
 Contributi pratici Aggravi G. 1 Mari M. 2 Regini M. 1 Casati D. 2 Falciani G. 1 Gradassi S. 2 Petreni A. 1 Ragionieri G. 2 Brajon G. 2 1 Azienda USL 7 di Siena 2 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Contributi pratici Aggravi G. 1 Mari M. 2 Regini M. 1 Casati D. 2 Falciani G. 1 Gradassi S. 2 Petreni A. 1 Ragionieri G. 2 Brajon G. 2 1 Azienda USL 7 di Siena 2 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Progetto di presa in carico territoriale dei malati con BPCO da parte dell Infermiere Case Manager. I risultati
 Progetto di presa in carico territoriale dei malati con BPCO da parte dell Infermiere Case Manager Paolo Pandolfi *, Monica Bianconcini, Corrado Zenesini * * Dipartimento Sanità Pubblica Direzione SATeR
Progetto di presa in carico territoriale dei malati con BPCO da parte dell Infermiere Case Manager Paolo Pandolfi *, Monica Bianconcini, Corrado Zenesini * * Dipartimento Sanità Pubblica Direzione SATeR
Questa tabella riporta le principali classi di FANS e le rispettive molecole di riferimento.
 1 2 Questa tabella riporta le principali classi di FANS e le rispettive molecole di riferimento. 3 Per quanto la classe dei FANS sia molto ampia e articolata, come si evince da questa tabella, il loro
1 2 Questa tabella riporta le principali classi di FANS e le rispettive molecole di riferimento. 3 Per quanto la classe dei FANS sia molto ampia e articolata, come si evince da questa tabella, il loro
CPAP-scafandro post operatoria nei pazienti cardiochirurgici. Confronto tra pazienti trattati e storico pazienti non trattati
 CPAP-scafandro post operatoria nei pazienti cardiochirurgici. Confronto tra pazienti trattati e storico pazienti non trattati Inf. Barletta Claudia Inf. Annoni Alice Dipartimento di Medicina Perioperatoria
CPAP-scafandro post operatoria nei pazienti cardiochirurgici. Confronto tra pazienti trattati e storico pazienti non trattati Inf. Barletta Claudia Inf. Annoni Alice Dipartimento di Medicina Perioperatoria
TRATTAMENTI ALTERNATIVI PER L OSTEOARTROSI: FATTI ED EVIDENZA SUI GLUCOSAMINOGLICANI E LA CONDROITINA
 FOGLIO INFORMATIVO n 8 TRATTAMENTI ALTERNATIVI PER L OSTEOARTROSI: FATTI ED EVIDENZA SUI GLUCOSAMINOGLICANI E LA CONDROITINA La glucosamina e la condroitina sono costituenti della cartilagine articolare.
FOGLIO INFORMATIVO n 8 TRATTAMENTI ALTERNATIVI PER L OSTEOARTROSI: FATTI ED EVIDENZA SUI GLUCOSAMINOGLICANI E LA CONDROITINA La glucosamina e la condroitina sono costituenti della cartilagine articolare.
2017: le novità nella mastocitosi e nella ipereosinofilia
 Settima Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche Sabato 13 Maggio 2017 CRIMM Centro di Ricerca e Innovazione per le Malattie Mieloproliferative AOU Careggi 2017:
Settima Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche Sabato 13 Maggio 2017 CRIMM Centro di Ricerca e Innovazione per le Malattie Mieloproliferative AOU Careggi 2017:
Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1540/2006 e D.G.R. 2129/2010) Documento PTR n. 133 relativo a: ALITRETINOINA
 Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1540/2006 e D.G.R. 2129/2010) Documento PTR n. 133 relativo a: ALITRETINOINA Luglio 2011 Indicazioni registrate Alitretinoina Trattamento dell'eczema cronico severo
Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1540/2006 e D.G.R. 2129/2010) Documento PTR n. 133 relativo a: ALITRETINOINA Luglio 2011 Indicazioni registrate Alitretinoina Trattamento dell'eczema cronico severo
DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE CLINICA
 Modello 1 DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE CLINICA Al Presidente del Comitato Etico dell Azienda Sanitaria Locale Viterbo via S.Lorenzo,101 VITERBO Il sottoscritto Prof./Dr. Della Unità
Modello 1 DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE CLINICA Al Presidente del Comitato Etico dell Azienda Sanitaria Locale Viterbo via S.Lorenzo,101 VITERBO Il sottoscritto Prof./Dr. Della Unità
Rassegna Stampa. Mercoledì 23 settembre 2015
 Rassegna Stampa Mercoledì 23 settembre 2015 Rassegna Stampa realizzata da SIFA Srl Servizi Integrati Finalizzati alle Aziende 20123 Milano Via Mameli, 11 Tel. 0243990431 Fax 0245409587 sifa@sifasrl.com
Rassegna Stampa Mercoledì 23 settembre 2015 Rassegna Stampa realizzata da SIFA Srl Servizi Integrati Finalizzati alle Aziende 20123 Milano Via Mameli, 11 Tel. 0243990431 Fax 0245409587 sifa@sifasrl.com
BACKGROUND (1) 31 CONGRESSO NAZIONALE ANIARTI 14,16 NOVEMBRE 2012 RIVA DEL GARDA
 31 CONGRESSO NAZIONALE ANIARTI Riva del Garda 14,16 novembre 2012 INFERMIERI E QUALITA DI VITA IN AREA CRITICA Competenza, tecnologia, procedure, efficienza, risorse, Relazioni, politica, diritti, etica,
31 CONGRESSO NAZIONALE ANIARTI Riva del Garda 14,16 novembre 2012 INFERMIERI E QUALITA DI VITA IN AREA CRITICA Competenza, tecnologia, procedure, efficienza, risorse, Relazioni, politica, diritti, etica,
Modulo 1 CORSO DI FITOTERAPIA. Docente: Dott.ssa Shuela Curatola
 Modulo 1 CORSO DI FITOTERAPIA Docente: Dott.ssa Shuela Curatola WWW.LEZIONE-ONLINE.IT Principali definizioni: Erboristeria Fitoterapia Farmaco Placebo Farmacologia Allopatia Omeopatia Farmacognosia Modulo
Modulo 1 CORSO DI FITOTERAPIA Docente: Dott.ssa Shuela Curatola WWW.LEZIONE-ONLINE.IT Principali definizioni: Erboristeria Fitoterapia Farmaco Placebo Farmacologia Allopatia Omeopatia Farmacognosia Modulo
La gestione del dolore in Triage. Valutazione di efficacia di un trattamento precoce.
 Simona Ribet CPSE DEA II LIVELLO-SEZ PICCOLI TRAUMI PRESIDIO CTO-AZIENDA OSPEDALIERA CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO La gestione del dolore in Triage. Valutazione di efficacia di un trattamento
Simona Ribet CPSE DEA II LIVELLO-SEZ PICCOLI TRAUMI PRESIDIO CTO-AZIENDA OSPEDALIERA CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO La gestione del dolore in Triage. Valutazione di efficacia di un trattamento
la ricerca infermieristica
 Dall esperienza un metodo: la ricerca infermieristica C. Forni CPSE responsabile Centro Ricerca Servizio Assistenza Istituti Ortopedici Rizzoli Bologna Un esperienza. Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna
Dall esperienza un metodo: la ricerca infermieristica C. Forni CPSE responsabile Centro Ricerca Servizio Assistenza Istituti Ortopedici Rizzoli Bologna Un esperienza. Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna
Premessa e obiettivi. dell individuo nella loro pienezza e totalità. ORGANIZZAZIONE STRATEGICA. Risorse Umane POTENZIALE
 Premessa e obiettivi La valutazione del potenziale rappresenta una metodologia ben precisa che genera diversi strumenti, schematizzati e di facile lettura, per la gestione del potenziale delle persone
Premessa e obiettivi La valutazione del potenziale rappresenta una metodologia ben precisa che genera diversi strumenti, schematizzati e di facile lettura, per la gestione del potenziale delle persone
