Strumenti per il monitoraggio della zona non satura
|
|
|
- Miranda Nicoletti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Nota tecnica Strumenti per il monitoraggio della zona non satura Alessandro Tarantino,* Annarita Pozzato** Sommario L articolo presenta uno studio sperimentale sulla risposta di sensori di misura del contenuto d acqua per il monitoraggio della zona non satura ed un indagine teorica degli effetti della temperatura e della lunghezza del cavo sulla misura. Sono stati considerati un sensore di riflettometria nel domino del tempo (TDR), un sensore di riflettometria nel dominio delle ampiezze (ADR), un sensore capacitivo e un sensore multi-capacitivo per misure di profondità. 1. Introduzione * ** Ricercatore, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale, Università di Trento Dottoranda, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale, Università di Trento Le condizioni di sicurezza degli argini fluviali nei riguardi della stabilità dipendono dalla distribuzione delle pressioni dell acqua interstiziale nel manufatto e nei terreni di fondazione che si generano in corrispondenza di un evento di piena. Tale distribuzione è associata anche alla propagazione del fronte di saturazione attraverso la zona non satura del manufatto ed il monitoraggio di tale zona può pertanto essere utile a comprendere i possibili meccanismi di instabilità di argini fluviali esistenti. In generale, il monitoraggio della zona non satura può essere eseguito attraverso la misura della suzione e del contenuto d acqua. In realtà, la misura della suzione è problematica. I tensiometri convenzionali possono essere utilizzati solo nell intervallo di suzione 0-80 kpa e non sempre tale intervallo risulta adeguato in terreni con una frazione limosa ed argillosa significativa. È richiesta una continua manutenzione a causa dell inevitabile desaturazione dello strumento e la misura è sempre affetta da incertezza poiché lo stato di saturazione può essere rilevato solo con un ispezione visiva. Strumenti di misura indiretta della suzione hanno il vantaggio di non richiedere manutenzione per la risaturazione dello strumento, consentire una misura in un intervallo di suzione più ampio di quello dei tensiometri convenzionali ma hanno tempi di risposta molto elevati, tipicamente di giorni, che li rendono spesso inadatti al monitoraggio in condizioni di rapida variazione del contenuto d acqua. Questi strumenti sono tipicamente costituiti da un blocco poroso in contatto con il terreno il cui contenuto d acqua dipende dalla suzione del terreno circostante. La variazione di contenuto d acqua del blocco poroso è rilevata attraverso una misura di conducibilità termica (sensori di conducibilità termica), di conducibilità elettrica (sensori di conducibilità elettrica) o di permettività dielettrica (equitensiometri). La misura richiede il trasferimento di acqua dal terreno al blocco poroso, la cui conducibilità idraulica è tuttavia relativamente bassa poiché risulta non saturo. Per questa ragione tempi di equalizzazione di questi strumenti di misura indiretta sono relativamente elevati. Un elegante alternativa consiste nella misura del contenuto (volumetrico) d acqua mediante sensori basati sulla misura della permettività dielettrica del terreno. Questi sensori hanno tempi di risposta praticamente istantanei, non richiedono manutenzione a parte quella legata all elettronica degli strumenti, e sono relativamente poco costosi. Uno studio della risposta di questi sensori è presentato in questo lavoro, sviluppato nell ambito del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale [2005] riguardante il Monitoraggio e valutazione della sicurezza nelle dighe in terra e negli argini fluviali. Quattro sensori sono stati investigati in laboratorio per valutarne la risposta, una sonda TDR (Time Domain Reflectometry), una sonda ADR (Amplitude Domain Reflectometry), una sonda capacitiva per installazioni di superficie ed una sonda multicapacitiva per installazione in tubo di accesso. Successivamente, mediante un analisi di tipo teorico, sono stati analizzati gli effetti della temperatura e della lunghezza del cavo sulla misura del contenuto d acqua. Queste variabili sono rilevanti per le misure in sito. I metodi dielettrici si basano sulla misura della permettività dielettrica del mezzo multifase terreno, la quale dipende della permettività dei singoli costituenti (solido, liquido e gassoso) e delle loro frazioni volumetriche. Poiché la permettività dielettrica relativa è pari a 1 per l aria, varia tra 3 e 5 per la fase solida, ed è circa pari ad 80 per l acqua, RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA 3/2008
2 110 TARANTINO - POZZATO la permettività dielettrica del terreno in quanto mezzo multifase dipende essenzialmente dal contenuto d acqua interstiziale ed è questo il principio su cui si basa la misura. La permettività non è tuttavia misurata in condizioni statiche ma in un campo elettrico non stazionario che si propaga sottoforma di onde. In tali condizioni la permettività dell acqua risulta dipendere dalla frequenza ed avere una componente sia reale sia immaginaria. Per comprendere vantaggi e limiti di queste tecniche di misura, è allora utile richiamare alcuni concetti elementari sulla permettività dielettrica dei materiali. 2. La permettività dielettrica dei terreni 2.1. Permettività dielettrica dell acqua in campo elettrico statico ed alternato Si consideri il condensatore in figura 1 nel quale sia posta acqua tra le armature. Il campo elettrico statico generato dalla carica superficiale σ causa l allineamento delle molecole d acqua (dipoli permanenti) e la presenza di cariche non equilibrate in corrispondenza delle armature genera una carica di polarizzazione superficiale σ P che in parte neutralizza la carica originale σ. Ne consegue che il campo elettrico risultante E è inferiore a quello nel vuoto E 0 di un fattore ε r, definito permettività dielettrica relativa (ε r =E 0 /E). Maggiore è la polarizzazione, maggiore è la permettività dielettrica. Si consideri poi il caso di un campo elettrico alternato che si propaghi sottoforma di onda attraverso l acqua. I dipoli oscillano allineandosi con il campo elettrico generando a loro volta un onda di polarizzazione che si propaga attraverso l acqua sovrapponendosi al campo elettrico alternato originario. Tale allineamento è associato alla parte reale (in fase) della permettività dielettrica relativa, ε r. Incrementando la frequenza del campo elettrico, le molecole possono non riuscire più ad allinearsi con il campo elettrico (rilassamento dipolare). Questo riduce l intensità dell onda di polarizzazione e dà luogo ad un ritardo di fase tra l onda di polarizzazione ed il campo elettrico originario. Tale sfasamento è associato alla parte immaginaria della permettività dielettrica relativa, ε r, e causa dissipazione di energia in forma di energia termica (come nei forni a microonde). L acqua nei terreni è raramente pura e contiene tipicamente dei portatori di carica quali gli ioni. La conducibilità ionica causa una dissipazione di energia (dissipazione per conduzione) che si aggiunge alla dissipazione per rilassamento dipolare (dissipazione per rilassamento). Per tener conto di entrambe queste dissipazione di energia, si considera una permettività dielettrica relativa equivalente ε* r definita da: (1) dove ε 0 è la permettività nel vuoto, σ dc la conducibilità elettrica in corrente continua e f è la frequenza. Secondo STOGRYN [1971], ε r, ε r e σ dc dipendono dalla temperatura T e dalla concentrazione espressa in termini di normalità N Permettività dielettrica dei terreni (mezzo multifase terreno) La permettività dielettrica di un mezzo eterogeneo dipende dalla permettività dielettrica dei singoli costituenti e dalla loro frazione volumetrica. Un comune approccio per stimare la permettività dielettrica relativa equivalente dei terreni ε * m si basa sull equazione di LITCHTENEKER [1926] che può essere estesa ad mezzo a quattro fasi secondo l espressione proposta da HEIMOVAARA et al., [1994] Fig. 1 Condensatore riempito con materiale dielettrico. Fig. 1 Capacitor filled with dielectric material. RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA
3 STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA ZONA NON SATURA 111 (2) dove ε s, ε a, ε* fw e ε* bw sono rispettivamente le permettività dielettriche relative della parte solida, dell aria, dell acqua libera e dell acqua adsorbita, ρ d è la densità secca, ρ s è la densità della parte solida, θ è il contenuto d acqua volumetrico ed il prodotto δρ d A s è la frazione volumetrica di acqua adsorbita, essendo A s and δ rispettivamente la superficie specifica e lo spessore dello strato di acqua adsorbita. La permettività dielettrica relativa di un terreno ha una componente reale ed una immaginaria, poiché risulta in generale complessa la permettività dielettrica dei suoi singoli costituenti. In molti casi, tuttavia, è utile esprimere la permettività dielettrica attraverso una variabile reale, la permettività apparente K a, definita da [VON HIPPEL, 1954]: - (3) dove ε m ed ε m sono rispettivamente le componenti reale ed immaginaria della permettività dielettrica relativa del terreno, σ è la conducibilità elettrica del terreno e f la frequenza f. La permettività apparente K a consente di determinare la velocità di propagazione di un segnale in un mezzo a permettività dielettrica complessa in un modo formalmente analogo al caso di un mezzo a permettività dielettrica reale. 3. Misura del contenuto d acqua dei terreni mediante la tecnica TDR (Time Domain Reflectometry) Il sistema di misura del contenuto d acqua mediante la tecnica della riflettometria nel dominio del tempo (Time Domain Reflectometry, TDR) è illustrato in figura 2 ed è costituito da un generatore di impulsi a gradino, da un oscilloscopio, da un cavo coassiale e da una sonda costituita da aste inserite nel terreno. In questo studio è stata usata una sonda trifilare con aste della lunghezza di 150 mm. La tecnica consiste nel misurare la velocità di propagazione del segnale V p lungo le aste inserite nel terreno dalla quale è derivata la permettività dielettrica apparente del terreno K a mediante l equazione (4) che può essere ricavata dalla teoria delle linee di trasmissione [KRAUS e FLEISCH, 1999] (c è la velocità della luce nel vuoto). La permettività apparente K a è quindi correlata al contenuto volumetrico d acqua θ mediante una relazione empirica. La tecnica di misura richiede pertanto 1) una procedura per estrarre la velocità di propagazione V p dal segnale registrato dall oscilloscopio; 2) la definizione di una relazione θ=θ(k a ). La figura 3a mostra il segnale misurato all oscilloscopio con la sonda in aria ed in acqua. Con riferimento alla misura in acqua, si osserva un primo ramo discendente associato alla riflessione del segnale in corrispondenza della base delle aste ed un successivo ramo ascendente associato alla riflessione in corrispondenza dell estremità delle aste. Il tempo che individua la riflessione all estremità delle aste, t end è normalmente determinato secondo la costruzione indicata in figura 3a. Il tempo che individua la riflessione in corrispondenza della base delle aste, t start, è invece meno semplice da determinare poiché mascherato dalla riflessione in corrispondenza della testa. In questo lavoro è stato utilizzato l approccio proposto da HEIMOVAARA [1993], il quale suggerisce di determinare dapprima il tempo associato alla riflessione in corrispondenza della testa, t head e quindi il tempo di transito attraverso la testa Δt mediante taratura in acqua ed in aria (Fig. 3b). La velocità di propagazione è quindi ottenuta come segue: (5) Fig. 2 Apparecchiatura per la misura del contenuto d acqua mediante riflettometria nel dominio del tempo (TDR). Fig. 2 Equipment for water content using Time Domain Reflectometry (TDR). LUGLIO - SETTEMBRE 2008
4 112 TARANTINO - POZZATO Fig. 3 Calibrazione in aria e acqua demineralizzata. (a) Onde di riflessione in acqua e aria e derivata prima del coefficiente di riflessione. (b) Onda di riflessione in corrispondenza della testa della sonda. Fig. 3 Calibration in demineralised water and air. (a) Reflection waveform in air and water and derivative of the reflection coefficient. (b)reflection waveforms at hhe probe head. Quest ultima equazione è chiaramente una relazione approssimata. L equazione (2) mostra che la permettività apparente dipende dal solo contenuto volumetrico d acqua θ se la densità non varia in modo significativo (ρ d /ρ s ~costante), la quantità di acqua adsorbita è trascurabile (A s ~0) e ε * fw è costante e reale nella banda delle frequenze del TDR. Quest ultima condizione è verificata quando la temperatura non varia in modo rilevante e la conducibilità elettrica dell acqua interstiziale è trascurabile. DIRKSEN and DASBERG [1993] hanno investigato 11 terreni concludendo che l equazione di Topp può essere assunta valida per densità secche comprese tra 1.35 and 1.50 g/cm 3 e superfici specifiche comprese tra 0 and 100 m 2 /g. Questo intervallo di superficie specifica, che può essere classificata da bassa a media, include le argille caolinitiche ed una buona parte di quelle illitiche. In prima approssimazione, la superficie specifica può essere determinata dal contenuto d acqua igroscopico secondo BA- NIN and AMIEL [1970] e DIRKSEN and DASBERG [1993]. Al contrario, l equazione di Topp può dare luogo ad errori significativi in terreni a grana fine [DASBERG and HOPMANS, 1992; DIRKSEN and DASBERG, 1993] e terreni organici [TOPP et al., 1980; HE- RKELRATH et al., 1991, PÉPIN et al., 1992]. Per investigare l errore che è possibile commettere utilizzando l equazione (6) sono state eseguite due misure in campioni di sabbia fine preparati a due contenuti d acqua differenti miscelando il terreno con acqua demineralizzata ed un campione di sabbia con limo debolmente argillosa. La sonda è stata inizialmente calibrata mediante misura in aria e acqua al fine di determinare il tempo Δt e la lunghezza elettrica L * (Δt=0.99 ns; L * =150.7 mm). Le onde di riflessione misurate nei due campioni di sabbia fine sono mostrate in figura 4 in- dove L * è la lunghezza elettrica della sonda determinata mediante taratura in acqua ed in aria. Per quanto riguarda la relazione empirica θ=θ(k a ), sono state proposte relazioni a quattro parametri [TOPP et al., 1980] e a due parametri [LEDIEU et al., 1986; YU et al., 1997; TOPP and REYNOLDS, 1998]. Queste relazioni sono essenzialmente coincidenti per θ<0.4, mentre per valori di θ superiori a 0.4 l equazione proposta da TOPP et al. [1980] sottostima il contenuto d acqua in modo significativo [ROTH et al., 1990]. In questo lavoro si è utilizzata la relazione proposta da LEDIEU et al. [1986]: (6) che propone una relazione di tipo quadratico tra θ e K a. Fig. 4 Onde di riflessione nei campioni di sabbia fine e determinazione del tempo di transito. Fig. 4 Reflection waveforms in fine sand samples and travel time determination. RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA
5 STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA ZONA NON SATURA 113 Fig. 6 Confronto tra contenuto d acqua stimato mediante l Eq. 6 ed il valore misurato. Fig. 6 Comparison between TDR estimated water content through Eq. 6 and measured water content. [1975] scritta nella forma presentata da TOPP et al., [1988]: Fig. 5 Onda di riflessione in campioni di sabbia con limo debolmente argillosa e determinazione del tempo di transito. (a) registrazione fino al raggiungimento delle condizioni stazionarie. (b) ingrandimento relativo alla prime e seconda riflessione corrispondenza della sonda. Fig. 5 Reflection waveform in clayey silty sand sample and travel time determination. (a) Recording extended to steady-state conditions. (b) enlargement showing first and second reflection at the probe. sieme ai tempi di ingresso nella testa (t head ), di ingresso nella sonda (t start ) e di riflessione all estremità delle aste (t end ). L onda di riflessione misurata nel campione di sabbia con limo debolmente argillosa è mostarata in figura 5. Determinato il tempo di transito del segnale nella sonda t end -t start, è stato determinato il contenuto volumetrico d acqua utilizzando le equazioni (4), (5), e (6). Il confronto tra la stima del contenuto d acqua ed il contenuto d acqua misurato è riportato in figura 6 e si osserva un errore compreso nell intervallo Δθ=±0.02 per la sabbia fine mentre l errore risulta maggiore per la sabbia con limo debolmente argillosa (cerchio pieno). Per questo terreno, il metodo TDR sembra quindi sovrastimare il contenuto d acqua. In generale, questo può essere associato ad una elevata conducibilità elettrica e/o ad un elevata densità. La conducibilità elettrica può essere stimata utilizzando l equazione proposta da GIESE e TIEMANN (7) dove ε 0 è la permittività dielettrica nel vuoto (8.854 x F m -1 ), c è la velocità della luce nel vuoto ( m s -1 ), L è la lunghezza della sonda (m), ρ il coefficiente di riflessione in condizioni stazionarie (vedi Fig. 5), Z c è l impedenza caratteristica del sistema (tipicamente 50 ) e Z 0 è l impedenza caratteristica della sonda nel vuoto. Poiché risulta ρ =0.50 (vedi Fig. 5) e assumendo Z 0 =183.5 Ω (vedi successivo paragrafo 3.1.3), si ottiene una conducibilità elettrica σ=0.022 S/m. Tale conducibilità elettrica è trascurabile nel senso che il suo effetto sulla permettività apparente K a risulta trascurabile secondo WYSEURE et al. [1997]. La bassa conducibilità elettrica non era inaspettata poiché il terreno era stato preparato con acqua demineralizzata e la superficie specifica A s risulta inoltre trascurabile. La superficie specifica è stata stimata a partire dal valore del contenuto d acqua igroscopico w h (w h =0.0047) ed assumendo uno spessore dell acqua adsorbita δ pari ad uno strato monomolecolare di acqua (δ= m) in accordo con DIRKSEN and DASBERG [1993]: (8) LUGLIO - SETTEMBRE 2008
6 114 TARANTINO - POZZATO dove ρ w è la densità dell acqua. Dall equazione (8), si ottiene un valore trascurabile per la superficie specifica della sabbia con limo e argilla utilizzata (A s =15 m 2 /g). Poiché la conducibilità elettrica è trascurabile, si può assumere che la permettività dielettrica del terreno sia reale e pari al valore in condizioni statiche. Assumendo inoltre A s 0, l equazione (2) può allora scriversi in termini di permettività apparente come segue: CAVO COASSIALE (CABLE) La permettività del cavo coassiale è stata determinate secondo LIN and TANG [2007], i quali suggeriscono le seguenti espressioni per la costante di propagazione, γ cable, e l impedenza caratteristica, Z cable : (10) (9) dove ρ d0 è una densità di riferimento. Assumendo ρ d0 =1.5 g/cm 3, i primi due termini dell equazione. 9 coincidono praticamente con l equazione di Ledieu (Eq. 6) [TARANTINO et al., 2008] mentre l ultimo termine rappresenta la correzione da apportare all equazione di Ledieu per tener conto della densità del terreno. Nel caso in esame, la densità secca della sabbia con limo debolmente argillosa risulta essere molto elevata (ρ d =1.99 g/cm 3 ). Se si apporta la correzione indicata dall ultimo termine dell equazione (9), si ottiene un valore molto più accurato (cerchio vuoto), che ricade nella fascia di errore tipica della misura TDR come mostrato in figura 6. (11) dove ε cable è la permettività dielettrica del materiale che riempie il cavo assunta reale ed indipendente dalla frequenza e α R è un fattore di dissipazione resistivo associato all effetto combinato di fattori geometrici e resistività superficiale. I parametri ε cable e α R per il cavo RG58A/U connesso alla sonda CS630 della Campbell Scientific sono stati determinati interpolando l attenuazione nominale in funzione della frequenza (db/m) riportata nelle specifiche tecniche del cavo. In figura 8, sono riportai i valori 3.1. La simulazione dell onda di riflessione Per analizzare gli effetti della temperatura e della lunghezza del cavo sulla misura, si è scelto di affrontare il problema mediante una simulazione numerica. In particolare, si è innanzitutto calibrato un modello di propagazione dell onda di riflessione, utilizzando le misure in acqua, aria, sabbia fine e sabbia con limo debolmente argillosa. Successivamente, tale modello è stato utilizzato per investigare teoricamente gli effetti della temperatura sulla permettività apparente K a e, quindi, sulla stima del contenuto volumetrico d acqua θ. Il modello di propagazione utilizzato è quello presentato da LIN [2003], integrato con il modello di propagazione nel cavo coassiale presentato da LIN and TANG [2007]. Il circuito equivalente del sistema TDR è mostrato in figura 7 e include un cavo coassiale (cable), una testa divisa in due sezioni (head 1 e head 2) e la sonda (probe). Ciascuna sezione è caratterizzata da un impedenza Z, una costante di propagazione γ ed una lunghezza l. Per simulare l onda di riflessione nel dominio del tempo occorre determinare i parametri della linea di trasmissione (lunghezza l, impedenza caratteristica Z e costante di propagazione γ di ciascuna sezione) e misurare il segnale di ingresso a gradino. Fig. 7 Linea di trasmissione a più sezioni. Fig. 7 Multisection transmission line. Fig. 8 Determinazione dei parametri α R e ε cable dalle specifiche tecniche del cavo coassiale. Fig. 8 Determination of α R e ε cable from coaxial cable datasheet. RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA
7 STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA ZONA NON SATURA 115 del costante di attenuazione α cable riportata nelle specifiche tecniche e quella ottenuta utilizzando l equazione 10 per α R =129.9 sec -0.5 e ε cable =1.62. L impedenza caratteristica del cavo è stata ottenuta considerando il valore del coefficiente di riflessione prima dell ingresso nella sonda ottenendo un valore Z p,cable =64.5 Ω, praticamente coincidente con il valore nominale di 63.6 Ω TESTA DELLA SONDA (HEAD) Per la testa della sonda, costituita da una resina epossidica, si è assunta une permittività dielettrica pari a ε head1 = ε head2 =5, che rappresenta un valore ragionevole per questo tipo di materiale. Le lunghezze l head1 e l head2 e le impedenza caratteristiche Z p,head1 e Z p,head2 sono state determinate interpolando le onde di riflessione sperimentali SONDA (PROBE) L impedenza caratteristica della sonda Z p,probe è stata determinata teoricamente utilizzando la relazione proposta da BALL [2002] per il calcolo dell impedenza caratteristica di sonde a più conduttori: l acqua utilizzata per la preparazione dei campioni di sabbia e σ fw =0.16 S/m per i campioni di sabbia con limo debolmente argillosa. La permettività equivalente dell acqua adsorbita ε* bw è stata stimata utilizzando la seguente relazione [HEIMOVAARA et al., 1994]: (14) dove ε bw, e σ bw sono rispettivamente la permettività dielettrica (reale) e la conducibilità dell acqua adsorbita. In accordo con FRIEDMAN [1998], la permettività dell acqua adsorbita può essere assunta costante e pari alla componente reale ad elevate frequenze (ε bw, ) SEGNALE DI INGRESSO Il segnale di ingresso è stato misurato collegando al TDR un connettore BNC terminale con impedenza da 50 Ω. In tale modo la linea risulta accoppiata e non c è riflessione. Il segnale di ingresso è stato campionato con frequenze di 5, 10, 20 e 40 GHz, con un numero di punti pari rispettivamente a 256, 512, 1024 e (12) dove μ 0 è la permeabilità magnetica nel vuoto, ε 0 è la costante dielettrica nel vuoto, a il raggio del conduttore, s l interasse ed n il numero di conduttori esterni (n=2 per una sonda trifilare). Utilizzando tale equazione si è ottenuto Z p,probe =183.5 Ω. Per la stima della permettività del mezzo nella quale sono inserite le sonde, si è fatto riferimento all equazione (2). La permettività della fase solida e dell aria sono state assunte reali ed indipendenti dalla frequenza (ε a =1, ε s =5). La permettività equivalente dell acqua interstiziale libera ε * fw è stata stimata utilizzando, in prima approssimazione, l equazione seguente: VERIFICA DEL MODELLO DI PROPAGAZIONE Il modello di propagazione dell onda è stato verificato con riferimento alle misure eseguite in acqua demineralizzata e nei campioni di sabbia e sabbia con limo debolmente argillosa. Come mostrato in figura 9, il risultato è soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda la stima del tempo di transito t end -t start. È il caso di sottolineare che la simulazione è stata eseguita determinando in modo indipendente le caratteristiche di trasmissione della linea ad eccezione dell impedenza caratteristica della testa (Z p,head1, Z p,head2 ) e della conducibilità elettrica (13) dove ε fw ed ε fw sono state assunte indipendenti dalla concentrazione e assunte pari a quelle dell acqua pura [HASTED, 1973], mentre la conducibilità elettrica dell acqua libera σ fw è stata determinata in modo tale che le onde di riflessione simulate si sovrapponessero alle onde sperimentali in condizioni stazionarie (t ). In particolare, si è ottenuto σ fw =0.002 S/m per l acqua demineralizzata, σ fw =0.022 S/m per Fig. 9 Verifica del modello di propagazione dell onda. Fig. 9 Validation of the wave propagation model. LUGLIO - SETTEMBRE 2008
8 116 TARANTINO - POZZATO Tab. I Parametri della linea di trasmissione utilizzati per analizzare l effetto della temperatura. Tab. I Transmission line parameters used to investigate temperature effects. T ( C) ρ d (g/m 3 ) ρ s (g/m 3 ) A s (m 2 /g) 100 L cable (m) 10 ε s,w f rel,fw (GHz) ε,fw 4.22 σ fw (S/m)) ε,bw 5 σ bw (S/m)) dell acqua libera σ fw che però influenzano poco il tempo di transito t end -t start. È lecito attendersi che una migliore simulazione sarebbe stata possibile se tutti i parametri di trasmissione fossero stati determinati per analisi inversa, ma questa analisi esula dagli scopi di questo lavoro. La verifica del modello di propagazione presentata in figura 9 ha lo scopo di mostrare che tale modello è sufficientemente accurato per la stima del tempo di transito dell onda e può essere quindi utilizzato per le simulazioni presentate nel paragrafo successivo Analisi numerica degli effetti della temperatura e della lunghezza del cavo Fig. 10 Simulazione dell onda di riflessione al variare del contenuto volumetrico d acqua θ (T=20 C). Fig. 10 Simulation of reflection waveform at different volumetric water contents (T=20 C). Al fine di analizzare gli effetti della temperatura sulla misura del contenuto d acqua mediante TDR, sono state simulate onde di riflessione alle temperature di 0, 20 e 40 C per differenti valori di contenuto volumetrico d acqua. In questo modo, sono state ricostruite le curve di taratura K a -θ per ciascuna di queste temperature. È stato considerato un terreno argilloso caratterizzato da una media superficie specifica, A s =100 m 2 /g, corrispondente ad un terreno con un contenuto d acqua igroscopico pari a w h =3% (Eq. 8). La permettività equivalente dell acqua interstiziale è stata determinata utilizzando l equazione (1) [STOGRYN, 1971], assumendo una conducibilità elettrica dell acqua libera pari a σ fw =0.1 S/m a 20 C. Per l acqua adsorbita, si è utilizzata l equazione 14, assumendo ε bw, =5 e σ bw =15 S/ m a 20 C seguendo HEIMOVAARA et al. [1994]. I parametri utilizzati per questa simulazione sono riportati in tabella I. Le onde di riflessione al variare del contenuto d acqua (ad una data temperatura) sono mostrate in figura 10. All aumentare del contenuto d acqua, diminuisce l ampiezza del ramo ascendente corrispondente alla riflessione all estremità della sonda a causa dell attenuazione dell onda dovuta alla dissipazione ionica. La figura 11 mostra invece le onde di riflessione al variare della temperatura (ad un dato contenuto d acqua). All aumentare della temperatura, aumenta la conducibilità elettrica e quindi la dissipazione ionica, e questo diminuisce l ampiezza del ramo ascendente corrispondente alla riflessione all estremità della sonda. Per ricostruire le curve di taratura K a -θ, sono state inizialmente simulate le onde di riflessione in acqua ed aria al fine di determinare la lunghezza elettrica L * ed il tempo di transito nella testa Δt in accordo con HEIMOVAARA [1993] (assumendo K a =1 per l aria, K a =80.2 per l acqua a 20 C). Per ciascuna onda corrispondente ad un assegnata temperatura T e contenuto volumetrico d acqua θ, è stato determinato il tempo di transito t end -t start. Secondo la co- RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA
9 STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA ZONA NON SATURA 117 Tab. II Parametri relativi alla permettività del terreno in condizioni standard. Tab. II Parameters for soil permittivity under standard conditions. ρ d (g/m 3 ) 1.5 ρ s (g/m 3 ) 2.65 T ( C) 20 ε,fw 80.2 f rel,fw (GHz) 17 σ fw (S/m)) 0 A s 0 Fig. 13 Effetto della temperatura sulla curva di calibrazione K a -θ in terreni argillosi (terreno dispersivo). Fig. 13 Temperature effects on K a -θ calibration curve in clayey soils (dispersive soil). Fig. 12 Effetto della superficie specifica e della conducibilità elettrica dell acqua libera (terreno dispersivo) sulla curva di calibrazione K a -θ. Fig. 12 Effects of specific surface and of free water electrical conductivity (dispersive soil) on K a -θ calibration curve. Fig. 11 Simulazione dell onda di riflessione al variare della temperatura (θ=0.2). Fig. 11 Simulation of reflection waveform at different temperatures (θ=0.2). struzione di figura 5 e quindi la permettività apparente K a utilizzando l equazione (4) e l equazione (5). La figura 12 riporta la curva di taratura K a -θ ottenuta per il terreno a media superficie specifica alla temperatura T=20 C confrontata con la curva di taratura ottenuta, sempre teoricamente, per il caso di un terreno non argilloso e acqua interstiziale non conduttiva (condizione standard in tabella II). Nella stessa figura è riportata anche la curva di taratura proposta da LEDIEU et al. [1986] come riferimento. Si osserva che la presenza di una frazione argillosa e di acqua interstiziale conduttiva incrementa la permettività apparente K a a pari contenuto volumetrico d acqua. La figura 13 mostra la curve di taratura alle temperature di 0, 20 e 40 C ottenute utilizzando i parametri di taratura della sonda Δt ed L* determinati alla temperatura T=20 C. Si osserva che un escursione di ±20 C determina un errore nella stima del contenuto d acqua pari a Δθ=±0.015, che non risulta essere particolarmente significativo. I risultati ottenuti sono in linea con quelli ottenuti sperimentalmente da EVETT et al. [2005]. Se si valuta la conducibilità elettrica del terreno argilloso a media superficie specifica utilizzato nella simulazione attraverso il coefficiente di riflessione a t si ottengono valori di ds/m che sono molto prossimi a quelli del terreno argilloso investigato sperimentalmente da EVETT et al. [2005] per il quale LUGLIO - SETTEMBRE 2008
10 118 TARANTINO - POZZATO Fig. 14 Permettività apparente di terreni argillosi in funzione della frequenza e della temperatura. Fig. 14 Effect of frequency and temperature on apparent permittivity of clayey soils. a) non si osservano apprezzabili effetti della temperatura sulla curva di taratura (terreno C nel citato articolo). Per comprendere perché la permettività del terreno argilloso a media superficie specifica sia maggiore di quello del terreno non dissipativo ( standard ) e perché la temperatura abbia un effetto trascurabile sulla permettività apparente K a, può essere istruttivo visualizzare la variazione della permettività apparente con la frequenza, ottenuta combinando l equazione (2) con l equazione (3). La figura 14 mostra la permettività apparente al variare della frequenza per le tre temperature di 0, 20 e 40 C, sia per il terreno argilloso a media superficie specifica considerato in questa analisi (curva tratteggiata) sia per il terreno standard non dispersivo (curva continua). Si osserva che alla frequenza di 1 GHz, che rappresenta la frequenza efficace per il terreno argilloso considerato, la permettività apparente del terreno argilloso considerato non differisce significativamente dalla permettività del terreno standard non dispersivo, che in prima approssimazione può essere assunto rappresentativo dei terreni rappresentati dalla curve di taratura universali di Ledieu o Topp [TOPP et al., 19080; LEDIEU et al., 1986] e non varia significativamente con la temperatura. L analisi dell effetto della lunghezza del cavo sulla curva di taratura K a -θ è mostrato in figura 15, sia per un terreno standard (non dispersivo) sia per il terreno argilloso considerato in questa analisi (dispersivo) con riferimento a cavi di lunghezza pari a 1, 10 e 20 m. Si può osservare come l effetto del cavo sulla curva di taratura sia praticamente trascurabile (Tab. III). b) Fig. 15 Effetto della lunghezza sulla curva di calibrazione K a -θ ; a) terreno non dispersivo; b) terreno dispersivo (terreno argilloso). Fig. 15 Effect of cable length on K a -θ calibration curve in. a) non-dispersive soil; b) dispersive soil (clayey soil). 4. Misura del contenuto d acqua dei terreni mediante la tecnica ADR (Amplitude Domain Reflectometry) Questo tipo di sensore è costituito da un oscillatore sinusoidale con frequenza di 100 MHz, da un segmento di cavo coassiale di impedenza assegnata e da un sensore a più aste, che costituisce un ulteriore sezione della linea di trasmissione la cui impedenza dipende dalla permettività dielettrica del terreno nel quale le aste sono inserite (Fig. 16). RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA
11 STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA ZONA NON SATURA 119 Tab. III Parametri della linea di trasmissione utilizzati per analizzare l effetto del cavo. Tab. III Transmission line parameters used to investigate cable effects. L cable (m) ρ d (g/m 3 ) ρ s (g/m 3 ) A s (m 2 /g) 100 T ( C) 20 ε s_fw 80.2 f rel_fw (GHz) 17 ε _fw 4.22 σ _fw (S/m)) 0.1 ε _bw 5 σ _bw (S/m)) 15 Fig. 16 Sensore di riflettometria nel dominio della ampiezze Delta-T ThetaProbe (ADR). Fig. 16 Amplitude Domain Reflectometry Delta-T ThetaProbe (ADR). Se l impedenza del sensore differisce da quello della linea di trasmissione coassiale interna, allora un porzione del segnale incidente è riflessa alla giunzione J tra il sensore la linea coassiale interna. La differenza tra il picco del segnale incidente e quello riflesso alla giunzione J può essere correlato all impedenza del terreno circostante la sonda, e questa può essere a sua volta correlata alla permettività apparente del terreno [GASKIN e MILLER, 1996; MILLER e GASKIN, 1999]. Con riferimento alla sonda utilizzata, la casa costruttrice fornisce la seguente relazione per la conversione del segnale elettrico in tensione (V) in permettività apparente K a : (15) Per verificare sperimentalmente questa correlazione, sono state eseguite misure in aria, acqua, acetone ed etanolo [STANIER, 2007]. Come mostrato in figura 17, la curva di taratura definita dall equazione (15) prevede in modo accurato la permettività dei fluidi di riferimento considerati ad eccezione della permettività dell acqua. La permettività dell acqua è tuttavia al di fuori dell intervallo di permettività significativo per un terreno e quindi tale errore non è rilevante. Fig. 17 Relazione tra permettività apparente e tensione elettrico per la sonda ThetaProbe. Fig. 17 Relationship between apparent permettivity and signal output for ThetaProbe. La stessa casa costruttrice fornisce inoltre una curva di taratura per convertire, nel caso di suoli minerali, la permettività apparente K a in contenuto volumetrico d acqua θ: (16) LUGLIO - SETTEMBRE 2008
12 120 TARANTINO - POZZATO È il caso di sottolineare che l effetto della temperatura è molto meno marcato nel caso di sonde TDR poiché queste operano a frequenze maggiori (0.7-1 GHz). Tali sonde presentano quindi una risposta molto più affidabile in terreni con una frazione argillosa da bassa a media superficie specifica come indicato dallo spettro della permettività apparente in figura 14. Chiaramente, nel caso di terreni ad elevata superficie specifica (bentoniti), anche la misura mediante TDR sarà affetta da errore significativo se interpretata utilizzando una curva di calibrazione per terreno standard. Fig. 18 Relazione K a -θ per la sonda ThetaProbe. Fig. 18 K a -θ relationship for ThetaProbe. 5. Misura del contenuto d acqua dei terreni mediante la tecnica capacitiva Il termine suoli minerali usato del costruttore è alquanto generico e deve intendersi come terreno caratterizzato da frazione argillosa e conducibilità elettrica del fluido interstiziale trascurabili (terreno non dissipativo). Per verificare sperimentalmente questa correlazione, sono state eseguite misure in sabbia fine e grossa compattata a differenti valori di [STA- NIER, 2007]. Come mostrato in figura 18, la curva di taratura definita dall equazione (16), la quale non differisce in modo significativo da quella proposta de LEDIEU et al. [1986], prevede il contenuto d acqua con errore accettabile se i dati sono corretti per tener conto della maggiore densità dei campioni a contenuto d acqua maggiore (Δρ= g/cm 3 ). L effetto della temperatura sulla misura può essere investigato teoricamente attraverso l analisi dello spettro della permettività apparente ottenuta combinando l equazione (2) con l equazione (3) e mostrato in figura 14. Nel caso di un terreno standard (non argilloso e con acqua interstiziale non conduttiva), l effetto della temperatura sulla permettività è trascurabile alla frequenza operativa della sonda ThetaProbe pari a 100 MHz (curve a tratto continuo). Al contrario, nel caso di terreni a bassa e media superficie specifica (S<100 m2/g), la permettività apparente risulta significativamente maggiore di quella di un terreno standard (curve trattegiate) e quindi la curva di taratura universale definita dall equazione 16 tenderà significativamente a sovrastimare il contenuto d acqua, come mostrato anche sperimentalmente da COSH et al. [2005]. Nel caso di terreni a bassa e media superficie specifica è opportuno quindi eseguire una taratura specifica per il terreno in esame. Inoltre, la permettività apparente a basse frequenze (100 MHz) risulta dipendere fortemente dalla temperatura come mostrato in figura 14 ed è quindi consigliabile eseguire la taratura a differenti temperature qualora si prevedano in sito escursioni di temperatura significative Sensori per installazione profonda in tubo di accesso A causa delle difficoltà di installazione, le sonde di tipo TDR ed ADR non sono sempre idonee a misurare il contenuto d acqua in profondità. Sono stati quindi sviluppati sensori di tipo capacitivo per sondare il terreno dall interno di un tubo di accesso. Tali sensori sono relativamente poco costosi e relativamente semplici da utilizzare e sono sempre più spesso utilizzati in sistemi di monitoraggio. Le sonde capacitive per installazione profonda sono costituite da una coppia di elettrodi separati da un materiale plastico che si inseriscono nel tubo di accesso in modo che sia ridotto al minimo l intercapedine tra il sensore e la parete interna del tubo. I due elettrodi formano un condensatore il cui campo elettrico intercetta il terreno all esterno del tubo di accesso, il tubo di accesso, più l aria tra la sonda ed il tubo di accesso (Fig. 19). Il condensatore è inserito in un circuito LC (L=induttanza, C=capacità) che include un oscillatore per la misura della frequenza di risonanza F res del circuito LC. La frequenza di risonanza dipende dalla capacità del sistema terrenotubo di accesso secondo la relazione seguente [DEAN et al., 1987]: (17) dove L è l induttanza della bobina del circuito LC, C b e C c sono rispettivamente la capacità della base e del collettore. La capacità C è a sua volta funzione alla permettività dielettrica apparente del terreno secondo la relazione C=gK a (18) dove g è un fattore geometrico difficile da calcolare per geometrie non elementari. La misura del contenuto d acqua può essere eseguita correlando direttamente la frequenza di risonanza F res al contenuto RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA
13 STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA ZONA NON SATURA 121 d acqua [PALTINEANU and STARR, 1997; SENTEK, 2001] oppure tarando i parametri delle equazioni (17) e (18) (o equazioni simili) per derivare la permettività apparente K a la quale è a sua volta correlata al contenuto d acqua mediante relazioni empiriche utilizzate nelle misure TDR [ROBINSON et al., 1998; KELLE- NERS et al., 2004]. Questo secondo approccio è utilizzato per la sonda multi-capacitiva utilizzata in questo studio (Fig. 20). In particolare, il costruttore fornisce due relazioni che correlano il segnale in uscita (V) alla permettività apparente, un equazione di 6 grado e una lineare: (19) (20) L equazione (16) è quindi utilizzata per correlare la permettività apparente al contenuto d acqua nel caso di suoli minerali (terreno standard non dissipativo). Per verificare sperimentalmente questa correlazione, sono state eseguite misure in una ghiaia con sabbia limosa compattata a differenti valori di θ [TAMBURRINI, 2007]. Come mostrato in figura 21, la curva di taratura definita dall equazione (19) e dall equazione (20) combinate con l equazione (16), prevede il contenuto d acqua con un errore Δθ=±0.03, corrispondente all errore dichiarato dal costruttore. Analogamente alla sonda ADR, la sonda multicapacitiva opera in un intervallo di frequenze relativamente basse, nell intorno di 100 MHz. Nel caso di misura in terreni argillosi, anche a bassa e media superficie specifica, valgono le stesse considerazioni fatte a proposito della sonda ADR circa la necessità di eseguire una curva di taratura specifica eventualmente includendo nella curva di taratura l effetto della temperatura. Le conclusioni tratte dalla figura 14 sono in accordo con la letteratura nella quale si suggerisce che Fig. 20 Sensore multi-capacitivo Profile probe Delta-T. Fig. 20 Multi-capacitive sensor Delta- T Profile Probe. Fig. 21 Curva di calibrazione mv-θ per le sonde multicapacitiva Profile Probe. Fig. 21 Calibration curve mv-θ for the multi-capacitive sensor Profile Probe. Fig. 19 Installazione superficiale e profonda di sonde capacitive e relativi campi elettrici. Fig. 19 Surface and depth installation capacitance probes and relative electric fields. LUGLIO - SETTEMBRE 2008
14 122 TARANTINO - POZZATO curve di taratura universali come quella definite dall equazione 16 possono ritenersi accettabili per basse conducibilità elettriche ( S/m secondo ROBINSON et al., 1998) e contenuto volumetrici d acqua relativamente bassi (θ<~0.30 secondo KELLE- NERS et al., 2004) Sensori per installazione di superficie Parallelamente alle sonde multi-capacitive, sono stati sviluppati sensori capacitivi per installazioni superficiali (Surface Capacitance Insertion Probes, SCIP) che, nel caso di un numero limitato di misure, possono costituire un alternativa economicamente più conveniente rispetto alle sonde TDR. I sensori capacitivi di superficie sono formati da due elettrodi ad asta che sono inseriti nel terreno ed hanno lo stesso principio di funzionamento delle sonde capacitive per installazione profonda. La relazione che correla la frequenza di risonanza alla capacità C è riportata in DEAN [1994] ed ha una forma simile all equazione 17. Anche in questo caso la misura del contenuto d acqua può essere eseguita correlando direttamente la frequenza di risonanza F res al contenuto d acqua oppure tarando i parametri delle equazioni (17) e (18) (o equazioni simili) per derivare la permettività apparente e quindi utilizzare le relazioni empiriche utilizzate nelle misure TDR per correlare la permettività apparente K a al contenuto d acqua. In questo studio, sono state utilizzate due sonde (Fig. 22) le quali sono caratterizzate da curve di taratura che correlano direttamente il valore digitale di output (raw) al contenuto d acqua. Per verificare sperimentalmente la correlazione proposta dal costruttore, sono state eseguite misure in limo argilloso debolmente sabbioso compattato a differenti valori di θ [CAZZOLLI, 2008]. Come mostrato in figura 23 la curva di taratura fornita dal costruttore per suoli minerali prevede il contenuto d acqua con un errore Δθ = ± 0.03, corrispondente all errore dichiarato dal costruttore stesso. L errore può essere ridotto a Δθ = ± Fig. 23 Curva di calibrazione del costruttore Raw-θ per le sonde capacitive Decagon. a) EC-5; b) ECHO-TE. Fig. 23 Manufacturer calibration curve Raw-θ for Decagon capacitive probes. a) EC-5; b) ECHO-TE se viene determinata una curva di taratura specifica come mostrato in figura 24. Anche in questo caso, la sonda multi-capacitiva opera in un intervallo di frequenze relativamente basse, nell intorno di 70 MHz. Nel caso di misura in terreni argillosi, anche a bassa e media superficie specifica, è lecito quindi attendersi deviazioni significative dalla curva di taratura per terreni standard come mostrato dal confronto dello spettro della permettività apparente per terreni standard e terreni argillosi a media superficie specifica in figura 14. Nel caso di terreni argillosi, anche a bassa e media superficie specifica, è pertanto opportuno eseguire una curva di taratura specifica eventualmente includendo l effetto della temperatura. 6. Conclusioni Fig. 22 Sensori capacitivi Decagon. a) EC-5; b) ECHO-TE. Fig. 22 Decagon capacitive sensors. a) EC-5; b) ECHO-TE. È stato presentato uno studio sulla risposta di quattro sensori per la misura del contenuto d acqua dei terreni. Questi sensori misurano indirettamente il contenuto d acqua attraverso la misura della permettività dielettrica del terreno e si differenziano per tecnica di misura e intervallo di frequenza nel quale la permettività dielettrica è misurata. RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA
15 STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA ZONA NON SATURA 123 TDR, richiedendo quindi una taratura specifica per una misura accurata in terreni non standard (dissipativi). Le sonde sono relativamente economiche (alcune centinaia di Euro la sonda capacitiva, molte centinaia di Euro la sonda ADR) e risultano convenienti da un punto di vista economico nel caso di installazione di un numero limitato di sonde. Da un punto di vista operativo, la gestione del dato è sicuramente più semplice rispetto al TDR. La sonda multi-capacitiva, pur operando a basse frequenze, ed avendo quindi limitazioni relative all impiego in terreni argillosi e/o conduttivi, consente di installare più sonde lungo una verticale con un minimo disturbo del terreno, al contrario di quanto accadrebbe per la sonda TDR che richiederebbe la realizzazione di un foro per ciascuna profondità di installazione e che presenterebbe la difficoltà di riempire il foro con un terreno simile in termini di porosità a quello in sito. Considerato il costo contenuto (tra mille e duemila Euro), la sonda capacitiva rappresenta probabilmente la migliore soluzione per installazioni profonde a più livelli. Fig. 24 Curva di calibrazione specifica Raw-θ per le sonde capacitive Decagon. a) EC-5; b) ECHO-TE. Fig. 24 Specific calibration curve Raw-θ for Decagon capacitive probes. a) EC-5; b) ECHO-TE. La sonda TDR misura il tempo di transito di un onda elettromagnetica lungo guide d onda inserite nel terreno, il quale è sua volta determinato interpretando un onda di riflessione. Questa tecnica è la più versatile poiché consente anche di determinare la conducibilità elettrica del terreno e correggere la misura in modo opportuno. L analisi teorica suggerisce che, operando ad elevate frequenze (0.7-1 GHz) risulta relativamente poco sensibile alla temperatura anche nel caso di terreni argillosi a bassa e media superficie specifica e di conducibilità elettrica del terreno fino a 1 ds/m. Il costo di un sistema TDR è essenzialmente legato all elettronica (diverse migliaia di Euro) mentre il costo della sonda è molto ridotto. Tale sistema risulta quindi conveniente nel caso di installazione di numerose sonde. Lo svantaggio di questo tipo di sonda è rappresentato dalla difficoltà di installarli in profondità. La sonda ADR misura l ampiezza dell onda riflessa in corrispondenza della superficie del terreno mentre la sonda capacitiva di tipo superficiale misura la frequenza di risonanza di un circuito che include un condensatore tra le cui armature è posto il terreno. Entrambe le sonde operano a frequenze relativamente basse e risultano quindi molto più sensibili al contenuto di argilla e alla conducibilità del fluido interstiziale rispetto al Ringraziamenti Si ringrazia il Ministero dell Università e della Ricerca per il supporto alle attività di ricerca attraverso il progetto PRIN 2005 Monitoraggio e valutazione della sicurezza nelle dighe in terra e negli argini fluviali. Si ringraziano inoltre Sam Stanier, Giancarlo Cazzolli, Elenonora Filippi e Chiara Tamburini, per il contributo all attività sperimentale. Bibliografia BALL J.A.R. (2002) Characteristic impedante of unbalanced TDR probes. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. LI, n. 3, pp BANIN A., AMIEL A. (1970) A correlative study of the chemical and physical properties of a group of natural soils in Israel. Geoderma, vol. III, pp CAZZOLLI G. (2008) Calibrazione di sensori di tipo capacitivo per la misura del contenuto d acqua dei terreni. Tesi di Laurea Triennale, Università di Trento, in preparazione. COSH M.H., JACKSON T.J., BINDLISH R., FAMIGLIETTI J.S., RYU D. (2005) Calibration of an impedance probe for estimation of surface soil water content over large regions. Journal of Hydrology, vol. CCCXI, pp DASBERG S., HOPMANS J.W. (1992) Time domain reflectometry calibration for uniformly and non-uni- LUGLIO - SETTEMBRE 2008
16 124 TARANTINO - POZZATO formly wetted sandy and clayey loam soils. Soil Sci. Soc. Am. J., vol. LVI, pp DEAN T.J., BELL J.P., BATY A.B.J. (1987) Soil moisture measurement by an improved capacitance technique. Part I. Sensor design and performance. J. Hydrology, vol. XCIII, pp DEAN T.J. (1994) The IH capacitance probe for measurement of soil water content. IH Report n Institute of Hydrology, Wallingford, Oxon. DEBYE P. (1929) Polar molecules. Chemical Catalog Company, New York. DIRKSEN C., DASBERG S. (1993) Improved calibration of time domain reflectometry soil water content measurements. Soil Sci. Soc. Am. J., vol. LVII, pp EVETT S.R., TOLK J.A., HOWELL T.A. (2005) Time Domain Reflectometry Laboratory Calibration in Travel Time, Bulk Electrical Conductivity, and Effective Frequency. Vadose Zone Journal, vol. IV, pp FRIEDMAN S.P. (1998) A saturation degree-dependent composite spheres model for describing the effective dielectric constant of unsaturated porous media. Water Resources Res., vol. XXXIV, n. 11, pp GASKIN G.J., MILLER J.D. (1996) Measurement of soil water content using a simplified impedance measuring technique. J. Agric. Res., vol. LXIII, pp GIESE K., TIEMANN R. (1975) Determination of the complex permittivity from thin-sample time domain reflectometry improved analysis of the step response waveform. Advances Molecular Relaxation Processes, vol. VII, pp HASTED J.B. (1973) Aqueous dielectrics. London, Chapman and Hall. HEIMOVAARA T.J. (1993) Design of triple-wire time domain reflectometry probes in practice and theory. Soil Sci. Soc. Am. J., vol. LVII, pp HEIMOVAARA T.J., BOUTEN W., VERSTRATEN J.M. (1994) Frequency domain analysis of time domain reflectometry waveform. 2. A four-component complex dielectric mixing model for soils. Water Resour. Res. vol. XXX, n. 2, pp HERKELRATH W.N., HAMBURG S.P., MURPHY F. (1991) Automatic, real-time monitoring of soil moisture in a remote field area with TDR. Water Resources Research, vol. XXVII, n. 5, pp KELLENERS T.J., SOPPE R.W.O., AYARS J.E., SKAGGS T.H. (2004) Calibration of capacitance probe sensors in a saline silty slay. Soil Soil Sci. Soc. Am. J., vol. LXVIII, pp KRAUS J.D., FLEISCH D.A. (1999) Electromagnetics with applications. McGraw-Hill. LEDIEU J., DE RIDDER P., DE CLERCK P., DAUTREBANDE S. (1986) A method of measuring soil moisture by time domain reflectometry. Journal of Hydrology, vol. LXXXVIII, pp LICHTENECKER K. (1926) Die dielektrizitatskonstante naturlicher und kunstlicher mischkorper. Physikalische Zeitschrift, vol. XXVII, pp LIN C.P., TANG S.H. (2007) Comprehensive wave propagation model to improve TDR intepretation for geotechnical applications. Geotech. Testing J., vol. XXX, n. 2, pp LIN C.P. (2003) Analysis of non uniform and dispersive time domain reflectometry measurement systems with application to the dielectric spectroscopy of soils. Water Resour. Res., vol. XXXIX, DOI: /2002 WR MILLER J.D., GASKIN G.J. (1999) ThetaProbe ML2x. Principles of operation and applications. MLURI Technical Note (2nd ed). PALTINEANU I.C., STARR J.L. (1997) Real-time soil water dynamics using multisensor capacitance probes: Laboratory calibration. Soil Sci. Soc. Am. J., vol. LXI, pp PÉPIN S., PLAMONDON A.P., STEIN J. (1992) Peat water content measurement using the time domain reflectometry. Can. J. For. Res., vol. CXV, pp ROBINSON D.A., GARDNER C.M.K., EVANS J., COOPER J.D., HODNETT M.J., BELL J.P. (1998) The dielectric calibration of capacitance probes for soil hydrology using an oscillation frequency response model. Hydrology and Earth System Sciences, vol. II, n. 1, pp ROTH K., SCHULIN R., FLÜHLER H., ATTINGER W. (1990) Calibration of TDR for water content measurement using a composite dielectric approach. Water Resources Research, vol. XXVI, n. 10, pp SENTEK (2001) Calibration of the Sentek Pty Ltd Soil Moisture Sensors. Sentek Pty Ltd, Kent Town, South Australia. STANIER S.A. (2007) Predicting Maximum Vertical Cut Height in Unsaturated Non-Cohesive Soils. MSc. Dissertation, University of Sheffield. STOGRYN A. (1971) Equations for calculating the dielectric constant of saline water. IEEE Trans Microwave Theory Tech, vol. XIX, pp TAMBURRINI C. (2007) Caratterizzazione idraulica di un suolo coltivato a vite: analisi sperimentale. Tesi di Laurea Magistrale, Università di Trento. TARANTINO A., RIDLEY A.M., TOLL D.G. (2008) Field measurement of suction, water content, and water permeability. Geotechnical and Geological Engineering, (in press). TOPP G.C., YANUKA M., ZEBCHUK W.D., ZEGELIN S. (1988) Determination of Electrical conductivity using TDR: soil and water experiments in coaxial lines. Water Resources Research, vol. XXIV, n. 7, pp TOPP G.C., DAVIS J.L., ANNAN A.P. (1980) Electromagnetic determination of soil water content: Measurements in coaxial transmission lines. Water Resour. Res., vol. XVI, pp TOPP G.C., REYNOLDS W.D. (1998) Time domain reflectometry: A seminal technique for measuring mass RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA
L attività di ricerca riguarda la messa a punto di procedure con metodi geofisici per la caratterizzazione del suolo e del sottosuolo
 L attività di ricerca riguarda la messa a punto di procedure con metodi geofisici per la caratterizzazione del suolo e del sottosuolo Le tecniche geofisiche consentono esplorazioni rapide invasive a differenza
L attività di ricerca riguarda la messa a punto di procedure con metodi geofisici per la caratterizzazione del suolo e del sottosuolo Le tecniche geofisiche consentono esplorazioni rapide invasive a differenza
SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE CURVE TIME DOMAIN REFLECTOMETRY PER STAZIONI AUTOMATICHE DI MISURA DEL CONTENUTO IDRICO DEL SUOLO
 Convegno di Medio Termine dell Associazione Italiana di Ingegneria Agraria Belgirate, 22-24 settembre 2011 memoria n. SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE CURVE TIME DOMAIN REFLECTOMETRY PER STAZIONI AUTOMATICHE
Convegno di Medio Termine dell Associazione Italiana di Ingegneria Agraria Belgirate, 22-24 settembre 2011 memoria n. SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE CURVE TIME DOMAIN REFLECTOMETRY PER STAZIONI AUTOMATICHE
Esercitazione 8 : LINEE DI TRASMISSIONE
 Esercitazione 8 : LINEE DI TRASMISSIONE Specifiche Scopo di questa esercitazione è verificare il comportamento di spezzoni di linea in diverse condizioni di pilotaggio e di terminazione. L'esecuzione delle
Esercitazione 8 : LINEE DI TRASMISSIONE Specifiche Scopo di questa esercitazione è verificare il comportamento di spezzoni di linea in diverse condizioni di pilotaggio e di terminazione. L'esecuzione delle
Linee di trasmissione
 Linee di trasmissione Finora esperienza con circuiti a costanti concentrate. E un approssimazione, valida solo per lunghezze d onda dei segnali grandi rispetto alle dimensioni del circuito. Esempio Sinusoidale
Linee di trasmissione Finora esperienza con circuiti a costanti concentrate. E un approssimazione, valida solo per lunghezze d onda dei segnali grandi rispetto alle dimensioni del circuito. Esempio Sinusoidale
L acqua nel terreno. Scaricabile da: it/dip timenti/dp /m te i did tti htm
 Corso Corso di Fondamenti di Corso Complementi di Agronomia di g Produzioni di Agronomia Vegetali --Viterbo, - Velletri, Novembre Gennaio Maggio 2007 2005 2009 - - L acqua nel terreno Scaricabile da: http://www.unitus.it/dipartimenti/dpv/materiale_didattico.htm
Corso Corso di Fondamenti di Corso Complementi di Agronomia di g Produzioni di Agronomia Vegetali --Viterbo, - Velletri, Novembre Gennaio Maggio 2007 2005 2009 - - L acqua nel terreno Scaricabile da: http://www.unitus.it/dipartimenti/dpv/materiale_didattico.htm
Agronomia Generale Fisica del terreno Relazioni acqua-terreno (idrostatica)
 Agronomia Generale Fisica del terreno Relazioni acqua-terreno (idrostatica) Marco Bittelli Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-ambientali (DiSTA) Universita di Bologna Variabili necessarie per definire
Agronomia Generale Fisica del terreno Relazioni acqua-terreno (idrostatica) Marco Bittelli Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-ambientali (DiSTA) Universita di Bologna Variabili necessarie per definire
Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I A.A Prova individuale
 Caratterizzazione di un componente Su un estremo di un connettore a T è montata una induttanza L. Figura 1: Dispositivo da misurare. 1. Riportare, in funzione della frequenza f e della induttanza L, l
Caratterizzazione di un componente Su un estremo di un connettore a T è montata una induttanza L. Figura 1: Dispositivo da misurare. 1. Riportare, in funzione della frequenza f e della induttanza L, l
2. Vibrazioni longitudinali nelle barre
 . Vibrazioni longitudinali nelle barre Si richiama, all interno di questo paragrafo, l analisi delle vibrazioni longitudinali di barre nell intorno della configurazione di equilibrio statico. Si ipotizzi,
. Vibrazioni longitudinali nelle barre Si richiama, all interno di questo paragrafo, l analisi delle vibrazioni longitudinali di barre nell intorno della configurazione di equilibrio statico. Si ipotizzi,
Misure e Tecniche Sperimentali - Alfredo Cigada
 Misure di spostamento senza contatto 2 TRASDUTTORI A CORRENTI PARASSITE 1 Trasduttori a correnti parassite: principio di funzionamento bobina alimentata con corrente alternata ( 1 MHz) 3 superficie metallica
Misure di spostamento senza contatto 2 TRASDUTTORI A CORRENTI PARASSITE 1 Trasduttori a correnti parassite: principio di funzionamento bobina alimentata con corrente alternata ( 1 MHz) 3 superficie metallica
Ingegneria dei Sistemi Elettrici_6f
 Ingegneria dei Sistemi Elettrici_6f Guide d onda e cavità risonanti Sono state studiate le proprietà caratteristiche delle onde elettromagnetiche trasversali guidate da linee di trasmissione. Una delle
Ingegneria dei Sistemi Elettrici_6f Guide d onda e cavità risonanti Sono state studiate le proprietà caratteristiche delle onde elettromagnetiche trasversali guidate da linee di trasmissione. Una delle
REGIONE VALLE D AOSTA
 REGIONE VALLE D AOSTA COMUNE DI AYAS COMMITTENTE: CHP s.r.l. OGGETTO: ESECUZIONE PROVA MASW NEL COMUNE DI AYAS NELLA FRAZIONE DI CHAMPOLUC REPORT PROVA TORINO 12/07/2016 Dott. Geol. Andrea DANIELE Via
REGIONE VALLE D AOSTA COMUNE DI AYAS COMMITTENTE: CHP s.r.l. OGGETTO: ESECUZIONE PROVA MASW NEL COMUNE DI AYAS NELLA FRAZIONE DI CHAMPOLUC REPORT PROVA TORINO 12/07/2016 Dott. Geol. Andrea DANIELE Via
B. Bracci, A. D Ambra, G.Licitra, A. Zari
 PROPOSTE PER LA VALUTAZIONE TEORICA IN AMBIENTE CARTOGRAFICO 3D DELL IMPATTO AMBIENTALE DI RADAR B. Bracci, A. D Ambra, G.Licitra, A. Zari Presentazione Dott. Andrea Zari Alessandria, 8 giugno 2016 SISTEMI
PROPOSTE PER LA VALUTAZIONE TEORICA IN AMBIENTE CARTOGRAFICO 3D DELL IMPATTO AMBIENTALE DI RADAR B. Bracci, A. D Ambra, G.Licitra, A. Zari Presentazione Dott. Andrea Zari Alessandria, 8 giugno 2016 SISTEMI
La misura delle proprietà idrauliche dei suoli nel laboratorio del CNR-ISAFOM
 Associazione Italiana Pedologi CORSO BREVE PER L AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO IN FISICA E IDROLOGIA DEL SUOLO 4 5 Giugno 2009 - Ercolano La misura delle proprietà idrauliche dei suoli nel laboratorio
Associazione Italiana Pedologi CORSO BREVE PER L AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO IN FISICA E IDROLOGIA DEL SUOLO 4 5 Giugno 2009 - Ercolano La misura delle proprietà idrauliche dei suoli nel laboratorio
Università di Roma Tor Vergata
 Università di Roma Tor Vergata Facoltà di Ingegneria Dipartimento di Ingegneria Industriale Corso di: TERMOTECNICA TRASMISSIONE DEL CALORE: RESISTENZA DI CONTATTO Ing. G. Bovesecchi gianluigi.bovesecchi@gmail.com
Università di Roma Tor Vergata Facoltà di Ingegneria Dipartimento di Ingegneria Industriale Corso di: TERMOTECNICA TRASMISSIONE DEL CALORE: RESISTENZA DI CONTATTO Ing. G. Bovesecchi gianluigi.bovesecchi@gmail.com
Misure elettriche. Scopo: misurare il comportamento elettrico di resistenze e condensatori misurare la costante dielettrica di alcuni materiali
 Misure elettriche Scopo: misurare il comportamento elettrico di resistenze e condensatori misurare la costante dielettrica di alcuni materiali Consideriamo un circuito elettrico in AC con una resistenza
Misure elettriche Scopo: misurare il comportamento elettrico di resistenze e condensatori misurare la costante dielettrica di alcuni materiali Consideriamo un circuito elettrico in AC con una resistenza
Laboratorio di Fisica Terrestre e dell Ambiente Esperimento n.1
 Laboratorio di Fisica Terrestre e dell Ambiente Esperimento n.1 Anno Accademico 009/010 Docente:Elena Pettinelli 1 Lo scopo dell esperimento Utilizzo di tecniche di misura elettriche per la stima della
Laboratorio di Fisica Terrestre e dell Ambiente Esperimento n.1 Anno Accademico 009/010 Docente:Elena Pettinelli 1 Lo scopo dell esperimento Utilizzo di tecniche di misura elettriche per la stima della
ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI ASSORBIMENTO ACUSTICO DI TENDAGGI IN CAMPO DIFFUSO E PER INCIDENZA NORMALE
 Associazione Italiana di Acustica 43 Convegno Nazionale Alghero, 25-27 maggio 216 ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI ASSORBIMENTO ACUSTICO DI TENDAGGI IN CAMPO DIFFUSO E PER INCIDENZA NORMALE Nicola Granzotto
Associazione Italiana di Acustica 43 Convegno Nazionale Alghero, 25-27 maggio 216 ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI ASSORBIMENTO ACUSTICO DI TENDAGGI IN CAMPO DIFFUSO E PER INCIDENZA NORMALE Nicola Granzotto
SENSORE DI TENSIONE SP
 SENSORE DI TENSIONE SP3000-01 2 Sensore di tensione per la cattura di segnali elettrici senza contatto metallico sul conduttore L ingegneria elettronica è spesso chiamata a misurare impulsi di breve durata
SENSORE DI TENSIONE SP3000-01 2 Sensore di tensione per la cattura di segnali elettrici senza contatto metallico sul conduttore L ingegneria elettronica è spesso chiamata a misurare impulsi di breve durata
Le sonde Pagina in. - figura
 Le sonde Paga 04 LE ONDE L impedenza di gresso,, di un oscilloscopio è modellabile dal parallelo tra una resistenza e una capacità C, i cui valori tipici sono rispettivamente MΩ e 0 0pF. Il loro valore
Le sonde Paga 04 LE ONDE L impedenza di gresso,, di un oscilloscopio è modellabile dal parallelo tra una resistenza e una capacità C, i cui valori tipici sono rispettivamente MΩ e 0 0pF. Il loro valore
OTTIMIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ACUSTICHE INTERNE DEGLI AMBIENTI MEDIANTE PANNELLI IN FIBRA DI POLIESTERE A GRADIENTE DI DENSITÀ CALIBRATO
 OTTIMIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ACUSTICHE INTERNE DEGLI AMBIENTI MEDIANTE PANNELLI IN FIBRA DI POLIESTERE A GRADIENTE DI DENSITÀ CALIBRATO Christian Barbati, Mariagiovanna Lenti TECNASFALTI s.r.l.,
OTTIMIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ACUSTICHE INTERNE DEGLI AMBIENTI MEDIANTE PANNELLI IN FIBRA DI POLIESTERE A GRADIENTE DI DENSITÀ CALIBRATO Christian Barbati, Mariagiovanna Lenti TECNASFALTI s.r.l.,
Campi Elettromagnetici e Circuiti I Adattatori d impedenza
 Facoltà di Ingegneria Università degli studi di Pavia Corso di aurea Triennale in Ingegneria Elettronica e Informatica Campi Elettromagnetici e Circuiti I Adattatori d impedenza Campi Elettromagnetici
Facoltà di Ingegneria Università degli studi di Pavia Corso di aurea Triennale in Ingegneria Elettronica e Informatica Campi Elettromagnetici e Circuiti I Adattatori d impedenza Campi Elettromagnetici
Filtri passivi Risposta in frequenza dei circuiti RC-RL-RLC
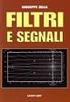 23. Guadagno di un quadripolo Filtri passivi isposta in frequenza dei circuiti C-L-LC In un quadripolo generico (fig. ) si definisce guadagno G il rapporto tra il valore d uscita e quello d ingresso della
23. Guadagno di un quadripolo Filtri passivi isposta in frequenza dei circuiti C-L-LC In un quadripolo generico (fig. ) si definisce guadagno G il rapporto tra il valore d uscita e quello d ingresso della
Figura 4 - Prova di permeabilità in sito a carico costante.
 Permeabilità La determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei depositi di terreno sciolto trova applicazione in tutti quei problemi legati agli abbassamenti di falda o ai moti di filtrazione
Permeabilità La determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei depositi di terreno sciolto trova applicazione in tutti quei problemi legati agli abbassamenti di falda o ai moti di filtrazione
L utilizzo di metodi a pressione di vapore per la determinazione della curva di ritenzione idrica
 L utilizzo di metodi a pressione di vapore per la determinazione della curva di ritenzione idrica Marco Bittelli Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali Università di Bologna Variabili necessarie
L utilizzo di metodi a pressione di vapore per la determinazione della curva di ritenzione idrica Marco Bittelli Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali Università di Bologna Variabili necessarie
Interconnessioni e Linee di Trasmissione
 Queste istruzioni sono scaricabili dal Portale (pagina dell insegnamento, sezione Materiale ), o da http://areeweb.polito.it/didattica/corsiddc/03moa. La versione più aggiornata è normalmente quella su
Queste istruzioni sono scaricabili dal Portale (pagina dell insegnamento, sezione Materiale ), o da http://areeweb.polito.it/didattica/corsiddc/03moa. La versione più aggiornata è normalmente quella su
Metodologie Elettromagnetiche per la geofisica. Proprietà elettromagnetiche di suoli e rocce (III)
 Metodologie Elettromagnetiche per la geofisica Proprietà elettromagnetiche di suoli e rocce (III) Anno Accademico 2009/2010 Docente:Elena Pettinelli Fattori che influenzano la permettività dielettrica
Metodologie Elettromagnetiche per la geofisica Proprietà elettromagnetiche di suoli e rocce (III) Anno Accademico 2009/2010 Docente:Elena Pettinelli Fattori che influenzano la permettività dielettrica
Ruggero Caravita, Giacomo Guarnieri Gruppo Gi101 Circuiti 1. Circuiti 1. Relazione sperimentale A P P A R A T O S P E R I M E N T A L E
 Relazione sperimentale Scopo dell esperienza è quella di determinare il valore di un set di resistenze incognite mediante la tecnica del ponte di Wheatstone. Sono inoltre indagate le caratteristiche di
Relazione sperimentale Scopo dell esperienza è quella di determinare il valore di un set di resistenze incognite mediante la tecnica del ponte di Wheatstone. Sono inoltre indagate le caratteristiche di
Università degli studi di Trento Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia
 Università degli studi di Trento Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia Prof. Dino Zardi Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica Fisica Componenti elementari
Università degli studi di Trento Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia Prof. Dino Zardi Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica Fisica Componenti elementari
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA E AMBIENTALE ABSTRACT MISURA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA E AMBIENTALE ABSTRACT MISURA
L EVAPOTRASPIRAZIONE (ETP) Bilancio Idrico = [(pioggia utile) + (irrigazione) ] (evapotraspirazione) ETP
![L EVAPOTRASPIRAZIONE (ETP) Bilancio Idrico = [(pioggia utile) + (irrigazione) ] (evapotraspirazione) ETP L EVAPOTRASPIRAZIONE (ETP) Bilancio Idrico = [(pioggia utile) + (irrigazione) ] (evapotraspirazione) ETP](/thumbs/50/27124498.jpg) Graziano Vittone - Luca Nari Venerdì 7 marzo 2014 L EVAPOTRASPIRAZIONE (ETP) Bilancio Idrico = [(pioggia utile) + (irrigazione) ] (evapotraspirazione) ETP ETP: quantità di acqua dispersa in atmosfera
Graziano Vittone - Luca Nari Venerdì 7 marzo 2014 L EVAPOTRASPIRAZIONE (ETP) Bilancio Idrico = [(pioggia utile) + (irrigazione) ] (evapotraspirazione) ETP ETP: quantità di acqua dispersa in atmosfera
ANALISI SPERIMENTALE PARAMETRICA SULL ASSORBIMENTO ACUSTICO DI RISONATORI ACUSTICI A CAVITÀ
 Associazione Italiana di Acustica 41 Convegno Nazionale Pisa, 17-19 giugno 214 ANALISI SPERIMENTALE PARAMETRICA SULL ASSORBIMENTO ACUSTICO DI RISONATORI ACUSTICI A CAVITÀ Paolo Ruggeri (1), Fabio Peron
Associazione Italiana di Acustica 41 Convegno Nazionale Pisa, 17-19 giugno 214 ANALISI SPERIMENTALE PARAMETRICA SULL ASSORBIMENTO ACUSTICO DI RISONATORI ACUSTICI A CAVITÀ Paolo Ruggeri (1), Fabio Peron
Inseritre prina coeptrina
 Inseritre prina coeptrina INDICE 1 - SCOPO... 3 2 - NORME DI RIFERIMENTO... 3 3 ASSUNZIONI... 3 4 - DATI NOMINALI DI IMPIANTO... 3 5 - CARATTERISTICHE DEL CAVO DI MEDIA TENSIONE... 4 6 - DIMENSIONAMENTO
Inseritre prina coeptrina INDICE 1 - SCOPO... 3 2 - NORME DI RIFERIMENTO... 3 3 ASSUNZIONI... 3 4 - DATI NOMINALI DI IMPIANTO... 3 5 - CARATTERISTICHE DEL CAVO DI MEDIA TENSIONE... 4 6 - DIMENSIONAMENTO
Corso di Microonde Esercizi su Linee di Trasmissione
 Corso di Microonde Esercizi su Linee di Trasmissione Tema del 6.7.1999 Il carico resistivo R L è alimentato alla frequenza f =3GHz attraverso una linea principale di impedenza caratteristica Z 0 = 50 Ω
Corso di Microonde Esercizi su Linee di Trasmissione Tema del 6.7.1999 Il carico resistivo R L è alimentato alla frequenza f =3GHz attraverso una linea principale di impedenza caratteristica Z 0 = 50 Ω
L irraggiamento termico
 L irraggiamento termico Trasmissione del Calore - 42 Il calore può essere fornito anche mediante energia elettromagnetica; ciò accade perché quando un fotone, associato ad una lunghezza d onda compresa
L irraggiamento termico Trasmissione del Calore - 42 Il calore può essere fornito anche mediante energia elettromagnetica; ciò accade perché quando un fotone, associato ad una lunghezza d onda compresa
Indicazioni sulla gestione dell irrigazione con l ausilio di sensori. S. Anconelli
 Indicazioni sulla gestione dell irrigazione con l ausilio di sensori S. Anconelli 23/02/2015 L acqua nel terreno C.I.M. macroprori e micropori pieni d acqua 25-45% V C.I.C. Solo micropori pieni d acqua
Indicazioni sulla gestione dell irrigazione con l ausilio di sensori S. Anconelli 23/02/2015 L acqua nel terreno C.I.M. macroprori e micropori pieni d acqua 25-45% V C.I.C. Solo micropori pieni d acqua
1.5 Calcolo di erenziale vettoriale Derivata ordinaria Gradiente Esempio n. 3 - Gradiente di 1
 Indice 1 ANALISI VETTORIALE 1 1.1 Scalari e vettori......................... 1 1.1.1 Vettore unitario (versore)............... 2 1.2 Algebra dei vettori....................... 3 1.2.1 Somma di due vettori.................
Indice 1 ANALISI VETTORIALE 1 1.1 Scalari e vettori......................... 1 1.1.1 Vettore unitario (versore)............... 2 1.2 Algebra dei vettori....................... 3 1.2.1 Somma di due vettori.................
VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA
 Associazione Italiana di Acustica 38 Convegno Nazionale Rimini, 08-10 giugno 2011 VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA Paolo
Associazione Italiana di Acustica 38 Convegno Nazionale Rimini, 08-10 giugno 2011 VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA Paolo
Lezione 4 GEOTECNICA. Docente: Ing. Giusy Mitaritonna
 Lezione 4 GEOTECNICA Docente: Ing. Giusy Mitaritonna e-mail: g.mitaritonna@poliba.it - Lezione 4 A. Cenni sul moto di filtrazione nelle terre B. Tensioni efficaci in presenza di forze di filtrazione C.
Lezione 4 GEOTECNICA Docente: Ing. Giusy Mitaritonna e-mail: g.mitaritonna@poliba.it - Lezione 4 A. Cenni sul moto di filtrazione nelle terre B. Tensioni efficaci in presenza di forze di filtrazione C.
Interazione tra strumenti e sistemi in misura: effetto di carico
 Corso di Laurea a distanza in INGEGNERIA ELETTRONICA Sede di Torino - A.A. 2005/2006 Modulo: Misure Elettroniche II (05EKCcm) Esercitazioni di Laboratorio Alessio Carullo 27 luglio 2006 Interazione tra
Corso di Laurea a distanza in INGEGNERIA ELETTRONICA Sede di Torino - A.A. 2005/2006 Modulo: Misure Elettroniche II (05EKCcm) Esercitazioni di Laboratorio Alessio Carullo 27 luglio 2006 Interazione tra
Mezzi non omogenei. Corso di Microonde I A.A. 2004/2005
 Mezzi non omogenei Nelle microonde si usano spesso mezzi trasmissivi non omogenei; Lo studio di questi mezzi viene ricondotto al caso equivalente TEM mediante la definizione di opportuni parametri caratteristici;
Mezzi non omogenei Nelle microonde si usano spesso mezzi trasmissivi non omogenei; Lo studio di questi mezzi viene ricondotto al caso equivalente TEM mediante la definizione di opportuni parametri caratteristici;
ESERCIZIO PRELIMINARE
 ESERCIZIO PRELIMINARE Prima di cominciare le misure, svolgere quanto indicato sotto e poi verificare con il docente le conclusioni. Sulla carta di Smith, la misura di un componente concentrato ha l andamento
ESERCIZIO PRELIMINARE Prima di cominciare le misure, svolgere quanto indicato sotto e poi verificare con il docente le conclusioni. Sulla carta di Smith, la misura di un componente concentrato ha l andamento
Programma di addestramento raccomandato per l esame con Correnti Indotte di 2 livello secondo EN 473
 Programma di addestramento raccomandato per l esame con Correnti Indotte di 2 livello secondo EN 473 0 0 0 Parte 1 - Principi del controllo con correnti indotte 1.1 Scopo e limitazioni del metodo di controllo
Programma di addestramento raccomandato per l esame con Correnti Indotte di 2 livello secondo EN 473 0 0 0 Parte 1 - Principi del controllo con correnti indotte 1.1 Scopo e limitazioni del metodo di controllo
Realizzazione del prototipo di un modulo a microonde per misure non invasive
 Progetto SP1a Nuove tecnologie per l analisi non intrusiva dei manufatti Programma di ricerca Ingegnerizzazione di prototipi e strumentazione per la diagnostica su manufatti monumentali in materiale lapideo
Progetto SP1a Nuove tecnologie per l analisi non intrusiva dei manufatti Programma di ricerca Ingegnerizzazione di prototipi e strumentazione per la diagnostica su manufatti monumentali in materiale lapideo
MISURA DELLE FREQUENZE DI RISONANZA DI UN TUBO SONORO
 MISURA DELLE FREQUENZE DI RISONANZA DI UN TUBO SONORO Scopo dell esperienza è lo studio della propagazione delle onde sonore all interno di un tubo, aperto o chiuso, contenete aria o altri gas. Si verificherà
MISURA DELLE FREQUENZE DI RISONANZA DI UN TUBO SONORO Scopo dell esperienza è lo studio della propagazione delle onde sonore all interno di un tubo, aperto o chiuso, contenete aria o altri gas. Si verificherà
L INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. V Scientifico Prof.ssa Delfino M. G.
 L INDUZIONE ELETTROMAGNETICA V Scientifico Prof.ssa Delfino M. G. INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 1. Il flusso del vettore B 2. La legge di Faraday-Neumann-Lenz 3. Induttanza e autoinduzione 4. I circuiti
L INDUZIONE ELETTROMAGNETICA V Scientifico Prof.ssa Delfino M. G. INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 1. Il flusso del vettore B 2. La legge di Faraday-Neumann-Lenz 3. Induttanza e autoinduzione 4. I circuiti
Programma di addestramento raccomandato per l esame di Ultrasuoni di 2 livello secondo EN 473
 Programma di addestramento raccomandato per l esame di Ultrasuoni di 2 livello secondo EN 473 0 0 0 Parte 1. Principi del controllo ultrasonoro 1.1 Scopo e limitazioni del metodo di controllo mediante
Programma di addestramento raccomandato per l esame di Ultrasuoni di 2 livello secondo EN 473 0 0 0 Parte 1. Principi del controllo ultrasonoro 1.1 Scopo e limitazioni del metodo di controllo mediante
Onde sonore stazionarie in un tubo risonante
 Onde sonore stazionarie in un tubo risonante Scopo dell esperimento Determinare la velocità del suono analizzando le caratteristiche delle onde sonore stazionarie in un tubo risonante. Richiamo teorico
Onde sonore stazionarie in un tubo risonante Scopo dell esperimento Determinare la velocità del suono analizzando le caratteristiche delle onde sonore stazionarie in un tubo risonante. Richiamo teorico
RIFASAMENTO DEI CARICHI
 RIFASAMENTO DEI CARICHI GENERALITÀ Nei circuiti in corrente alternata la potenza assorbita da un carico può essere rappresentata da due componenti: la componente attiva P che è direttamente correlata al
RIFASAMENTO DEI CARICHI GENERALITÀ Nei circuiti in corrente alternata la potenza assorbita da un carico può essere rappresentata da due componenti: la componente attiva P che è direttamente correlata al
Fisica Generale II (prima parte)
 Corso di Laurea in Ing. Medica Fisica Generale II (prima parte) Cognome Nome n. matricola Voto 4.2.2011 Esercizio n.1 Determinare il campo elettrico in modulo direzione e verso generato nel punto O dalle
Corso di Laurea in Ing. Medica Fisica Generale II (prima parte) Cognome Nome n. matricola Voto 4.2.2011 Esercizio n.1 Determinare il campo elettrico in modulo direzione e verso generato nel punto O dalle
Cavo Carbonio. Sergio Rubio Carles Paul Albert Monte
 Cavo o Sergio Rubio Carles Paul Albert Monte o, Rame e Manganina PROPRIETÀ FISICHE PROPRIETÀ DEL CARBONIO Proprietà fisiche del o o Coefficiente di Temperatura α o -0,0005 ºC -1 o Densità D o 2260 kg/m
Cavo o Sergio Rubio Carles Paul Albert Monte o, Rame e Manganina PROPRIETÀ FISICHE PROPRIETÀ DEL CARBONIO Proprietà fisiche del o o Coefficiente di Temperatura α o -0,0005 ºC -1 o Densità D o 2260 kg/m
Applicazioni. Rete di monitoraggio idropluviometrica:verifica e taratura
 ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA REGIONE TOSCANA E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ATTIVITA DI RICERCA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA REGIONE TOSCANA E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ATTIVITA DI RICERCA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Meccanica delle Terre Geotecnica Prova scritta di esame
 # 1 Con riferimento allo schema mostrato di seguito: - calcolare la tensione verticale totale, la pressione interstiziale e la tensione verticale efficace alle profondità indicate dai punti A, B, C, D,
# 1 Con riferimento allo schema mostrato di seguito: - calcolare la tensione verticale totale, la pressione interstiziale e la tensione verticale efficace alle profondità indicate dai punti A, B, C, D,
Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale
 Università degli Studi di Catania Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale Corso di TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA A.A. 20015/2016 Prof. Ing. Giuseppe
Università degli Studi di Catania Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale Corso di TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA A.A. 20015/2016 Prof. Ing. Giuseppe
Comportamento termico dei conduttori percorsi da sovracorrenti 1/38
 Comportamento termico dei conduttori percorsi da sovracorrenti 1/38 Portata di un cavo a) Il conduttore. b) L isolante. c) La portata I z. /38 Il conduttore Un conduttore percorso da corrente assume una
Comportamento termico dei conduttori percorsi da sovracorrenti 1/38 Portata di un cavo a) Il conduttore. b) L isolante. c) La portata I z. /38 Il conduttore Un conduttore percorso da corrente assume una
60 o e. E i. ε 2. ε 1. acqua marina A B I ONDE PIANE E MATERIALI
 I ONDE PIANE E MATERIALI OP 1 Il campo elettrico nel punto A ha un modulo di 1V/m e forma un angolo di 6 o con la normale alla superficie. Calcolare e(b). ε 1 ε 2 A B 6 o e ε 1 =, ε 2 = 2 Nel punto A le
I ONDE PIANE E MATERIALI OP 1 Il campo elettrico nel punto A ha un modulo di 1V/m e forma un angolo di 6 o con la normale alla superficie. Calcolare e(b). ε 1 ε 2 A B 6 o e ε 1 =, ε 2 = 2 Nel punto A le
Argomenti per esame orale di Fisica Generale (Elettromagnetismo) 9 CFU A.A. 2012/2013
 Argomenti per esame orale di Fisica Generale (Elettromagnetismo) 9 CFU A.A. 2012/2013 1. Il campo elettrico e legge di Coulomb: esempio del calcolo generato da alcune semplici distribuzioni. 2. Il campo
Argomenti per esame orale di Fisica Generale (Elettromagnetismo) 9 CFU A.A. 2012/2013 1. Il campo elettrico e legge di Coulomb: esempio del calcolo generato da alcune semplici distribuzioni. 2. Il campo
La granulometria nella scienza del suolo: nuove tecniche di misura per nuovi scenari. I metodi di misura. dr. Roberto De Mascellis
 La granulometria nella scienza del suolo: nuove tecniche di misura per nuovi scenari I metodi di misura dr. Roberto De Mascellis Reologia Industria farmaceutica Analisi granulometrica di particelle Industria
La granulometria nella scienza del suolo: nuove tecniche di misura per nuovi scenari I metodi di misura dr. Roberto De Mascellis Reologia Industria farmaceutica Analisi granulometrica di particelle Industria
1^ LEGGE di OHM - CONDUTTORI in SERIE e in PARALLELO
 ^ LEGGE di OHM - CONDUTTOI in SEIE e in PAALLELO attività svolta con le classi 3^D e 3^G - as 2009/0 Scopo dell esperienza Le finalità dell esperimento sono: ) Verificare la relazione tra la ddp ai capi
^ LEGGE di OHM - CONDUTTOI in SEIE e in PAALLELO attività svolta con le classi 3^D e 3^G - as 2009/0 Scopo dell esperienza Le finalità dell esperimento sono: ) Verificare la relazione tra la ddp ai capi
Metodologie Elettromagnetiche per la geofisica. Proprietà elettromagnetiche di suoli e rocce (II)
 Metodologie Elettromagnetiche per la geofisica Proprietà elettromagnetiche di suoli e rocce (II) Anno Accademico 2009/2010 Docente:Elena Pettinelli Dielettrici e conduttori σ s ε e = ε + ω σ è la conducibilità
Metodologie Elettromagnetiche per la geofisica Proprietà elettromagnetiche di suoli e rocce (II) Anno Accademico 2009/2010 Docente:Elena Pettinelli Dielettrici e conduttori σ s ε e = ε + ω σ è la conducibilità
Circuito RC con d.d.p. sinusoidale
 Circuito C con d.d.p. sinusoidale Un circuito C-serie ha la seguente configurazione: G è la resistenza interna del generatore. Misura dello sfasamento della tensione ai capi del condensatore rispetto alla
Circuito C con d.d.p. sinusoidale Un circuito C-serie ha la seguente configurazione: G è la resistenza interna del generatore. Misura dello sfasamento della tensione ai capi del condensatore rispetto alla
Esercizi di magnetismo
 Esercizi di magnetismo Fisica II a.a. 2003-2004 Lezione 16 Giugno 2004 1 Un riassunto sulle dimensioni fisiche e unità di misura l unità di misura di B è il Tesla : definisce le dimensioni [ B ] = [m]
Esercizi di magnetismo Fisica II a.a. 2003-2004 Lezione 16 Giugno 2004 1 Un riassunto sulle dimensioni fisiche e unità di misura l unità di misura di B è il Tesla : definisce le dimensioni [ B ] = [m]
05. Errore campionario e numerosità campionaria
 Statistica per le ricerche di mercato A.A. 01/13 05. Errore campionario e numerosità campionaria Gli schemi di campionamento condividono lo stesso principio di fondo: rappresentare il più fedelmente possibile,
Statistica per le ricerche di mercato A.A. 01/13 05. Errore campionario e numerosità campionaria Gli schemi di campionamento condividono lo stesso principio di fondo: rappresentare il più fedelmente possibile,
Esercitazione 1. Invece, essendo il mezzo omogeneo, il vettore sarà espresso come segue
 1.1 Una sfera conduttrice di raggio R 1 = 10 cm ha una carica Q = 10-6 C ed è circondata da uno strato sferico di dielettrico di raggio (esterno) R 2 = 20 cm e costante dielettrica relativa. Determinare
1.1 Una sfera conduttrice di raggio R 1 = 10 cm ha una carica Q = 10-6 C ed è circondata da uno strato sferico di dielettrico di raggio (esterno) R 2 = 20 cm e costante dielettrica relativa. Determinare
Misure piezometriche. Installazione: in foro di sondaggio o infissi da superficie
 Misure piezometriche Attrezzatura Piezometri idraulici a tubo aperto misura della quota piezometrica h Celle piezometriche misura della pressione neutra u Installazione: in foro di sondaggio o infissi
Misure piezometriche Attrezzatura Piezometri idraulici a tubo aperto misura della quota piezometrica h Celle piezometriche misura della pressione neutra u Installazione: in foro di sondaggio o infissi
su USB key esterna Memoria per i dati misurati valori su memoria interna Funzione Comparatore
 I modelli proposti Ponti LCR IM3533/01 IM3533 IM3523 IM3570 Settori di utilizzo Ricerca & Sviluppo, Linea di Produzione, Controllo Qualità Applicazione tipica Oggetto in prova (tipico) Caratterizzazione
I modelli proposti Ponti LCR IM3533/01 IM3533 IM3523 IM3570 Settori di utilizzo Ricerca & Sviluppo, Linea di Produzione, Controllo Qualità Applicazione tipica Oggetto in prova (tipico) Caratterizzazione
Università di Roma Tor Vergata
 Università di Roma or Vergata Facoltà di Ingegneria Dipartimento di Ingegneria Industriale Corso di: ERMOECNICA RASMISSIONE DEL CALORE: Conduzione Ing. G. Bovesecchi gianluigi.bovesecchi@gmail.com 06-759-77
Università di Roma or Vergata Facoltà di Ingegneria Dipartimento di Ingegneria Industriale Corso di: ERMOECNICA RASMISSIONE DEL CALORE: Conduzione Ing. G. Bovesecchi gianluigi.bovesecchi@gmail.com 06-759-77
CAP. VIII CRITERI DI PROGETTAZIONE E VERIFICA DI COMPONENTI REALI
 CAP. III CRITERI DI PROGETTAZIONE E ERIFICA DI COMPONENTI REALI III. Circuiti equivalenti di resistori, condensatori ed induttori reali (vedi nota a parte) III. Progetto di resistori a) progetto di una
CAP. III CRITERI DI PROGETTAZIONE E ERIFICA DI COMPONENTI REALI III. Circuiti equivalenti di resistori, condensatori ed induttori reali (vedi nota a parte) III. Progetto di resistori a) progetto di una
ing. Patrizia Ferrara I Condensatori
 I Condensatori Definizione Il condensatore è un componente elettrico caratterizzato da un ben determinato valore di capacità Struttura I condensatori sono in genere strutturati da 2 superfici parallele
I Condensatori Definizione Il condensatore è un componente elettrico caratterizzato da un ben determinato valore di capacità Struttura I condensatori sono in genere strutturati da 2 superfici parallele
Spettri e banda passante
 Banda passante - Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Controlli Automatici L Spettri e banda passante DEIS-Università di Bologna Tel. 5 2932 Email: crossi@deis.unibo.it URL: www-lar.deis.unibo.it/~crossi
Banda passante - Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Controlli Automatici L Spettri e banda passante DEIS-Università di Bologna Tel. 5 2932 Email: crossi@deis.unibo.it URL: www-lar.deis.unibo.it/~crossi
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE (8015) CORSO: PRINCIPI DI MECCANICA DELLE TERRE E DELLE ROCCE L ACQUA NEL MEZZO POROSO.
 CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE (8015) CORSO: PRINCIPI DI MECCANICA DELLE TERRE E DELLE ROCCE L ACQUA NEL MEZZO POROSO Docente: Alessandro Gargini (E-mail: alessandro.gargini@unibo.it)
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE (8015) CORSO: PRINCIPI DI MECCANICA DELLE TERRE E DELLE ROCCE L ACQUA NEL MEZZO POROSO Docente: Alessandro Gargini (E-mail: alessandro.gargini@unibo.it)
Amplificatori in classe A con accoppiamento capacitivo
 Ottobre 00 Amplificatori in classe A con accoppiamento capacitivo amplificatore in classe A di Fig. presenta lo svantaggio che il carico è percorso sia dalla componente di segnale, variabile nel tempo,
Ottobre 00 Amplificatori in classe A con accoppiamento capacitivo amplificatore in classe A di Fig. presenta lo svantaggio che il carico è percorso sia dalla componente di segnale, variabile nel tempo,
Micro Electro Mechanical Systems RF MEMS Switches Modello Elettromagnetico
 Micro Electro Mechanical Systems RF MEMS Switches Modello Elettromagnetico Augusto Tazzoli E-Mail: augusto.tazzoli@dei.unipd.it Tel: 049 827 7664 DEI Department of Information Engineering University of
Micro Electro Mechanical Systems RF MEMS Switches Modello Elettromagnetico Augusto Tazzoli E-Mail: augusto.tazzoli@dei.unipd.it Tel: 049 827 7664 DEI Department of Information Engineering University of
Cenni sulla struttura della materia
 Cenni sulla struttura della materia Tutta la materia è costituita da uno o più costituenti fondamentali detti elementi Esistono 102 elementi, di cui 92 si trovano in natura (i rimanenti sono creati in
Cenni sulla struttura della materia Tutta la materia è costituita da uno o più costituenti fondamentali detti elementi Esistono 102 elementi, di cui 92 si trovano in natura (i rimanenti sono creati in
Misure su linee di trasmissione
 Appendice A A-1 A-2 APPENDICE A. Misure su linee di trasmissione 1) Misurare, in trasmissione o in riflessione, la lunghezza elettrica TL della linea. 2) Dal valore di TL e dalla lunghezza geometrica calcolare
Appendice A A-1 A-2 APPENDICE A. Misure su linee di trasmissione 1) Misurare, in trasmissione o in riflessione, la lunghezza elettrica TL della linea. 2) Dal valore di TL e dalla lunghezza geometrica calcolare
Misure di pressione. Lab di rivelatori LS. Tecnologia del vuoto sistemi di pompaggio(ciullo G.)
 Misure di pressione Misura diretta Misura indiretta Misura diretta Manometri capacitivi Baratron Piezo Membranovac Diaframma capacitivo: لا Misuratori tra i più precisi esistenti sul mercato 0.15.%» 1100-10
Misure di pressione Misura diretta Misura indiretta Misura diretta Manometri capacitivi Baratron Piezo Membranovac Diaframma capacitivo: لا Misuratori tra i più precisi esistenti sul mercato 0.15.%» 1100-10
Il comportamento di un amplificatore ideale, ad esempio di tensione, è descritto dalla relazione lineare V out = A V in (3.1)
 Capitolo 3 Amplificazione 3.1 Circuiti attivi Gli elementi circuitali considerati sino ad ora, sia lineari (resistenze, capacità, induttanze e generatori indipendenti), sia non lineari (diodi), sono detti
Capitolo 3 Amplificazione 3.1 Circuiti attivi Gli elementi circuitali considerati sino ad ora, sia lineari (resistenze, capacità, induttanze e generatori indipendenti), sia non lineari (diodi), sono detti
Capitolo Descrizione tecnica del sensore MAF a filo caldo
 Capitolo 2 2.1 Descrizione tecnica del sensore MAF a filo caldo Come anticipato nel paragrafo 1.3.3, verrà ora analizzato in maniera più approfondita il principio di funzionamento del sensore MAF, con
Capitolo 2 2.1 Descrizione tecnica del sensore MAF a filo caldo Come anticipato nel paragrafo 1.3.3, verrà ora analizzato in maniera più approfondita il principio di funzionamento del sensore MAF, con
Taratura dei dati sismici con pozzi
 Taratura dei dati sismici con pozzi I dati di pozzo, qualora disponibili, sono di fondamentale interesse per la taratura di sommità e base di una sequenza stratigrafica (unconformities e relativa durata
Taratura dei dati sismici con pozzi I dati di pozzo, qualora disponibili, sono di fondamentale interesse per la taratura di sommità e base di una sequenza stratigrafica (unconformities e relativa durata
Un materiale si definisce un buon conduttore se la sua conducibilità σ soddisfa a
 1 BUON CONDUTTORE Un materiale si definisce un buon conduttore se la sua conducibilità σ soddisfa a σ ωε (1). Mentre in un materiale con conducibilità infinita il campo deve essere nullo, la presenza di
1 BUON CONDUTTORE Un materiale si definisce un buon conduttore se la sua conducibilità σ soddisfa a σ ωε (1). Mentre in un materiale con conducibilità infinita il campo deve essere nullo, la presenza di
La taratura dei radiometri solari effettuata dal Laboratorio di Ottica di ARPA Piemonte:metodo e risultati
 VI Convegno nazionale Il Controllo degli Agenti fisici: ambiente, salute e qualità della vita Alessandria 6-8 giugno 2016 La taratura dei radiometri solari effettuata dal Laboratorio di Ottica di ARPA
VI Convegno nazionale Il Controllo degli Agenti fisici: ambiente, salute e qualità della vita Alessandria 6-8 giugno 2016 La taratura dei radiometri solari effettuata dal Laboratorio di Ottica di ARPA
DEIS ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
 ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Campi a basse e alte frequenze per la valutazione dei livelli di esposizione Vengono considerati in modo del tutto distinto i campi elettrici e magnetici a bassa frequenza
ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Campi a basse e alte frequenze per la valutazione dei livelli di esposizione Vengono considerati in modo del tutto distinto i campi elettrici e magnetici a bassa frequenza
Gli schemi circuitali impiegati per la realizzazione dei convertitori statici sono molteplici.
 Gli schemi circuitali impiegati per la realizzazione dei convertitori statici sono molteplici. Infatti, la struttura del convertitore risulta fortemente influenzata: dal tipo di sorgente primaria di alimentazione;
Gli schemi circuitali impiegati per la realizzazione dei convertitori statici sono molteplici. Infatti, la struttura del convertitore risulta fortemente influenzata: dal tipo di sorgente primaria di alimentazione;
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
 EFFETTI DI SITO DELLA PIANA DEL FUCINO attraverso lo studio comparato di dati sismici e geologici. D. Famiani 1, F. Cara 2, G. Di Giulio 2, G. Milana 2,G. Cultrera 2, P. Bordoni 2, G.P. Cavinato 3 1 Dipartimento
EFFETTI DI SITO DELLA PIANA DEL FUCINO attraverso lo studio comparato di dati sismici e geologici. D. Famiani 1, F. Cara 2, G. Di Giulio 2, G. Milana 2,G. Cultrera 2, P. Bordoni 2, G.P. Cavinato 3 1 Dipartimento
Funzione del suolo (entità dinamica di natura fisico-chimica e biologica)
 Funzione del suolo (entità dinamica di natura fisico-chimica e biologica) Rottura della componente merobiotica Fertilità Copyright 20010 Università di Sassari Conduzione e Flusso di Calore nel Suolo Perché
Funzione del suolo (entità dinamica di natura fisico-chimica e biologica) Rottura della componente merobiotica Fertilità Copyright 20010 Università di Sassari Conduzione e Flusso di Calore nel Suolo Perché
Università IUAV di Venezia corso : Fondamenti di Geotecnica a.a
 Università IUAV di Venezia corso : Fondamenti di Geotecnica a.a. 2016-17 17 Progettazione GEOTECNICA Progetto e realizzazione: - delle opere di fondazione; - delle opere di sostegno; - delle opere in sotterraneo;
Università IUAV di Venezia corso : Fondamenti di Geotecnica a.a. 2016-17 17 Progettazione GEOTECNICA Progetto e realizzazione: - delle opere di fondazione; - delle opere di sostegno; - delle opere in sotterraneo;
La sonda compensata. La sonda compensata
 1/6 1 Introduzione La seguente esercitazione di laboratorio affronta il problema di realizzare una sonda compensata per un cavo di 50 m con capacità distribuita di circa 100 pf/m. 2 Tempo di salita di
1/6 1 Introduzione La seguente esercitazione di laboratorio affronta il problema di realizzare una sonda compensata per un cavo di 50 m con capacità distribuita di circa 100 pf/m. 2 Tempo di salita di
R = 2.2 kω / 100 kω Tensione di alimentazione picco-picco ε = 2 V (R int = 600 Ω)
 Strumentazione: oscilloscopio, generatore di forme d onda (utilizzato con onde sinusoidali), 2 sonde, basetta, componenti R,L,C Circuito da realizzare: L = 2 H (±10%) con resistenza in continua di R L
Strumentazione: oscilloscopio, generatore di forme d onda (utilizzato con onde sinusoidali), 2 sonde, basetta, componenti R,L,C Circuito da realizzare: L = 2 H (±10%) con resistenza in continua di R L
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO FACOLTA DI INGEGNERIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO FACOLTA DI INGEGNERIA TESI DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI STUDIO E SIMULAZIONE DI ANTENNE STAMPATE RELATORE: Prof. Marco Donald Migliore CORRELATORE:
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO FACOLTA DI INGEGNERIA TESI DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI STUDIO E SIMULAZIONE DI ANTENNE STAMPATE RELATORE: Prof. Marco Donald Migliore CORRELATORE:
PROVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITÀ
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA FACOLTÀ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE PROVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITÀ SALVATORE GRASSO CORSO DI GEOTECNICA Catania, Maggio
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA FACOLTÀ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE PROVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITÀ SALVATORE GRASSO CORSO DI GEOTECNICA Catania, Maggio
Formulario Elettromagnetismo
 Formulario Elettromagnetismo. Elettrostatica Legge di Coulomb: F = q q 2 u 4 0 r 2 Forza elettrostatica tra due cariche puntiformi; ε 0 = costante dielettrica del vuoto; q = cariche (in C); r = distanza
Formulario Elettromagnetismo. Elettrostatica Legge di Coulomb: F = q q 2 u 4 0 r 2 Forza elettrostatica tra due cariche puntiformi; ε 0 = costante dielettrica del vuoto; q = cariche (in C); r = distanza
5.4 Caratterizzazione in regime quasi statico e ad elevata velocità di deformazione di un acciaio per applicazione Oil and Gas
 5.4 Caratterizzazione in regime quasi statico e ad elevata velocità di deformazione di un acciaio per applicazione Oil and Gas Si riportano in questa sezione i risultati relativi ai test sperimentali effettuati
5.4 Caratterizzazione in regime quasi statico e ad elevata velocità di deformazione di un acciaio per applicazione Oil and Gas Si riportano in questa sezione i risultati relativi ai test sperimentali effettuati
Onde acustiche in un tubo di Kundt
 1 Onde acustiche in un tubo di Kundt [Caravita Ruggero, 727965, ruggero.caravita@rcm.inet.it] Onde acustiche in un tubo di Kundt Relazione sperimentale Scopo dell esperienza è la misura della velocità
1 Onde acustiche in un tubo di Kundt [Caravita Ruggero, 727965, ruggero.caravita@rcm.inet.it] Onde acustiche in un tubo di Kundt Relazione sperimentale Scopo dell esperienza è la misura della velocità
Convezione Conduzione Irraggiamento
 Sommario Cenni alla Termomeccanica dei Continui 1 Cenni alla Termomeccanica dei Continui Dai sistemi discreti ai sistemi continui: equilibrio locale Deviazioni dalle condizioni di equilibrio locale Irreversibilità
Sommario Cenni alla Termomeccanica dei Continui 1 Cenni alla Termomeccanica dei Continui Dai sistemi discreti ai sistemi continui: equilibrio locale Deviazioni dalle condizioni di equilibrio locale Irreversibilità
Specifica tecnica delle attività Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d acqua del bacino del fiume Po
 Specifica tecnica delle attività Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d acqua del bacino del fiume Po Specifica per le indagini e le prove geotecniche per la caratterizzazione degli
Specifica tecnica delle attività Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d acqua del bacino del fiume Po Specifica per le indagini e le prove geotecniche per la caratterizzazione degli
Motori Motore passo-passo Stadio di potenza PWM Sincrono Stadio di potenza del motore passopasso. Blocchi funzionali. Set point e generatore PWM
 RC1 Blocchi funzionai Motori a corrente continua Generatori Circuiti per il controllo dei motori in CC Motori a corrente alternata Circuiti per il controllo dei motori in CA Motori passo-passo Circuiti
RC1 Blocchi funzionai Motori a corrente continua Generatori Circuiti per il controllo dei motori in CC Motori a corrente alternata Circuiti per il controllo dei motori in CA Motori passo-passo Circuiti
STIMA INCERTEZZA CONDUCIBILITA
 Pagina 1 di 6 REVISIONE NUMERO DATA REDATTA DA DIR (firma) VERIFICATA DA RAQ (firma) APPROVATA DA AMM (firma) PARAGRAFO REVISIONATO NUMERO 00 07/.2/13 / / MOTIVO Pagina 2 di 6 INDICE DELLA PROCEDURA 1.
Pagina 1 di 6 REVISIONE NUMERO DATA REDATTA DA DIR (firma) VERIFICATA DA RAQ (firma) APPROVATA DA AMM (firma) PARAGRAFO REVISIONATO NUMERO 00 07/.2/13 / / MOTIVO Pagina 2 di 6 INDICE DELLA PROCEDURA 1.
POLITECNICO DI TORINO SEDE DI ALESSANDRIA RAPPORTO DI PROVA
 LABORATORIO DI INGEGNERIA ELETTRICA DOC. TR 09-18 LIE PAG. 1/18 POLITECNICO DI TORINO SEDE DI ALESSANDRIA Documento TR 09-18 LIE Data di emissione: 28/06/2010 Prove di compatibilità elettromagnetica Norme
LABORATORIO DI INGEGNERIA ELETTRICA DOC. TR 09-18 LIE PAG. 1/18 POLITECNICO DI TORINO SEDE DI ALESSANDRIA Documento TR 09-18 LIE Data di emissione: 28/06/2010 Prove di compatibilità elettromagnetica Norme
Università del Salento Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Industriale Secondo esonero di FISICA GENERALE 2 del 16/01/15
 Università del Salento Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Industriale Secondo esonero di FISICA GENERALE 2 del 16/01/15 Esercizio 1 (7 punti): Nella regione di spazio compresa tra due cilindri coassiali
Università del Salento Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Industriale Secondo esonero di FISICA GENERALE 2 del 16/01/15 Esercizio 1 (7 punti): Nella regione di spazio compresa tra due cilindri coassiali
ELETTROTECNICA (10 CFU) CS INGEGNERIA MATEMATICA I
 ELETTOTECNICA (0 CFU) CS INGEGNEIA MATEMATICA I prova in itinere 20 Novembre 2009 SOLUZIONI - - D. (punti 4 ) ) Spiegare cosa si intende per DUALITA nello studio dei circuiti elettrici. 2) Scrivere per
ELETTOTECNICA (0 CFU) CS INGEGNEIA MATEMATICA I prova in itinere 20 Novembre 2009 SOLUZIONI - - D. (punti 4 ) ) Spiegare cosa si intende per DUALITA nello studio dei circuiti elettrici. 2) Scrivere per
