Indice. Volume 1 Microbiologia generale
|
|
|
- Valentina Righi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Romane :09 Pagina v Prefazione all edizione americana x Gli autori xii Prefazione all edizione italiana xiii La mappa dei contenuti xiv Presentazione di questo volume xvii Guida al testo xix Volume 1 Microbiologia generale 1 Storia e scopo della microbiologia La scoperta dei microrganismi La disputa sulla generazione spontanea Il ruolo dei microrganismi nelle malattie 6 Tecniche e applicazioni 1.1: Il metodo scientifico 7 Malattie 1.2: I postulati di Koch in chiave molecolare Microbiologia industriale ed ecologia microbica I membri del mondo microbico Scopo e importanza della microbiologia Il futuro della microbiologia 13 2 Lo studio della struttura microbica: le tecniche di microscopia e l allestimento dei campioni biologici Le lenti e la deviazione della luce Il microscopio ottico Preparazione e colorazione dei campioni Microscopia elettronica Nuove tecniche di microscopia 31 3 Struttura e funzione della cellula procariotica La struttura della cellula procariotica: quadro generale 35 Diversità ed ecologia microbica 3.1: Microbi mostruosamente grandi Le membrane cellulari dei procarioti La matrice citoplasmatica 44 Diversità ed ecologia microbica 3.2: Magneti viventi Il nucleoide I plasmidi La parete cellulare batterica Pareti cellulari degli Archea Secrezione proteica nei procarioti Componenti esterni alla parete cellulare La chemiotassi L endospora batterica 71 4 La nutrizione microbica Le richieste nutrizionali comuni Le richieste di carbonio, idrogeno e ossigeno Tipi nutrizionali dei microrganismi Le richieste di azoto, fosforo e zolfo I fattori di crescita L assunzione di nutrienti da parte della cellula Terreni di coltura 84 Nota storica 4.1: La scoperta dell agar come agente solidificante e della tecnica per isolare colture pure L isolamento di colture pure 86 Tecniche e applicazioni 4.2: Arricchimento e isolamento di colture pure 88 5 La crescita microbica Il ciclo cellulare degli organismi procarioti La curva di crescita Misurazione della crescita microbica La coltura continua di microrganismi Influenza dei fattori ambientali sulla crescita microbica La crescita microbica negli ambienti naturali Controllo dei microrganismi mediante agenti fisici e chimici Definizione di termini usati di frequente 123 Tecniche e applicazioni 6.1: La sicurezza nel laboratorio di microbiologia La curva di mortalità microbica Le condizioni che influenzano l efficacia di un agente antimicrobico Metodi di controllo fisici Agenti di controllo chimici 132 Tecniche e applicazioni 6.2: Norme precauzionali valide per i laboratori di microbiologia Valutazione dell efficacia degli agenti antimicrobici Il metabolismo: rilascio e conservazione dell energia Una visione d insieme del metabolismo La degradazione del glucosio ad acido piruvico Le fermentazioni 146 Nota storica 7.1: La microbiologia e la I Guerra Mondiale Il ciclo degli acidi tricarbossilici Il trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa La respirazione anaerobica Il catabolismo dei carboidrati e i polimeri di riserva intracellulari Il catabolismo dei lipidi Il catabolismo delle proteine e degli aminoacidi L ossidazione delle molecole inorganiche La fotosintesi 160 Diversità ed ecologia microbica 7.2: Gli scarichi acidi delle miniere 161
2 Romane :09 Pagina vi vi 8 Il metabolismo: l utilizzo dell energia nelle biosintesi I principi che governano le biosintesi 170 Tecniche e applicazioni 8.1: L identificazione delle vie anaboliche La fissazione fotosintetica di CO La sintesi di zuccheri e polisaccaridi L assimilazione di azoto, fosforo e zolfo inorganici La sintesi degli aminoacidi Le reazioni anaplerotiche La sintesi di purine, pirimidine e nucleotidi La sintesi dei lipidi Sintesi del peptidoglicano I meccanismi di formazione della parete cellulare Espressione genica La trascrizione del DNA ossia la sintesi dell RNA 189 Recenti sviluppi della microbiologia 9.1: L RNA catalitico (i ribozimi) La sintesi proteica La genetica dei microbi: la regolazione dell espressione genica I livelli di regolazione dell espressione genica La regolazione dell inizio della trascrizione 213 Nota storica 10.1: La scoperta della regolazione genica La regolazione dell allungamento della trascrizione La regolazione a livello della traduzione I sistemi di regolazione globale La regolazione dell espressione genica in Eucarya e Archaea Genetica microbica: meccanismi di alterazione genetica Le mutazioni e la loro base chimica Riconoscimento e isolamento dei mutanti Riparazione del DNA Come si origina la variabilità genetica Elementi trasponibili Plasmidi batterici Coniugazione batterica Trasformazione del DNA Trasduzione Mappatura del genoma Ricombinazione e mappatura dei genomi virali Genomica microbica Introduzione Determinazione delle sequenze di DNA Whole-genome shotgun sequencing Bioinformatica Caratteristiche generali dei genomi microbici Genomica funzionale Il futuro della genomica Genomica ambientale Virus: introduzione e caratteristiche generali Origine della virologia 302 Nota storica 13.1: Prime fasi della colonizzazione americana e diffusione di malattie Proprietà generali dei virus Coltivazione dei virus Purificazione dei virus e metodi di saggio Struttura dei virus Principi di tassonomia virale 317 Recenti sviluppi della microbiologia 13.2: Origine dei virus Virus: i batteriofagi Classificazione dei batteriofagi 319 Diversità ed ecologia microbica 14.1: Un mare di virus Riproduzione dei fagi dotati di DNA a doppio filamento: il ciclo litico Riproduzione dei fagi dotati di DNA a singolo filamento Riproduzione dei fagi a RNA Batteriofagi temperati e lisogenia I virus: rilascio e conservazione dell energia Classificazione dei virus animali Riproduzione dei virus animali 338 Tecniche e applicazioni 15.1: Costruzione di un virus Infezioni citocide e danno cellulare Infezioni virali persistenti, latenti e lente Virus e cancro Virus vegetali Virus dei funghi, delle alghe e dei protozoi Virus degli insetti Viroidi e prioni 355 Appendice A-1 Tassonomia e filogenesi dei microrganismi analitico I-1 Volume 2 Microbiologia sistematica, ecologica, industriale 16 Tassonomia e filogenesi dei microrganismi Introduzione generale e uno sguardo d insieme Evoluzione e diversità dei microrganismi Categorie tassonomiche (Taxa) Sistemi di classificazione Principali caratteri impiegati nella tassonomia Valutazione della filogenesi dei microrganismi Le principali divisioni degli organismi viventi Il Bergey s Manual of Systematic Bacteriology 18 Diversità ed ecologia microbica 16.1: Liste ufficiali di nomenclatura: una lettera dal Bergey s Uno sguardo d insieme alla filogenesi e alla diversità dei procarioti 23
3 Romane :09 Pagina vii vii 17 Gli Archebatteri Introduzione agli archebatteri Il phylum dei Crenarcheoti Il phylum dei Euriarcheoti 34 Diversità ed ecologia microbica 17.1: La filogenesi degli archebatteri: molto più che Crenarcheoti ed Euriarcheoti? 35 Diversità ed ecologia microbica 17.2: Archebatteri Metanotrofici I batteri: i deinococchi e i Gram-negativi non-proteobatteri Aquificae e Thermotogae Deinococcus-thermus I batteri fotosintetici 45 Diversità ed ecologia microbica 18.1: Il meccanismo della motilità strisciante Il phylum Planctomycetes Il phylum Clamydiae Il phylum Spirochaetes Il phylum Bacteroidetes I batteri: i proteobatteri La classe Alphaproteobacteria La classe Betaproteobacteria La classe Gammaproteobacteria 72 Diversità ed ecologia microbica 19.1: Bioluminescenza batterica La classe Deltaproteobacteria La classe Epsilonproteobacteria I batteri: i Gram-positivi con basso G + C Introduzione generale La classe Mollicutes (i micoplasmi) Struttura del peptidoglicano e delle endospore 92 Diversità ed ecologia microbica 20.1: Spore nello spazio La classe Clostridia La classe Bacilli I batteri: i Gram-positivi con alto G + C Caratteristiche generali degli attinomiceti Il sottordine Actinomycineae Il sottordine Micrococcineae Il sottordine Corynebacterineae Il sottordine Micromonosporineae Il sottordine Propionibacterinea Il sottordine Streptomycineae Il sottordine Streptosporangineae Il sottordine Frankineae L ordine Bifidobacteriales I protisti Distribuzione Nutrizione Morfologia Incistamento ed excistamento Riproduzione Classificazione dei protisti 123 Malattie 22.1: Fioriture algali tossiche (Harmful Algal Blooms HABs) 133 Tecniche e applicazioni 22.2: L importanza pratica delle diatomee I funghi (Eumycota) Distribuzione Importanza Struttura Nutrizione e metabolismo Riproduzione Caratteristiche delle divisioni fungine I cicli biogeochimici. Introduzione all ecologia microbica Fondamenti di diversità e di ecologia microbica 155 Diversità ed ecologia microbica 24.1: L ecologia microbica in confronto alla microbiologia ambientale I cicli biogeochimici L ambiente fisico L ecologia microbica e i suoi metodi: una panoramica I microrganismi negli ambienti marini e di acqua dolce Gli ambienti marini e di acqua dolce 177 Malattie 25.1: Nuovi agenti in medicina. Il mare come nuova frontiera Gli adattamenti microbici agli ambienti marini e di acqua dolce I microrganismi negli ambienti marini Microrganismi negli ambienti di acqua dolce Le comunità microbiche negli ambienti terrestri I suoli come ambiente per i microrganismi Suoli, piante e nutrienti 199 Recenti sviluppi della microbiologia 26.1: Un esperimento casuale sull azoto su scala globale I microrganismi nell ambiente suolo I microrganismi e la formazione di diversi tipi di suolo Associazioni dei microrganismi del suolo con le piante vascolari 206 Diversità ed ecologia microbica 26.2: Le micorrize e l evoluzione delle piante vascolari I microrganismi nel suolo e nell atmosfera 218 Diversità ed ecologia microbica 26.3: Suoli, termiti, microrganismi intestinali e metano atmosferico 219 Tecniche e applicazioni 26.4: Come mantenere salubre l aria degli ambienti interni con i microrganismi del suolo La biosfera sotterranea Microrganismi del suolo e salute umana 223
4 Romane :09 Pagina viii viii 27 Interazioni microbiche Interazioni microbiche 225 Diversità ed ecologia microbica 27.1: Wolbachia pipientis: il microrganismo più infettivo del mondo? 228 Diversità ed ecologia microbica 27.2: Coevoluzione di animali e delle comunità microbiche del loro tratto intestinale Interazioni uomo-microrganismo Microbioti normali del corpo umano 242 Tecniche e applicazioni 27.3: Probiotici per uomini e animali Microbiologia degli alimenti Proliferazione microbica negli alimenti Crescita microbica e deterioramento alimentare Controllo del deterioramento alimentare 254 Nota storica 28.1: Un esercito in marcia visto dal suo stomaco Malattie a trasmissione alimentare 258 Nota storica 28.2: Febbre tifoide e carne in scatola Identificazione dei microrganismi patogeni trasmessi per via alimentare Microbiologia degli alimenti fermentati 262 Tecniche e applicazioni 28.3: Colture starter, infezioni da batteriofagi e plasmidi Microrganismi come alimenti e integratori alimentari Microbiologia e biotecnologie industriali Potabilizzazione e analisi microbiologica dell acqua 274 Tecniche e applicazioni 29.1: Malattie di origine idrica, forniture idriche e filtrazione lenta a sabbia Trattamento delle acque reflue Selezione dei microrganismi adatti per la microbiologia e le biotecnologie industriali 284 Tecniche e applicazioni 29.2: Le potenzialità degli archeobatteri termofili nelle biotecnologie Crescita dei microrganismi in ambienti controllati Principali prodotti della microbiologia industriale La crescita microbica in ambienti naturali complessi 299 Diversità ed ecologia microbica 29.3: I metanogeni: un nuovo ruolo per un gruppo microbico unico 302 Diversità ed ecologia microbica 29.4: Un fungo dall appetito insaziabile Applicazioni di biotecnologia 306 Tecniche e applicazioni 29.5: Biotecnologia e legame streptavidina-biotina Effetti delle biotecnologie microbiche 309 Appendice A Classificazione dei procarioti secondo il Bergey s Manual of Systematic Bacteriology, seconda edizione A-1 Appendice B Classificazione dei virus A-12 analitico I-1 Volume 3 Microbiologia medica 30 Immunità aspecifica (innata) Stato di resistenza dell ospite: visione d insieme Cellule, tessuti e organi del sistema immunitario Fagocitosi Infiammazione Barriere fisiche nella resistenza aspecifica (innata) Mediatori chimici nella resistenza aspecifica (innata) Immunità specifica (acquisita) Immunità specifica (acquisita): visione d insieme Antigeni Forme di immunità specifica (adattativa) Riconoscimento di materiale estraneo 36 Tecniche e applicazioni 31.1: Selezione di donatori per trapianti d organo e di tessuto Biologia dei linfociti T Biologia dei linfociti B Anticorpi Funzione degli anticorpi 58 Tecniche e applicazioni 31.2: Anticorpi monoclonali Sintesi: il ruolo degli anticorpi e dei linfociti nella difesa immunitaria Immunotolleranza acquisita Disordini immunitari Patogenicità dei microrganismi Relazioni ospite-parassita Patogenesi delle malattie virali Patogenesi delle malattie batteriche Difese antimicrobiche dell ospite 88 Tecniche e applicazioni 32.1: Rilevazione e rimozione delle endotossine Meccanismi microbici per sfuggire alle difese dell ospite Chemioterapia antimicrobica Lo sviluppo della chemioterapia Caratteristiche generali dei farmaci antimicrobici 94 Tecniche e applicazioni 33.1: Utilizzo degli antibiotici nella ricerca microbiologica Determinazione del livello di attività antimicrobica Meccanismi di azione degli agenti antimicrobici Fattori che influenzano l efficacia dei farmaci antimicrobici I farmaci antibatterici La farmacoresistenza 107 Malattie 33.2: Uso scorretto degli antibiotici e farmacoresistenza I farmaci antifungini I farmaci antivirali I farmaci antiprotozoari 113
5 Romane :09 Pagina ix ix 34 Microbiologia e immunologia clinica Campioni 117 Tecniche e applicazioni 34.1: Regole pratiche standard per laboratori di microbiologia clinica Identificazione dei microrganismi all interno dei campioni 122 Diversità ed ecologia microbica 34.2: Biosensori: il futuro è ora Immunologia clinica 134 Tecniche e applicazioni 34.3: Storia e importanza della sierotipizzazione Analisi di sensibilità L informatica in microbiologia clinica L epidemiologia delle malattie infettive 143 Nota storica 35.1: John Snow: il primo epidemiologo Terminologia epidemiologica Indici di frequenza: gli strumenti a disposizione degli epidemiologi Riconoscimento di una malattia infettiva all interno di una popolazione Riconoscimento di un epidemia 147 Nota storica 35.2: Mary tifoide Il ciclo infettivo: storia di una malattia 149 Nota storica 35.3: Le prime segnalazioni di diffusione di una malattia infettiva da persona a persona Virulenza e modalità di trasmissione Malattie infettive e patogeni emergenti e riemergenti Controllo delle epidemie 159 Nota storica 35.4: Le prime immunizzazioni Biodifesa: lotta e strategie contro il bioterrorismo 163 Nota storica 35.5: 1346: la prima documentazione storica di un attentato terroristico biologico Viaggi transcontinentali e considerazioni di salute pubblica Infezioni nosocomiali Patologie umane causate da virus e prioni Malattie a trasmissione aerea 171 Malattie 36.1: La sindrome di Reye e di Guillain-Barré Malattie trasmesse da artropodi 182 Malattie 36.2: Febbri emorragiche virali: una lezione di storia della microbiologia Malattie trasmesse per contatto diretto Malattie trasmesse per via alimentare e idrica 198 Nota storica 36.3: Breve storia della poliomielite Zoonosi Malattie da prioni Patologie umane causate da batteri Malattie a trasmissione aerea Malattie trasmesse da artropodi 219 Nota storica 37.1: I rischi della ricerca microbiologica Malattie trasmesse per contatto diretto 225 Malattie 37.2: Biofilm 229 Malattie 37.3: Stafilococchi antibiotico-resistenti 232 Malattie 37.4: Breve storia della sifilide Malattie trasmesse per via alimentare e idrica 238 Tecniche e applicazioni 37.5: Le tossine dei clostridi come agenti terapeutici. I benefici derivanti dalle proteine più tossiche presenti in natura Sepsi e shock settico Zoonosi Infezioni dentali Patologie umane causate da funghi e protozoi Funghi e protozoi patogeni Malattie trasmesse per via aerea Malattie trasmesse da artropodi vettori 262 Malattie 38.1: Breve storia della malaria Malattie trasmesse per contatto diretto Malattie trasmesse per via alimentare e idrica Malattie opportunistiche 274 Malattie 38.2: L emergenza candidosi 275 analitico I-1
Microbiologia clinica
 Microbiologia clinica Docente : Prof. Ubaldo Scardellato Testo: MICROBIOLOGIA CLINICA Eudes Lanciotti Cea ed. 2001 Temi cardine del programma 1. Lo sviluppo della microbiologia come scienza. 2. La natura
Microbiologia clinica Docente : Prof. Ubaldo Scardellato Testo: MICROBIOLOGIA CLINICA Eudes Lanciotti Cea ed. 2001 Temi cardine del programma 1. Lo sviluppo della microbiologia come scienza. 2. La natura
ANNO 2008 I SESSIONE BIOLOGO. L eredità dei caratteri: i geni e i cromosomi L ambiente e i microrganismi Il sangue e la sua analisi
 ANNO 2008 L eredità dei caratteri: i geni e i cromosomi L ambiente e i microrganismi Il sangue e la sua analisi Igiene e laboratorio Legislazione professionale Certificazione di qualità I Il candidato
ANNO 2008 L eredità dei caratteri: i geni e i cromosomi L ambiente e i microrganismi Il sangue e la sua analisi Igiene e laboratorio Legislazione professionale Certificazione di qualità I Il candidato
ANNO 2008 I SESSIONE BIOLOGO. L eredità dei caratteri: i geni e i cromosomi L ambiente e i microrganismi Il sangue e la sua analisi
 ANNO 2008 L eredità dei caratteri: i geni e i cromosomi L ambiente e i microrganismi Il sangue e la sua analisi Igiene e laboratorio Legislazione professionale Certificazione di qualità I Il candidato
ANNO 2008 L eredità dei caratteri: i geni e i cromosomi L ambiente e i microrganismi Il sangue e la sua analisi Igiene e laboratorio Legislazione professionale Certificazione di qualità I Il candidato
Membri dell universo microbico
 Membri dell universo microbico Cellule procariote: mancanza di un nucleo ben delimitato all interno della cellula Cellule eucariote: presenza di un compartimento nucleare ben definito, maggiore complessità
Membri dell universo microbico Cellule procariote: mancanza di un nucleo ben delimitato all interno della cellula Cellule eucariote: presenza di un compartimento nucleare ben definito, maggiore complessità
INDICE. VOLUME 1 Cellula. VOLUME 2 Genetica. PARTE III Genetica. Capitolo 8. Fotosintesi 159. Capitolo 1. Capitolo 9. Introduzione alla biologia 1
 00PrPag_Vol_06_BROOKER 30/07/10 11:46 Pagina V VOLUME 1 Cellula Capitolo 1 Introduzione alla biologia 1 Capitolo 8 Fotosintesi 159 Capitolo 9 Comunicazione cellulare 181 PARTE I Chimica Capitolo 10 Capitolo
00PrPag_Vol_06_BROOKER 30/07/10 11:46 Pagina V VOLUME 1 Cellula Capitolo 1 Introduzione alla biologia 1 Capitolo 8 Fotosintesi 159 Capitolo 9 Comunicazione cellulare 181 PARTE I Chimica Capitolo 10 Capitolo
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROF. FAUSTO PITROLINO PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE CLASSE 3^A
 LICEO SCIENTIFICO STATALE «GALILEO GALILEI» Via Ceresina 17 - Tel. 049 8974487 Fax 049 8975750 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROF. FAUSTO PITROLINO PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE
LICEO SCIENTIFICO STATALE «GALILEO GALILEI» Via Ceresina 17 - Tel. 049 8974487 Fax 049 8975750 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROF. FAUSTO PITROLINO PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE
Esempi di programmazione di moduli e unità didattiche
 1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA INTERUNIVERSITARIA CAMPANA DI SPECIALIZZAZIONE ALL INSEGNAMENTO A.N.I.S.N. ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI SEZIONE CAMPANIA di moduli
1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA INTERUNIVERSITARIA CAMPANA DI SPECIALIZZAZIONE ALL INSEGNAMENTO A.N.I.S.N. ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI SEZIONE CAMPANIA di moduli
CHIMICA E BIOLOGIA. PRIMO ANNO (Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane)
 1/5 PRIMO ANNO Testo consigliato: CRIPPA FIORANI NEPGEN RUSCONI, Scienze naturali, 1. Mondatori Scuola. Obiettivi minimi. Conoscere le unità di misura. Conoscere le caratteristiche della materia. Conoscere
1/5 PRIMO ANNO Testo consigliato: CRIPPA FIORANI NEPGEN RUSCONI, Scienze naturali, 1. Mondatori Scuola. Obiettivi minimi. Conoscere le unità di misura. Conoscere le caratteristiche della materia. Conoscere
METABOLISMO E CRESCITA MICROBICA
 METABOLISMO E CRESCITA MICROBICA CRESCITA MICROBICA Riproduzione dei Microrganismi a- Scissione b-crescita apicale c- Gemmazione Scissione Batteri Alghe alcuni Lieviti CRESCITA MICROBICA Crescita apicale
METABOLISMO E CRESCITA MICROBICA CRESCITA MICROBICA Riproduzione dei Microrganismi a- Scissione b-crescita apicale c- Gemmazione Scissione Batteri Alghe alcuni Lieviti CRESCITA MICROBICA Crescita apicale
ITIS ENRICO MEDI. Individuare l organizzazione strutturale, le funzioni e classificare i virus
 UDA UDA N. 1 I Virus UDA 2 Attività patogena dei microrganismi ITIS ENRICO MEDI PIANO DELLA DISCIPLINA: Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo Ambientale Classe 4Ab PIANO DELLE UDA ANNO 2013-2014
UDA UDA N. 1 I Virus UDA 2 Attività patogena dei microrganismi ITIS ENRICO MEDI PIANO DELLA DISCIPLINA: Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo Ambientale Classe 4Ab PIANO DELLE UDA ANNO 2013-2014
CORSO di BIOLOGIA ANIMALE E GENETICA
 Corso di Laurea in Farmacia CORSO di BIOLOGIA ANIMALE E GENETICA Prof.ssa Stefania Bulotta Testio consigliato: Alberts et al., (Ed. Zanichelli), L Essenziale di Biologia molecolare della cellula. Testi
Corso di Laurea in Farmacia CORSO di BIOLOGIA ANIMALE E GENETICA Prof.ssa Stefania Bulotta Testio consigliato: Alberts et al., (Ed. Zanichelli), L Essenziale di Biologia molecolare della cellula. Testi
Microbiologia: Classificazione e Morfologia. Coordinatore: Oliviero E. Varnier
 Microbiologia: Classificazione e Morfologia Coordinatore: Oliviero E. Varnier 010 353 7649 CLASSIFICAZIONE Classificazione Distribuzione dei microrganismi in gruppi tassonomici (taxa=categorie) basati
Microbiologia: Classificazione e Morfologia Coordinatore: Oliviero E. Varnier 010 353 7649 CLASSIFICAZIONE Classificazione Distribuzione dei microrganismi in gruppi tassonomici (taxa=categorie) basati
INCLUSIONI MEMBRANA, CAPSULA, PARETE CELL. FLAGELLI PILI RIBOSOMI STRUTTURE CELLULARI INCLUSIONI MEMBRANA, CAPSULA, PARETE CELL.
 ANALISI ELEMENTARE Elemento % peso Funzione Origine secco Carbonio 50 Costituente principale del materiale cellulare Composti organici; CO2 Ossigeno 20 Costituente dei composti organici e dell'acqua cellulare
ANALISI ELEMENTARE Elemento % peso Funzione Origine secco Carbonio 50 Costituente principale del materiale cellulare Composti organici; CO2 Ossigeno 20 Costituente dei composti organici e dell'acqua cellulare
Biodiversità e salute. Flavia Caretta
 Biodiversità e salute Flavia Caretta Biodiversità e salute salute degli ecosistemi salute umana Effetti della perdita di biodiversità sulla salute umana Ricerca epidemiologica Rivolta a fattori singoli
Biodiversità e salute Flavia Caretta Biodiversità e salute salute degli ecosistemi salute umana Effetti della perdita di biodiversità sulla salute umana Ricerca epidemiologica Rivolta a fattori singoli
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale «Via Silvestri 301»
 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale «Via Silvestri 301» Plesso «ALESSANDRO«VOLTA» Programma di SCIENZE NATURALI Classe 3 a L Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE Anno Scolastico 2015-2016
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale «Via Silvestri 301» Plesso «ALESSANDRO«VOLTA» Programma di SCIENZE NATURALI Classe 3 a L Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE Anno Scolastico 2015-2016
Percorso formativo di BIOLOGIA. I Biennio (Lo studio scientifico della vita Dal macroscopico al microscopico)
 Percorso formativo di BIOLOGIA I Biennio (Lo studio scientifico della vita Dal macroscopico al microscopico) Principi di classificazione e filogenesi degli organismi viventi e basi dell evoluzione Le principali
Percorso formativo di BIOLOGIA I Biennio (Lo studio scientifico della vita Dal macroscopico al microscopico) Principi di classificazione e filogenesi degli organismi viventi e basi dell evoluzione Le principali
Controllo della crescita con antibiotici: batteriostatici
 La curva di crescita in terreno liquido: un modello di fisiologia batterica Controllo della crescita con antibiotici: batteriostatici Momento di aggiunta dell antibiotico Densità ottica Arresto della crescita
La curva di crescita in terreno liquido: un modello di fisiologia batterica Controllo della crescita con antibiotici: batteriostatici Momento di aggiunta dell antibiotico Densità ottica Arresto della crescita
Materiale genetico presente nella cellula batterica. Cromosoma batterico Plasmidi Elementi genetici trasponibili DNA fagico
 Genetica batterica Materiale genetico presente nella cellula batterica Cromosoma batterico Plasmidi Elementi genetici trasponibili DNA fagico Nucleoide (morfologia) È costituito da un unica unica molecola
Genetica batterica Materiale genetico presente nella cellula batterica Cromosoma batterico Plasmidi Elementi genetici trasponibili DNA fagico Nucleoide (morfologia) È costituito da un unica unica molecola
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA-BALLINI
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA-BALLINI Via Tirandi n. 3 BRESCIA Programma di SCIENZE INTEGRATE (Biologia) A.s.2015/2016 classe 2^F a.f.m. Libro di testo: Silvia Saraceni, Giorgio Strumia Vita,
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA-BALLINI Via Tirandi n. 3 BRESCIA Programma di SCIENZE INTEGRATE (Biologia) A.s.2015/2016 classe 2^F a.f.m. Libro di testo: Silvia Saraceni, Giorgio Strumia Vita,
LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI Siena
 LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI Siena Docente: Francesco Parigi Classe: 2 D Materia: Scienze naturali Origine e storia della biologia. Il metodo scientifico. Caratteristiche degli esseri viventi.
LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI Siena Docente: Francesco Parigi Classe: 2 D Materia: Scienze naturali Origine e storia della biologia. Il metodo scientifico. Caratteristiche degli esseri viventi.
ORGANISMI PROCARIOTI. BATTERI (Bacteria) ARCHEI (Archaea) ORGANISMI VIVENTI EUCARIOTI PROCARIOTI BACTERIA EUKARYA ARCHAEA
 ORGANISMI PROCARIOTI BATTERI (Bacteria) ARCHEI (Archaea) Per lo più unicellulari, ma non mancano notevoli esempi di procarioti che vivono in associazioni pluricellulari Spesso il termine batteri è usato
ORGANISMI PROCARIOTI BATTERI (Bacteria) ARCHEI (Archaea) Per lo più unicellulari, ma non mancano notevoli esempi di procarioti che vivono in associazioni pluricellulari Spesso il termine batteri è usato
caratteristiche dei viventi
 caratteristiche dei viventi teoria cellulare Teoria cellulare La Teoria Cellulare formulata da Schleiden e Schwann tra il 1838 e il 1839 afferma che Tutti gli organismi viventi sono formati da cellule.
caratteristiche dei viventi teoria cellulare Teoria cellulare La Teoria Cellulare formulata da Schleiden e Schwann tra il 1838 e il 1839 afferma che Tutti gli organismi viventi sono formati da cellule.
Parte I I principi fondamentali della clonazione dei geni e dell analisi del DNA
 6746 BROWN Iniziali I-XIV 13-04-2007 11:57 Pagina VII Indice Parte I I principi fondamentali della clonazione dei geni e dell analisi del DNA Capitolo 1 L importanza della clonazione dei geni e dell analisi
6746 BROWN Iniziali I-XIV 13-04-2007 11:57 Pagina VII Indice Parte I I principi fondamentali della clonazione dei geni e dell analisi del DNA Capitolo 1 L importanza della clonazione dei geni e dell analisi
Archaea. Eukarya. Bacteria. Il raggruppamento in. Eukarya, Archaea, Bacteria ALCUNE CLASSIFICAZIONI "GLOBALI" DEGLI ORGANISMI VIVENTI
 Il raggruppamento in Eukarya, Archaea, Bacteria HA LA PRETESA DI RAPPRESENTARE UNA CLASSIFICAZIONE NATURALE E DI INDICARE LE RELAZIONI FILOGENETICHE Procarioti ed Eucarioti condividono le proprietà fondamentali
Il raggruppamento in Eukarya, Archaea, Bacteria HA LA PRETESA DI RAPPRESENTARE UNA CLASSIFICAZIONE NATURALE E DI INDICARE LE RELAZIONI FILOGENETICHE Procarioti ed Eucarioti condividono le proprietà fondamentali
A_Test di valutazione di Biologia Generale:
 COGNOME NOME... C.I./Patente n... MATRICOLA NO SI, n:... Prova di accertamento per la determinazione di eventuali debiti formativi Iscritti 2011-2012 A_Test di valutazione di Biologia Generale: Il ciclo
COGNOME NOME... C.I./Patente n... MATRICOLA NO SI, n:... Prova di accertamento per la determinazione di eventuali debiti formativi Iscritti 2011-2012 A_Test di valutazione di Biologia Generale: Il ciclo
Gli ecosistemi del pianeta Terra. 1 I biomi terrestri A20. Lavorare con i dati I diagrammi climatici di Walter A33
 A1 A2 A3 Lo studio dei viventi Gli ecosistemi del pianeta Terra Le comunità e le loro interazioni 1 Gli esseri viventi sono sistemi complessi A2 2 I virus: al confine con la vita A11 3 Il metodo scientifico:
A1 A2 A3 Lo studio dei viventi Gli ecosistemi del pianeta Terra Le comunità e le loro interazioni 1 Gli esseri viventi sono sistemi complessi A2 2 I virus: al confine con la vita A11 3 Il metodo scientifico:
Microbiologia generale
 Microbiologia generale Docente : Prof. Alberto Cresci Dip. Sc. Morfologiche e Biochimiche Comparate Testo: MICROBIOLOGIA - Lansing M. PRESCOTT Zanichelli Editore BOLOGNA Temi cardine del programma 1. Lo
Microbiologia generale Docente : Prof. Alberto Cresci Dip. Sc. Morfologiche e Biochimiche Comparate Testo: MICROBIOLOGIA - Lansing M. PRESCOTT Zanichelli Editore BOLOGNA Temi cardine del programma 1. Lo
Nei batteri non è presente una membrana nucleare
 La cellula procariota (Bacteria e Archaea) Morfologia generale Composizione chimica Le strutture cellulari e le loro funzioni parte 1 L involucro Appendici esterne: Le strutture cellulari e le loro funzioni
La cellula procariota (Bacteria e Archaea) Morfologia generale Composizione chimica Le strutture cellulari e le loro funzioni parte 1 L involucro Appendici esterne: Le strutture cellulari e le loro funzioni
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN BIOLOGIA. Descrizione degli insegnamenti
 CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN BIOLOGIA Descrizione degli insegnamenti Insegnamento: APPLICAZIONI MOLECOLARI IN BIOLOGIA VEGETALE Settore Scientifico - Disciplinare: BIO/01 BIO/02 BIO/03 CFU: 4 Obiettivi
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN BIOLOGIA Descrizione degli insegnamenti Insegnamento: APPLICAZIONI MOLECOLARI IN BIOLOGIA VEGETALE Settore Scientifico - Disciplinare: BIO/01 BIO/02 BIO/03 CFU: 4 Obiettivi
Metabolismo batterico
 Metabolismo batterico La somma di tutte le reazioni chimiche che avvengono nella cellula.questa è resa possibile dal flusso dell energia e dalla partecipazione di enzimi. Funzione principale della cellula
Metabolismo batterico La somma di tutte le reazioni chimiche che avvengono nella cellula.questa è resa possibile dal flusso dell energia e dalla partecipazione di enzimi. Funzione principale della cellula
Corso di Laurea inscienze Animali e Produzioni Alimentari (SAPA) - classe 38. Anno Accademico 2016/2017
 Corso di Laurea inscienze Animali e Produzioni Alimentari (SAPA) - classe 38 Programma dell insegnamento di BIOLOGIA Anno di corso I Semestre I N CFU 7 Ore complessive 56 Anno Accademico 016/017 Programma
Corso di Laurea inscienze Animali e Produzioni Alimentari (SAPA) - classe 38 Programma dell insegnamento di BIOLOGIA Anno di corso I Semestre I N CFU 7 Ore complessive 56 Anno Accademico 016/017 Programma
OBIETTIVI PER LA SUFFICIE ZA DELLE CLASSI PRIME SCIE ZE ATURALI
 OBIETTIVI PER LA SUFFICIE ZA DELLE CLASSI PRIME - identificare le fasi del metodo di indagine scientifica con particolare riferimento all osservazione; - comprendere e utilizzare in modo adeguato lessico
OBIETTIVI PER LA SUFFICIE ZA DELLE CLASSI PRIME - identificare le fasi del metodo di indagine scientifica con particolare riferimento all osservazione; - comprendere e utilizzare in modo adeguato lessico
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI - Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: X LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate LICEO TECNICO ISTITUTO TECNICO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI - Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: X LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate LICEO TECNICO ISTITUTO TECNICO
Epidemiologia generale delle malattie infettive
 Epidemiologia generale delle malattie infettive ecologia microbica rapporti ospite-parassita storia naturale delle malattie infettive sorgenti e serbatoi di infezione vie di penetrazione e modalità di
Epidemiologia generale delle malattie infettive ecologia microbica rapporti ospite-parassita storia naturale delle malattie infettive sorgenti e serbatoi di infezione vie di penetrazione e modalità di
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI - Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate LICEO TECNICO ISTITUTO TECNICO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI - Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate LICEO TECNICO ISTITUTO TECNICO
OBIETTIVI MINIMI DI SCIENZE ANNO SCOLASTICO LICEO DELLE SCIENZE UMANE CLASSI SECONDE
 OBIETTIVI MINIMI DI SCIENZE LICEO DELLE SCIENZE UMANE CLASSI SECONDE Chimica Competenze Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : Saper riconoscere proprietà misurabili e non misurabili
OBIETTIVI MINIMI DI SCIENZE LICEO DELLE SCIENZE UMANE CLASSI SECONDE Chimica Competenze Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : Saper riconoscere proprietà misurabili e non misurabili
Criteri di classificazione
 Cosa sono? Entità: non si ritengono organismi viventi infatti sono classificati in un impero diverso rispetto a quello cellulare impero virale Submicroscopiche: non sono visibili al M.O., ma solo a quello
Cosa sono? Entità: non si ritengono organismi viventi infatti sono classificati in un impero diverso rispetto a quello cellulare impero virale Submicroscopiche: non sono visibili al M.O., ma solo a quello
AVC (Audio Video Conferenza) in collegamento diretto con il docente
 Modalità AVC (Audio Video Conferenza) in collegamento diretto con il docente Totale 60 ore Presso Da casa tua. Calendario Dall 8 al 22 luglio 2013 Durata - 60 ore (n. 12 lezione di 5 ore: dalle ore 8,30
Modalità AVC (Audio Video Conferenza) in collegamento diretto con il docente Totale 60 ore Presso Da casa tua. Calendario Dall 8 al 22 luglio 2013 Durata - 60 ore (n. 12 lezione di 5 ore: dalle ore 8,30
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE
 TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE MATERIA: SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA) CLASSE SECONDA DOCENTE: PIETRO VISCONE INDIRIZZO* AFM * indicare Amministrazione, Finanza e Marketing per il biennio. Per il triennio indicare
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE MATERIA: SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA) CLASSE SECONDA DOCENTE: PIETRO VISCONE INDIRIZZO* AFM * indicare Amministrazione, Finanza e Marketing per il biennio. Per il triennio indicare
Alessia Pertuso. Veronica Cassiano. Pietro Mongiardini. Alessia Cacciò
 Alessia Pertuso Veronica Cassiano Pietro Mongiardini Alessia Cacciò Alghe azzurre sono in grado di sopravvivere in qualsiasi situazione sfavorevole. sono autotrofe (trasformano lesostanze da inorganiche
Alessia Pertuso Veronica Cassiano Pietro Mongiardini Alessia Cacciò Alghe azzurre sono in grado di sopravvivere in qualsiasi situazione sfavorevole. sono autotrofe (trasformano lesostanze da inorganiche
Le reazioni esoergoniche e quelle endoergoniche del metabolismo cellulare sono legate dalla molecola di ATP.
 1 METABOLISMO CELLULARE Definizione Metabolismo cellulare insieme delle reazioni che producono e necessitano energia nel nostro corpo. Nel metabolismo si distinguono due fasi: Fase catabolica Insieme delle
1 METABOLISMO CELLULARE Definizione Metabolismo cellulare insieme delle reazioni che producono e necessitano energia nel nostro corpo. Nel metabolismo si distinguono due fasi: Fase catabolica Insieme delle
Istituto Comprensivo Massarosa 2 Percorsi per capire Laboratori del Sapere Scientifico. Virus e Batteri. biologia e caratteristiche...
 Istituto Comprensivo Massarosa 2 Percorsi per capire Laboratori del Sapere Scientifico Virus e Batteri biologia e caratteristiche... Paolo Ercolini Piano di Conca, 11 novembre 2013 Fonti internet rilevate
Istituto Comprensivo Massarosa 2 Percorsi per capire Laboratori del Sapere Scientifico Virus e Batteri biologia e caratteristiche... Paolo Ercolini Piano di Conca, 11 novembre 2013 Fonti internet rilevate
Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive
 Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive Biologia applicata Prof. Cinzia Di Pietro RECAPITI Cinzia Di Pietro dipietro@unict.it 095 3782075 Via S. Sofia 87 Pal. C - piano 2 - stanza
Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive Biologia applicata Prof. Cinzia Di Pietro RECAPITI Cinzia Di Pietro dipietro@unict.it 095 3782075 Via S. Sofia 87 Pal. C - piano 2 - stanza
Anno scolastico 2015/16
 Anno scolastico 2015/16 P R O G R A M M A S V O L T O Docente: David Fiacchini Materia: Scienze Naturali - Classe - - Indirizzo - 2^C Liceo Scientifico Primo quadrimestre UNITA DIDATTICA FORMATIVA n. 1
Anno scolastico 2015/16 P R O G R A M M A S V O L T O Docente: David Fiacchini Materia: Scienze Naturali - Classe - - Indirizzo - 2^C Liceo Scientifico Primo quadrimestre UNITA DIDATTICA FORMATIVA n. 1
INDICE PARTE I CHIMICA. Autori Introduzione
 INDICE Autori Introduzione XI XIII PARTE I CHIMICA Capitolo 1 STRUTTURA DELL ATOMO 3 1.1 Teorie atomiche 3 1.2 Costituenti dell atomo 4 1.3 Numeri quantici 4 1.4 Tipi di orbitali 5 1.5 Aufbau 6 1.6 Sistema
INDICE Autori Introduzione XI XIII PARTE I CHIMICA Capitolo 1 STRUTTURA DELL ATOMO 3 1.1 Teorie atomiche 3 1.2 Costituenti dell atomo 4 1.3 Numeri quantici 4 1.4 Tipi di orbitali 5 1.5 Aufbau 6 1.6 Sistema
Temi per Biologo Senior II sessione I prova scritta INTERAZIONE TRA ORGANISMI ED AMBIENTE, BIOINDICATORI DI ALTERAZIONI AMBIENTALI
 I sessione 2013 Biologo - I prova scritta: 1) Metabolismo energetico 2) Diversità biologica o Biodiversità 3) Dal prelievo microbiologico al risultato finale: si illusti l'iter di una analisi batteriologica
I sessione 2013 Biologo - I prova scritta: 1) Metabolismo energetico 2) Diversità biologica o Biodiversità 3) Dal prelievo microbiologico al risultato finale: si illusti l'iter di una analisi batteriologica
TFA A.A CLASSE A60 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA. Modalità di svolgimento degli esami
 PROVA SCRITTA Stesura di un elaborato di presentazione di un unità didattica come da modello allegato (allegato 1), da preparare su tre argomenti rappresentativi rispettivamente degli insegnamenti di chimica,
PROVA SCRITTA Stesura di un elaborato di presentazione di un unità didattica come da modello allegato (allegato 1), da preparare su tre argomenti rappresentativi rispettivamente degli insegnamenti di chimica,
Anno: 1 Semestre: 2 Corso integrato: MICROBIOLOGIA, PATOLOGIA GENERALE, GENETICA MEDICA Disciplina: MICROBIOLOGIA Docente: Prof.
 Corso di Laurea in OSTETRICIA Anno: 1 Semestre: 2 Corso integrato: MICROBIOLOGIA, PATOLOGIA GENERALE, GENETICA MEDICA Disciplina: MICROBIOLOGIA Docente: Prof.ssa Andreina BAJ Programma: 1. Storia della
Corso di Laurea in OSTETRICIA Anno: 1 Semestre: 2 Corso integrato: MICROBIOLOGIA, PATOLOGIA GENERALE, GENETICA MEDICA Disciplina: MICROBIOLOGIA Docente: Prof.ssa Andreina BAJ Programma: 1. Storia della
METODICHE DIAGNOSTICHE DI MICROBIOLOGIA CLINICA E PARASSITOLOGIA
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)
È stimato che oggi sulla terra sono presenti da 10*10 6 a 100*10 6 specie viventi
 È stimato che oggi sulla terra sono presenti da 10*10 6 a 100*10 6 specie viventi Enorme diversità di forme Costanza di struttura interna La cellula è l unità fondamentale di tutti gli organismi viventi
È stimato che oggi sulla terra sono presenti da 10*10 6 a 100*10 6 specie viventi Enorme diversità di forme Costanza di struttura interna La cellula è l unità fondamentale di tutti gli organismi viventi
Biol Cell Anim BIOTEC Esempi di Testi da utilizzare (sono equivalenti) Unità didattica: Biologia della Cellula Animale (6 CFU)
 http://www 3.unipv.it/webbio/anatcomp/freitas/freitas.html Insegnamento Biologia della Cellula Animale e Vegetale (9 CFU) Unità didattica: Biologia della Cellula Animale (6 CFU) Esempi di Testi da utilizzare
http://www 3.unipv.it/webbio/anatcomp/freitas/freitas.html Insegnamento Biologia della Cellula Animale e Vegetale (9 CFU) Unità didattica: Biologia della Cellula Animale (6 CFU) Esempi di Testi da utilizzare
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE. Roberto Valturio RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO. a.s.
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE Roberto Valturio RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2O13-2014 Materia : Chimica e Biologia Classe : II sez. E Rimini,05/06/2014
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE Roberto Valturio RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2O13-2014 Materia : Chimica e Biologia Classe : II sez. E Rimini,05/06/2014
Microbiologia Agraria
 CORSO DI LAUREA SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E AMBIENTALI (SAFA) Microbiologia Agraria Docente: Prof.ssa Olimpia Pepe (olipepe@unina.it) Obiettivi del corso: Conoscenze di base relative ai microrganismi
CORSO DI LAUREA SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E AMBIENTALI (SAFA) Microbiologia Agraria Docente: Prof.ssa Olimpia Pepe (olipepe@unina.it) Obiettivi del corso: Conoscenze di base relative ai microrganismi
individuazione della causa di una patologia Diagnostica di laboratorio
 DIAGNOSI (διαγνωσισ = distinguere) individuazione della causa di una patologia Diagnosi su base clinica e/o anatomo-patologica sospetto o orientamento diagnostico Diagnosi di laboratorio (diagnosi eziologica)
DIAGNOSI (διαγνωσισ = distinguere) individuazione della causa di una patologia Diagnosi su base clinica e/o anatomo-patologica sospetto o orientamento diagnostico Diagnosi di laboratorio (diagnosi eziologica)
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI CRESCENZI PACINOTTI. PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI CRESCENZI PACINOTTI PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2016-2017 Classe 2^Bcos Materia Biologia Docente Elena Pozzi LIVELLO DI PARTENZA: non è stato effettuato
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI CRESCENZI PACINOTTI PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2016-2017 Classe 2^Bcos Materia Biologia Docente Elena Pozzi LIVELLO DI PARTENZA: non è stato effettuato
INDICE. VOLUME 1 Cellula. VOLUME 2 Genetica. Capitolo 9 Comunicazione cellulare 181. Capitolo 1 Introduzione alla biologia 1
 00PrPag_Vol_02_BROOKER 30/07/10 11:22 Pagina V VOLUME 1 Cellula Capitolo 1 Introduzione alla biologia 1 PARTE I Capitolo 2 Chimica Basi chimiche della vita I: atomi, molecole e acqua 19 Capitolo 3 Basi
00PrPag_Vol_02_BROOKER 30/07/10 11:22 Pagina V VOLUME 1 Cellula Capitolo 1 Introduzione alla biologia 1 PARTE I Capitolo 2 Chimica Basi chimiche della vita I: atomi, molecole e acqua 19 Capitolo 3 Basi
Prof. Giorgio Sartor. Il metabolismo. Metabolismo. È il processo che permette di ricavare energia da legami chimici (sottoforma di
 Prof. Giorgio Sartor Il metabolismo Copyright 2001-2008 by Giorgio Sartor. All rights reserved. Versione 1.4 oct 2008 Metabolismo È il processo che permette di ricavare energia da legami chimici (sottoforma
Prof. Giorgio Sartor Il metabolismo Copyright 2001-2008 by Giorgio Sartor. All rights reserved. Versione 1.4 oct 2008 Metabolismo È il processo che permette di ricavare energia da legami chimici (sottoforma
3 fatti del giorno. Salute pubblica e allattamento: le informazioni scientifiche a supporto delle scelte informate per genitori ed operatori
 Allattamento e dintorni: comunicazione e relazioni Salute pubblica e allattamento: le informazioni scientifiche a supporto delle scelte informate per genitori ed operatori Alberto Perra, ISS, CNESPS 3
Allattamento e dintorni: comunicazione e relazioni Salute pubblica e allattamento: le informazioni scientifiche a supporto delle scelte informate per genitori ed operatori Alberto Perra, ISS, CNESPS 3
DGGE/TTGE. Le differenze nel punto di denaturazione, chimica o termica, dipendono dalla sequenza nucleotidica
 DGGE/TTGE Lungo gradiente di sostanze denaturanti (es. Urea) - DGGE Separazione degli amplimeri con elettroforesi Lungo gradiente temporale di temperatura (TTGE) Le differenze nel punto di denaturazione,
DGGE/TTGE Lungo gradiente di sostanze denaturanti (es. Urea) - DGGE Separazione degli amplimeri con elettroforesi Lungo gradiente temporale di temperatura (TTGE) Le differenze nel punto di denaturazione,
CORSO INTEGRATO DI IMMUNOLOGIA ED IMMUNOPATOLOGIA. Prof. Roberto Testi Indirizzo
 CORSO INTEGRATO DI IMMUNOLOGIA ED IMMUNOPATOLOGIA COORDINATORE Prof. Roberto Testi Indirizzo e-mail: roberto.testi@uniroma2.it SVOLGIMENTO DEL CORSO: I parte. Immunologia II parte. Immunopatologia 1 LIBRI
CORSO INTEGRATO DI IMMUNOLOGIA ED IMMUNOPATOLOGIA COORDINATORE Prof. Roberto Testi Indirizzo e-mail: roberto.testi@uniroma2.it SVOLGIMENTO DEL CORSO: I parte. Immunologia II parte. Immunopatologia 1 LIBRI
3B BIO classe partecipante al progetto Generazione Web
 Anno scolastico 2012-13 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (Articolazione: Biotecnologie sanitarie) PROGRAMMA PREVENTIVO MATERIA Biologia, Microbiologia e
Anno scolastico 2012-13 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (Articolazione: Biotecnologie sanitarie) PROGRAMMA PREVENTIVO MATERIA Biologia, Microbiologia e
aggregati di macromolecole dato virus contiene un solo tipo di acido nucleico (DNA o RNA)
 Virus Virus Non sono classificati fra gli organismi viventi in quanto non sono cellule, bensì aggregati di macromolecole (acidi nucleici, proteine, talvolta rivestite da membrana fosfolipidica) Non possono
Virus Virus Non sono classificati fra gli organismi viventi in quanto non sono cellule, bensì aggregati di macromolecole (acidi nucleici, proteine, talvolta rivestite da membrana fosfolipidica) Non possono
Capitolo 6 La respirazione cellulare
 Capitolo 6 La respirazione cellulare Introduzione alla respirazione cellulare 6.1 La respirazione polmonare rifornisce le nostre cellule di ossigeno ed elimina diossido di carbonio La respirazione polmonare
Capitolo 6 La respirazione cellulare Introduzione alla respirazione cellulare 6.1 La respirazione polmonare rifornisce le nostre cellule di ossigeno ed elimina diossido di carbonio La respirazione polmonare
LICEO SCIENTIFICO STATALE R. CACCIOPPOLI ANNO SCOLASTICO 2012/13 CLASSE III G PROGRAMMA DI SCIENZE PROF.SSA ANGELOZZI ROBERTA CHIMICA
 LICEO SCIENTIFICO STATALE R. CACCIOPPOLI ANNO SCOLASTICO 2012/13 CLASSE III G PROGRAMMA DI SCIENZE PROF.SSA ANGELOZZI ROBERTA CHIMICA Misure e grandezze: Il Sistema Internazionale di unità di misura Grandezze
LICEO SCIENTIFICO STATALE R. CACCIOPPOLI ANNO SCOLASTICO 2012/13 CLASSE III G PROGRAMMA DI SCIENZE PROF.SSA ANGELOZZI ROBERTA CHIMICA Misure e grandezze: Il Sistema Internazionale di unità di misura Grandezze
02/12/2014. Tutti gli esseri viventi sono composti da cellule LA CELLULA E L UNITA STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI VIVENTI
 Tutti gli esseri viventi sono composti da cellule Eubatteri Procarioti unicellulari Archebatteri LA CELLULA E L UNITA STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI VIVENTI -Autoconservazione mantenimento della
Tutti gli esseri viventi sono composti da cellule Eubatteri Procarioti unicellulari Archebatteri LA CELLULA E L UNITA STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI VIVENTI -Autoconservazione mantenimento della
SCUOLA PRIMARIA SCIENZE (Classe 1ª)
 SCUOLA PRIMARIA SCIENZE (Classe 1ª) scientifico. all ambiente. Osservare e descrivere i cambiamenti della natura in rapporto al trascorrere delle stagioni. Analizzare oggetti e coglierne le principali
SCUOLA PRIMARIA SCIENZE (Classe 1ª) scientifico. all ambiente. Osservare e descrivere i cambiamenti della natura in rapporto al trascorrere delle stagioni. Analizzare oggetti e coglierne le principali
Progettazione per unità di apprendimento Percorso di istruzione di 1 livello, 2 periodo didattico, asse scientifico Unità di apprendimento 1
 Unità di apprendimento 1 UdA n. 1 SCIENZE DELLA TERRA DURATA PREVISTA 5 25 Standard di Riferimento asse Osservare, descrivere e analizzare fenomeni sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente
Unità di apprendimento 1 UdA n. 1 SCIENZE DELLA TERRA DURATA PREVISTA 5 25 Standard di Riferimento asse Osservare, descrivere e analizzare fenomeni sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A. MARTINI - SCHIO. LICEO ARTISTICO - Dipartimento di SCIENZE e CHIMICA BIOLOGIA ore sett.li 2.
 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A. MARTINI - SCHIO LICEO ARTISTICO - Dipartimento di SCIENZE e CHIMICA BIOLOGIA ore sett.li 2. Obiettivi didattici Conoscenza dei contenuti e dei linguaggi specifici delle
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A. MARTINI - SCHIO LICEO ARTISTICO - Dipartimento di SCIENZE e CHIMICA BIOLOGIA ore sett.li 2. Obiettivi didattici Conoscenza dei contenuti e dei linguaggi specifici delle
Metodi dell ecologia microbica
 Metodi dell ecologia microbica -Biodiversità: isolamento identificazione e quantizzazione dei microrganismi nei diversi habitat; -Attività microbica: misura di ciò che i microrganismi fanno nel loro ambiente
Metodi dell ecologia microbica -Biodiversità: isolamento identificazione e quantizzazione dei microrganismi nei diversi habitat; -Attività microbica: misura di ciò che i microrganismi fanno nel loro ambiente
Unità fondamentale di tutti gli organismi viventi.
 La cellula Unità fondamentale di tutti gli organismi viventi. Cellula procariote Cellula animale Cellula vegetale Le cellule procariote e eucariote Cellula procariote Cellula eucariote Cromosomi Membrana
La cellula Unità fondamentale di tutti gli organismi viventi. Cellula procariote Cellula animale Cellula vegetale Le cellule procariote e eucariote Cellula procariote Cellula eucariote Cromosomi Membrana
Università degli Studi del Sannio. Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Corso di Laurea in Biotecnologie a.a Programma di Biologia Cellulare
 Università degli Studi del Sannio Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Corso di Laurea in Biotecnologie a.a. 2010-2011 Programma di Biologia Cellulare (Prof Massimo Mallardo, I semestre, I anno) massimo.mallardo@unina.it
Università degli Studi del Sannio Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Corso di Laurea in Biotecnologie a.a. 2010-2011 Programma di Biologia Cellulare (Prof Massimo Mallardo, I semestre, I anno) massimo.mallardo@unina.it
L'ECOLOGIA UMANA indaga su due tipi di strategie che i soggetti mettono in atto per adattarsi ai differenti ambienti: ADATTAMENTO GENETICO
 L'ECOLOGIA UMANA indaga su due tipi di strategie che i soggetti mettono in atto per adattarsi ai differenti ambienti: STRATEGIA BIOLOGICA STRATEGIA CULTURALE ADATTAMENTO FISIOLOGICO ADATTAMENTO GENETICO
L'ECOLOGIA UMANA indaga su due tipi di strategie che i soggetti mettono in atto per adattarsi ai differenti ambienti: STRATEGIA BIOLOGICA STRATEGIA CULTURALE ADATTAMENTO FISIOLOGICO ADATTAMENTO GENETICO
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DAL DOCENTE
 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto d Istruzione Superiore Severi-Correnti IIS Severi-Correnti 02-318112/1 via Alcuino 4-20149 Milano 02-33100578 codice fiscale 97504620150
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto d Istruzione Superiore Severi-Correnti IIS Severi-Correnti 02-318112/1 via Alcuino 4-20149 Milano 02-33100578 codice fiscale 97504620150
Programma dell Insegnamento
 Anno accademico 2010/2011 Laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13) Insegnamento: Microbiologia Generale con Laboratorio 1 anno - 6 CFU (48 ore) di lezioni in aula + 1 CFU
Anno accademico 2010/2011 Laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13) Insegnamento: Microbiologia Generale con Laboratorio 1 anno - 6 CFU (48 ore) di lezioni in aula + 1 CFU
Diversità tra i viventi
 Diversità tra i viventi Unità didattica di biologia Proprietà della VITA La CELLULA Classificazione dei viventi Info Per una corretta visualizzazione è necessario attivare le Macro! Premere Esc per Uscire
Diversità tra i viventi Unità didattica di biologia Proprietà della VITA La CELLULA Classificazione dei viventi Info Per una corretta visualizzazione è necessario attivare le Macro! Premere Esc per Uscire
La nuova biologia.blu
 David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum La nuova biologia.blu Il corpo umano PLUS 2 Capitolo C6 Il sistema linfatico e l immunità 3 Il sistema linfatico /1 Il sistema linfatico
David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum La nuova biologia.blu Il corpo umano PLUS 2 Capitolo C6 Il sistema linfatico e l immunità 3 Il sistema linfatico /1 Il sistema linfatico
Al Dirigente Scolastico dell I.I.S.. F. Algarotti Venezia PROGRAMMA
 MATERIA: SCIENZE INTEGRATE -SCIENZE DELLA TERRA CLASSE: I E -La Terra come sistema integrato: litosfera, atmosfera, idrosfera, biosfera; esempi di relazioni ed interazioni che tra queste intercorrono -
MATERIA: SCIENZE INTEGRATE -SCIENZE DELLA TERRA CLASSE: I E -La Terra come sistema integrato: litosfera, atmosfera, idrosfera, biosfera; esempi di relazioni ed interazioni che tra queste intercorrono -
I VIRUS. Tutti i virus esistono in due stati: EXTRACELLULARE e INTRACELLULARE. Nel primo caso si parla comnemente di virioni o particelle virali.
 I VIRUS Un virus è definito come materiale nucleico (DNA o RNA) organizzato in una struttura di rivestimento proteico. Il materiale nucleico del virus contiene l informazione necessaria alla sua replicazione
I VIRUS Un virus è definito come materiale nucleico (DNA o RNA) organizzato in una struttura di rivestimento proteico. Il materiale nucleico del virus contiene l informazione necessaria alla sua replicazione
DIPARTIMENTO DELL INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA UFFICIO IV DELL EX MINISTERO DELLA SALUTE ***
 DIPARTIMENTO DELL INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA UFFICIO IV DELL EX MINISTERO DELLA SALUTE *** LE BIOTECNOLOGIE CHE COSA SONO LE BIOTECNOLOGIE? Le biotecnologie
DIPARTIMENTO DELL INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA UFFICIO IV DELL EX MINISTERO DELLA SALUTE *** LE BIOTECNOLOGIE CHE COSA SONO LE BIOTECNOLOGIE? Le biotecnologie
Biologia. Esplicitazone del prodotto/compito ESITI DI APPRENDIMENTO
 Scheda di progettazione delle Unità di Apprendimento Classe ANAGRAFICA UdA N 1 Titolo: La Cellula Anno Periodo inizio Settembre fine Dicembre 24 ore Origine della vita e comparsa delle prime cellule eucariotiche;
Scheda di progettazione delle Unità di Apprendimento Classe ANAGRAFICA UdA N 1 Titolo: La Cellula Anno Periodo inizio Settembre fine Dicembre 24 ore Origine della vita e comparsa delle prime cellule eucariotiche;
Micros (piccolo) bios (vita) logos (parola)
 Corso di aggiornamento MICROBIOLOGIA Pievesestina 2010 Micros (piccolo) bios (vita) logos (parola) Aspetti generali della microbiologia e delle tecniche analitiche relative Classificazione e regni degli
Corso di aggiornamento MICROBIOLOGIA Pievesestina 2010 Micros (piccolo) bios (vita) logos (parola) Aspetti generali della microbiologia e delle tecniche analitiche relative Classificazione e regni degli
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
 Calendario del II anno A.A. 2016/2017 Le attività in presenza, riferite alle seguenti tematiche: Tempo (Disciplina di riferimento: Biologia/Geologia) Moto (Disciplina di riferimento: Astronomia/Fisica)
Calendario del II anno A.A. 2016/2017 Le attività in presenza, riferite alle seguenti tematiche: Tempo (Disciplina di riferimento: Biologia/Geologia) Moto (Disciplina di riferimento: Astronomia/Fisica)
 http://digilander.libero.it/glampis64 Idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto costituiscono il 99% delle cellule. I composti del carbonio sono chiamati composti organici o molecole organiche. I composti organici
http://digilander.libero.it/glampis64 Idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto costituiscono il 99% delle cellule. I composti del carbonio sono chiamati composti organici o molecole organiche. I composti organici
Insegnamenti SSD CFU
 PAS CLASSE A057 - Scienza degli alimenti PIANO DI STUDIO Tipologia insegnamenti Gruppo A Didattica generale e didattica speciale Insegnamenti SSD CFU Pedagogia e didattica speciale M-PED/0 6 Pedagogia
PAS CLASSE A057 - Scienza degli alimenti PIANO DI STUDIO Tipologia insegnamenti Gruppo A Didattica generale e didattica speciale Insegnamenti SSD CFU Pedagogia e didattica speciale M-PED/0 6 Pedagogia
LA CELLULA BATTERICA. Dimensioni Struttura Componenti fondamentali Componenti accessorie
 LA CELLULA BATTERICA Dimensioni Struttura Componenti fondamentali Componenti accessorie Cosa sono i batteri? I batteri sono organismi semplici, unicellulari, procarioti, di piccole dimensioni. Anche se
LA CELLULA BATTERICA Dimensioni Struttura Componenti fondamentali Componenti accessorie Cosa sono i batteri? I batteri sono organismi semplici, unicellulari, procarioti, di piccole dimensioni. Anche se
Riproduzione molecolare. Riproduzione cellulare. Riproduzione degli organismi. Gametogenesi (femminile e maschile) Fecondazione
 ARGOMENTO STRUTTURA CELLULARE CONCETTO DI REGOLAZIONE GENICA REGOLAZIONE GENICA PROCARIOTI REGOLAZIONE GENICA EUCARIOTI trascrizione e maturazione RNA trasporto nucleo-citoplasma sintesi proteica via secretiva
ARGOMENTO STRUTTURA CELLULARE CONCETTO DI REGOLAZIONE GENICA REGOLAZIONE GENICA PROCARIOTI REGOLAZIONE GENICA EUCARIOTI trascrizione e maturazione RNA trasporto nucleo-citoplasma sintesi proteica via secretiva
PIANO DI LAVORO ANNUALE
 PIANO DI LAVORO ANNUALE Classe 5D2 A.S. 2015/2016 Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Docente: prof.ssa Palma Elena Ore settimanali: 4 (2 laboratorio) Libro di testo: Rippa, Ricciotti La chimica
PIANO DI LAVORO ANNUALE Classe 5D2 A.S. 2015/2016 Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Docente: prof.ssa Palma Elena Ore settimanali: 4 (2 laboratorio) Libro di testo: Rippa, Ricciotti La chimica
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA CDL IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante all esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico) Presidente: Prof.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA CDL IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante all esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico) Presidente: Prof.
per alcune malattie causate da prodotti tossici dell agente (ad es. tossine batteriche) non si può parlare di trasmissibilità Raffaella Baldelli DSMV
 Malattie trasmissibili Malattie sostenute da un agente biologico (agente eziologico), che si trasmette da un individuo ad un altro (ospiti) in natura in modo diretto o indiretto per alcune malattie causate
Malattie trasmissibili Malattie sostenute da un agente biologico (agente eziologico), che si trasmette da un individuo ad un altro (ospiti) in natura in modo diretto o indiretto per alcune malattie causate
Botanica (CFU 5+1) Martedì 11:00-13:00 Venerdì. scienza della diversità I turno 14:00-16:00 2 turno 16:00-18:00. aa
 Botanica (CFU 5+1) Botanica o Biologia vegetale: Lezioni Morfologia vegetale Anatomia vegetale * Citologia vegetale * Martedì 11:00-13:00 Venerdì Fisiologia vegetale * Genetica dei vegetali Biologia molecolare
Botanica (CFU 5+1) Botanica o Biologia vegetale: Lezioni Morfologia vegetale Anatomia vegetale * Citologia vegetale * Martedì 11:00-13:00 Venerdì Fisiologia vegetale * Genetica dei vegetali Biologia molecolare
I CICLI BIOGEOCHIMICI dell'azoto e del FOSFORO (parte II)
 I CICLI BIOGEOCHIMICI dell'azoto e del FOSFORO (parte II) Un video : clic Il ciclo dell'azoto (I) L azoto (N2) è l elemento più abbondante presente nell atmosfera. Se come gas non è respirabile (dal greco
I CICLI BIOGEOCHIMICI dell'azoto e del FOSFORO (parte II) Un video : clic Il ciclo dell'azoto (I) L azoto (N2) è l elemento più abbondante presente nell atmosfera. Se come gas non è respirabile (dal greco
ULSS 2 INCONTRA I mercoledì della Salute
 ULSS 2 INCONTRA I mercoledì della Salute Antibiotici: servono sempre? Relatore: Dr. Vincenzo Catena 05 febbraio 2014 sala Piccolotto Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione U.L.S.S.2 Feltre Direttore
ULSS 2 INCONTRA I mercoledì della Salute Antibiotici: servono sempre? Relatore: Dr. Vincenzo Catena 05 febbraio 2014 sala Piccolotto Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione U.L.S.S.2 Feltre Direttore
per alcune malattie causate da prodotti tossici dell agente (ad es. tossine batteriche) non si può parlare di trasmissibilità Raffaella Baldelli DSMV
 Malattie trasmissibili Malattie sostenute da un agente biologico (agente eziologico), che si trasmette da un individuo ad un altro (ospiti) in natura in modo diretto o indiretto per alcune malattie causate
Malattie trasmissibili Malattie sostenute da un agente biologico (agente eziologico), che si trasmette da un individuo ad un altro (ospiti) in natura in modo diretto o indiretto per alcune malattie causate
Materiale didattico validato da: Il Rischio Biologico. Rev. 2 ott Rischio biologico slide 1 di 16
 Il Rischio Biologico Rev. 2 ott. 2009 Rischio biologico slide 1 di 16 Definizione Consiste nella possibilità di contrarre, in seguito all esposizione a virus, batteri, miceti o funghi (lieviti e muffe),
Il Rischio Biologico Rev. 2 ott. 2009 Rischio biologico slide 1 di 16 Definizione Consiste nella possibilità di contrarre, in seguito all esposizione a virus, batteri, miceti o funghi (lieviti e muffe),
INDICE DEL BOOK DI BIOLOGIA
 INDICE DEL BOOK DI BIOLOGIA SEZIONE A - STRUTTURA E FUNZIONE DEGLI ECOSISTEMI 1 A.1 - FLUSSO DI ENERGIA 1 A.2 - GLI ORGANISMI AUTOTROFI 5 A.3 - GLI ORGANISMI ETEROTROFI 7 A.4 - LA COMPONENTE BIOTICA E
INDICE DEL BOOK DI BIOLOGIA SEZIONE A - STRUTTURA E FUNZIONE DEGLI ECOSISTEMI 1 A.1 - FLUSSO DI ENERGIA 1 A.2 - GLI ORGANISMI AUTOTROFI 5 A.3 - GLI ORGANISMI ETEROTROFI 7 A.4 - LA COMPONENTE BIOTICA E
Facoltà di Scienze Biotecnologiche Corso di Laurea in Biotecnologie per l innovazione di processi e prodotti A.A. 2011/12
 Facoltà di Scienze Biotecnologiche Corso di Laurea in Biotecnologie per l innovazione di processi e prodotti A.A. 2011/12 Titolo insegnamento: Biotecnologie delle fermentazioni (Prof. Luigi Palmieri) integrato
Facoltà di Scienze Biotecnologiche Corso di Laurea in Biotecnologie per l innovazione di processi e prodotti A.A. 2011/12 Titolo insegnamento: Biotecnologie delle fermentazioni (Prof. Luigi Palmieri) integrato
Il progetto LIFE+ BIOSUR: un processo biologico innovativo per una migliore qualità dell'ambiente. E i biologi cosa c'entrano?
 Il progetto LIFE+ BIOSUR: un processo biologico innovativo per una migliore qualità dell'ambiente. E i biologi cosa c'entrano? Claudia Vannini Dipartimento di Biologia Università di Pisa (UNIPI) Nome:
Il progetto LIFE+ BIOSUR: un processo biologico innovativo per una migliore qualità dell'ambiente. E i biologi cosa c'entrano? Claudia Vannini Dipartimento di Biologia Università di Pisa (UNIPI) Nome:
Il SISTEMA IMMUNITARIO
 Il SISTEMA IMMUNITARIO RETE DIFENSIVA CONTRO INFEZIONI MICROBICHE, SOSTANZE ESTRANEE E CANCRO IMMUNOLOGIA: STUDIO DELLE CELLULE, DELLE MOLECOLE E DEI MECCANISMI ATTRAVERSO I QUALI IL S.I. PROTEGGE IL S.I.
Il SISTEMA IMMUNITARIO RETE DIFENSIVA CONTRO INFEZIONI MICROBICHE, SOSTANZE ESTRANEE E CANCRO IMMUNOLOGIA: STUDIO DELLE CELLULE, DELLE MOLECOLE E DEI MECCANISMI ATTRAVERSO I QUALI IL S.I. PROTEGGE IL S.I.
Corso di Microbiologia Generale
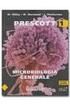 Corso di Microbiologia Generale PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA FORMALE a.a.: 2000-01 %DWWHULRORJLDJHQHUDOH Le tappe fondamentali delle ricerche microbiologiche - le prime osservazioni morfologiche
Corso di Microbiologia Generale PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA FORMALE a.a.: 2000-01 %DWWHULRORJLDJHQHUDOH Le tappe fondamentali delle ricerche microbiologiche - le prime osservazioni morfologiche
PROGRAMMAZIONE INIZIALE
 ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 PROGRAMMAZIONE INIZIALE MATERIA: Scienze Integrate - Biologia INSEGNANTE: Arianna La Rocca CLASSE: 2C SETTORE: Servizi commerciali INDIRIZZO: Pubblicitario FINALITA DELLA DISCIPLINA
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 PROGRAMMAZIONE INIZIALE MATERIA: Scienze Integrate - Biologia INSEGNANTE: Arianna La Rocca CLASSE: 2C SETTORE: Servizi commerciali INDIRIZZO: Pubblicitario FINALITA DELLA DISCIPLINA
