lat. cantare habeo 'ho da cantare' (> 'canterò) > lat. volg. cantare *ao > fior. ant. cantarò > canterò
|
|
|
- Maddalena Masini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A / 2012 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. Il mutamento linguistico: la linguistica storica Premessa: le lingue variano nel tempo Ess.: lat. ĭlle 'quello' > lat. volg. ĭllī > it. antico elli 'egli' > egli lat. cantare habeo 'ho da cantare' (> 'canterò) > lat. volg. cantare *ao > fior. ant. cantarò > canterò ingl. medio meet ['me:t], foot ['fo:t] > ingl. moderno ['mi:t], ['fu:t] dimensione diacronica della variazione
2 Asse della simultaneità / sincronia (A-B) e asse della successione / diacronia (C-D): C A B D (A-B): esclusione dell intervento del tempo (C-D): cambiamenti lungo l asse del tempo (Saussurre, F. de, 1916, Cours de linguistique general, Paris, Éditions Payot & Rivages; trad. it. a cura di Tullio de Mauro, 1967, Bari, Laterza) 2
3 Mutamento linguistico: cambiamenti che avvengono in una lingua nel corso del tempo ai vari livelli di analisi (fonologico, morfologico, sintattico, lessicale) mutamento più veloce del mutamento genetico e biologico, ma più lento dei mutamenti socio-culturali (richiede di norma più di una generazione) Ess.: G. Leopardi, Zibaldone di pensieri (prima metà del XIX sec.) "Passioni, morti, tempeste ec. piacciono egregiamente, benché sian brutte, per questo solo che son bene imitate, (...) perché l uomo niente tanto odia quanto la noia, e però gli piace di veder qualche novità ancorché brutta. Tragedia, commedia, satira han per oggetto il brutto, ed è una mera quistion di nome il contrastar se questa sia poesia. Il brutto, come tutto il resto, deve star nel suo luogo; e nell epica e lirica avrà luogo piú di raro, ma spessissimo nella commedia tragedia satira, ed è quistion di parole ec. come sopra." 3
4 Boccaccio, Decameron, novella di Chichibio (metà del XIV sec.) "A Currado piacque tanto questa risposta, che tutta la sua ira si convertì in festa e riso, e disse: - Chichibio, tu hai ragione, ben lo doveva fare. Così adunque con la sua pronta e sollazzevol risposta Chichibio cessò la mala ventura e paceficossi col suo signore" lat. Conradus / Corradus > Currado (cfr. cŏcīna(m) > cucina) lat. debēba(m) > doveva > dovevo (cfr. pres. ind. devo) paceficossi > si rappacificò (cfr. maravigliomi, dissegli) U. Foscolo (inizio XIX sec.): "ma il cavallo più s'irritava e più impetusosamente lanciavasi" G. Carducci (XIX sec.): "Io chiedo i baci tuoi, se l'ombra avvolgemi" cfr. dicasi, volevasi, affittasi... (Patota, G., Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Bologna, Il Mulino) 4
5 Es./2: pronome soggetto egli vs. lui, ella vs. lei "costei abbracciò Salabaetto, et egli lei (...)" (Boccaccio, Decameron, ottava giornata, novella decima) Pietro Bembo, Prose della Volgar Lingua (XVI sec.): "Dunque se esso Adamo fu nobile, tutti siamo nobili, e se lui fu vile, tutti siamo vili" (Dante, Convivio, IV 15 4) "Egli, tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi, come se leggesse, spingeva lo sguardo in su, per ispiar le mosse di coloro; e, vedendoseli venir proprio incontro, fu assalito a un tratto da mille pensieri. (...) '... Disposto... disposto sempre all ubbidienza'. E, proferendo queste parole, non sapeva nemmen lui se faceva una promessa, o un complimento." "(...) e lui continuò allora a raccontare altre di quelle belle cose. (...) Il conte zio dovette anche lui lasciar parlare un poco, e stare a sentire (...)" (A. Manzoni, I promessi sposi, 1840) 5
6 Caratterizzazione diamesica del mutamento: La lingua scritta è di norma più 'conservatrice' rispetto alla lingua parlata, i cambiamenti avvengono inizialmente nel parlato e poi possono essere (più o meno) gradualmente accettati nello scritto (formale, sorvegliato) Es.: grafia 'corretta' vs. grafia 'scorretta' del latino nell'appendix Probi (III sec. d.c.) speculum non speclum (it. specchio) columna non colomna (it. colonna) auris non oricla (it. orecchia) Februarius non Febrarius (it. febbraio) turma non torma (it. torma) le forme di destra riflettono con ogni probabilità il latino parlato rilevante anche la dimensione diastratica (Patota, G., Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Bologna, Il Mulino) 6
7 Mutamento 'in atto' Italiano: lingua SVO Claudio saluta Marcello vs. Marcello saluta Claudio SOGGETTO OGGETTO SOGGETTO OGGETTO Latino: lingua SOV Claudius Marcellum salutat ma cfr. Claudius salutat Marcellum, Marcellum salutat Claudius, Marcellum salutat Claudius... SOV (flessibile) > SVO Latino tardo, vulgata editio della Bibbia di S. Gerolamo (IV-V sec.): Homo quidam descendebat ab Hierusalem in Hiericho et incidit in latrones, qui etiam SOGGETTO VERBO VERBO SOGGETTO despoliaverunt eum et plagis inpositis abierunt (...) VERBO OGGETTO (Patota, G., Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Bologna, Il Mulino) 7
8 Latino 'pompeiano' (iscrizioni murali di Pompei, 79 d.c.): SOV: 57% SVO: circa 33% OVS, OSV, VSO, VOS: circa 10% NA: 65.5% AN: 34.5% GN: 30.5% NG: 69.5% NRel: 100% RelN: 0% Posp: solo due occorrenze, il resto Prep italiano, spagnolo, francese, portoghese, rumeno: SVO, NA, NG, NRel, Prep latino pompeiano come tipo 'di transizione' tra Testa-Complementi e Complementi-Testa (Banfi, E., Grandi, N., 2003, Lingue d'europa, Roma, Carocci) cfr. Boccaccio, Alfieri, Bembo, Verri: utilizzo di SOV per imitare il modello Latino cfr. E. Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato (SOV) 8
9 1.1 Gli 'stati di lingua' Premessa: una lingua storico-naturale è un sistema in continuo mutamento, ma i risultati di questi cambiamenti sono visibili solo dopo un certo lasso temporale mutamenti graduali e progressivi Stato di lingua: denominazione di una fase storica di una lingua, distinguibile dagli stati precedenti e da quelli successivi per una serie di caratteristiche Es.: periodizzazione della lingua inglese Inglese antico (o 'anglosassone'): VII sec. d. C. - inizio dell'xi sec. Inglese medio (middle English): XI sec. - inizio del XVI sec. invasione normanna, acquisizione di numerosi lessemi franco-normanni e latini, notevole semplificazione della morfologia, ordine delle parole più flessibile Inglese moderno: dal XVI sec. in poi Great vowel shift (meet ['me:t], foot ['fo:t] > ['mi:t], ['fu:t]), ulteriore semplificazione della morfologia verbale, stabilizzazione di alcuni verbi ausiliari ( do interrogativo, get passivo), fissazione dell'ordine VO, etc. 9
10 L'italiano 'deriva' dal latino? Stati di lingua vs. nascita di una nuova lingua: "Cambiamenti locali multipli in parti diverse del sistema possono sommarsi e ingrandire via via le differenze fra una stato di lingua e l'altro, al punto tale che ad un certo momento, quando uno stato di lingua risulti così cambiato rispetto ai precedenti da non essere più riconoscibile dai parlanti come 'quella lingua', si è in presenza di una nuova lingua." criterio della 'mancanza di comprensibilità': se due stati di lingua non sono reciprocamente comprensibili (se i parlanti 'moderni' non comprendo la lingua 'antica'), allora è nata una nuova lingua (lingua madre > lingua/e figlia/e) (Berruto, G., Cerruti, 2011, La linguistica: un corso introduttivo, Torino, UTET) cfr. Patota: "L'italiano non deriva (cioè non nasce) dal latino, ma continua il latino: una tradizione ininterrotta lega la lingua di Roma antica alla lingua di Roma moderna, dai tempi remoti della fondazione fino ai giorni nostri. Si può dire, in buona sostanza, che l'italiano è il latino adoperato oggi in Italia, così come il portoghese, lo spagnolo e il francese sono i latini adoperati oggi in Portogallo, in Spagna e in Francia." (Patota, G., Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Bologna, Il Mulino) 10
11 Es.: dal Vangelo secondo Matteo (8:20) "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo" (King James Bible, 1611) (Inglese antico, ca d.c.) il testo in inglese antico è sostanzialmente irriconoscibile ed incomprensibile per un parlante medio di inglese moderno (Lass, R., 2006, Phonology and Morphology, in Hogg, R. & Denison, D., A Historry of The English Language, Cambridge, CUP) 11
12 cfr. la situazione linguistica degli stati dell'ex-jugoslavia: Fino al 1991 (Yugoslavia socialista): lingua ufficiale il 'serbo-croato' Situazione attuale: serbo, croato, bosniaco e (dal 2007) montenegrino Italia dei 'volgari' Latino: lingua scritta, lingua di prestigio Volgari locali: varie forme, affermazione del volgare fiorentino del XIII-XIV sec. prima grammatica di 'italiano': Regole della lingua fiorentina (ca. 1450) di Leon Battista Alberti P. Bembo, 1525, Prose della Volgar Lingua: lingua letteraria a base toscana (Petrarca modello per la poesia, Boccaccio per la prosa), toscano urbano della classe colta di Firenze. 12
13 2. I meccanismi del mutamento Variazione diastratica (legata allo 'strato sociale' di appartenenza del parlante): il mutamento può avvenire all'interno di un gruppo o di più gruppi sociali (frequentemente, parlanti giovani) se il gruppo ha un certo prestigio nella società di riferimento, l'innovazione sarà accettata anche dagli altri gruppi di parlanti ruolo dell'individuo: singoli individui, caratterizzati da un particolare ruolo sociale o da una certa mobilità sociale, possono introdurre innovazioni che, se adottate da gruppi sufficientemente numerosi di parlanti, possono diventare effettivi mutamenti nel sistema lingua Es.: 'creazione' dell'italiano letterario da parte di Dante Alighieri (Luraghi, S., 2006, Introuduzione alla lingustica storica, Roma, Carocci) 13
14 Es.: sonorizzazione delle occlusive intervocaliche nel gruppo romanzo Lat. mercātus > sp. mercado, port. mercado, it. mercato Lat. acūtŭs > sp. agudo, fr. aigu, it. acuto ma cfr. Lat. lacŭ(m), spīca(m), acŭ(m) > it. lago, spiga, ago nel toscano, circa metà delle occlusive si sono sonorizzate; pronuncia sonorizzata come 'moda', imitazione della pronuncia settentrionale (dei commercianti ed artigiani del nord che nel medioevo si spostarono verso la Toscana, soprattutto Pisa e Lucca; cfr. le forme oga, duga, pogo) cfr. figo vs. fico nell'italiano contemporaneo (Patota, G., Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Bologna, Il Mulino) 14
15 importanza di tutte le dimensioni della variazione sincronica (diastratica, diafasica, diatopica) Es.: lat. ē > ant. fr. ei > oi > fr. mod. ['wa] (lat. tectu(m) > ant. fr. teit > fr. toit ['twa]) (a) ei > oi attestato nell'area galloromanza orientale (X sec.), dal XII sec. si diffonde anche nell'area di Parigi (b) oi > ue ([we]) dal XIII sec (c) ue > ua [wa] dal XIV sec.; la pronuncia [wa] è comune negli strati più umili della popolazione, viene considerata rozza, accettata solo per alcune parole a partire dal XVIII sec. (d) Rivoluzione Francese [wa] diventa la pronuncia standard (ma cfr. la grafia toit) (Lazzeroni, R., 1987/1998, Il mutamento linguistico, in Lazzeroni, R. (a cura di), Linguistica storica, Roma, Carocci) 15
16 Ruolo del contatto linguistico (1) Influsso di sostrato: se una lingua A viene imposta in un territorio dove si parla una lingua B, o i parlanti di B adottano più o meno volontariamente la lingua A, portando alla scomparsa di B, la lingua B può lasciare delle 'tracce' nella lingua A Es.: presenza di vocali anteriori arrotondate nei dialetti dell'italia settentrionale (milanese lüna) e in Francia (fr. une, aigu) probabile effetto del sostrato celtico della Gallia cisalpina e transalpina romane; toponimi celtici in ago (Assago) e ate (Biandrate) (Luraghi, S., 2006, Introuduzione alla lingustica storica, Roma, Carocci) (2) Influsso di superstrato: se una lingua A viene portata in un territorio dove si parla una lingua B, ma la lingua B sopravvive pur se i parlanti di A detengono il potere politico o economico, la lingua A può lasciare delle 'tracce' nella lingua B Es.: influsso del francese dei conquistatori normanni sull'inglese medio al livello del lessico (beef, royal, liberty), della morfologia derivazionale ( ment, able) e della prosodia (accento di parola) (Hogg, R., Denison, D., 2006, Overview, in Hogg, R. & Denison, D., A Historry of The English Language, Cambridge, CUP) 16
17 Es./2: influsso romanzo (siculo-italiano) e inglese sulla morfologia del maltese, lingua afro-asiatica karta 'carta', bravu 'bravo plur. karti, bravi kuker (< cooker), lig (< league) plur. kukers, ligs versus: skola > plur. skejjel (Banfi, E., Grandi, N., 2003, Lingue d'europa, Roma, Carocci) (3) Influsso di adstrato: se una lingua A e una lingua B convivono in un territorio o sono comunque in contatto senza che nessuna delle due sia nettamente più prestigiosa dell'altra, in un rapporto paritario, esse possono influenzarsi a vicenda Es.: tratti comuni delle lingue dei Balcani (principalmente, albanese, neogreco, bulgaro, macedone, serbo e croato) articolo determinativo posposto alb. mik amico vs. mik-u l'amico rum. om uomo vs. om-ul l uomo blg. krava mucca vs. krava-ta la mucca (Banfi, E., 1991, Storia linguistica del sud-est europeo, Milano, Franco Angeli) 17
18 Cause 'interne' del mutamento: alcuni esempi Mutamento fonologico: economia articolatoria Es.: assimilazione lat. octo, lacte(m), factu(m) > it. otto, latte, fatto lat. fixare, saxu(m) > it. fissare, sasso lat. aptu(m), scrīptu(m) > it. atto, scritto N.B.: "Se è vero che le lingue tendono, in generale, verso forme 'naturali', (...) è anche vero il contrario. Le nozioni di 'naturalezza' e 'marcatezza' derivano da osservazioni empiriche e indicano perciò processi probabili, non necessari. Una assimilazione come quella dell'it. otto < otto è comune a molte lingue. Ma in altre come, per esempio, nel greco antico il processo non avviene. (...)" (Lazzeroni, R., 1987/1998, Il mutamento linguistico, in Lazzeroni, R. (a cura di), Linguistica storica, Roma, Carocci) 18
19 Mutamento morfologico: livellamento analogico riduzione dell'allomorfia Es.: lat. debēba(m) > doveva > dovevo (cfr. pres. ind. devo) lat. legēba(m) > leggeva > leggevo (cfr. pres. ind. leggo) ingl. antico cu [ku:] 'mucca' > [kaʊ] cy [ky:] 'mucche' > [kai ] > cows [kaʊz] analogia con stones, boys, rivers... ingl. mod. hang - hung - hung vs. hang - hanged - hanged dream - dreamt - dreamt vs. dream - dreamed - dreamed analogia con i verbi 'regolari' ma cfr. foot - feet, goose - geese, go - went - gone... 19
20 nozione di 'deriva' (drift): il mutamento linguistico non è completamente casuale, ma segue delle 'correnti' che vanno in una direzione preferenziale, le variazioni individuali sono accettate solo se seguono la corrente (Sapir, E., 1921/2007, Il linguaggio: introduzione alla linguistica. Torino, Einaudi) "Il mutamento linguistico non è prevedibile. (...) Anche se si ammette che il mutamento risponde alla tendenza ad organizzare il materiale linguistico in modo coerente ed economico, a imporre ordine e regolarità al sistema (il che non è sempre vero), avremo individuato le condizioni e i fini non le cause, del mutamento." (Lazzeroni, R., 1987/1998, Il mutamento linguistico, in Lazzeroni, R. (a cura di), Linguistica storica, Roma, Carocci) 20
21 2.1 Il mutamento fonetico Leggi fonetiche: mutamenti fonetici che si applicano in tutti i casi pertinenti, in una determinata lingua e in un determinato periodo Latino > Italiano iacēre giacere iŏcare giocare [j] > [ʤ] *iōvene(m) giovane planŭ(m) piano clave(m) chiave C+ [l] > C + [j] flōre(m) fiore ma cfr. Flōra(m) > flora, gloria(m) > gloria; parole dotte 21
22 Legge di Grimm (parziale): Latino Greco antico Sanscrito Gotico Inglese pater patḗr pitár fadar father decem déka dáśa taíhun ten caput kaput haubiþ head corrispondenze sistematiche tra consonanti di latino, greco, sanscrito (e altre lingue indoeuropee) e consonanti delle lingue germaniche rotazione consonantica: p > f, d > t, k > h occlusive sorde > fricative sorde, occlusive sonore > occlusive sorde, etc. (Luraghi, S., 2006, Introuduzione alla lingustica storica, Roma, Carocci) cfr. ingl. paternal < ant. fr. paternal < lat. paternālis (latino classico paternus) 22
23 Altri tipi di mutamento fonetico (a) Assimilazione (lat. macĕrare [make'rare] > [maʧe'rare]) e dissimilazione (lat. arbore(m) > it. albero, sp. arbol) (b) metatesi (lat. fābula(m) > *flaba > fiaba) (c) caduta di foni: aferesi (lat. apothēca(m) > it. bottega), sincope (lat. dŏmīna(m) > dŏmna(m) > it. donna) e apocope (lat. civitate(m) > *civtate > *cittate > *cittade > it. città) (d) aggiunta di foni: pro(s)tesi (lat. stătu(m) > sp. estado), epentesi (lat. baptismu(m) > it. battesimo) e epitesi (lat. cŏr > it. cuore) (e) fonologizzazione (fr. bonté [b n'te] > [b 'te] vs. botté [b 'te]), defonologizzazione (lat. rosă nominativo vs. rosā ablativo > lat. tardo rosa) e perdita di fonemi (lat. [h]) 23
24 2.2 Il mutamento morfologico Perdita di distinzioni: Latino bonus 'buono' Singolare Plurale maschile femminile neutro maschile femminile neutro Nominativo bonus bona bonum bonī bonae bona Genitivo bonī bonae bonī bonōrum bonārum bonōrum Dativo bonō bonae bonō bonīs bonīs bonīs Accusativo bonum bonam bonum bonōs bonās bona Ablativo bonō bonā bonō bonīs bonīs bonīs Vocativo bone bona bonum bonī bonae bona > aggettivo italiano (a quattro uscite): buono, buona, buoni, buone 24
25 Rianalisi e grammaticalizzazione Passato prossimo italiano (e romanzo) Lat. multa bona bene parta habemus 'abbiamo molti beni (che sono stati) ben procurati' cfr. it. ho gli occhi aperti haec omnia probatum habemus 'abbiamo provato tutte queste cose' (II sec. a.c.) (IV sec. d.c.) mancanza di accordo tra omnia e probatum rianalisi di probatum habemus come costruzione verbale cfr. it. ho aperto gli occhi Grammaticalizzazione del verbo habeo: da parola 'piena', dal significato lessicale (verbo) a parola 'vuota', dal significato grammaticale (ausiliare) cfr. lat. mĕnte (ablativo di mens): turbata mĕnte 'con spirito turbato', lenta mĕnte 'con spirito non pronto' > it. mente 'suffisso derivazionale che forma avverbi da aggettivi' (giuridicamente, prossimamente) 25
26 2.3 Il mutamento lessicale e semantico (a) Mutamenti semantici per somiglianza (metafora): lat. tĕsta(m) 'vaso di terra' > 'cranio' > 'testa' (cfr. lat. caput) (b) Mutamenti semantici per contiguità (metonimia): lat. bŭcca(m) 'guancia' > 'bocca' (cfr. lat. ōs 'bocca', it. orale) (c) Paretimologia (folk etymology): lat. cŭbāre 'giacere' > it. covare (associazione tra ova e 'uova'); sp. Armbrust 'balestra' < fr. arbalestre < lat. arcuballista Arm 'braccio' + Brust 'petto' (d) Estensioni di significato: lat. caballus 'cavallo da lavoro' > it. cavallo, lat. dŏmīna(m) 'padrona di casa' > it. donna; lat. panarium 'cesto del pane' > it. paniere 'cesto' (e) Restringimenti di significato: lat. necare 'uccidere' > it. annegare, fr. noyer; ingl. ant. mete 'cibo' > ingl. mod. meat 'carne'; fr. viande 'cibo' > 'carne' (f) Creazione di eufemismi per parole tabù: lat. mustēla, it. donnola, fr. belette, sp. comadreja ('comare'), port. doninha, romeno nevasta 'fidanzata'; cfr. svedese jungfru 'ragazza' 26
lat. cantare habeo ho da cantare (> canterò) > lat. volg. cantare *ao > fior. ant. cantarò > canterò
 Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2012 / 2013 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. Il mutamento linguistico: la linguistica storica
Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2012 / 2013 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. Il mutamento linguistico: la linguistica storica
lat. cantare habeo ho da cantare (> canterò) > lat. volg. cantare *ao > fior. ant. cantarò > canterò
 Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2013 / 2014 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. Il mutamento linguistico: la linguistica storica
Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2013 / 2014 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. Il mutamento linguistico: la linguistica storica
Il latino pompeiano: quando la diacronia spiega la sincronia
 Il latino pompeiano: quando la diacronia spiega la sincronia P. Ramat (1984): L importanza di un esame delle iscrizioni pompeiane dal punto di vista linguistico è evidente: abbiamo a che fare con uno dei
Il latino pompeiano: quando la diacronia spiega la sincronia P. Ramat (1984): L importanza di un esame delle iscrizioni pompeiane dal punto di vista linguistico è evidente: abbiamo a che fare con uno dei
Brevi note di filologia romanza (per gli studenti del 1 Liceo Classico) Giuliano Cianfrocca 2014
 * Brevi note di filologia romanza (per gli studenti del 1 Liceo Classico) 01 Concorrenza tra greco e latino L Impero romano, a partire dal I secolo d.c., si presenta come sostanzialmente bilingue, almeno
* Brevi note di filologia romanza (per gli studenti del 1 Liceo Classico) 01 Concorrenza tra greco e latino L Impero romano, a partire dal I secolo d.c., si presenta come sostanzialmente bilingue, almeno
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/ anno
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOLOGIA ROMANZA 9 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento MARIO PAGANO Email: mapagano@unict.it
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOLOGIA ROMANZA 9 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento MARIO PAGANO Email: mapagano@unict.it
DIPARTIMENTO LETTERE CLASSICO LINGUISTICO DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico)
 Educazione linguistica: Educazione letteraria: Produzione scritta: DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico) morfologia: il verbo. Sintassi: gli elementi fondamentali di analisi della proposizione.
Educazione linguistica: Educazione letteraria: Produzione scritta: DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico) morfologia: il verbo. Sintassi: gli elementi fondamentali di analisi della proposizione.
BFLR A Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA. edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto
 BFLR A 351667 Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto INDICE ABBREVIATURE 1. Principali abbreviature usate, p. 11 n INTRODUZIONE
BFLR A 351667 Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto INDICE ABBREVIATURE 1. Principali abbreviature usate, p. 11 n INTRODUZIONE
Linguistica italiana. Lezione introduttiva
 Linguistica italiana Lezione introduttiva L italiano nella Romània Latino volgare La lingua italiana è lo sviluppo del latino parlato nel territorio italiano Si tratta però non del latino classico, bensì
Linguistica italiana Lezione introduttiva L italiano nella Romània Latino volgare La lingua italiana è lo sviluppo del latino parlato nel territorio italiano Si tratta però non del latino classico, bensì
PROGRAMMA. Istituto: LICEO ADOLFO VENTURI. Prof.: Francesco Gallo. Materia d insegnamento: Italiano. Classe: 1 a D BIENNO COMUNE
 PROGRAMMA Anno Scolastico 2015/2016 Istituto: LICEO ADOLFO VENTURI Prof.: Francesco Gallo Materia d insegnamento: Italiano Classe: 1 a D BIENNO COMUNE Data di presentazione: 4/06/2016 CONTENUTO Modulo
PROGRAMMA Anno Scolastico 2015/2016 Istituto: LICEO ADOLFO VENTURI Prof.: Francesco Gallo Materia d insegnamento: Italiano Classe: 1 a D BIENNO COMUNE Data di presentazione: 4/06/2016 CONTENUTO Modulo
La tipologia e gli universali
 La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
Sistema vocalico del latino: ă vs. ā, ŏ vs. ō, ĕ vs. ē, ĭ vs. ī, ŭ vs. ū (es. mălum il male vs. mālum mela o pŏpulus popolo vs.
 Sistema vocalico del latino: ă vs. ā, ŏ vs. ō, ĕ vs. ē, ĭ vs. ī, ŭ vs. ū (es. mălum il male vs. mālum mela o pŏpulus popolo vs. pōpulus pioppo ) Passaggio dal latino alle lingue romanze: distinzioni di
Sistema vocalico del latino: ă vs. ā, ŏ vs. ō, ĕ vs. ē, ĭ vs. ī, ŭ vs. ū (es. mălum il male vs. mālum mela o pŏpulus popolo vs. pōpulus pioppo ) Passaggio dal latino alle lingue romanze: distinzioni di
STORIA DELLA LINGUA TEDESCA
 STORIA DELLA LINGUA TEDESCA PROF. LUCA PANIERI A.A. 2012-2013 Libera Università di Lingue e comunicazione IULM Introduzione Il corso viene tenuto dal professor Luca Panieri e si occupa di tracciare la
STORIA DELLA LINGUA TEDESCA PROF. LUCA PANIERI A.A. 2012-2013 Libera Università di Lingue e comunicazione IULM Introduzione Il corso viene tenuto dal professor Luca Panieri e si occupa di tracciare la
GLOTTOLOGIA Giacomo Ferrari
 GLOTTOLOGIA Giacomo Ferrari ferrari@lett.unipmn.it Unità 1: Delimitazione del dominio scientifico GLOTTOLOGIA Il termine Glottologia è stato creato circa un secolo e mezzo fa come pseudo-derivato dal greco
GLOTTOLOGIA Giacomo Ferrari ferrari@lett.unipmn.it Unità 1: Delimitazione del dominio scientifico GLOTTOLOGIA Il termine Glottologia è stato creato circa un secolo e mezzo fa come pseudo-derivato dal greco
La morfologia. (Giannini, S. (1994), Morfologia, in Beccaria, G.L. (a cura di), Dizionario di linguistica, Torino, Einaudi)
 La morfologia Studio del valore grammaticale dei morfemi e, nelle lingue flessive, delle relative regole flessionali, in rapporto alla composizione delle parti del discorso (De Mauro, T. (1999), GRADIT,
La morfologia Studio del valore grammaticale dei morfemi e, nelle lingue flessive, delle relative regole flessionali, in rapporto alla composizione delle parti del discorso (De Mauro, T. (1999), GRADIT,
Consonantismo dal latino all italiano (4)
 Consonantismo dal latino all italiano (4) Sonorizzazione delle sorde intervocal. (o tra voc. e /r/) e di S Nell italiano di oggi in alcuni casi abbiamo la sonora, in altri la sorda: (H)OSPITALE(M) > ospedale
Consonantismo dal latino all italiano (4) Sonorizzazione delle sorde intervocal. (o tra voc. e /r/) e di S Nell italiano di oggi in alcuni casi abbiamo la sonora, in altri la sorda: (H)OSPITALE(M) > ospedale
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
 BRUNO MIGLIORINI STORIA DELLA LINGUA ITALIANA Sansoni Editore INDICE DEI CAPITOLI 'REMESSA pp. vn-xi BIBLIOGRAFIA pp. xm-xvi - LA LATINITÀ D'ITALIA IN ETÀ IMPERIALE pp. 1-43 1. Da Augusto a Odoacre, p.
BRUNO MIGLIORINI STORIA DELLA LINGUA ITALIANA Sansoni Editore INDICE DEI CAPITOLI 'REMESSA pp. vn-xi BIBLIOGRAFIA pp. xm-xvi - LA LATINITÀ D'ITALIA IN ETÀ IMPERIALE pp. 1-43 1. Da Augusto a Odoacre, p.
4) Con la fine dell Impero romano (476 d.c.) il latino fu sostituito dalle lingue romanze negli atti ufficiali e nel parlato.
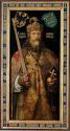 1) La differenza tra documento e monumento sta nel fatto che: a) i documenti sono cartacei, i monumenti lapidei b) il documento è una scrittura non fatta per durare, il monumento sì c) il documento è personale,
1) La differenza tra documento e monumento sta nel fatto che: a) i documenti sono cartacei, i monumenti lapidei b) il documento è una scrittura non fatta per durare, il monumento sì c) il documento è personale,
MA IL LATINO, DA DOVE DERIVA?
 MA IL LATINO, DA DOVE DERIVA? Per scoprirlo dobbiamo andare molto indietro nel tempo sul colle Palatino, a Roma, sono stati rinvenuti fondi di capanne risalenti circa al X sec. A.C.. L area poi occupata
MA IL LATINO, DA DOVE DERIVA? Per scoprirlo dobbiamo andare molto indietro nel tempo sul colle Palatino, a Roma, sono stati rinvenuti fondi di capanne risalenti circa al X sec. A.C.. L area poi occupata
La nascita delle forme verbali perifrastiche nelle lingue romanze
 La nascita delle forme verbali perifrastiche nelle lingue romanze Premesse generali: Tempo: collocazione temporale del discorso (in genere rispetto al momento dell'enunciazione) Es. presente passato futuro
La nascita delle forme verbali perifrastiche nelle lingue romanze Premesse generali: Tempo: collocazione temporale del discorso (in genere rispetto al momento dell'enunciazione) Es. presente passato futuro
Taranproject - Occhi di mari
 Taranproject-Occhi di mari Perla d argentu e occhi di mari, di la Calabria tu sì la reggina. La notti nta lu sonnu mi cumpari, cuntentu mi risbigghju ogni matina. Guardandu eu li stiddi i sta nuttata li
Taranproject-Occhi di mari Perla d argentu e occhi di mari, di la Calabria tu sì la reggina. La notti nta lu sonnu mi cumpari, cuntentu mi risbigghju ogni matina. Guardandu eu li stiddi i sta nuttata li
Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo
 Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo mirco.fasolo@unimib.it Bibliografia Testi obbligatori - D amico, Devescovi (2003). Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci: Roma.
Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo mirco.fasolo@unimib.it Bibliografia Testi obbligatori - D amico, Devescovi (2003). Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci: Roma.
La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico)
 La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo sono
La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo sono
Introduzione. L idea che le diverse lingue derivino tutte da un unica lingua originaria è molto antica
 Introduzione L idea che le diverse lingue derivino tutte da un unica lingua originaria è molto antica Il mito di Babele (Genesi, 11): la lingua primitiva dell umanità sarebbe stata una sola, l ebraico
Introduzione L idea che le diverse lingue derivino tutte da un unica lingua originaria è molto antica Il mito di Babele (Genesi, 11): la lingua primitiva dell umanità sarebbe stata una sola, l ebraico
Premessa 11 [PARTE PRIMA I LE STRUTTURE DELL'ITALIANO D'OGGI
 Premessa 11 [PARTE PRIMA I LE STRUTTURE DELL'ITALIANO D'OGGI 1.1. Fonetica e fonologia 17 1.1.1. fonetica e fonologia, foni e fonemi 17 1.1.2. La produzione dei suoni 18 1.1.3. Le vocali 20 1.1.4. Le consonanti
Premessa 11 [PARTE PRIMA I LE STRUTTURE DELL'ITALIANO D'OGGI 1.1. Fonetica e fonologia 17 1.1.1. fonetica e fonologia, foni e fonemi 17 1.1.2. La produzione dei suoni 18 1.1.3. Le vocali 20 1.1.4. Le consonanti
DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N. Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato.
 DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N Contenuti da recuperare Tipologia della prova Modalità di recupero Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato. -
DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N Contenuti da recuperare Tipologia della prova Modalità di recupero Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato. -
I - classificazione delle lingue romanze. latino volgare
 FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA a.a. 2015-2016 (LM 37) PROF. AGGREGATO BEATRICE FEDI I - classificazione delle lingue romanze. latino volgare 1 ROMÁNIA / ROMANZO 2 Romanzo: dall avverbio latino romanice
FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA a.a. 2015-2016 (LM 37) PROF. AGGREGATO BEATRICE FEDI I - classificazione delle lingue romanze. latino volgare 1 ROMÁNIA / ROMANZO 2 Romanzo: dall avverbio latino romanice
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/ anno
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/2017-1 anno LINGUISTICA GENERALE 9 CFU - 1 semestre Docente titolare dell'insegnamento SALVATORE SGROI OBIETTIVI FORMATIVI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/2017-1 anno LINGUISTICA GENERALE 9 CFU - 1 semestre Docente titolare dell'insegnamento SALVATORE SGROI OBIETTIVI FORMATIVI
3. La classificazione tipologica
 3. La classificazione tipologica Due lingue sono tipologicamente correlate se manifestano una o più caratteristiche comuni questa correlazione è indipendente dal fatto che tali lingue siano apparentate
3. La classificazione tipologica Due lingue sono tipologicamente correlate se manifestano una o più caratteristiche comuni questa correlazione è indipendente dal fatto che tali lingue siano apparentate
LICEO SCIENTIFICO GIORDANO BRUNO MESTRE - VENEZIA
 LICEO SCIENTIFICO GIORDANO BRUNO MESTRE - VENEZIA Anno scolastico 2010-2011 Classe 2^ C Materie: ITALIANO Docente: ONGARO GIANPIETRO Oggetto: PROGRAMMAZIONE ANNUALE La classe è composta di 24 alunni, palesa
LICEO SCIENTIFICO GIORDANO BRUNO MESTRE - VENEZIA Anno scolastico 2010-2011 Classe 2^ C Materie: ITALIANO Docente: ONGARO GIANPIETRO Oggetto: PROGRAMMAZIONE ANNUALE La classe è composta di 24 alunni, palesa
Linguistica generale prof. Nicola Grandi
 Linguistica generale prof. Nicola Grandi Per l'esame da 12 cfu: 10-12 cfu: Berruto, G. / Cerruti, M. (2011), La linguistica. Un corso introduttivo, Torino, UTET Grandi, N. (a cura di) (2011), Dialoghi
Linguistica generale prof. Nicola Grandi Per l'esame da 12 cfu: 10-12 cfu: Berruto, G. / Cerruti, M. (2011), La linguistica. Un corso introduttivo, Torino, UTET Grandi, N. (a cura di) (2011), Dialoghi
Indice. 1. Pittogrammi e ideogrammi Ilogogrammi 35. Premessa 11. Le origini del linguaggio 13. II. Gli animali e il linguaggio umano 21
 Indice Premessa 11 Le origini del linguaggio 13 1. L'origine divina 13 2. La teoria dei suoni naturali 14 3. La teoria dell'adattamento fisico 15 4. Denti, labbra, bocca, laringe e faringe 16 5. Il cervello
Indice Premessa 11 Le origini del linguaggio 13 1. L'origine divina 13 2. La teoria dei suoni naturali 14 3. La teoria dell'adattamento fisico 15 4. Denti, labbra, bocca, laringe e faringe 16 5. Il cervello
Gli abitanti d Europa
 Gli abitanti d Europa La popolazione POPOLO E POPOLAZIONE Un popolo è un gruppo di persone caratterizzate da: stesso modo di vivere stessa lingua e cultura. La popolazione è l insieme degli abitanti che
Gli abitanti d Europa La popolazione POPOLO E POPOLAZIONE Un popolo è un gruppo di persone caratterizzate da: stesso modo di vivere stessa lingua e cultura. La popolazione è l insieme degli abitanti che
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 ISTITUTO DI ISTRUZI SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI - Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: X LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate LICEO TECNICO ISTITUTO TECNICO
ISTITUTO DI ISTRUZI SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI - Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: X LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate LICEO TECNICO ISTITUTO TECNICO
La tipologia sintattica
 La tipologia sintattica 1. La frase indipendente dichiarativa assertiva: l ordine di soggetto, verbo e oggetto 1) Parametri di indagine: a) posizione del soggetto (S) b) posizione dell oggetto diretto
La tipologia sintattica 1. La frase indipendente dichiarativa assertiva: l ordine di soggetto, verbo e oggetto 1) Parametri di indagine: a) posizione del soggetto (S) b) posizione dell oggetto diretto
Area linguistica (o Sprachbund):
 Area linguistica (o Sprachbund): regione geografica in cui alcuni tratti linguistici si sono propagati a seguito di una profonda contaminazione interlinguistica, cioè a seguito del contatto tra le lingue
Area linguistica (o Sprachbund): regione geografica in cui alcuni tratti linguistici si sono propagati a seguito di una profonda contaminazione interlinguistica, cioè a seguito del contatto tra le lingue
PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO. Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto. Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia
 PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO Docenti Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto Insegnamento LINGUISTICA GENERALE Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia 1.1. Alfabeti e corrispondenza biunivoca;
PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO Docenti Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto Insegnamento LINGUISTICA GENERALE Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia 1.1. Alfabeti e corrispondenza biunivoca;
Linguistica Generale prof. dr. Giorgio Francesco Arcodia MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO
 Linguistica Generale prof. dr. Giorgio Francesco Arcodia MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO 1) Definire ed illustrare con esempi la nozione di ricorsività : 2) Identificare e descrivere i morfemi contenuti
Linguistica Generale prof. dr. Giorgio Francesco Arcodia MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO 1) Definire ed illustrare con esempi la nozione di ricorsività : 2) Identificare e descrivere i morfemi contenuti
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica. La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio. L articolo
 Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
Indice. Introduzione. Unità I. Unità 2. Unità Unità Unità Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica
 Indice Introduzione Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica Unità I 1.1. I1 latino lingua indoeuropea / 1.2. Le fasi della lingua latina / 11.1. L alfabeto latino / 11.2. La pronuncia del
Indice Introduzione Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica Unità I 1.1. I1 latino lingua indoeuropea / 1.2. Le fasi della lingua latina / 11.1. L alfabeto latino / 11.2. La pronuncia del
Corso di laurea in Comunicazione Interculturale A. A / 2016 Linguistica Generale Prof. Giorgio Francesco Arcodia
 Corso di laurea in Comunicazione Interculturale A. A. 2015 / 2016 Linguistica Generale Prof. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. Le funzioni della lingua Il linguaggio umano è caratterizzato
Corso di laurea in Comunicazione Interculturale A. A. 2015 / 2016 Linguistica Generale Prof. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. Le funzioni della lingua Il linguaggio umano è caratterizzato
Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente, beneficiario, strumento, ecc.
 Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA. PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 2015
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 201 Materia d insegnamento: ITALIANO Classe 3^ sezione G Prof.ssa Linda Billi LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 201 Materia d insegnamento: ITALIANO Classe 3^ sezione G Prof.ssa Linda Billi LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
Le varietà dell italiano: Standard e Neostandard
 Le varietà dell italiano: Standard e Neostandard Occupiamoci ancora nello specifico della varietà strutturale. Visto il principio generale che raccomanda, nella redazione di testi scritti, l'aderenza alle
Le varietà dell italiano: Standard e Neostandard Occupiamoci ancora nello specifico della varietà strutturale. Visto il principio generale che raccomanda, nella redazione di testi scritti, l'aderenza alle
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO MATERIA: ITALIANO Prof.ssa Santomauro Teresa ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Classe I^ AS ELENCO DELLE UNITA DIDATTICHE/MODULI Num Titolo delle UNITA
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO MATERIA: ITALIANO Prof.ssa Santomauro Teresa ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Classe I^ AS ELENCO DELLE UNITA DIDATTICHE/MODULI Num Titolo delle UNITA
Proprietà del linguaggio: - Congenito: è una facoltà mentale che nasce con l organismo, è registrato nel suo patrimonio genetico e rimane a livello
 Proprietà del linguaggio: - Congenito: è una facoltà mentale che nasce con l organismo, è registrato nel suo patrimonio genetico e rimane a livello potenziale finché uno stimolo la fa emergere; - Inapprendibile:
Proprietà del linguaggio: - Congenito: è una facoltà mentale che nasce con l organismo, è registrato nel suo patrimonio genetico e rimane a livello potenziale finché uno stimolo la fa emergere; - Inapprendibile:
DIAGRAMMA RELATIVO ALLA CATALOGAZIONE SEMANTICA DEI MATERIALI DIDATTICI ELABORATI DAGLI ISTRUTTORI S.P.I.Di.S. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
 DIAGRAMMA RELATIVO ALLA CATALOGAZIONE SEMANTICA DEI MATERIALI DIDATTICI ELABORATI DAGLI ISTRUTTORI S.P.I.Di.S. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO MATERIALE ELABORATO DAGLI ISTRUTTORI AREA LINGUISTICA LINGUA STRANIERA
DIAGRAMMA RELATIVO ALLA CATALOGAZIONE SEMANTICA DEI MATERIALI DIDATTICI ELABORATI DAGLI ISTRUTTORI S.P.I.Di.S. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO MATERIALE ELABORATO DAGLI ISTRUTTORI AREA LINGUISTICA LINGUA STRANIERA
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME. Competenze specifiche Abilità Conoscenze ABILITÀ MORFO-SINTATTICHE
 OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
CLASSE 80/A - ITALIANO NELLA SCUOLA MEDIA CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA. Programma d'esame. Temi d'esame proposti in precedenti concorsi
 CLASSE 80/A - ITALIANO NELLA SCUOLA MEDIA Programma d'esame CLASSE 80/A - ITALIANO NELLA SCUOLA MEDIA Temi d'esame proposti in precedenti concorsi CLASSE 80/A - ITALIANO NELLA SCUOLA MEDIA Programma d'esame
CLASSE 80/A - ITALIANO NELLA SCUOLA MEDIA Programma d'esame CLASSE 80/A - ITALIANO NELLA SCUOLA MEDIA Temi d'esame proposti in precedenti concorsi CLASSE 80/A - ITALIANO NELLA SCUOLA MEDIA Programma d'esame
PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE ANNUALE
 INSEGNANTE: Maggi Francesca ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 CLASSE: III Scientifico MATERIA: Italiano Scienze Applicate PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE ANNUALE UDA 1: Ripasso: la letteratura delle origini Ripasso
INSEGNANTE: Maggi Francesca ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 CLASSE: III Scientifico MATERIA: Italiano Scienze Applicate PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE ANNUALE UDA 1: Ripasso: la letteratura delle origini Ripasso
PROGRAMMA DI GRECO. ANNO SCOLASTICO
 GRAMMATICA INTRODUZIONE Il greco lingua indoeuropea La prima fase della lingua greca: il miceneo FONETICA E MORFOLOGIA Leggere e scrivere il greco L alfabeto La pronuncia I segni diacritici La classificazione
GRAMMATICA INTRODUZIONE Il greco lingua indoeuropea La prima fase della lingua greca: il miceneo FONETICA E MORFOLOGIA Leggere e scrivere il greco L alfabeto La pronuncia I segni diacritici La classificazione
a. s CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino
 a. s. 2015-2016 CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino PROGRAMMA SVOLTO Segni e suoni L alfabeto: confronto italiano - latino Vocali e dittonghi Come si legge il latino La quantità della penultima
a. s. 2015-2016 CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino PROGRAMMA SVOLTO Segni e suoni L alfabeto: confronto italiano - latino Vocali e dittonghi Come si legge il latino La quantità della penultima
2 Affinità e differenze 15 La pronunzia 15 L alfabeto e la fonetica 16 Il lessico 16 La morfologia e la sintassi 17 I casi e le funzioni logiche 18
 XI verso il latino 1 Il latino per strada 2 2 Il latino e la sua storia 6 1 L antica lingua di Roma 6 Il latino e l italiano 6 Perché il latino si chiama così 7 Quando si parlò l antica lingua di Roma
XI verso il latino 1 Il latino per strada 2 2 Il latino e la sua storia 6 1 L antica lingua di Roma 6 Il latino e l italiano 6 Perché il latino si chiama così 7 Quando si parlò l antica lingua di Roma
3. La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico)
 3. La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo
3. La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo
La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico)
 La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo sono
La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo sono
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
VIII. Indice. Unità 2 La semantica 20
 Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
PARTE PRIMA - FONETICA
 Sommario PARTE PRIMA - FONETICA 1. Scrittura e pronuncia 3 1.1. Introduzione 3 1.2. L alfabeto: i segni grafici 6 1.2.1. La pronuncia del greco e la fonetica 7 1.2.2. Spiriti 10 1.2.3. Segni d interpunzione
Sommario PARTE PRIMA - FONETICA 1. Scrittura e pronuncia 3 1.1. Introduzione 3 1.2. L alfabeto: i segni grafici 6 1.2.1. La pronuncia del greco e la fonetica 7 1.2.2. Spiriti 10 1.2.3. Segni d interpunzione
Programma del corso. Il corso si propone di presentare le nozioni base, le principali articolazioni e i metodi di indagine della linguistica.
 Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2010 / 2011 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) Programma del corso Il corso si propone di presentare
Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2010 / 2011 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) Programma del corso Il corso si propone di presentare
Il codice linguistico
 Laboratorio Linguistico Il Testo narrativo Il codice linguistico www.nicolanapolitano.altervista.org App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM Le funzioni e la
Laboratorio Linguistico Il Testo narrativo Il codice linguistico www.nicolanapolitano.altervista.org App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM Le funzioni e la
L italiano regionale. Lezione del 13 novembre 2014
 L italiano regionale Lezione del 13 novembre 2014 A proposito del dialetto tra i giovani, a p. 52 del libro di testo (Marcato) si legge: Il dialettalismo, in qualche caso, può non essere diretto nel senso
L italiano regionale Lezione del 13 novembre 2014 A proposito del dialetto tra i giovani, a p. 52 del libro di testo (Marcato) si legge: Il dialettalismo, in qualche caso, può non essere diretto nel senso
Che cos è il pronome. Rispetto al SIGNIFICATO i pronomi si distinguono in:
 IL PRONOME Che cos è il pronome Il pronome è la parte variabile del discorso che SOSTITUISCE: un nome È l autobus CHE (l autobus) prendo ogni mattina. un aggettivo Dicono che sei gentile, ma a me non LO
IL PRONOME Che cos è il pronome Il pronome è la parte variabile del discorso che SOSTITUISCE: un nome È l autobus CHE (l autobus) prendo ogni mattina. un aggettivo Dicono che sei gentile, ma a me non LO
LICEO SCIENTIFICO STATALE ANTONIO GRAMSCI Via del Mezzetta, FIRENZE Tel. 055/ Fax 055/608400
 PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2015/16 MATERIA: ITALIANO CLASSE: 2 SEZIONE: E DOCENTE: Rossella Baldini CONTENUTI L ASCOLTO LA LETTURA Ascolto di brani (anche musicali) come introduzione o completamento ad argomenti
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2015/16 MATERIA: ITALIANO CLASSE: 2 SEZIONE: E DOCENTE: Rossella Baldini CONTENUTI L ASCOLTO LA LETTURA Ascolto di brani (anche musicali) come introduzione o completamento ad argomenti
Programmazione di Tedesco seconda lingua straniera a.s
 Programmazione di Tedesco seconda lingua straniera a.s. 2015-16 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - turismo CLASSE PRIMA TEMI relativi alla sfera personale e quotidiana Informazioni sulla persona, famiglia, amici,
Programmazione di Tedesco seconda lingua straniera a.s. 2015-16 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - turismo CLASSE PRIMA TEMI relativi alla sfera personale e quotidiana Informazioni sulla persona, famiglia, amici,
L apprendimento dell italiano L2. Insegnare l italiano. Giuseppe Faso
 L apprendimento dell italiano L2 Insegnare l italiano Giuseppe Faso premessa La scuola italiana si è già trovata di fronte a difficoltà di inserimento attribuite alla diversità culturale Educazione linguistica:
L apprendimento dell italiano L2 Insegnare l italiano Giuseppe Faso premessa La scuola italiana si è già trovata di fronte a difficoltà di inserimento attribuite alla diversità culturale Educazione linguistica:
PROGRAMMA DI ITALIANO
 I.I.S. ENZO FERRARI ROMA Sede Via Contardo Ferrini, 83 PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE III SEZIONE B - A F M Anno Scolastico 2015/2016 Per il recupero delle insufficienze gli alunni verranno sottoposti a
I.I.S. ENZO FERRARI ROMA Sede Via Contardo Ferrini, 83 PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE III SEZIONE B - A F M Anno Scolastico 2015/2016 Per il recupero delle insufficienze gli alunni verranno sottoposti a
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 ISTITUTO DI ISTRUZI SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI - Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: X LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate LICEO TECNICO ISTITUTO TECNICO
ISTITUTO DI ISTRUZI SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI - Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: X LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate LICEO TECNICO ISTITUTO TECNICO
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
Criteri per la definizione della parola grammaticale
 Criteri per la definizione della parola grammaticale Una parola grammaticale (morfo-sintattica, non fonologica) è definita in base alla co-occorrenza dei seguenti criteri: a) COESIONE: si definisce parola
Criteri per la definizione della parola grammaticale Una parola grammaticale (morfo-sintattica, non fonologica) è definita in base alla co-occorrenza dei seguenti criteri: a) COESIONE: si definisce parola
Programma di italiano
 ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. S.BANDINI SIENA Programma di italiano Antologia: TITOLO = SCRITTORI e SCRITTURE Poesia e Teatro AUTORE = A. De Simone C. Gusmini EDIZIONE = Le Monnier La poesia: Gli strumenti
ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. S.BANDINI SIENA Programma di italiano Antologia: TITOLO = SCRITTORI e SCRITTURE Poesia e Teatro AUTORE = A. De Simone C. Gusmini EDIZIONE = Le Monnier La poesia: Gli strumenti
IIS Via Silvestri Liceo Scientifico Anno scolastico Classe I sez. D Prof. ssa Francesca Ferrari. Programma di Latino
 IIS Via Silvestri Liceo Scientifico Anno scolastico 2014-2015 Classe I sez. D Prof. ssa Francesca Ferrari Programma di Latino Introduzione allo studio del Latino Riflessioni sulle motivazioni allo studio.
IIS Via Silvestri Liceo Scientifico Anno scolastico 2014-2015 Classe I sez. D Prof. ssa Francesca Ferrari Programma di Latino Introduzione allo studio del Latino Riflessioni sulle motivazioni allo studio.
CLASSE 91/A - ITALIANO ( SECONDA LINGUA ) NELLA SCUOLA MEDIA IN LINGUA TEDESCA. Programma d'esame. Temi d'esame proposti in precedenti concorsi
 CLASSE 91/A - ITALIANO ( SECONDA LINGUA ) NELLA SCUOLA MEDIA IN LINGUA TEDESCA Programma d'esame CLASSE 91/A - ITALIANO ( SECONDA LINGUA ) NELLA SCUOLA MEDIA IN LINGUA TEDESCA Temi d'esame proposti in
CLASSE 91/A - ITALIANO ( SECONDA LINGUA ) NELLA SCUOLA MEDIA IN LINGUA TEDESCA Programma d'esame CLASSE 91/A - ITALIANO ( SECONDA LINGUA ) NELLA SCUOLA MEDIA IN LINGUA TEDESCA Temi d'esame proposti in
I.T.I. Giordani Caserta
 I.T.I. Giordani Caserta Prof.ssa De Iorio Rosaria Programma di Italiano A.S. 2014/2015 Classe 3^A T.L. IL MEDIOEVO Il contesto storico e politico La rinascita delle città e la fioritura comunale in Italia
I.T.I. Giordani Caserta Prof.ssa De Iorio Rosaria Programma di Italiano A.S. 2014/2015 Classe 3^A T.L. IL MEDIOEVO Il contesto storico e politico La rinascita delle città e la fioritura comunale in Italia
La tipologia e gli universali
 La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
Semantica I L S I G N I F I C A T O D E L L E P A R O L E E D E L L E F R A S I
 Semantica I L S I G N I F I C A T O D E L L E P A R O L E E D E L L E F R A S I Cos è? Aspetti «interni» del linguaggio 2 i suoni linguistici la struttura delle parole la combinazione delle parole in gruppi
Semantica I L S I G N I F I C A T O D E L L E P A R O L E E D E L L E F R A S I Cos è? Aspetti «interni» del linguaggio 2 i suoni linguistici la struttura delle parole la combinazione delle parole in gruppi
G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio N O Z I O N I B A S I L A R I 3
 G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio N O Z I O N I B A S I L A R I 3 Introduzione: classificazione 1 2 Un primo criterio classificatorio potrebbe essere proprio quello del numero dei parlanti
G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio N O Z I O N I B A S I L A R I 3 Introduzione: classificazione 1 2 Un primo criterio classificatorio potrebbe essere proprio quello del numero dei parlanti
INDICE GENERALE Capitolo 1 - preliminari... 3 Capitolo 2 - Morfologia: preliminari... 12
 INDICE GENERALE Capitolo 1 - Preliminari... 3 1. L alfabeto latino...3 2. La pronunzia del latino...4 3. Vocali e semivocali...5 4. Dittonghi...6 5. La dieresi...7 6. L apofonia...7 7. Consonanti...7 8.
INDICE GENERALE Capitolo 1 - Preliminari... 3 1. L alfabeto latino...3 2. La pronunzia del latino...4 3. Vocali e semivocali...5 4. Dittonghi...6 5. La dieresi...7 6. L apofonia...7 7. Consonanti...7 8.
NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA
 Mod.: DID 39.04 PQ12 Rev.: 2 data: 10.09.2014 pag.: 1 di 5 NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DISCIPLINA ITALIANO BIENNIO A. F. M - ITER TRIENNIO A.F. M - ITER SERALE Elaborazione collegiale del dipartimento
Mod.: DID 39.04 PQ12 Rev.: 2 data: 10.09.2014 pag.: 1 di 5 NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DISCIPLINA ITALIANO BIENNIO A. F. M - ITER TRIENNIO A.F. M - ITER SERALE Elaborazione collegiale del dipartimento
5 L evoluzione delle lingue: livelli del mutamento linguistico
 Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2014-15 1 5 L evoluzione delle lingue: livelli del mutamento linguistico [Materiali di riferimento per questa parte (solo in riferimento agli arrgomenti trattati):
Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2014-15 1 5 L evoluzione delle lingue: livelli del mutamento linguistico [Materiali di riferimento per questa parte (solo in riferimento agli arrgomenti trattati):
Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti. Alla scoperta dell italiano
 Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti Alla scoperta dell italiano 2003 by G.B. Palumbo & C. Editore S.P.A. PROGETTO GRAFICO Vincenzo Marineo COPERTINA Federica Giovannini ILLUSTRAZIONI Francesca Speziale
Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti Alla scoperta dell italiano 2003 by G.B. Palumbo & C. Editore S.P.A. PROGETTO GRAFICO Vincenzo Marineo COPERTINA Federica Giovannini ILLUSTRAZIONI Francesca Speziale
IDIOSINCRASIE LESSICO-MORFOLOGICHE DELLA LINGUA ROMENA IN CONFRONTO ALLE LINGUE EUROPEE ROMANZE E GERMANICHE. ANALOGIE E CONTRASTI II.
 IDIOSINCRASIE LESSICO-MORFOLOGICHE DELLA LINGUA ROMENA IN CONFRONTO ALLE LINGUE EUROPEE ROMANZE E GERMANICHE. ANALOGIE E CONTRASTI II. IL NOME (LEXICO-MORPHOLOGICAL IDIOSYNCRASIES OF ROMANIAN AS COMPARED
IDIOSINCRASIE LESSICO-MORFOLOGICHE DELLA LINGUA ROMENA IN CONFRONTO ALLE LINGUE EUROPEE ROMANZE E GERMANICHE. ANALOGIE E CONTRASTI II. IL NOME (LEXICO-MORPHOLOGICAL IDIOSYNCRASIES OF ROMANIAN AS COMPARED
ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna LICEO LINGUISTICO. Riconoscere la situazione di comunicazione ( chi, dove e quando) Comprendere il messaggio globale
 Classe 1^ - FRANCESE (seconda lingua) OBIETTIVI Comprensione orale ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna LICEO LINGUISTICO Riconoscere la situazione di comunicazione ( chi, dove e quando) Comprendere il messaggio
Classe 1^ - FRANCESE (seconda lingua) OBIETTIVI Comprensione orale ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna LICEO LINGUISTICO Riconoscere la situazione di comunicazione ( chi, dove e quando) Comprendere il messaggio
CLASSE II F a.s Letteratura Italiana. 1. Le Origini
 Letteratura Italiana 1. Le Origini Argomenti In questa lezione vedremo le cause della nascita del volgare e della lenta sparizione del latino Esamineremo anche a sommi capi le prime letterature in volgare
Letteratura Italiana 1. Le Origini Argomenti In questa lezione vedremo le cause della nascita del volgare e della lenta sparizione del latino Esamineremo anche a sommi capi le prime letterature in volgare
I.S.I.S. BONALDO STRINGHER CORSI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI. Anno scolastico 2011 2012 PROGRAMMAZIONE. Disciplina: Lingua e civiltà francese
 I.S.I.S. BONALDO STRINGHER CORSI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI Anno scolastico 2011 2012 PROGRAMMAZIONE Disciplina: Lingua e civiltà francese Docente:Loretta Specogna Classe: Gruppo classe 3^ Comm.,3^ Alb.,
I.S.I.S. BONALDO STRINGHER CORSI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI Anno scolastico 2011 2012 PROGRAMMAZIONE Disciplina: Lingua e civiltà francese Docente:Loretta Specogna Classe: Gruppo classe 3^ Comm.,3^ Alb.,
Ripetere e scrivere parole e frasi per la comunicazione in classe.
 tavola dei contenuti Unità Comunicazione Grammatica 0 Benvenuti! p. 10 Ripetere e scrivere parole e frasi per la comunicazione in classe. L alfabeto. 1 Primo giorno p. 14 di scuola 2 Tanti auguri! p. 26
tavola dei contenuti Unità Comunicazione Grammatica 0 Benvenuti! p. 10 Ripetere e scrivere parole e frasi per la comunicazione in classe. L alfabeto. 1 Primo giorno p. 14 di scuola 2 Tanti auguri! p. 26
III origine e sviluppo delle lingue romanze. morfosintassi (cenni)
 FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA a.a. 2015-2016 (LM 37) PROF. AGGREGATO BEATRICE FEDI III origine e sviluppo delle lingue romanze. morfosintassi (cenni) 1 SISTEMA NOMINALE LATINO Comprende: sostantivi aggettivi
FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA a.a. 2015-2016 (LM 37) PROF. AGGREGATO BEATRICE FEDI III origine e sviluppo delle lingue romanze. morfosintassi (cenni) 1 SISTEMA NOMINALE LATINO Comprende: sostantivi aggettivi
LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE
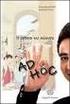 Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
Due tipi di diversità linguistica: orizzontale
 Diversità linguistica e diversità genetica Cambiamento delle lingue ed evoluzione delle specie Due tipi di diversità linguistica: orizzontale orizzontale : diversità tra lingue parlate nella stessa epoca
Diversità linguistica e diversità genetica Cambiamento delle lingue ed evoluzione delle specie Due tipi di diversità linguistica: orizzontale orizzontale : diversità tra lingue parlate nella stessa epoca
MATERIA: RUSSO CLASSE 1^ M ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PROF. ANTONIO PUCCIO. STRUMENTI DI LAVORO utilizzati
 MATERIA: RUSSO CLASSE 1^ M ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DOCENTE: PROF. ANTONIO PUCCIO STRUMENTI DI LAVORO utilizzati Reportage 1 libro ed eserciziario. CD annessi. Lezione 1 alla 8 Manuali consigliati: Chavronina,
MATERIA: RUSSO CLASSE 1^ M ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DOCENTE: PROF. ANTONIO PUCCIO STRUMENTI DI LAVORO utilizzati Reportage 1 libro ed eserciziario. CD annessi. Lezione 1 alla 8 Manuali consigliati: Chavronina,
Aspetti di lingua russa
 A10 271 Ekaterina Gruzova Aspetti di lingua russa Lessicologia, fraseologia e linguaggio giornalistico Copyright MMVII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo,
A10 271 Ekaterina Gruzova Aspetti di lingua russa Lessicologia, fraseologia e linguaggio giornalistico Copyright MMVII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo,
Linguistica Generale. Docente: Paola Monachesi. Contents First Last Prev Next
 Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Contents 1 La linguistica e i suoi settori............................... 3 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica...............................................
Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Contents 1 La linguistica e i suoi settori............................... 3 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica...............................................
TIPOLOGIA E SINTASSI: LA FRASE DICHIARATIVA l'ordine dei costituenti nella frase indipendente dichiarativa assertiva
 TIPOLOGIA E SINTASSI: LA FRASE DICHIARATIVA l'ordine dei costituenti nella frase indipendente dichiarativa assertiva 1. Parametri di indagine: a) posizione del soggetto (S) b) posizione dell oggetto diretto
TIPOLOGIA E SINTASSI: LA FRASE DICHIARATIVA l'ordine dei costituenti nella frase indipendente dichiarativa assertiva 1. Parametri di indagine: a) posizione del soggetto (S) b) posizione dell oggetto diretto
Fonologia e ortografia
 Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO MINEO A.S INDICATORI OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO UNITA D'APPRENDIMENTO A.
 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO MINEO A.S. 2016-2017 CURRICOLO ITALIANO SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA INDICATORI OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO UNITA D'APPRENDIMENTO A. ASCOLTO E PARLATO 1. Ascoltare testi
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO MINEO A.S. 2016-2017 CURRICOLO ITALIANO SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA INDICATORI OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO UNITA D'APPRENDIMENTO A. ASCOLTO E PARLATO 1. Ascoltare testi
4 lezione: 30/10/2015
 4 lezione: 30/10/2015 Argomenti trattati: 1) Esercizi sulle note 2) Connettivi e coesivi 3) La stesura: convenzioni e accortezze editoriali 1) Esercizi sulle note: gli errori 1) Nobili, Claudia Sebastiana,
4 lezione: 30/10/2015 Argomenti trattati: 1) Esercizi sulle note 2) Connettivi e coesivi 3) La stesura: convenzioni e accortezze editoriali 1) Esercizi sulle note: gli errori 1) Nobili, Claudia Sebastiana,
Linguistica Generale
 Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Aprile-Maggio 2003 Contents 1 La linguistica e i suoi settori 2 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica 2 3 Le componenti della
Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Aprile-Maggio 2003 Contents 1 La linguistica e i suoi settori 2 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica 2 3 Le componenti della
Linguaggio giuridico e lingua di genere
 Linguaggio giuridico e lingua di genere Stefania Cavagnoli, Università di Macerata Bari, 21 maggio 2012 Lingua e realtà http://www3.lastampa.it/costume/sezioni/articolo/ lstp/454834/ È l'ora della sindaca
Linguaggio giuridico e lingua di genere Stefania Cavagnoli, Università di Macerata Bari, 21 maggio 2012 Lingua e realtà http://www3.lastampa.it/costume/sezioni/articolo/ lstp/454834/ È l'ora della sindaca
Grammatica : morfologia Le parti del discorso: nome, articolo, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, preposizioni, congiunzioni, interiezione.
 Programma Lingua e letteratura italiana classe prima Le tecniche narrative: fabula e intreccio, ruolo e funzione dei personaggi, spazio e tempo, sequenze, narratore e punto di vista, lingua e stile I generi
Programma Lingua e letteratura italiana classe prima Le tecniche narrative: fabula e intreccio, ruolo e funzione dei personaggi, spazio e tempo, sequenze, narratore e punto di vista, lingua e stile I generi
IL RUOLO DELLA TOSCANA NELLA QUESTIONE DELLA LINGUA
 IL RUOLO DELLA TOSCANA NELLA QUESTIONE DELLA LINGUA l dibattito sulla questione della lingua si apre con il poema De Vulgari Eloquentia (sulla retorica in volgare) di Dante, DANTE DE VULGARI ELOQUENTIA
IL RUOLO DELLA TOSCANA NELLA QUESTIONE DELLA LINGUA l dibattito sulla questione della lingua si apre con il poema De Vulgari Eloquentia (sulla retorica in volgare) di Dante, DANTE DE VULGARI ELOQUENTIA
1 MODULO OPERATIVO LE ABILITA LINGUISTICHE
 1 MODULO OPERATIVO LE ABILITA LINGUISTICHE N 1 Acquisire gradualmente, attraverso l osservazione e l esercizio dell attenzione e della memoria la padronanza delle regole comunicative relative all ascoltare
1 MODULO OPERATIVO LE ABILITA LINGUISTICHE N 1 Acquisire gradualmente, attraverso l osservazione e l esercizio dell attenzione e della memoria la padronanza delle regole comunicative relative all ascoltare
5. Scritto e parlato nella storia della lingua italiana
 Modulo A La variazione linguistica tra scritto e parlato 5. Scritto e parlato nella storia della lingua italiana 22 ottobre 2015 Linguistica italiana II Mirko Tavosanis A. a. 2015-2016 Oggi Limiti della
Modulo A La variazione linguistica tra scritto e parlato 5. Scritto e parlato nella storia della lingua italiana 22 ottobre 2015 Linguistica italiana II Mirko Tavosanis A. a. 2015-2016 Oggi Limiti della
