Analisi trofico-funzionale delle comunità macrobentoniche del bacino del Fiume Tacina (Crotone, Calabria)
|
|
|
- Alessandro Foti
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Analisi trofico-funzionale delle comunità macrobentoniche del bacino del Fiume Tacina (Crotone, Calabria) Lucio Lucadamo a*, Maurizio Battegazzore b, Antonietta Mezzotero a, Angelo Morisi b, Luana Gallo a a Dipartimento di Ecologia, Università della Calabria, via Pietro Bucci, Cubo 6b, Arcavacata di Rende (CS), Italia b A.R.P.A. Piemonte, Dipartimento di Cuneo, Area Tematica Conservazione della Natura, via D Azeglio 4, Cuneo, Italia Abstract Il bacino del Fiume Tacina e quelli dei suoi affluenti Soleo e San Antonio sono stati oggetto di due campagne di campionamento (Maggio e Novembre 2002) di macroinvertebrati bentonici per una valutazione di ricchezza tassonomica e dominanza e per uno studio dell assetto trofico-funzionale. I risultati hanno mostrato una eccellente correlazione inversa tra la ricchezza tassonomica e l abbondanza del taxon dominante con, in media, le maggiori riduzioni nel numero di taxa e le più evidenti dilatazioni di nicchia di organismi eurivalenti in corrispondenza di quei tratti dei bacini a maggior tasso di antropizzazione. Le attività presenti nel bacino riguardano il comparto agro-zootecnico o quello estrattivo, con ripercussioni sulla quota di materiale in sospensione e sul carico trofico, e l analisi trofico-funzionale della comunità risulta un efficace indicatore delle perturbazioni che ne conseguono. Lo studio ha confermato la validità dell utilizzo delle comunità attraverso un approccio ecosistemico-funzionale evidenziando una buona associazione dell intensità e tipologia di attività antropica con l aumento del trasporto in sospensione (valutabile come rapporto tra collettorifiltratori e collettori-aspiratori) e fenomeni di eutrofizzazione (rilevabili dalla quota di organismi utilizzatori di perifiton) SItE. All rights reserved Keywords: fiume Tacina; macroinvertebrati bentonici; gruppi trofico-funzionali; rapporti trofici; taxon dominante; 1. Introduzione I macroinvertebrati bentonici vengono accorpati in corporazioni dette Gruppi Trofico-Funzionali (G.T.F.) (Merrit and Cummins, 1996a) sulla base delle specializzazioni morfo-anatomiche che consentono loro di utilizzare la sostanza organica presente sotto forma di differenti classi dimensionali e distribuita tra il letto e la colonna d acqua. I relativi rapporti (detti Rapporti Trofici: Tab 1.1) danno utili indicazioni sullo stato e tipologia delle risorse alimentari ecosistemiche e sullo sviluppo di eventi di inquinamento (Metcalfe-Smith J.L., 1994). * Corresponding author. Tel.: ; fax: ; lucio.lucadamo@unical.it
2 2 Available online at Il presente lavoro è stato finalizzato alla descrizione della biodiversità e della struttura trofico-funzionale delle comunità dei macroinvertebrati bentonici presenti nel fiume Tacina e nei suoi principali affluenti, il Soleo e il S. Antonio. Tab Rapporti Trofici e loro significato relativo (T: Tagliuzzatori, utilizzatori di detrito vegetale; R: Raschiatori, utilizzatori di perifiton epilitico; C.F.: Collettori Filtratori, utilizzatori di microparticolato sestonico; C.A.: Collettori Aspiratori, utilizzatori di microparticolato bentonico; P: Predatori, utilizzatori di organismi vivi); C.T.: Collettori Totali (C.F. + C.A.). Rapporti trofici Valore soglia T. / C.T. > 0,25 R. / T. + C.T. > 0,75 C.F. / C.A. > 0,50 C.F. + R. / T. + C.A. P. / tutti gli altri > 0,50 > 0,15 2. Materiali e Metodi Significato Elevata quota di CPOM (Coarse Particulate Organic Matter), ovvero detrito vegetale in alveo Produzione maggiore della Respirazione Sovraccarico di microparticolato organico sestonico (SFPOM) rispetto a quello bentonico (BFPOM) Eccesso di substrati instabili o poco favorevoli alla colonizzazione superficiale Eccesso di prede a rapido ciclo biologico ed elevato tasso di colonizzazione Sulla base dello stato di antropizzazione del territorio sono state individuate 11 stazioni di campionamento dislocate lungo il decorso longitudinale delle rispettive aste fluviali (Fig. 2.1) ed eseguiti prelievi di macrobenthos in due differenti fasi stagionali (Giugno e Novembre 2002). Gli organismi sono stati raccolti con l ausilio di un retino immanicato con un diametro di maglia pari a 500 µm, utilizzando la procedura di Ghetti (1997), inquadrati a livello tassonomico (famiglia e genere) e conteggiati per la valutazione della ricchezza tassonomica, delle dimensioni numeriche del taxon dominante, dei G.T.F. (espressi come % sul totale degli individui) e per il calcolo dei Rapporti Trofici (Merrit and Cummins, 1996b). diga su Migliarite buon grado di naturalità F. Soleo transito di bovini F. S. Antonio Taso1 Ta2 Ta3 Taso2 briglie; silos frantoi Tasan1 elevato grado di naturalità 3. Risultati e Discussioni captazione a scopo irriguo e potabile Ta4 Taso3 rimozione della vegetazione riparia agrumicoltura agricoltura intensiva ed estensiva reflui urbani Fig Dislocazione delle stazioni di campionamento e di alcune tipologie di attività antropiche a potenziale impatto. Le Figure 3.1 e 3.2 riportano i dati relativi alle abbondanze numeriche dei prelievi di macrobenthos, del taxon dominante e della Ricchezza Tassonomica. L analisi di correlazione tra la Ricchezza Tassonomica e la rappresentatività percentuale del taxon dominante risulta ottimale (r = -0,725, p < 0,001), suggerendo che spesso l incremento eccessivo di una nicchia è il riflesso di processi di semplificazione ambientale che, come nella fattispecie, risultano associati alla presenza di attività antropiche (Figg. 3.1 e 3.2). Particolarmente impattato appare il Tacina dove, sovente, il taxon dominante arriva a costituire il 50% della comunità e risulta formato da organismi eurivalenti ad elevata capacità di colonizzazione quali il genere Baetis e le famiglie Chironomidae, Simuliidae e Hydropsychidae. La struttura trofico funzionale delle comunità è mostrata nelle Tabelle 3.1 e 3.2. In generale, in entrambi i campionamenti, i Collettori (sia aspiratori che filtratori) sono le categorie più numerose e ciò suggerisce che la canalizzazione dell energia avvenga, in maniera rilevante, attraverso il microparticolato bentonico e sestonico. I raschiatori (consumatori di produzione primaria autoctona) assumono valori piuttosto alti solo nelle stazioni Ta2 (Giugno 2002) e Taso2 (Giugno e Novembre 2002) e, secondariamente, nelle stazioni Ta1, Ta3 e Taso1. Come da previsione, gli organismi che si nutrono di lettiera vegetale Ta5 agrumicoltura RSU in alveo orticoltura; briglia allevamento di ovini Tasan2 F. Tacina Ta6 Ta7 allevamento di bovini; silos; frantoio attività agricole aratura letamazioni
3 15 th Meeting of the Italian Society of Ecology, September 2005, Torino 3 (tagliuzzatori) raggiungono una rappresentatività sensibile a Novembre, ed in quelle stazioni ove risulta ben preservata la componente arborea riparia (Taso1, Taso2 e Tasan1). N. organismi Ta1 Ta2 Ta3 Ta4 Ta5 Ta6 Taso1 Taso2 Taso3 Tasan1 Tasan2 Simuliidae Lymnaeidae Baetis Chironomidae Resto della Comunità Fig Abbondanza numerica del taxon dominante rispetto al totale della comunità macrobentonica (Giugno 2002). Il numero sugli istogrammi esprime il numero totale di taxa presenti nel campione. N. organismi Ta1 Ta2 Ta3 Ta4 Ta5 Ta6 Taso1 Taso2 Taso3 Tasan1 Tasan2 Hydropsychidae Simuliidae Baetis Tab 3.2. Struttura trofico-funzionale delle comunità macrobentoniche relativa al campionamento di Ottobre Stazioni T. C. A. C. F. R. P. Ta1 4% 37% 34% 20% 5% Ta2 5% 33% 32% 19% 11% Ta3 0% 33% 58% 1% 8% Ta4 0% 34% 25% 23% 18% Ta5 9% 32% 56% 0% 3% Ta6 2% 54% 42% 0% 2% Taso1 23% 25% 13% 22% 17% Taso2 21% 17% 19% 37% 6% Taso3 1% 38% 40% 12% 9% Tasan1 26% 13% 30% 22% 8% Tasan2 0% 34% 62% 0% 4% Nella Ta1 l attività della diga (sita sull affluente Migliarite) determina lo sviluppo di un greto ampio e con fisionomia appiattita, impedendo la deposizione di lettiera nell alveo bagnato o, comunque, un accumulo a seguito dei picchi di portata. Nelle Figure 3.3 e 3.4 viene illustrato il risultato della cluster analysis eseguita sui valori dei Rapporti Trofici indicati nelle Tabelle 3.3 e 3.4. Similarity 79,28 Rapporti trofici (Giugno 2002) Athericidae Sericostomatidae Resto della Comunità Fig Abbondanza numerica del taxon dominante rispetto al totale della comunità macrobentonica (Novembre 2002). Il numero sugli istogrammi esprime il numero totale di taxa presenti nel campione. Tab 3.1. Struttura trofico-funzionale delle comunità macrobentoniche relativa al campionamento di Giugno Stazioni T. C. A. C. F. R. P. Ta1 1% 26% 70% 0% 3% Ta2 1% 23% 14% 33% 29% Ta3 0% 45% 52% 0% 3% Ta4 0% 64% 13% 19% 4% Ta5 5% 31% 54% 1% 9% Ta6 6% 70% 19% 1% 4% Taso1 3% 65% 7% 15% 10% Taso2 0% 32% 12% 50% 6% Taso3 0% 40% 43% 4% 3% Tasan1 3% 62% 11% 9% 15% Tasan2 0% 39% 40% 8% 13% 86,19 93,09 100,00 Ta1 Ta5 Ta2 Taso2 Ta3 Tasan 2 Taso3 Ta4 Ta6 Taso1 Tasan1 Fig Cluster analysis eseguita sui valori che assumono i Rapporti Trofici nel campionamento primaverile. Nel campionamento primaverile (Tab. 3.3), per quanto attiene alla produzione primaria (rapporto R/T+C.T.) questa sembra assumere, spesso, valori modesti. Ciò, in parte, potrebbe essere ascrivibile al sensibile grado di ombreggiamento di qualche stazione (Tasan1 e, secondariamente, Taso3) e, soprattutto, all elevato grado di torbidità dell acqua
4 4 Available online at (Ta3, Ta5, Ta6, Tasan2) ed alle perturbazioni idrodinamiche frequenti (Ta1). Tab 3.3. Valori dei rapporti trofici relativi al campionamento primaverile Stazioni T/CT R/T+CT CF/CA R+CF/CA+T P/TA Ta1 0,005 0,003 2,63 2,60 0,002 Ta6 0,007 0,008 2,50 2,00 0,120 Ta2 0,020 0,850 0,61 1,94 0,700 Taso2 0,003 1,14 0,36 1,92 0,060 Ta3 0,002 0,003 1,13 1,13 0,020 Tasan2 0,000 0,100 1,01 1,20 0,150 Taso3 0,002 0,130 1,07 1,40 0,030 Ta4 0,000 0,0 0,200 0,49 0,040 Ta6 0,070 0,008 0,270 0,25 0,037 Taso1 0,040 0,200 0,10 0,30 0,100 Tasan1 0,030 0,110 0,180 0,31 0,170 stazioni Taso1, Taso2 e Tasan1 mostrano un alto valore dei rapporti T/C.T. e C.F./C.A. suggerendo che la decomposizione del detrito fogliare sostenga l attività dei filtratori (tab. 3.4). Assenti sono le dilatazioni di nicchia (Fig. 3.2). In quasi tutte le altre stazioni (Fig. 3.4), pur mancando eventi piovosi rilevanti ed in assenza, in diversi casi, di una componente arborea riparia ben sviluppata, si assiste ad un sensibile aumento del valore C.F./C.A., spesso associato ad un incremento di una singola nicchia (Fig. 3.2). Ciò denota l acuirsi dei fenomeni di impatto antropico da scarichi inquinanti. Similarity 84,05 Rapporti trofici Novembre 2002 Le stazioni Ta2 e Taso3, benchè mostrino una volta ben sviluppata, presentano valori molto alti del rapporto R/T+CT e ciò fa ipotizzare la presenza di fattori che promuovano la crescita microalgale ovvero un miglioramento dell irraggiamento bentonico (Ta2) a causa di una drastica riduzione della portata (dovuta a captazioni idriche) e per lo sviluppo di deflussi eutrofizzanti (Taso2). Delle altre stazioni, cinque mostrano un eccesso di SFPOM rispetto alla BFPOM (Ta1, Ta3, Ta5, Tasan2 e Taso3) e tre di queste hanno anche un rapporto Taxon Dominante/Resto della Comunità elevato (Ta1 = 2,31; Ta3 = 1,01 Ta5 = 1,35). Nella stazione Ta1 l eccesso di SFPOM è attribuibile agli aumenti artificiali di portata (Fig. 2.1) che impongono anche una semplificazione della comunità. Nelle altre stazioni, dal momento che la frequenza degli eventi pluviali è fortemente diradata e il regime idrologico tende ad una fase di magra, l aumento di SFPOM è ascrivibile alla produzione di deflussi legati alle attività agricole e zootecniche. Tutte le stazioni rimanenti hanno un rapporto C.F./C.A. inferiore a 0,50 e due di queste presentano un T.D./R.C elevato (Ta4 = 1,21; Ta6 = 1,22), supportando l ipotesi che il carico organico inquinante (visto il sovradimensionamento di nicchia) sia presente come BFPOM ovvero derivi dallo sviluppo di deflussi episodici, di breve durata ma elevata intensità. Nel campionamento autunnale le 89,37 94,68 100,00 Ta1 Ta2 Taso3 Ta4 Ta6 Taso2 Ta3 Tasan2 Ta5 Tasan1 Taso1 Fig Cluster analysis eseguita sui valori che assumono i Rapporti Trofici nel campionamento autunnale. Tab 3.4. Valori dei Rapporti Trofici relativi al campionamento autunnale. Stazioni T/CT R/T+CT CF/CA R+CF/CA+T P/TA Ta1 0,050 0,260 0,950 1,34 0,050 Ta2 0,080 0,270 0,950 1,34 0,050 Taso3 0,050 0,150 1,04 1,33 0,100 Ta4 0,004 0,380 0,75 1,39 0,220 Ta6 0,020 0,000 0,77 0,74 0,018 Taso2 0,580 0,610 1,17 1,47 0,070 Ta3 0,000 0,002 1,76 1,77 0,090 Tasan2 0,000 0,001 1,83 1,84 0,039 Ta5 0,100 0,000 1,70 1,34 0,026 Tasan1 0,60 0,310 2,0 1,30 0,080 Taso1 0,690 0,360 0,51 0,73 0, Conclusioni Lo studio della struttura Trofico-Funzionale dei fiumi Tacina, Soleo e S. Antonio ha messo in
5 15 th Meeting of the Italian Society of Ecology, September 2005, Torino 5 evidenza che tali corpi idrici sono soggetti a deflussi arricchiti di sostanza organica e nutrienti, probabilmente promossi dalle attività agricole, zootecniche ed agro-industriali (frantoi) presenti. Questi eventi determinano non solo la dilatazione di intere categorie trofico-funzionali, ma anche di singole nicchie ecologiche che diventano dominanti nell ambito dei raggruppamenti. 5. Bibliografia Ghetti P. F. (1997). Indice Biotico Esteso I macroinvertebrati nel controllo della qualità degli ambienti di acque correnti. Provincia autonoma di Trento Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, Trento. Merrit R.W. and Cummins K.W. (Eds) (1996a). An introduction to the aquatic insects of North America, (3rd edn). Kendall/Hunt Publishing Company, Iowa. Merrit R.W. and Cummins K.W. (1996b). Trophic relations of macroinvertebrates. In Methods in Stream Ecology (Hauer F.R. and Lamberti G.A. eds). Academis Press, San Diego. CA. Metcalfe-Smith J.L. (1994). Biological Water Quality Assesment of Rivers: Use of Macroinvertebrate Communities. In The Rivers Handbook (Calow P. and Geoffrey G.E. eds). Blackwell Science, Oxford, U.K.
13 dicembre Descrizione dell attività didattica
 13 dicembre 2007 Descrizione dell attività didattica 13 dicembre 2007 Modulo didattico 3 interventi per le scuole superiori (lezione frontale in aula + uscita di campo + laboratorio) 2 interventi per le
13 dicembre 2007 Descrizione dell attività didattica 13 dicembre 2007 Modulo didattico 3 interventi per le scuole superiori (lezione frontale in aula + uscita di campo + laboratorio) 2 interventi per le
Pressioni puntuali, diffuse e idromorfologiche determinate dal comparto agricolo sui corpi idrici del Veneto
 Pressioni puntuali, diffuse e idromorfologiche determinate dal comparto agricolo sui corpi idrici del Veneto dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del fiume Adige Architettura del piano Il modello DPSIR EEA Environmental
Pressioni puntuali, diffuse e idromorfologiche determinate dal comparto agricolo sui corpi idrici del Veneto dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del fiume Adige Architettura del piano Il modello DPSIR EEA Environmental
PROGRAMMA CORSO ECOLOGIA APPLICATA Dott. Fabrizio Scialanca - Limnologo
 PROGRAMMA CORSO ECOLOGIA APPLICATA Dott. Fabrizio Scialanca - Limnologo 1. CENNI DI ECOLOGIA I principali cicli biogeochimici Le catene trofiche 2. FATTORI ED ELEMENTI CLIMATICI Caratteristiche chimico-fisiche
PROGRAMMA CORSO ECOLOGIA APPLICATA Dott. Fabrizio Scialanca - Limnologo 1. CENNI DI ECOLOGIA I principali cicli biogeochimici Le catene trofiche 2. FATTORI ED ELEMENTI CLIMATICI Caratteristiche chimico-fisiche
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI ASPETTI ECOLOGICI E NORMATIVA PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ACQUE CORRENTI: CONFRONTO TRA
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI ASPETTI ECOLOGICI E NORMATIVA PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ACQUE CORRENTI: CONFRONTO TRA
Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali
 Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
Naples Shipping Week, 25 Giugno 2014, Tavola rotonda: «Il dragaggio dei porti e la destinazione dei sedimenti»
 Naples Shipping Week, 25 Giugno 2014, Tavola rotonda: «Il dragaggio dei porti e la destinazione dei sedimenti» Principi fondamentali per un dragaggio ambientalmente sostenibile: dalla caratterizzazione
Naples Shipping Week, 25 Giugno 2014, Tavola rotonda: «Il dragaggio dei porti e la destinazione dei sedimenti» Principi fondamentali per un dragaggio ambientalmente sostenibile: dalla caratterizzazione
AAVV, (1998), Water quality criteria in enviromental management Commission of the European Communities.
 BIBLIOGRAFIA AAVV, (1998), Water quality criteria in enviromental management Commission of the European Communities. AAVV, (2001), Manuale di riqualificazione fluviale C.I.R.F. AAVV, (2002), Applicazione
BIBLIOGRAFIA AAVV, (1998), Water quality criteria in enviromental management Commission of the European Communities. AAVV, (2001), Manuale di riqualificazione fluviale C.I.R.F. AAVV, (2002), Applicazione
5.1 - CONSUMO DI ACQUA PER USO DOMESTICO E PERDITE DI RETE
 5.1 - CONSUMO DI ACQUA PER USO DOMESTICO E PERDITE DI RETE Collaborazione ISPRA ISTAT es. Tavolo Tecnico ISTAT inerente le problematiche del censimento delle risorse idriche ISTAT 2011: Consumo pro-capite
5.1 - CONSUMO DI ACQUA PER USO DOMESTICO E PERDITE DI RETE Collaborazione ISPRA ISTAT es. Tavolo Tecnico ISTAT inerente le problematiche del censimento delle risorse idriche ISTAT 2011: Consumo pro-capite
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
 DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
Codice RASTA Area bacino (Kmq) Lunghezza totale (Km) A1Z ,5 5,6
 Rio Cavelonte Codice RASTA Area bacino (Kmq) Lunghezza totale (Km) A1Z5010000 13,5 5,6 Tabella 1: Punteggio, livello, giudizio IFF reale e relativ o Descrizione tratto IFF reale IFF relativo Codice Data
Rio Cavelonte Codice RASTA Area bacino (Kmq) Lunghezza totale (Km) A1Z5010000 13,5 5,6 Tabella 1: Punteggio, livello, giudizio IFF reale e relativ o Descrizione tratto IFF reale IFF relativo Codice Data
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione
 La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
5 IL BACINO DEL FIUME USO
 5 IL BACINO DEL FIUME USO Pagina 39 5.1 GENERALITÀ Il bacino idrografico del fiume Uso è costituito da una superficie, stretta e lunga, di 141 km 2 compresa tra i bacini idrografici dei fiumi Savio, Rubicone
5 IL BACINO DEL FIUME USO Pagina 39 5.1 GENERALITÀ Il bacino idrografico del fiume Uso è costituito da una superficie, stretta e lunga, di 141 km 2 compresa tra i bacini idrografici dei fiumi Savio, Rubicone
Diga di Saretto Comune di Acceglio. La gestione di un invaso. ENEL Produzione ing. Barettini San Damiano Macra 18 ottobre 2014
 Diga di Saretto Comune di Acceglio La gestione di un invaso ENEL Produzione ing. Barettini San Damiano Macra 18 ottobre 2014 Asta del T. Maira Produzione idroelettrica Profilo idraulico Asta del T. Maira
Diga di Saretto Comune di Acceglio La gestione di un invaso ENEL Produzione ing. Barettini San Damiano Macra 18 ottobre 2014 Asta del T. Maira Produzione idroelettrica Profilo idraulico Asta del T. Maira
IMPATTI INDOTTI SU UN CORSO D ACQUA
 servizio idraulica DERIVAZIONI IDROELETTRICHE: IMPATTI INDOTTI SU UN CORSO D ACQUA Ing. Federica Lippi Malnisio,, 16 giugno 2011 Le filiere dell energia Energia idroelettrica PREMESSA L acqua rappresenta
servizio idraulica DERIVAZIONI IDROELETTRICHE: IMPATTI INDOTTI SU UN CORSO D ACQUA Ing. Federica Lippi Malnisio,, 16 giugno 2011 Le filiere dell energia Energia idroelettrica PREMESSA L acqua rappresenta
Università di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica. Agenzia Provinciale per la Protezione dell Ambiente
 LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI MONITORAGGIO RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE DERIVAZIONI IDRICHE SULLO STATO DI QUALITA DEI CORPI IDRICI Università di Trento
LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI MONITORAGGIO RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE DERIVAZIONI IDRICHE SULLO STATO DI QUALITA DEI CORPI IDRICI Università di Trento
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA ED AMBIENTALE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA ED AMBIENTALE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA
I fiumi. La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia
 I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
PIANO PER LA PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA
 REGIONE VENETO SEGRETERIA REGIONALE ALL AMBIENTE DIREZIONE TUTELA DELL AMBIENTE PIANO PER LA PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA
REGIONE VENETO SEGRETERIA REGIONALE ALL AMBIENTE DIREZIONE TUTELA DELL AMBIENTE PIANO PER LA PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA
I FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE E GLI ENTI PUBBLICI CHE RIUTILIZZANO LE ACQUE REFLUE
 I FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE E GLI ENTI PUBBLICI CHE RIUTILIZZANO LE ACQUE REFLUE COMPARTO AGRICOLO E AGROALIMENTARE Le imprese agricole possono usufruire delle acque reflue ai fini irrigui. A tal fine
I FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE E GLI ENTI PUBBLICI CHE RIUTILIZZANO LE ACQUE REFLUE COMPARTO AGRICOLO E AGROALIMENTARE Le imprese agricole possono usufruire delle acque reflue ai fini irrigui. A tal fine
Piano di Tutela delle Acque e Direttiva 2000/60/CE: Quali gli obblighi e le azioni per il futuro
 Piano di Tutela delle Acque e Direttiva 2000/60/CE: Quali gli obblighi e le azioni per il futuro Corrado Soccorso Dipartimento Difesa del Suolo Sezione Geologia e Georisorse Settore Tutela Acque Iniziativa
Piano di Tutela delle Acque e Direttiva 2000/60/CE: Quali gli obblighi e le azioni per il futuro Corrado Soccorso Dipartimento Difesa del Suolo Sezione Geologia e Georisorse Settore Tutela Acque Iniziativa
L Indice di Funzionalità Fluviale (IFF): applicazione al fiume Soligo
 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GEOMETRI A.A. 2004-05 Corso di Estimo ambientale, riqualificazione fluviale ed ingegneria naturalistica- II sezione: riqualificazione fluviale ed ingegneria naturalistica
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GEOMETRI A.A. 2004-05 Corso di Estimo ambientale, riqualificazione fluviale ed ingegneria naturalistica- II sezione: riqualificazione fluviale ed ingegneria naturalistica
Caffaro e Brescia I nuovi dati. I sedimenti delle rogge
 Caffaro e Brescia I nuovi dati I sedimenti delle rogge Brescia, 20 ottobre 2015 Dott. Geol. Sandro Zaniboni Caratterizzazione Rogge Scopo del lavoro proposto Conferma «Modello Concettuale» Quadro dettagliato
Caffaro e Brescia I nuovi dati I sedimenti delle rogge Brescia, 20 ottobre 2015 Dott. Geol. Sandro Zaniboni Caratterizzazione Rogge Scopo del lavoro proposto Conferma «Modello Concettuale» Quadro dettagliato
UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI D ACQUA E STRUMENTO DI MONITORAGGIO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
 2 Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale Riqualificazione fluviale e gestione del territorio 6-7 novembre 2012, Bolzano UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI
2 Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale Riqualificazione fluviale e gestione del territorio 6-7 novembre 2012, Bolzano UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI
Modellistica numerica avanzata a supporto dell idroecologia Scenari di impatto sulla qualità delle acque
 Modellistica numerica avanzata a supporto dell idroecologia Scenari di impatto sulla qualità delle acque Luca Dutto - Hydrodata S.p.A. Mauro Porcelli - Ente Parco Nazionale del Circeo Torino, 14-15 Ottobre
Modellistica numerica avanzata a supporto dell idroecologia Scenari di impatto sulla qualità delle acque Luca Dutto - Hydrodata S.p.A. Mauro Porcelli - Ente Parco Nazionale del Circeo Torino, 14-15 Ottobre
La Pianificazione delle acque Paolo Mancin
 La Pianificazione delle acque Paolo Mancin Modello DPSIR su Acqua : le risposte Lo schema della Direttiva Quadro Acque Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po STATO monitoraggi PRESSIONI
La Pianificazione delle acque Paolo Mancin Modello DPSIR su Acqua : le risposte Lo schema della Direttiva Quadro Acque Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po STATO monitoraggi PRESSIONI
ARPA Sezione di Rimini
 ARPA Sezione di Rimini 5.3 STAZIONE DI MONITORAGGIO 19000500 PONTE VIA MARECCHIESE RIMINI Caratteristiche del punto: Questo punto di campionamento è situato sul torrente Ausa, immediatamente prima della
ARPA Sezione di Rimini 5.3 STAZIONE DI MONITORAGGIO 19000500 PONTE VIA MARECCHIESE RIMINI Caratteristiche del punto: Questo punto di campionamento è situato sul torrente Ausa, immediatamente prima della
Piano di Tutela delle Acque
 Piano di Tutela delle Acque E lo strumento di Pianificazione territoriale attraverso il quale raggiungere gli obiettivi di qualità fissati dalla Direttive Europee. In quanto Piano di valenza territoriale
Piano di Tutela delle Acque E lo strumento di Pianificazione territoriale attraverso il quale raggiungere gli obiettivi di qualità fissati dalla Direttive Europee. In quanto Piano di valenza territoriale
All. C_bis integrazione alla relazione preliminare ambientale. a cura di. Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale
 All. C_bis integrazione alla relazione preliminare ambientale a cura di Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale 1 Sommario 1. PREMESSA... 3 2. EVOLUZIONE DELLE METODOLOGIE DI MONITORAGGIO... 3
All. C_bis integrazione alla relazione preliminare ambientale a cura di Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale 1 Sommario 1. PREMESSA... 3 2. EVOLUZIONE DELLE METODOLOGIE DI MONITORAGGIO... 3
6 METODOLOGIA qualità chimico-fisica
 6 METODOLOGIA Si è ritenuto opportuno considerare e valutare in maniera non dettagliata anche l intero bacino, soprattutto tramite dati esistenti, per ottenere un quadro generale e andare, così, oltre
6 METODOLOGIA Si è ritenuto opportuno considerare e valutare in maniera non dettagliata anche l intero bacino, soprattutto tramite dati esistenti, per ottenere un quadro generale e andare, così, oltre
LIFE. Dott. Marco Zanetti (biologo) Martedì 17 maggio Azione. . Mappaggio biologico di qualità. Analisi dei macroinvertebrati bentonici.
 LIFE 14/NAT/IT/000809 River functionality index as planning instrument for a good governance of Sile s ecosystem A2 Azione. Mappaggio biologico di qualità. Analisi dei macroinvertebrati bentonici. Dott.
LIFE 14/NAT/IT/000809 River functionality index as planning instrument for a good governance of Sile s ecosystem A2 Azione. Mappaggio biologico di qualità. Analisi dei macroinvertebrati bentonici. Dott.
I RISULTATI WQI 1) BOD
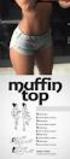 WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
LINEE GUIDA PER I PIANI DI ADEGUAMENTO
 LINEE GUIDA PER I PIANI DI ADEGUAMENTO Valido per il CRITERIO n. 1 e 2 (da consegnare entro il 7 agosto 2006) 1. DESCRIZIONE DELLA DERIVAZIONE IN ATTO 1.1 Inquadramento geografico della derivazione in
LINEE GUIDA PER I PIANI DI ADEGUAMENTO Valido per il CRITERIO n. 1 e 2 (da consegnare entro il 7 agosto 2006) 1. DESCRIZIONE DELLA DERIVAZIONE IN ATTO 1.1 Inquadramento geografico della derivazione in
Rovigo, Veccione, e Brentana). Il torrente Santerno non è quindi direttamente interferito da cantieri o campi base nel territorio emiliano.
 Comune di Castel del Rio/Casalfiumanese 110 ACQUE SUPERFIICIIALII Nei territori comunali in oggetto, non insistono attività di cantiere legate alla realizzazione dell opera. Al di fuori del confine provinciale
Comune di Castel del Rio/Casalfiumanese 110 ACQUE SUPERFIICIIALII Nei territori comunali in oggetto, non insistono attività di cantiere legate alla realizzazione dell opera. Al di fuori del confine provinciale
ACQUACOLTURA BIOLOGICA
 Corso di formazione/aggiornamento ACQUACOLTURA BIOLOGICA Dr. Pierluigi Carbonara COISPA Tecnologia & Ricerca Via dei Trulli 18/20-70126 BARI 080 5433596 carbonara@coispa.it Tipologie di allevamento Intensità
Corso di formazione/aggiornamento ACQUACOLTURA BIOLOGICA Dr. Pierluigi Carbonara COISPA Tecnologia & Ricerca Via dei Trulli 18/20-70126 BARI 080 5433596 carbonara@coispa.it Tipologie di allevamento Intensità
Laboratorio Isonzo. CONSULTAZIONE: SITUAZIONI di OPPORTUNITA' CRITICITA' ed ELEMENTI DI ATTENZIONE. 15 dicembre ARPA FVG Palmanova - Italy
 Laboratorio Isonzo CONSULTAZIONE: SITUAZIONI di OPPORTUNITA' CRITICITA' ed ELEMENTI DI ATTENZIONE 15 dicembre 2011 Del Zotto - Zanolin ARPA FVG Palmanova - Italy 1 VALUTAZIONI OPPORTUNITA' BACINO DI RIFASAMENTO
Laboratorio Isonzo CONSULTAZIONE: SITUAZIONI di OPPORTUNITA' CRITICITA' ed ELEMENTI DI ATTENZIONE 15 dicembre 2011 Del Zotto - Zanolin ARPA FVG Palmanova - Italy 1 VALUTAZIONI OPPORTUNITA' BACINO DI RIFASAMENTO
Il valore ecologico della risorsa acqua
 Il valore ecologico della risorsa acqua Che cos è una risorsa? Qualsiasi cosa che noi preleviamo dall ambiente vivente e non, per soddisfare le nostre necessità. Le risorse sono divisibili in 1) risorse
Il valore ecologico della risorsa acqua Che cos è una risorsa? Qualsiasi cosa che noi preleviamo dall ambiente vivente e non, per soddisfare le nostre necessità. Le risorse sono divisibili in 1) risorse
Contenuti della sezione ACQUE
 Contenuti della sezione ACQUE La Qualità delle acque superficiali Azioni del Dipartimento di Como Punti di monitoraggio delle acque superficiali Descrittore: Stato ecologico dei corsi d acqua Descrittore:
Contenuti della sezione ACQUE La Qualità delle acque superficiali Azioni del Dipartimento di Como Punti di monitoraggio delle acque superficiali Descrittore: Stato ecologico dei corsi d acqua Descrittore:
Incontro di consultazione pubblica Venezia, 6 luglio 2017
 Inquadramento norma-vo europeo: le linee guida europee sull ecological flow Il conceao di deflusso ecologico in Europa A Blueprint to safeguard Europe s water resources, 2012 (Piano per la salvaguardia
Inquadramento norma-vo europeo: le linee guida europee sull ecological flow Il conceao di deflusso ecologico in Europa A Blueprint to safeguard Europe s water resources, 2012 (Piano per la salvaguardia
Il percorso del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po al 2015 e le sue criticità
 2 ciclo di pianificazione 2015-2021 Workshop della Rete Ambientale I Piani di Gestione dei distretti idrografici e la qualità del corpo idrico Roma, 15 settembre 2014 Il percorso del Piano di Gestione
2 ciclo di pianificazione 2015-2021 Workshop della Rete Ambientale I Piani di Gestione dei distretti idrografici e la qualità del corpo idrico Roma, 15 settembre 2014 Il percorso del Piano di Gestione
L ITALIA SOSTENIBILE IDEE E AZIONI PER IL FUTURO
 L ITALIA SOSTENIBILE IDEE E AZIONI PER IL FUTURO BOLOGNA 20-21 MAGGIO 2016 C.N.R. AREA DELLA RICERCA DI BOLOGNA Biodiversità e Cambiamenti Climatici proposte operative Roberto Danovaro Università Politecnica
L ITALIA SOSTENIBILE IDEE E AZIONI PER IL FUTURO BOLOGNA 20-21 MAGGIO 2016 C.N.R. AREA DELLA RICERCA DI BOLOGNA Biodiversità e Cambiamenti Climatici proposte operative Roberto Danovaro Università Politecnica
CON-VIVIAMO IL FIUME. Centro di Educazione Ambientale Parco Alpi Liguri. A cura di STEFANO BRIGHENTI
 Centro di Educazione Ambientale Parco Alpi Liguri CON-VIVIAMO IL FIUME A cura di STEFANO BRIGHENTI Filone B- Protezione civile e cultura del rischio naturale Oggi parliamo di fiumi! Ok...ma cosa è un fiume???
Centro di Educazione Ambientale Parco Alpi Liguri CON-VIVIAMO IL FIUME A cura di STEFANO BRIGHENTI Filone B- Protezione civile e cultura del rischio naturale Oggi parliamo di fiumi! Ok...ma cosa è un fiume???
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica
 Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
SIA CAVONE - APPENDICE 2
 SIA CAVONE - APPENDICE 2 ATTIVITA DI MONITORAGGIO (Elaborato redatto dalla CIIP spa Area Gestione Servizio Lavori) Durante le operazioni di ricognizione dei luoghi, necessarie per la redazione degli apporti
SIA CAVONE - APPENDICE 2 ATTIVITA DI MONITORAGGIO (Elaborato redatto dalla CIIP spa Area Gestione Servizio Lavori) Durante le operazioni di ricognizione dei luoghi, necessarie per la redazione degli apporti
QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI INTERNE
 AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA 88 QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI INTERNE ARPA FVG è impegnata in una grande campagna per il monitoraggio delle acque. Allo stato attuale, si evidenziano impatti
AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA 88 QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI INTERNE ARPA FVG è impegnata in una grande campagna per il monitoraggio delle acque. Allo stato attuale, si evidenziano impatti
Fiume ADDA. Cornate d Adda. Dati biologici. Dati generali. Caratteristiche ambientali. Stato biologico. Tendenza
 Fiume ADDA Cornate d Adda Periodo di campionamento: - Numero campionamenti: Numero dati : POADCN Cornate d Adda Frazione Porto d Adda m km Caratteristiche ambientali Il territorio circostante è coperto
Fiume ADDA Cornate d Adda Periodo di campionamento: - Numero campionamenti: Numero dati : POADCN Cornate d Adda Frazione Porto d Adda m km Caratteristiche ambientali Il territorio circostante è coperto
Prof. Ing. Francesco De Paola. Il Corso di Costruzioni Idrauliche - Introduzione
 Prof. Ing. Francesco De Paola Il Corso di Costruzioni Idrauliche - Introduzione L uomo e l acqua 2 L acqua è una risorsa primaria per la vita, ed è grazie ad essa che l uomo svolge gran parte delle sue
Prof. Ing. Francesco De Paola Il Corso di Costruzioni Idrauliche - Introduzione L uomo e l acqua 2 L acqua è una risorsa primaria per la vita, ed è grazie ad essa che l uomo svolge gran parte delle sue
IBE del principale fiume calabrese negli ultimi 15 anni: tendenze emerse e riflessioni
 Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 83 (007): 19-133 ISSN 039-054 Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 007 IBE del principale fiume calabrese negli ultimi 15 anni: tendenze emerse e riflessioni
Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 83 (007): 19-133 ISSN 039-054 Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 007 IBE del principale fiume calabrese negli ultimi 15 anni: tendenze emerse e riflessioni
CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: scheda 26_MAR
 a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine Lunghezza (km) Foce Magra 0701101126 Punta Corvo Confine con 8,8 * Regione Toscana * Il codice è costruito con i seguenti campi:
a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine Lunghezza (km) Foce Magra 0701101126 Punta Corvo Confine con 8,8 * Regione Toscana * Il codice è costruito con i seguenti campi:
acqua il monitoraggio in Campania
 acqua il monitoraggio in Campania 2002-2006 L acqua è probabilmente l unica risorsa naturale che interessa tutti gli aspetti della civiltà umana, dallo sviluppo agricolo e industriale ai valori culturali
acqua il monitoraggio in Campania 2002-2006 L acqua è probabilmente l unica risorsa naturale che interessa tutti gli aspetti della civiltà umana, dallo sviluppo agricolo e industriale ai valori culturali
nni Callegari, Nicola Cantasano, Raffaele Froio, Nicola Ricca, Antonella Veltri, Ernesto Infusino*
 I/MEMORIE IDRAULICA FLUVIALE. nni Callegari, Nicola Cantasano, Raffaele Froio, Nicola Ricca, Antonella Veltri, Ernesto Infusino* DICE DI FUNZIONALITA' FLUVIALE (I.F.F.) IN CALABRIA. caso del fiume Crati
I/MEMORIE IDRAULICA FLUVIALE. nni Callegari, Nicola Cantasano, Raffaele Froio, Nicola Ricca, Antonella Veltri, Ernesto Infusino* DICE DI FUNZIONALITA' FLUVIALE (I.F.F.) IN CALABRIA. caso del fiume Crati
7 IL BACINO DEL FIUME MARANO
 7 IL BACINO DEL FIUME MARANO Pagina 61 7.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Marano sfocia nel Mare Adriatico al confine fra i comuni di Rimini e Riccione, ed è compreso fra i bacini del Melo, del Conca
7 IL BACINO DEL FIUME MARANO Pagina 61 7.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Marano sfocia nel Mare Adriatico al confine fra i comuni di Rimini e Riccione, ed è compreso fra i bacini del Melo, del Conca
GLI INDICATORI DI QUALITA BIOLOGICA DEL SUOLO
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA DI AGRARIA GLI INDICATORI DI QUALITA BIOLOGICA DEL SUOLO Prof. Paola Ferrazzi Dott. Federica Berger 29 EDIZIONE della FIERA NAZIONALE della MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA DI AGRARIA GLI INDICATORI DI QUALITA BIOLOGICA DEL SUOLO Prof. Paola Ferrazzi Dott. Federica Berger 29 EDIZIONE della FIERA NAZIONALE della MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI
 SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
REGGIO CALABRIA 29 ottobre 2015
 III Convegno Nazionale sulla Riqualificazione Fluviale Sessione Internazionale Riqualificare i corsi d acqua nella regione mediterranea ispirazione dalle buone pratiche - impegno per le sfide correnti
III Convegno Nazionale sulla Riqualificazione Fluviale Sessione Internazionale Riqualificare i corsi d acqua nella regione mediterranea ispirazione dalle buone pratiche - impegno per le sfide correnti
Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto Figura Dislocazione delle stazioni meteorologiche
 Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto 1 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 3.1 - Gli indicatori meteorologici per lo studio della
Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto 1 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 3.1 - Gli indicatori meteorologici per lo studio della
Istituto Comprensivo Sandro Pertini Ovada
 Istituto Comprensivo Sandro Pertini Ovada Attraverso l'analisi della fauna macrobentonica delle acque si può conoscere la condizione di un corso d'acqua. La classificazione di questi organismi viene fatta
Istituto Comprensivo Sandro Pertini Ovada Attraverso l'analisi della fauna macrobentonica delle acque si può conoscere la condizione di un corso d'acqua. La classificazione di questi organismi viene fatta
Elementi idromorfologici: indice di alterazione del regime idrologico (IARI)
 Direttiva 2000/60/CE: Struttura delle reti e dei programmi di monitoraggio sui corsi d acqua Indici di classificazione dello stato di qualità Elementi idromorfologici: indice di alterazione del regime
Direttiva 2000/60/CE: Struttura delle reti e dei programmi di monitoraggio sui corsi d acqua Indici di classificazione dello stato di qualità Elementi idromorfologici: indice di alterazione del regime
ACQUE CORRENTI. Scelta delle stazioni di campionamento. Qualità dell habitat fluviale
 ACQUE CORRENTI Scelta delle stazioni di campionamento La campagna di raccolta dati è stata compiuta nei periodi idrologici di magra e ha riguardato 65 corsi d acqua, di interesse ittico, per un numero
ACQUE CORRENTI Scelta delle stazioni di campionamento La campagna di raccolta dati è stata compiuta nei periodi idrologici di magra e ha riguardato 65 corsi d acqua, di interesse ittico, per un numero
PRESSIONI AMBIENTALI A CARICO DELLA FAUNA ITTICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO PER LE ALTERAZIONI DEL REGIME IDRICO
 PRESSIONI AMBIENTALI A CARICO DELLA FAUNA ITTICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO PER LE ALTERAZIONI DEL REGIME IDRICO Dr. Cesare M. Puzzi GRAIA srl CARTA ITTICA DEL FIUME PO Carta Ittica del Fiume Po (2007 2009)
PRESSIONI AMBIENTALI A CARICO DELLA FAUNA ITTICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO PER LE ALTERAZIONI DEL REGIME IDRICO Dr. Cesare M. Puzzi GRAIA srl CARTA ITTICA DEL FIUME PO Carta Ittica del Fiume Po (2007 2009)
Ciclo idrico e governo delle acque Titolo contratti Sottotitolo di fiume con particolare riguardo alle attività di monitoraggio e controllo
 Ciclo idrico e governo delle acque Il Titolo ruolo di ARPA Lombardia in materia di contratti Sottotitolo di fiume con particolare riguardo alle attività di monitoraggio e controllo Dr.ssa Paola Bossi Sede
Ciclo idrico e governo delle acque Il Titolo ruolo di ARPA Lombardia in materia di contratti Sottotitolo di fiume con particolare riguardo alle attività di monitoraggio e controllo Dr.ssa Paola Bossi Sede
Nel settore delle infrastrutture per insediamenti edilizi. Dopo aver definito il rapporto ottimale tra superficie pavimentata ed area a
 ALCUNI ESEMPI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE Oltre a quanto specificamente evidenziato nelle norme (Tav. n 11), è di seguito elencata una serie di interventi che possono costituire delle linee guida atte a
ALCUNI ESEMPI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE Oltre a quanto specificamente evidenziato nelle norme (Tav. n 11), è di seguito elencata una serie di interventi che possono costituire delle linee guida atte a
Comune di SAN ROCCO AL PORTO Provincia di LODI
 Comune di SAN ROCCO AL PORTO Provincia di LODI STUDIO PER L INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO
Comune di SAN ROCCO AL PORTO Provincia di LODI STUDIO PER L INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO
La pianificazione della risorsa idrica in Emilia-Romagna Rosanna Bissoli
 RICARICA DELLA CONOIDE DEL MARECCHIA Rimini 15 aprile 2016 La pianificazione della risorsa idrica in Emilia-Romagna Rosanna Bissoli I Piani di gestione delle acque 2015-2021 I Piani di gestione delle acque
RICARICA DELLA CONOIDE DEL MARECCHIA Rimini 15 aprile 2016 La pianificazione della risorsa idrica in Emilia-Romagna Rosanna Bissoli I Piani di gestione delle acque 2015-2021 I Piani di gestione delle acque
(Elaborazioni grafiche a cura di G. Bonafè - ARPA - SIMC)
 Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto 21 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (Elaborazioni grafiche a cura di G. Bonafè - ARPA
Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto 21 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (Elaborazioni grafiche a cura di G. Bonafè - ARPA
ARPA Sezione di Rimini
 ARPA Sezione di Rimini Melo Rio Melo 211 B Ponte Via Venezia Riccione Bacino idrografico Corso d acqua Codice Tipo Localizzazione Pagina 76 Pagina 77 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Anche per
ARPA Sezione di Rimini Melo Rio Melo 211 B Ponte Via Venezia Riccione Bacino idrografico Corso d acqua Codice Tipo Localizzazione Pagina 76 Pagina 77 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Anche per
Monitoraggio, controllo e valutazioni ambientali sulle risorse idriche dei bacini idrografici di Salto e Turano
 Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia Lega Navale Italiana Delegazione del Turano I LAGHI COME RISORSA PER LO SVILUPPO DELLE VALLI DEL SALTO E DEL TURANO Condividiamo le conoscenze per elaborare
Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia Lega Navale Italiana Delegazione del Turano I LAGHI COME RISORSA PER LO SVILUPPO DELLE VALLI DEL SALTO E DEL TURANO Condividiamo le conoscenze per elaborare
Gli indirizzi regionali per la gestione della pesca in lombardia
 Gli indirizzi regionali per la gestione della pesca in lombardia Adozione del documento tecnico ai sensi art.8 l.r.12/01 Stefano Agostoni & Nadia Rota Corso di Formazione CISBA La Fauna ittica dei corsi
Gli indirizzi regionali per la gestione della pesca in lombardia Adozione del documento tecnico ai sensi art.8 l.r.12/01 Stefano Agostoni & Nadia Rota Corso di Formazione CISBA La Fauna ittica dei corsi
Centrale termoelettrica. di Porto Tolle. Allegato /II
 Allegato 2.1.3.1/II LA PRIMA CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA DEI CORSI D ACQUA DEL VENETO (abstract) ANNO 2002, 2001 E BIENNIO 2001-2002 ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. approvata dalla Regione Veneto
Allegato 2.1.3.1/II LA PRIMA CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA DEI CORSI D ACQUA DEL VENETO (abstract) ANNO 2002, 2001 E BIENNIO 2001-2002 ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. approvata dalla Regione Veneto
A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno Servizio Sistemi Ambientali
 A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno Servizio Sistemi Ambientali RELAZIONE ANNUALE SUL MONITORAGGIO DELLA QUALITÁ DELLE ACQUE NEL COMUNE DI BELLUNO (ANNO 2010) 2 INDICE Premessa 5 1. Introduzione
A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno Servizio Sistemi Ambientali RELAZIONE ANNUALE SUL MONITORAGGIO DELLA QUALITÁ DELLE ACQUE NEL COMUNE DI BELLUNO (ANNO 2010) 2 INDICE Premessa 5 1. Introduzione
Dighe ed ecologia delle acque
 HYDROS e SE Hydropower Gruppo SEL Dighe ed ecologia delle acque Bolzano, 15 maggio 2014 Vito Adami Laghi artificiali Dal punto di vista qualitativo, ecologico e funzionale, i laghi artificiali non possono
HYDROS e SE Hydropower Gruppo SEL Dighe ed ecologia delle acque Bolzano, 15 maggio 2014 Vito Adami Laghi artificiali Dal punto di vista qualitativo, ecologico e funzionale, i laghi artificiali non possono
DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA
 PRESIDENZA DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA CLIMB - General Assembly Climate Change Impacts on Water and Security (in Southern
PRESIDENZA DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA CLIMB - General Assembly Climate Change Impacts on Water and Security (in Southern
SESSIONE PARALLELA CENTRO TEMATICO NATURA E BIODIVERSITA
 L INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA CONOSCENZA E DELLA PREVENZIONE Dai sistemi di monitoraggio alla diffusione della cultura ambientale Milano, 24 25 26 Novembre 2003 Teatro Dal Verme - Palazzo delle Stelline
L INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA CONOSCENZA E DELLA PREVENZIONE Dai sistemi di monitoraggio alla diffusione della cultura ambientale Milano, 24 25 26 Novembre 2003 Teatro Dal Verme - Palazzo delle Stelline
MONITORAGGIO AMBIENTALE 5.1 RETE DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE
 Pag. 5.1-1 5 MONITORAGGIO AMBIENTALE 5.1 RETE DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE Nel corso degli anni la Rete di Sorveglianza Ambientale dell Impianto Eurex ha subito diverse revisioni, in relazione soprattutto
Pag. 5.1-1 5 MONITORAGGIO AMBIENTALE 5.1 RETE DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE Nel corso degli anni la Rete di Sorveglianza Ambientale dell Impianto Eurex ha subito diverse revisioni, in relazione soprattutto
METODOLOGIA MONITORAGGIO MACROINVERTEBRATI BENTONICI
 Progetto convenzionato: Attività di monitoraggio nell ambito del progetto LIFE RINASCE - LIFE13 ENV/IT/000169 ACTION C.1: MONITORAGGIO CHIMICO-FISICO, ECOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDRULICO DEGLI INTERVENTI
Progetto convenzionato: Attività di monitoraggio nell ambito del progetto LIFE RINASCE - LIFE13 ENV/IT/000169 ACTION C.1: MONITORAGGIO CHIMICO-FISICO, ECOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDRULICO DEGLI INTERVENTI
POLIGONALE ESTERNA DI BARI S.P. 92 "BITRITTO - MODUGNO" ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DEL TRATTO DAL KM AL KM 1+250
 S.P. 92 "BITRITTO - MODUGNO" ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DEL TRATTO DAL KM 0+000 AL KM 1+250 RELAZIONE DI COMPATIBILITA IDRAULICA 1. PREMESSA Nella presente relazione viene riportato lo studio
S.P. 92 "BITRITTO - MODUGNO" ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DEL TRATTO DAL KM 0+000 AL KM 1+250 RELAZIONE DI COMPATIBILITA IDRAULICA 1. PREMESSA Nella presente relazione viene riportato lo studio
Qualità delle acque di balneazione del Fiume Ticino a nord ovest di Milano
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Qualità delle acque di balneazione del Fiume Ticino a nord ovest di Milano Premessa Quando si parla di qualità delle acque destinate alla
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Qualità delle acque di balneazione del Fiume Ticino a nord ovest di Milano Premessa Quando si parla di qualità delle acque destinate alla
Zaupa S.! "# Boggero A. Rossaro B. Bettinetti R. Buscarinu P. Sesia E.
 Zaupa S.! "# Boggero A. Rossaro B. Bettinetti R. Buscarinu P. Sesia E. Il progetto finanziato per l implementazione della Direttiva 2000/60/CE ha lo scopo di definire lo stato ecologico e il potenziale
Zaupa S.! "# Boggero A. Rossaro B. Bettinetti R. Buscarinu P. Sesia E. Il progetto finanziato per l implementazione della Direttiva 2000/60/CE ha lo scopo di definire lo stato ecologico e il potenziale
9 IL BACINO DEL TORRENTE VENTENA
 9 IL BACINO DEL TORRENTE VENTENA Pagina 83 9.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Ventena confina in sinistra idrografica con il bacino del Conca ed in destra con i bacini del Foglia e del Tavollo. Il bacino
9 IL BACINO DEL TORRENTE VENTENA Pagina 83 9.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Ventena confina in sinistra idrografica con il bacino del Conca ed in destra con i bacini del Foglia e del Tavollo. Il bacino
MONITORAGGIO BIOLOGICO E CHIMICO
 MONITORAGGIO BIOLOGICO E CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E COSTIERE DR. TOMMASO PAGLIANI 1. INTRODUZIONE La qualità delle acque, specie quelle superficiali correnti, rappresenta indubbiamente lo specchio
MONITORAGGIO BIOLOGICO E CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E COSTIERE DR. TOMMASO PAGLIANI 1. INTRODUZIONE La qualità delle acque, specie quelle superficiali correnti, rappresenta indubbiamente lo specchio
ARPATnews RISORSE IDRICHE
 n. 095-2008 Mercoledì 18 giugno 2008 Newsletter sulle tematiche ambientali ARPATnews RISORSE IDRICHE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DELL ARNO E DEI SUOI PRINCIPALI AFFLUENTI NELLA PROVINCIA DI FIRENZE Sintesi
n. 095-2008 Mercoledì 18 giugno 2008 Newsletter sulle tematiche ambientali ARPATnews RISORSE IDRICHE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DELL ARNO E DEI SUOI PRINCIPALI AFFLUENTI NELLA PROVINCIA DI FIRENZE Sintesi
Comune di Bovolenta PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. Valutazione Ambientale Strategica
 Comune di Bovolenta PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO Valutazione Ambientale Strategica 1 PARTE I - INTRODUZIONE 1. INTRODUZIONE. pag. 9 1.1. Il concetto di sostenibilità e la sua valutazione... pag. 9 1.2.
Comune di Bovolenta PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO Valutazione Ambientale Strategica 1 PARTE I - INTRODUZIONE 1. INTRODUZIONE. pag. 9 1.1. Il concetto di sostenibilità e la sua valutazione... pag. 9 1.2.
Piero Gagliardo Il processo di desertificazione in Calabria
 Piero Gagliardo Il processo di desertificazione in Calabria ARACNE Copyright MMVIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133 A/B 00173 Roma (06) 93781065
Piero Gagliardo Il processo di desertificazione in Calabria ARACNE Copyright MMVIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133 A/B 00173 Roma (06) 93781065
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile,Edile e Ambientale
 Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile,Edile e Ambientale Corso di Laurea in INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile,Edile e Ambientale Corso di Laurea in INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed
La rete di monitoraggio del suolo in Piemonte: un esempio di applicazione del lavoro del CTN Territorio e Suolo
 La rete di monitoraggio del suolo in Piemonte: un esempio di applicazione del lavoro del CTN Territorio e Suolo Gabriele Fabietti*, Renzo Barberis**, Tommaso Niccoli** * Università degli Studi di Torino
La rete di monitoraggio del suolo in Piemonte: un esempio di applicazione del lavoro del CTN Territorio e Suolo Gabriele Fabietti*, Renzo Barberis**, Tommaso Niccoli** * Università degli Studi di Torino
La fauna delle risaie nel progetto CORINAT
 La fauna delle risaie nel progetto CORINAT A cura di E. Cardarelli, V. Longoni & G. Bogliani Regione Lombardia Università degli Studi di Pavia Scopo della ricerca Valutare come sia possibile condurre una
La fauna delle risaie nel progetto CORINAT A cura di E. Cardarelli, V. Longoni & G. Bogliani Regione Lombardia Università degli Studi di Pavia Scopo della ricerca Valutare come sia possibile condurre una
Dr. Valeria Roella. Varese 16 marzo 2013 Sala Montanari
 Dr. Valeria Roella Varese 16 marzo 2013 Sala Montanari Rete idrica provinciale Il quadro normativo a tutela delle risorse idriche è molto complesso e in evoluzione e ha introdotto sostanziali innovazioni
Dr. Valeria Roella Varese 16 marzo 2013 Sala Montanari Rete idrica provinciale Il quadro normativo a tutela delle risorse idriche è molto complesso e in evoluzione e ha introdotto sostanziali innovazioni
8 IL BACINO DEL FIUME CONCA
 8 IL BACINO DEL FIUME CONCA Pagina 72 8.1 GENERALITÀ Il fiume Conca nasce in provincia di Pesaro-Urbino, dalle pendici del monte Carpegna a 1415 metri sul livello medio del mare, e sfocia nei pressi di
8 IL BACINO DEL FIUME CONCA Pagina 72 8.1 GENERALITÀ Il fiume Conca nasce in provincia di Pesaro-Urbino, dalle pendici del monte Carpegna a 1415 metri sul livello medio del mare, e sfocia nei pressi di
11 CONCLUSIONI. Convenzione Provincia di Rimini ARPA Sezione di Rimini
 - CONCLUSIONI - 11 CONCLUSIONI Lo studio della rete di secondo grado svolto nel 2004 ha permesso di completare la conoscenza della qualità dei nostri corsi d acqua, approfondendo, così, il quadro conoscitivo
- CONCLUSIONI - 11 CONCLUSIONI Lo studio della rete di secondo grado svolto nel 2004 ha permesso di completare la conoscenza della qualità dei nostri corsi d acqua, approfondendo, così, il quadro conoscitivo
Gli indirizzi regionali per la gestione della pesca in lombardia
 Gli indirizzi regionali per la gestione della pesca in lombardia Adozione del documento tecnico ai sensi art.8 l.r.12/01 Aspetti tecnico-scientifici Gabriele Borsani Università di Milano Interventi per
Gli indirizzi regionali per la gestione della pesca in lombardia Adozione del documento tecnico ai sensi art.8 l.r.12/01 Aspetti tecnico-scientifici Gabriele Borsani Università di Milano Interventi per
Esperienza di salvaguardia ambientale su un grande intervento di riordino irriguo
 27 marzo 2007 Facoltà di Agraria dell Universit Università degli Studi di Milano Esperienza di salvaguardia ambientale su un grande intervento di riordino irriguo dott. arch.. Fausto Cremascoli Inquadramento
27 marzo 2007 Facoltà di Agraria dell Universit Università degli Studi di Milano Esperienza di salvaguardia ambientale su un grande intervento di riordino irriguo dott. arch.. Fausto Cremascoli Inquadramento
COME STANNO I FIUMI ITALIANI E IN CHE MODO NE VALUTIAMO LO STATO DI SALUTE?
 COME STANNO I FIUMI ITALIANI E IN CHE MODO NE VALUTIAMO LO STATO DI SALUTE? G.L.Rossi, C.Rossato ENEA - Sezione Biologia Ambientale e Conservazione della Natura Centro Ricerche Saluggia La qualità delle
COME STANNO I FIUMI ITALIANI E IN CHE MODO NE VALUTIAMO LO STATO DI SALUTE? G.L.Rossi, C.Rossato ENEA - Sezione Biologia Ambientale e Conservazione della Natura Centro Ricerche Saluggia La qualità delle
FORUM TEMATICO: ACQUA. Arch. Daniele Mazzotta Servizio Governo del Territorio
 FORUM TEMATICO: ACQUA Arch. Daniele Mazzotta Servizio Governo del Territorio Cos è l Acqua? A differenza della maggior parte delle altre sostanze, per le quali la forma solida è più densa di quella liquida,
FORUM TEMATICO: ACQUA Arch. Daniele Mazzotta Servizio Governo del Territorio Cos è l Acqua? A differenza della maggior parte delle altre sostanze, per le quali la forma solida è più densa di quella liquida,
IL RUOLO DEL GEOLOGO NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
 IL RUOLO DEL GEOLOGO NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Corso di Aggiornamento Professionale Viterbo, 24 maggio 2010 - Palazzo della Provincia Prima Sessione Le componenti geologiche nello SIA: ambiente
IL RUOLO DEL GEOLOGO NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Corso di Aggiornamento Professionale Viterbo, 24 maggio 2010 - Palazzo della Provincia Prima Sessione Le componenti geologiche nello SIA: ambiente
Bologna, 11 dicembre Clara Bravi, Regione Lombardia - Pietro Genoni, ARPA Lombardia
 1 Il progetto di gestione - obiettivi Pianificazione ed attuazione delle operazioni di gestione del materiale sedimentato nell invaso (svaso, sfangamento, spurgo). Assicurare il mantenimento e ripristino
1 Il progetto di gestione - obiettivi Pianificazione ed attuazione delle operazioni di gestione del materiale sedimentato nell invaso (svaso, sfangamento, spurgo). Assicurare il mantenimento e ripristino
WATERFORLIFE LIFEFORWATER
 PROVINCIA DI VICENZA IMPLEMENTAZIONE DI UNA STRATEGIA PARTECIPATA DI RISPARMIO IDRICO E RICARICA ARTIFICIALE PER IL RIEQUILIBRIO QUANTITATIVO DELLA FALDA DELL'ALTA PIANURA VICENTINA. ERSO UN CONTRATTO
PROVINCIA DI VICENZA IMPLEMENTAZIONE DI UNA STRATEGIA PARTECIPATA DI RISPARMIO IDRICO E RICARICA ARTIFICIALE PER IL RIEQUILIBRIO QUANTITATIVO DELLA FALDA DELL'ALTA PIANURA VICENTINA. ERSO UN CONTRATTO
BALNEABILITA del Friuli Venezia Giulia ANNO 2017
 BALNEABILITA del Friuli Venezia Giulia ANNO 2017 Lignano Sabbiadoro, 11 Agosto 2017 Luigi Del Zotto Delibera di Giunta Regionale n.2386 del 09 dicembre 2016 La Regione FVG in accordo con ARPA-FVG ha classificato
BALNEABILITA del Friuli Venezia Giulia ANNO 2017 Lignano Sabbiadoro, 11 Agosto 2017 Luigi Del Zotto Delibera di Giunta Regionale n.2386 del 09 dicembre 2016 La Regione FVG in accordo con ARPA-FVG ha classificato
ECOLOGIA. Gruppo di ricerca in:
 Gruppo di ricerca in: ECOLOGIA Antonio Rolando Guido Badino Francesca Bona Dan Chamberlain Marco Isaia Giuseppe Maiorana Ferruccio Pizzolato Enrico Caprio Elisa Falasco Marta Franchino Valentina La Morgia
Gruppo di ricerca in: ECOLOGIA Antonio Rolando Guido Badino Francesca Bona Dan Chamberlain Marco Isaia Giuseppe Maiorana Ferruccio Pizzolato Enrico Caprio Elisa Falasco Marta Franchino Valentina La Morgia
Le principali criticità
 Investimenti nel servizio idrico: la depurazione è al primo posto Mercoledì 22 ottobre 2014 ore 10.00 Le principali criticità Prof. Bernardo De Bernardinis presentata da Ing. Andrea Bianco Istituto Superiore
Investimenti nel servizio idrico: la depurazione è al primo posto Mercoledì 22 ottobre 2014 ore 10.00 Le principali criticità Prof. Bernardo De Bernardinis presentata da Ing. Andrea Bianco Istituto Superiore
SEMINARIO IL VALORE DELL ACQUA
 Programma Operativo Italia-Malta 2007-2013 Monitoraggio delle risorse idriche sotterranee ed interventi per il controllo dell intrusione marina e per la riduzione dell inquinamento da attività agricole
Programma Operativo Italia-Malta 2007-2013 Monitoraggio delle risorse idriche sotterranee ed interventi per il controllo dell intrusione marina e per la riduzione dell inquinamento da attività agricole
Giornata celebrativa per il ventennale del Programma LIFE Università degli Studi di Brescia 25 maggio 2012
 Premesse, obiettivi e struttura generale del progetto INHABIT: importanza dell habitat nella definizione dello stato ecologico in fiumi e laghi del Sud Europa Giornata celebrativa per il ventennale del
Premesse, obiettivi e struttura generale del progetto INHABIT: importanza dell habitat nella definizione dello stato ecologico in fiumi e laghi del Sud Europa Giornata celebrativa per il ventennale del
