Modelli attuariali per la valutazione dei rischi sanitari
|
|
|
- Samuele Carbone
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Modelli attuariali per la valutazione dei rischi sanitari Susanna Levantesi Dipartimento di Scienze Statistiche Sapienza Università di Roma Roma, 30 marzo 2017
2 Agenda Le assicurazioni sulla salute: Caratteristiche e peculiarità Forme assicurative di lunga durata Forme assicurative di breve durata Modelli attuariali per la stima di basi tecniche delle assicurazioni sulla salute Modelli multistato e processi markoviani Metodi di analisi della sopravvivenza Tavole a decremento multiplo Applicazioni alle assicurazioni di non autosufficienza e di malattia grave: Costruzione di basi tecniche per l assicurazione LTC Costruzione di basi tecniche per l assicurazione di malattia grave Slide 2
3 SSN e assicurazioni sulla salute: introduzione Assicurazione pubblica Servizio Sanitario Nazionale (SSN) basato su principi universalistici, obbligatorietà e garanzia di prestazione dei servizi essenziali. Lo Stato assicura a tutti i cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero il diritto alla salute garantito da servizi e prestazioni standard. Assicurazione privata: prevede l intervento dell assicuratore al manifestarsi di un alterazione, tra quelle previste in polizza, dello stato di salute dell assicurato o al sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza Cause dell alterazione dello stato di salute: Infortunio; Malattia; Invalidità senile (stati patologici o di deterioramento fisiologico che impediscono la conduzione di una vita autonoma) Fondi sanitari, mutue, assicurazioni collettive Assicurazioni individuali Slide 3
4 Assicurazioni sulla salute: antiselezione e moral hazard Antiselezione degli assicurati tendenza ad assicurarsi da parte di individui particolarmente esposti al rischio di contrarre malattie o di incorrere in infortuni Incide sulla sinistrosità del rischio Limitata da accertamenti sanitari all ingresso in assicurazione per una corretta valutazione del rischio Moral hazard rischio morale derivante da comportamenti scorretti da parte dell assicurato (es. propensione a denunciare sinistri anche non oggettivamente evidenti in base alle proprie condizioni di salute) che impediscono all assicuratore di conoscere realmente le effettive condizioni di salute dell assicurato Frequente nelle coperture di rendita per periodi di incapacità lavorativa Slide 4
5 Assicurazioni sulla salute: periodi di carenza e di qualificazione Periodo di carenza ( waiting period ) arco di tempo, susseguente la stipula del contratto, che esclude dalla copertura assicurativa le malattie che in esso si manifestano Contiene i costi e contrasta gli effetti dell antiselezione Periodo di qualificazione arco di tempo, a partire dal verificarsi della malattia o dall insorgere dell incapacità lavorativa, necessario affinché l assicurato sia titolato a percepire il beneficio Generalmente dura qualche settimana Opera come franchigia relativa Può essere incluso nella franchigia (rendite o diarie) Slide 5
6 Assicurazioni sulla salute: natura delle prestazioni Prestazione a rimborso Rimborso totale o parziale di un costo sostenuto dall assicurato Rami danni Rimborso spese mediche Rami vita Prestazione indennitaria Ammontare forfettario indipendente dalla perdita di reddito Prestazione prefissata sostitutiva del reddito da lavoro Prestazione di servizio Diaria da infortunio/malattia Capitale caso morte Capitale invalidità permanente Rendita (LTC/PHI) Capitale (malattia grave) Servizi di assistenza e cure ospedaliere Slide 6
7 Assicurazioni sulla salute: clausole contrattuali Le clausole contrattuali Producono una diminuzione del prezzo della copertura assicurativa Rendono l assicurato corresponsabile inducendolo ad adottare precauzioni che prevengono i sinistri Riducono il fenomeno del moral hazard - Massimali di durata - Massimali di importo - Franchigia temporale - Franchigia relativa - Franchigia assoluta - Periodo di qualificazione della malattia - Scoperto - Periodo di carenza iniziale Slide 7
8 Le assicurazioni sulla salute di lunga durata IV Ramo vita: «l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità» (D. Lgs. n.209/2005 e successive modifiche) Assicurazione del rischio di malattie gravi (Dread Disease (DD) o Critical Illness (CI)); Assicurazione del rischio di perdita di autosufficienza (Long Term Care (LTC)); Assicurazione del rischio di incapacità lavorativa dovuta a infortunio o malattia (Permanent Health Insurance (PHI)). Slide 8
9 Le assicurazioni sulla salute di breve durata I Ramo danni: «Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate» Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte o un invalidità permanente o un inabilità temporanea Assicurazione infortuni: forme di copertura Diaria in caso d inabilità temporanea causata da infortunio Capitale in caso d invalidità permanente, totale o parziale, da infortunio Capitale in caso di decesso Garanzie accessorie: ad esempio, copertura del rimborso delle spese sanitarie sostenute dall assicurato a seguito di infortunio Slide 9
10 Le assicurazioni sulla salute di breve durata II Ramo danni: «Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste» Malattia: ogni alterazione dello stato di salute dell assicurato non dipendente da infortunio Assicurazione malattia: forme di copertura Rimborso delle spese mediche (o di cura) sostenute dall'assicurato in caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico, reso necessario da: o o o Malattia, Infortunio, Parto. Diaria per ricovero ospedaliero Diaria per inabilità temporanea da malattia Capitale per invalidità permanente, totale o parziale, da malattia Slide 10
11 Le assicurazioni sulla salute di breve durata Coperture annuali Calcolo del premio in base al principio di equità In base all osservazione statistica su un insieme di rischi omogenei r : numero di rischi s : numero di sinistri annui registrati tra gli r rischi c 1, c 2, c s : costo dei sinistri 1,2,..,s Quota danni: frequenza sinistri s r * costo medio per sinistro c 1 +c 2 + +c s s Q = c 1+c 2 + +c s r = s r c 1+c 2 + +c s s h : numero massimo di sinistri che colpiscono un rischio Indice di ripetibilità: ρ = s r 1 +r 2 + +r h Slide 11
12 Modelli attuariali per la stima di basi tecniche di assicurazioni sulla salute di lunga durata Coperture pluriennali Modelli di pricing basati su modelli multistato (più diffusi) Modelli di mortalità applicati in un contesto multistato (mortalità degli attivi, mortalità degli invalidi, transizione da attivo ad invalido, ecc.) o o Deterministici (Gompertz-Makeham, Weibull, ) Stocastici (Lee-Carter, Cairns-Blake-Dowd) Tavole a decrementi multipli Prevedono più cause di uscita Strumento utile per lo studio delle assicurazioni sulla salute basate su modelli multistato Modelli di pricing basati su metodi di analisi della sopravvivenza (meno diffusi) Slide 12
13 Modelli multistato Consentono di riassumere la storia assicurativa di ciascun individuo mediante la rappresentazione dei possibili stati assunti dall individuo in un istante di tempo. Definiti da: spazio degli stati {1,2,,m} e insieme delle transizioni dirette tra stati Stato transitorio Stato transitorio Stato strettamente transitorio Stato assorbente Slide 13 1
14 Modelli multistato Struttura dello schema coerente con le condizioni contrattuali della copertura assicurativa da rappresentare (transizione tra stati che comporta un flusso monetario) L insieme degli stati aleatori occupati dall assicurato costituiscono il processo stocastico {S(t)}, con t parametro operativo Modelli discreti: assegnazione di probabilità di transizione tra stati che si riferiscono ad intervalli di tempo di ampiezza determinata. Processo S(t) a parametro discreto (t = 0,1,2, a valori interi) Modelli continui: assegnazione di intensità istantanee di transizione tra stati che si riferiscono ad intervalli di tempo infinitesimi (dt). Processo S(t) a parametro continuo (t 0 reale) Slide 14
15 Processi markoviani Si assume che {S(t)} sia una catena di Markov: processo stocastico in cui la probabilità di transizione che determina il passaggio tra stati del sistema dipende unicamente dallo stato del sistema immediatamente precedente (proprietà di Markov) ed è indipendente dalla traiettoria del processo La distribuzione del processo {S(t)} è determinata unicamente dalla distribuzione iniziale e dalle probabilità/intensità di transizione tra stati Catena di Markov non omogenea: processo in cui la probabilità di transizione dipende sia dalla distanza tra due istanti temporali sia dall'origine dell'asse dei tempi (età). Quindi, siano: Slide 15
16 Processi markoviani Probabilità di transizione dallo stato i allo stato j Intensità di transizione dallo stato i allo stato j La struttura probabilistica del processo {S(t) } può essere riassunta in una matrice delle probabilità di transizione: Matrice di transizione del processo Esempio di modello a 3 stati: a = attivo i = invalido d = deceduto a d i Slide 16
17 Equazioni differenziali di Kolmogorov Le equazioni differenziali prospettive di Kolmogorov permettono di trovare le probabilità di transizione e di permanenza in funzione delle intensità di transizione: d dt t p aa x t p aa x ai x t ad x t a i d dt t p ai x t p ai x id x t t p aa x ai x t Stato di partenza: attivo d d dt t p ad x t p aa x ad x t Stato di partenza: invalido d dt t p ii x t p ii x id x t d dt t p ia x t p ia x ad x t t p ii x ia x t d dt t p id x t p ii x id x t Slide 17
18 Tavole a decrementi multipli Tavole «increment-decrement» che prevedono più modalità di entrata/uscita In ambito attuariale le tavole a decrementi multipli (multiple decrement table) sono di grande utilità Analisi della mortalità per causa (prestazioni differenti per cause di morte differenti) Analisi delle transizioni tra stati in un modello multistato (prestazioni differenti per cause di uscita differenti, ad es. malattia grave e morte) Sono estensioni di tavole di mortalità standard in cui coesistono decrementi simultanei dovuti a varie cause L eliminazione da ogni stato è studiata separatamente Le uscite da uno stato rappresentano in genere entrate in un nuovo stato Slide 18
19 Tavole a decrementi multipli Notazione convenzionale: : numero atteso di sopravviventi all età x : numero di individui che escono dalla popolazione (decrementi) tra le età x e x + 1 per la causa j : numero totale di uscite per tutte le cause m : numero totale di possibili decrementi : probabilità che un individuo di età x uscirà dalla popolazione entro l anno per la causa (o decremento) j : probabilità che un individuo di età x uscirà dalla popolazione entro l anno Analogamente si possono calcolare le corrispondenti probabilità di sopravvivenza Slide 19
20 Tavole a decrementi multipli Slide 20
21 Metodi di analisi della sopravvivenza Metodologie utilizzate per descrivere e studiare la durata residua di permanenza in un particolare stato del sistema, ovvero il tempo di attesa prima che l individuo transiti in un altro stato a seguito di un particolare evento (per esempio, invalidità) Non parametrici nessuna assunzione sulla forma analitica della funzione di ripartizione Tavole di sopravvivenza Stimatore di Kaplan- Meier Parametrici si assume una distribuzione notevole per la funzione di ripartizione Weibull Lognormale Esponenziale Semiparametrici nessuna ipotesi sulla funzione di sopravvivenza ma forma funzionale rispetto a caratteristiche individuali GLM Cox proportional hazard rate Slide 21
22 Tavole di sopravvivenza Suddivisione in sotto-intervalli, non necessariamente della stessa lunghezza, della variabile aleatoria durata di vita alla nascita [0, ω] Unità scelta: tipicamente l anno Siano : m: numero di intervalli scelti n j : numero di individui presenti ad inizio intervallo d j : numero di individui usciti nell intervallo [t j 1, t j ] per la causa oggetto di studio c j : numero di individui usciti nell intervallo [t j 1, t j ] per cause diverse da quella oggetto di studio (censored data); τ j : ampiezza dell intervallo j. La probabilità di uscita è stimata come: Ipotesi di uniforme distribuzione delle uscite nell anno Numero di uscite Esposti al rischio Slide 22
23 Tavole di sopravvivenza La probabilità di permanenza è quindi: La stima della funzione di sopravvivenza si ottiene moltiplicando le stime della probabilità di sopravvivenza su tutti i sotto-intervalli Indicando con T 0 la variabile aleatoria durata di vita residua per un individuo al tempo t 0 = 0 (alla nascita), si ottiene la funzione di sopravvivenza: Stimatore di Kaplan Meier Prodotto-limite = si ottiene come valore limite della stima della funzione di sopravvivenza, facendo tendere a 0 l ampiezza degli intervalli Osservazione continua delle unità statistiche, al fine di ottenere il tempo di sopravvivenza esatto per ogni singolo individuo Adatto per campioni di bassa numerosità Slide 23
24 Stimatore di Kaplan-Meier Campione formato da n unità con tempi di sopravvivenza t 1,, t n t (1) < < t (r) con r n : tempi osservati al verificarsi dell'evento ordinati in modo crescente n j : numero dei soggetti a rischio immediatamente prima del tempo t j d j : numero di individui che subiscono l evento (ad esempio uscita per morte) al tempo t j, per j = 1,, r. La probabilità di uscita nell istante t j, essendo l individuo rimasto nel collettivo fino a tale epoca, è stimata come: Lo stimatore Kaplan-Meier della funzione di sopravvivenza si ottiene dalla produttoria delle probabilità di sopravvivenza: I dati censurati sono assunti a fine periodo, anziché distribuiti in modo uniforme sull intervallo di riferimento come nel metodo delle tavole di sopravvivenza. Slide 24
25 Stimatore di Kaplan-Meier Curva di sopravvivenza di 40 pazienti con tumore al seno. Slide 25
26 Metodi parametrici Modelli in cui la distribuzione di probabilità può essere definita da una funzione analitica dipendente da uno o più parametri incogniti. Esempi di distribuzioni ampiamente utilizzate in ambito attuariale: Distribuzione Funzione di sopravvivenza Gompertz-Makeham Weibull Lognormale Esponenziale Slide 26
27 Modelli lineari generalizzati (GLM) Mettono in relazione il valore atteso del fenomeno aleatorio oggetto di analisi con un set di osservazioni di diverse variabili indipendenti. Per stabilire un legame tra il fenomeno aleatorio e il set delle variabili indipendenti, è necessario verificare che vi sia tra di loro un sufficiente grado di dipendenza. Dalla combinazione lineare delle variabili indipendenti si ottiene il valore atteso di una trasformata della variabile aleatoria studiata. Siano: Link function (monotona e invertibile) Intercetta regressori Termine di errore Slide 27
28 Cox proportional hazard rate Modello di regressione proposto da Cox nel 1972 Variabili «evento» (malattia, invalidità, ) e «tempo» Hazard function dell i-mo individuo: : baseline hazard rate : variabili indipendenti (covariate) : coefficienti di regressione se β = 0 il rischio è costante e indipendente dalle caratteristiche di ciascun individuo 0 ( t) z z,..., z i i1,..., 1 ik k z i ( t, zi) i T z t, z 0( t e ) L hazard rate di soggetti differenti con covariate z 1 e z 2 sono proporzionali (per ogni t): T ( t, z ( t, z 1 2 ) ) e e i z T z 1 2 Slide 28
29 Cox proportional hazard rate Tale modello consente di esplorare facilmente i collegamenti tra rischio e covariate individuali.,..., E un modello semi-parametrico perchè i coefficienti 1 sono stimati senza tener conto della forma della baseline hazard function ( ) 0 ( t) Le covariate possono variare nel tempo, in tal caso il modello può essere utilizzato come un potente strumento predittivo Può essere utilizzato per stimare le intensità di transizione da uno stato all altro in un modello multistato (si veda ad esempio: Czado e Rudolph, 2002) k Slide 29
30 Cox proportional hazard rate: esempio di applicazione Impiego del modello di Cox per studiare la sopravvivenza dei percettori di prestazioni LTC Covariate considerate: età sesso tipo di cura livello di non autosufficienza Slide 30
31 Cox proportional hazard rate: esempio di applicazione Funzione dell hazard rate dipendente dalle covariate considerate: Dalla stima degli hazard rate per ogni transizione del modello, si possono ricavare tutte le probabilità che definiscono il modello, ad esempio: Slide 31
32 COSTRUZIONE DI BASI TECNICHE PER L ASSICURAZIONE LTC e MALATTIE GRAVI: APPLICAZIONI Slide 32
33 La base dati Incidence rates numero di persone che hanno un nuovo caso di malattia/disabilità nell anno Prevalence rates proporzione di persone che sono malate o non autosufficienti in una popolazione Decessi Decessi per causa (assicurazioni malattie gravi) Decessi tra la popolazione non autosufficiente (assicurazioni LTC) Età Sesso Anno Età Sesso Anno Età Sesso Anno Durata della condizione/ livello di non autosuff. Slide 33
34 La non autosufficienza Concetto diverso da: Malattia: alterazione temporanea dello stato di salute Invalidità: ridotta capacità di condurre normali attività a seguito di infortunio o malattia Legata all incapacità di conseguire reddito da lavoro Può non implicare un bisogno di assistenza Handicap: limitazione fisica o psicologica nella conduzione di normali attività Svantaggio sociale Può implicare un bisogno di assistenza Non autosufficienza: perdita di autonomia nelle attività più semplici della vita quotidiana Implica un bisogno di assistenza Slide 34
35 La popolazione non autosufficiente in Italia Indagine ISTAT sulle Condizioni di salute, fattori di rischio e ricorso ai servizi sanitari Non autosufficienza: incapacità di svolgere, in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio, una serie di attività elementari della vita quotidiana Persone con disabilità di 6 anni e più per tipo di disabilità e classe di età Italia. Anni 2000, 2005, 2013 Anno M F T Maschi Femmine Slide 35
36 Definizione di Long Term Care (LTC) Complesso di interventi, erogati da istituzioni pubbliche o private, necessari per far fronte al bisogno di assistenza di individui prevalentemente anziani in condizioni di non autosufficienza. Necessità di assistenza a vari livelli Assistenza domiciliare Soggiorno con assistenza in case di riposo Ricovero in case o istituti di cura Sistema a tre pilastri 1 pilastro: assicurazione pubblica (indennità di accompagnamento (statale), prestazioni regionali e comunali) 2 pilastro: fondi pensione, fondi sanitari, assicurazioni collettive 3 pilastro: polizze assicurative individuali Slide 36
37 Le prestazioni LTC nel settore pubblico Prestazioni eterogenee: sanitarie, assistenziali, monetarie Articolate su 3 livelli (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali L. 328/2000): Stato Regioni Comuni Fissa il livello assistenziale minimo (LEA) garantito Implementano i LEA Indennità di accompagnamento invalidità totale e permanente del 100% impossibilità di deambulare senza aiuto permanente ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita Importo: 515 mensili (tassazione generale) No livelli differenti di disabilità, no test dei mezzi Programmazione e orientamento interventi sociali a livello territoriale Ruolo operativo indiretto Attori principali dell assistenza sociale ai non autosufficienti Funzione amministrativa Slide 37
38 Assicurazione LTC privata Contratto che copre il rischio di perdita dell autosufficienza nello svolgimento delle attività elementari della vita quotidiana Definizione del rischio in base alle Activities of Daily Living (ADL): ad es. 4/6; 3/4; talvolta anche in base alla presenza di Alzheimer o di altre demenze senili Più frequente: prestazione LTC in forma di rendita vitalizia finché l assicurato rimane nello stato di non autosufficiente Meno frequente: rimborso spese sanitarie e assistenziali (ramo danni) Limiti di età all ingresso in assicurazione: anni Premi in base a stato di salute, età e sesso Presenza di un periodo di carenza: generalmente 1 anno, se la non autosufficienza è dovuta a malattia Slide 38
39 Copertura LTC in forma di rendita: tipologie Stand-alone o autonoma Complementare ad un assicurazione sulla vita (per es. di una caso morte o di una rendita vitalizia) Complementare ad un assicurazione sulla salute (aggiuntiva o anticipativa): assicurazione malattia + rimborso spese LTC Enhanced pension: rendita vitalizia immediata a premio unico (acquistata all età di pensionamento), il cui importo è maggiorato in caso di non autosufficienza Enhanced annuity: rendita LTC immediata, a premio unico, destinata a chi già si trova in condizioni di non autosufficienza Slide 39
40 Un modello attuariale per la stima di basi tecniche per assicurazioni LTC Modello presente in «Assicurazioni sulla salute: caratteristiche, modelli attuariali e basi tecniche», A cura di: De Angelis P., Di Falco, L.. Ed. Il Mulino. Baione F., Conforti, C., Levantesi S., Menzietti M., Tripodi A. (2016). Stima di basi tecniche per assicurazioni LTC, malattie gravi e invalidità : p Base dati: Titolari di indennità di accompagnamento e/o pensioni di invalidità. INPS, Slide 40
41 Indennità di accompagnamento Requisiti per ottenere l indennità di accompagnamento: riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche, impossibilità di deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un assistenza continua. Al compimento del 65 anno di età, il diritto all indennità è subordinato alla condizione che la persona abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza. L indennità è compatibile con lo svolgimento di un attività lavorativa. L indennità è compatibile e cumulabile con: pensione di inabilità e pensioni per i ciechi totali o parziali. Buona aderenza con la definizione presente nei prodotti assicurativi (che prevedono però vincoli specifici per la determinazione della non autosufficienza, come l incapacità di svolgere un determinato numero di ADL). Slide 41
42 Un modello attuariale per la stima di basi tecniche per assicurazioni LTC Modello multistato non omogeneo a tempo discreto con tre stati: 1 = attivo, 2 = non autosufficiente, 3 = deceduto. D ij x, t : numero osservato di transizioni dallo stato i allo stato j l i x, t : numero di individui (della popolazione di riferimento) di età x che si trovano nello stato i nell anno t Probabilità di transizione: e di permanenza: p ij x, t = Dij x,t ; l i x,t pii x, t = li x+1,t+1 l i x,t Riattivazione non considerata per l indisponibilità di dati ed il carattere sostanzialmente cronico della perdita di autosufficienza. Slide 42
43 Un modello attuariale per la stima di basi tecniche per assicurazioni LTC Alcuni modelli stocastici (ad es. Lee-Carter) esaminano il tasso centrale di transizione, m ij x, t, invece delle probabilità di transizione. Tasso centrale di transizione: m ij x, t = Dij x,t E i x,t E i x, t : esposti al rischio di transizione dallo stato i allo stato j Assumendo che m ij x, t sia costante all interno di ciascun anno di calendario, valgono le seguenti relazioni: Slide 43
44 Utilizzo di modelli stocastici di proiezione delle probabilità La lunga durata delle polizze LTC, unitamente all evoluzione dinamica delle probabilità di transizione, rende necessario ricorrere a modelli di proiezione delle probabilità di transizione (non solo per le probabilità di sopravvivenza). Nell ambito dei modelli introdotti in letteratura si è optato di impiegare modelli appartenenti alla famiglia dei modelli stocastici. Vantaggi: tengono conto della natura stocastica dei dati di partenza permettono di proiettare sia una best estimate che gli intervalli di confidenza Modello utilizzato: Lee-Carter adattato in un ambiente multistato In alternativa è possibile utilizzare altri modelli stocastici. Si veda ad esempio Levantesi-Menzietti (2012) per un applicazione del modello Cairns-Blake-Dowd in ambito multistato Slide 44
45 Modello Lee-Carter in ambito multistato Evoluzione dei tassi centrali di transizione tra gli stati: Vincoli: Processi k t ij modellizzati e proiettati tramite un modello ARIMA(0,1,0): Con C matrice triangolare 3 3 ricavata dalla matrice di varianza e covarianza tra i parametri K e Z vettore 3 1 di variabili normali standardizzate indipendenti Slide 45
46 I parametri del modello Lee-Carter multivariato: alfa Maschi Femmine Slide 46
47 I parametri del modello Lee-Carter multivariato: beta Maschi Femmine Slide 47
48 I parametri del modello Lee-Carter multivariato: kappa Maschi Femmine Slide 48
49 La perequazione dei parametri beta L andamento irregolare (e biologicamente non giustificato) dei beta ha indotto ad effettuare lo smoothing degli stessi con funzioni di tipo spline (Currie-Durban-Eilers (2004)). Slide 49
50 La scelta del modello ARIMA per la proiezione delle intensità Scelto per tutti i tre processi kappa, sia per popolazione maschile che femminile, un ARIMA(0,1,0) (random walk with drift) k t 13 per entrambi i generi andamento sostanzialmente lineare su tutto l orizzonte di analisi k t 23 per entrambi i generi andamento sostanzialmente lineare sino al 2009 k t 12 per entrambi i generi inversione di tendenza dal 2009 (effetto dei cambiamenti normativi INPS) Slide 50
51 La proiezione dei fattori temporali (kappa) Maschi Femmine Slide 51
52 Probabilità di transizione p13, maschi Probabilità di transizione p23, maschi Slide 52
53 Probabilità di transizione p12, maschi Slide 53
54 p23 p13 p12) Le probabilità di transizione proiettate 0.02 p13 maschi low 0.01 p12 maschi low mean high mean high Età Età p23 maschi low mean Età high Età 70 - Maschi Slide 54
55 Un modello attuariale per la stima di basi tecniche per assicurazioni malattie gravi Modello presente in «Assicurazioni sulla salute: caratteristiche, modelli attuariali e basi tecniche», A cura di: De Angelis P., Di Falco, L.. Ed. Il Mulino. Baione F., Conforti, C., Levantesi S., Menzietti M., Tripodi A. (2016). Stima di basi tecniche per assicurazioni LTC, malattie gravi e invalidità : p Base dati: Tassi specifici di mortalità per grandi gruppi di cause e popolazione con malattie croniche. ISTAT, Slide 55
56 Assicurazione malattie gravi Denominata comunemente Dread Disease (DD) o Critical Illness (CI) Interviene nella circostanza in cui l assicurato sia colpito da una malattia particolarmente grave, attraverso il pagamento di un capitale forfettario Non ha carattere risarcitorio quindi non offre un risarcimento commisurato alle effettive spese di cura e/o chirurgiche Il supporto finanziario fornito mira a far fronte alle necessità dell assicurato mentre è in vita Non intende offrire introiti mirati alla sostituzione parziale del reddito da lavoro Il pagamento ha luogo solo in seguito alla diagnosi della malattia Sono previsti limiti di età (65/70 anni) oltre i quali cessa la copertura Spesso offerta sul mercato in via complementare a polizze sulla durata di vita Slide 56
57 Assicurazione Dread Disease (DD) Prestazione pari alla somma pattuita in polizza Durata pluriennale Premio annuo costante Breve periodo di qualificazione della malattia Periodo iniziale di carenza Tipologia di copertura: Autonoma o Stand Alone Abbinata con un assicurazione vita (TCM) Anticipativa Aggiuntiva Slide 57
58 Criteri di scelta delle malattie Per essere inclusa in un contratto DD ogni malattia deve soddisfare i seguenti criteri: deve comportare alla persona un bisogno di denaro deve avere una definizione chiara e precisa non deve permettere l antiselezione da parte degli assicurati deve esistere una base statistica relativa alle specifiche malattie coperte dalla polizza per il calcolo dei costi della copertura Malattie generalmente coperte dall assicurazione (appartengono alle principali cause di morte): Infarto Tumore Ictus Chirurgia del cuore o del by-pass Insufficienza renale Trapianto di organo Sclerosi multipla Slide 58
59 La base dati utilizzata (Italia) Tassi di prevalenza delle persone che riportano condizioni croniche (anno 2005 (ISTAT (2008)) tipologia di malattia sesso classe di età Tassi specifici di mortalità (anno 2009 (ISTAT)) grandi gruppi di cause sesso classe di età Tavole di mortalità (anno 2009 (ISTAT)) sesso Età Limitazioni: dati nazionali e non di esperienza, presenza di grandi gruppi di patologie più generici rispetto alle definizioni previste usualmente dalle coperture assicurative sulle malattie gravi. Slide 59
60 Un modello attuariale per la stima di basi tecniche per assicurazioni malattie gravi Modello multistato non omogeneo a tempo discreto con 4 stati: 1 = attivo 2 = malato grave 3 = deceduto a causa di malattia grave 4 = deceduto per altre cause Relazioni tra probabilità ed intensità Slide 60
61 La metodologia utilizzata Assegnazione di una funzione analitica alle intensità di transizione μ ij Stima dei parametri attraverso un metodo statistico Minimi quadrati Massima verosimiglianza La scelta del modello per la stima delle intensità di transizione dipende dalle caratteristiche della base dati disponibile per quanto attiene: qualità informativa profondità storica La transizione da sano a malato, μ 12 : se disponibili i tassi di incidenza (incidence rates), è stimabile direttamente dai dati con metodi parametrici o non-parametrici se disponibili i tassi di prevalenza (prevalence rates), è necessario definire le relazioni tra tassi di prevalenza e probabilità di transizione Slide 61
62 Un modello attuariale per la stima di basi tecniche per assicurazioni malattie gravi Modelli parametrici per la mortalità: μ 14, μ 23 Gompertz-Makeham Weibull Disponibilità dei soli tassi di prevalenza (prevalence rates) per la stima della transizione da sano a malato. Relazione tra tassi di prevalenza e probabilità di transizione: Fissata un età di riferimento iniziale x 0, i prevalence rate possono essere interpretati come la probabilità di essere malato all età x per un soggetto che era attivo all età x 0 : PREVALENCE RATES Ipotesi sulla transizione da sano a malato: μ 12 Modelli non parametrici: funzione costante a tratti Modelli parametrici: Gompertz-Makeham, Weibull Slide 62
63 Modelli adottati per la stima delle intensità di transizione del modello malattie gravi Slide 63
64 Modelli adottati per la stima delle intensità di transizione del modello malattie gravi Transizione Mortalità attivi (1) (4) Mortalità malati gravi (2) (3) Transizione da attivo a malato grave (1) (2) Ipotesi A Approccio Grezzo Modello parametrico (GM(0,2)) Modello parametrico (GM(0,2)) Modello non parametrico (funzione costante a tratti) Ipotesi B Full GM Modello parametrico (GM(0,2)) Modello parametrico (GM(0,2)) Modello parametrico (GM(0,2)) Slide 64
65 La stima dei parametri del modello GM(0,2) sulla mortalità GM(0,2) è riconducibile ad una regressione lineare semplice. Si possono calcolare indicatori di bontà di adattamento. Si possono calcolare intervalli di confidenza delle stime. 40% Uomini 40% Donne 35% 30% Prob. Morte Totale Prob. morte Cardio Prob. morte Tumori 35% 30% Prob. Morte Totale Prob. morte Cardio Prob. morte Tumori 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% % Slide 65
66 La stima dei parametri Prevalence rates: valori grezzi vs perequati La scelta a priori di un modello di perequazione è rilevante ai fini dei risultati di stima della intensità di transizione da attivo a malato Negli approcci proposti non è stata effettuata la perequazione dei prevalence rate Minor intensità della variazione relativa osservata sui prevalence rates tra i gruppi di età e Slide 66
67 La stima dei parametri Intensità di transizione μ 12 0,10 0,09 Totale - Maschi Approccio Grezzo l modello identifica dei prevalence rates stimati identici a quelli osservati per singola classe di età. 0,08 0,07 0,06 0,05 Può determinare un effetto a scalino che risultano incoerenti per la costruzione delle basi demografiche. 0,04 0,03 0,02 0,01 0, Età grezzi interpolazione grezzi PR (spline) interpolazione ex-postgm(0,2) PR (spline) Full GM- ex-ante GM(0,2) Approccio Full GM Consente di smussare e rendere più regolari gli andamenti e, quindi, essere più adatta ai fini della costruzione della base demografica. l modello identifica dei prevalence rates meno coerenti con la base dati di riferimento 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 Totale - Femmine Età grezzi interpolazione grezzi PR (spline) interpolazione ex-postgm(0,2) PR (spline) Full GM- ex-ante GM(0,2) Slide 67
68 La stima delle probabilità Soluzione in ipotesi Full GM Slide 68
69 Probabilità di permanenza nello stato di attivo per età e sesso La stima delle probabilità I risultati principali 1,00 0,10 0,95 0,90 0,85 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 p x età Grezzo - Maschi Grezzo - Femmine Full - Maschi Full - Femmine p x età Grezzo - Maschi Grezzo - Femmine Full - Maschi Full - Femmine p x età Grezzo - Maschi Grezzo - Femmine Full - Maschi Full - Femmine Totale 0,05 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Tumori Cardio 0,00 0,00 0,00 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 p x età Grezzo - Femmine Grezzo - Maschi Full - Maschi Full - Femmine p x età Grezzo - Femmine Grezzo - Maschi Full - Maschi Full - Femmine p x età Grezzo - Femmine Grezzo - Maschi Full - Maschi Full - Femmine Probabilità di transizione da attivo a malato grave per età e sesso Slide 69
70 Conclusioni e futuri sviluppi Approccio metodologico utile in caso di informazioni poco dettagliate, frammentarie e non continuative. Principale contributo del modello: soluzione in forma chiusa per la stima delle probabilità del modello multistato di riferimento a partire dalla conoscenza dei prevalence rate. Utilizzo di modelli diversi dal GM purché consentano di trovare soluzioni in forma chiusa. Modello utilizzabile su diverse malattie in modo singolo o congiunto Modello che consente di individuare anche intervalli di confidenza delle stime ottenute. Limite potenziale relativo alle ipotesi sulle intensità di mortalità (es. GM(0,2)) che devono essere preliminarmente verificate attraverso l impiego test statistici sulla qualità del fitting. E possibile definire ipotesi alternative sulla distribuzioni sottostanti l ipotesi di mortalità (i.e. Weibull) purché consentano di trovare soluzioni in forma chiusa.. Laddove disponibili dati su un orizzonte storico sarebbe possibile implementare modelli previsionali delle probabilità (di tipo deterministico o stocastico) Slide 70
71 Bibliografia Baione, F., Levantesi, S. (2014). A Health Insurance Pricing Model Based on Prevalence Rates: Application to Critical Illness Insurance. Insurance: Mathematics and Economics», 58: Baione F., De Angelis, P., Levantesi S., Menzietti M., Tripodi A. (2016). Modelli attuariali per la stima di basi tecniche relative ad assicurazioni di persone. In Assicurazioni sulla salute: caratteristiche, modelli attuariali e basi tecniche: A cura di: De Angelis P., Di Falco, L., Il Mulino. ISBN: Baione F., Conforti, C., Levantesi S., Menzietti M., Tripodi A. (2016). Stima di basi tecniche per assicurazioni LTC, malattie gravi e invalidità. In Assicurazioni sulla salute: caratteristiche, modelli attuariali e basi tecniche: A cura di: De Angelis P., Di Falco, L., Il Mulino. ISBN: Brouhns, N., Denuit, M. and Vermunt, J. K. (2002). A Poisson Log-Bilinear Approach to the Construction of Projected Life Tables. Insurance: Mathematics and Economics 31: Cairns, A.J.G., Blake, D., Dowd, K. (2006). A Two-Factor Model for Stochastic Mortality with Parameter Uncertainty: Theory and Calibration. Journal of Risk and Insurance, 73: Coughlan et al. (2007). LifeMetrics: A toolkit for measuring and managing longevity and mortality risk. Technical Document. JP Morgan, London. Cox, D.R. (1972). Regression models and life-tables (with discussion). Journal of the Royal Statistical Society, 34: Slide 71
72 Bibliografia Currie I. D., Durban, M. and Eilers, P. H. C. (2004). Smoothing and forecasting mortality rates Statistical Modelling, 4, Czado, C., Rudolph, F. (2002). Application of Survival Analysis Methods to Long Term Care Insurance. Insurance: Mathematics and Economics, 31: Haberman S., Pitacco E. (1999). Actuarial models for Disability Insurance. Chapman & Hall, Londra. Lee, R.D., Carter, L.R. (1992). Modelling and forecasting U.S. mortality. Journal of the American Statistical Association, 87: Levantesi, S., Menzietti, M. (2012). Managing Longevity and Disability Risks in Life Annuities with Long Term Care. Insurance: Mathematics and Economics, 50: Macdonald, A.S. (1996) An Actuarial Survey of Statistical Models for Decrement and Transition Data. I: Multiple State, Binomial and Poisson Models. British Actuarial Journal, 2, Macdonald, A.S. (1996) An Actuarial Survey of Statistical Models for Decrement and Transition Data. II: Competing Risks, Non-Parametric and Regression Models. British Actuarial Journal, 2, Macdonald, A.S. (1996) An Actuarial Survey of Statistical Models for Decrement and Transition Data. III: Counting Process Models. British Actuarial Journal, 2, Slide 72
ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA
 Prof.ssa G. Serio, Prof. P. Trerotoli, Cattedra di Statistica Medica, Università di Bari 1/9 ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA L analisi statistica dei cosiddetti tempi di sopravvivenza o tempi di fallimento
Prof.ssa G. Serio, Prof. P. Trerotoli, Cattedra di Statistica Medica, Università di Bari 1/9 ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA L analisi statistica dei cosiddetti tempi di sopravvivenza o tempi di fallimento
LE NUOVE BASI TECNICHE ANIA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: UN PUNTO DI PARTENZA PER L EVOLUZIONE DELLE STRATEGIE DI COPERTURA ROMA, 17 NOVEMBRE 2016
 LE NUOVE BASI TECNICHE ANIA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: UN PUNTO DI PARTENZA PER L EVOLUZIONE DELLE STRATEGIE DI COPERTURA ROMA, 17 NOVEMBRE 2016 L UTILIZZO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA AI FINI WELFARE:
LE NUOVE BASI TECNICHE ANIA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: UN PUNTO DI PARTENZA PER L EVOLUZIONE DELLE STRATEGIE DI COPERTURA ROMA, 17 NOVEMBRE 2016 L UTILIZZO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA AI FINI WELFARE:
Dott. Paolo Olivero. Novità nella prognosi e nella terapia della sclerosi multipla: aspetti assicurativi
 Dott. Paolo Olivero Novità nella prognosi e nella terapia della sclerosi multipla: aspetti assicurativi Assicurazioni private Assicurato non affetto da sclerosi multipla definita o possibile (CIS) all
Dott. Paolo Olivero Novità nella prognosi e nella terapia della sclerosi multipla: aspetti assicurativi Assicurazioni private Assicurato non affetto da sclerosi multipla definita o possibile (CIS) all
Stima della pensione complementare
 Stima della pensione complementare Progetto Esemplificativo Standardizzato Modello ISV-IMDPES - Ed. 03/2016 Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 84 gestito da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Il presente
Stima della pensione complementare Progetto Esemplificativo Standardizzato Modello ISV-IMDPES - Ed. 03/2016 Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 84 gestito da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Il presente
pensionline Documento sull erogazione delle rendite Allegato alle Condizioni Generali di contratto di pensionline Genertellife S.p.A.
 pensionline Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5077 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) Genertellife
pensionline Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5077 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) Genertellife
GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sull erogazione delle rendite (ed.
 GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sull erogazione (ed. 11/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 10 - Pagina Documento bianca sull'erogazione
GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sull erogazione (ed. 11/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 10 - Pagina Documento bianca sull'erogazione
DOCUMENTO SULLE RENDITE
 DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 9/12/2015 Per l erogazione della rendita COMETA ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, una convenzione assicurativa, in vigore fino al
DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 9/12/2015 Per l erogazione della rendita COMETA ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, una convenzione assicurativa, in vigore fino al
Assicurazioni Long Term Care: Analisi e
 Assicurazioni Long Term Care: Analisi e Valutazione dei Rischi Susanna Levantesi Università Sapienza susanna.levantesi@uniroma1.it Massimiliano Menzietti Università della Calabria massimiliano.menzietti@unical.it
Assicurazioni Long Term Care: Analisi e Valutazione dei Rischi Susanna Levantesi Università Sapienza susanna.levantesi@uniroma1.it Massimiliano Menzietti Università della Calabria massimiliano.menzietti@unical.it
La sanità integrativa in Italia e le assicurazioni complementari
 La sanità integrativa in Italia e le assicurazioni complementari L andamento della spesa sanitaria Evoluzione della popolazione anziana per fasce di età Distribuzione della spesa sanitaria per spesa di
La sanità integrativa in Italia e le assicurazioni complementari L andamento della spesa sanitaria Evoluzione della popolazione anziana per fasce di età Distribuzione della spesa sanitaria per spesa di
λ è detto intensità e rappresenta il numero di eventi che si
 ESERCITAZIONE N 1 STUDIO DI UN SISTEMA DI CODA M/M/1 1. Introduzione Per poter studiare un sistema di coda occorre necessariamente simulare gli arrivi, le partenze e i tempi di ingresso nel sistema e di
ESERCITAZIONE N 1 STUDIO DI UN SISTEMA DI CODA M/M/1 1. Introduzione Per poter studiare un sistema di coda occorre necessariamente simulare gli arrivi, le partenze e i tempi di ingresso nel sistema e di
Stima della pensione complementare
 Stima della pensione complementare Progetto Esemplificativo Standardizzato Modello ISV-PSPES - Ed. 03/2015 Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 10 gestito da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Il presente
Stima della pensione complementare Progetto Esemplificativo Standardizzato Modello ISV-PSPES - Ed. 03/2015 Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 10 gestito da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Il presente
UN MODERNO APPROCCIO ALLA CREAZIONE DEI PRODOTTI NON VITA
 UN MODERNO APPROCCIO ALLA CREAZIONE DEI PRODOTTI NON VITA Valerio Scacco Ordine Nazionale degli Attuari Bologna, 16 Giugno 2016 INTRODUZIONE L evoluzione normativa degli ultimi anni fa emergere una maggiore
UN MODERNO APPROCCIO ALLA CREAZIONE DEI PRODOTTI NON VITA Valerio Scacco Ordine Nazionale degli Attuari Bologna, 16 Giugno 2016 INTRODUZIONE L evoluzione normativa degli ultimi anni fa emergere una maggiore
equazione della popolazione o bilancio demografico:
 La dimensione della popolazione Consideriamo un conto corrente bancario: il saldo (fenomeno statico) è riferito ad un certo istante, ad es. inizio anno. Nel corso dell anno si verificano entrate ed uscite
La dimensione della popolazione Consideriamo un conto corrente bancario: il saldo (fenomeno statico) è riferito ad un certo istante, ad es. inizio anno. Nel corso dell anno si verificano entrate ed uscite
TRANSIZIONE DEMOGRAFICA.. E NON SOLO
 TRANSIZIONE DEMOGRAFICA.. E NON SOLO Convegno Criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell assistenza all anziano Rosa Maria Lipsi Sapienza Università di Roma rosa.lipsi@uniroma1.it
TRANSIZIONE DEMOGRAFICA.. E NON SOLO Convegno Criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell assistenza all anziano Rosa Maria Lipsi Sapienza Università di Roma rosa.lipsi@uniroma1.it
La prevenzione degli infortuni stradali Report annuale 2011 sulle fonti di dati disponibili
 [2011] La prevenzione degli infortuni stradali Report annuale 2011 sulle fonti di dati disponibili Unità Organizzativa Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria DG Sanità La prevenzione degli infortuni
[2011] La prevenzione degli infortuni stradali Report annuale 2011 sulle fonti di dati disponibili Unità Organizzativa Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria DG Sanità La prevenzione degli infortuni
Capitolo 1 MODELLI ECONOMICI DEL TASSO DI CAMBIO 11
 Indice INTRODUZIONE p. 8 Capitolo 1 MODELLI ECONOMICI DEL TASSO DI CAMBIO 11 1.1 - TASSI DI CAMBIO E MERCATI VALUTARI: APPROCCIO DI PORTAFOGLIO 11 1.1.1 TASSI DI CAMBIO E TRANSAZIONI INTERNAZIONALI Prezzi
Indice INTRODUZIONE p. 8 Capitolo 1 MODELLI ECONOMICI DEL TASSO DI CAMBIO 11 1.1 - TASSI DI CAMBIO E MERCATI VALUTARI: APPROCCIO DI PORTAFOGLIO 11 1.1.1 TASSI DI CAMBIO E TRANSAZIONI INTERNAZIONALI Prezzi
Analisi di sopravvivenza. Dati di sopravvivenza. caratteristiche peculiari dell analisi. Osservazioni troncate. Censura del I tipo
 Analisi di sopravvivenza Dati di sopravvivenza Insieme di metodi statistici per l analisi della distribuzione del tempo di comparsa di un evento. È una modalità di analisi per dati provenienti da studi
Analisi di sopravvivenza Dati di sopravvivenza Insieme di metodi statistici per l analisi della distribuzione del tempo di comparsa di un evento. È una modalità di analisi per dati provenienti da studi
METODI UTILIZZATI NEL SITO ATLANTEONLINE.ASLMI1.MI.IT
 METODI UTILIZZATI NEL SITO ATLANTEONLINE.ASLMI1.MI.IT SOMMARIO Indicatori... 2 Residenti, indici demografici... 2 Ricoveri Ordinari... 2 Cronicità... 3 Tumori maligni... 3 Mortalità... 3 Tempi e distanze
METODI UTILIZZATI NEL SITO ATLANTEONLINE.ASLMI1.MI.IT SOMMARIO Indicatori... 2 Residenti, indici demografici... 2 Ricoveri Ordinari... 2 Cronicità... 3 Tumori maligni... 3 Mortalità... 3 Tempi e distanze
Sistemi di welfare. IL MERCATO DEL LAVORO. Strumenti di base per l analisi.
 A.A. 2014-2015 Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell Amministrazione Sistemi di welfare IL MERCATO DEL LAVORO. Strumenti di base per l analisi Maria Letizia Pruna SPS/09 Sociologia dei processi economici
A.A. 2014-2015 Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell Amministrazione Sistemi di welfare IL MERCATO DEL LAVORO. Strumenti di base per l analisi Maria Letizia Pruna SPS/09 Sociologia dei processi economici
EPIDEMIOLOGIA DEL TUMORE DEL COLON RETTO IN VENETO
 EPIDEMIOLOGIA DEL TUMORE DEL COLON RETTO IN VENETO Registro Tumori del Veneto dicembre 2014 Baracco M, Baracco S, Bovo E, Dal Cin A, Fiore AR, Greco A, Guzzinati S, Monetti D, Rosano A, Stocco C, Tognazzo
EPIDEMIOLOGIA DEL TUMORE DEL COLON RETTO IN VENETO Registro Tumori del Veneto dicembre 2014 Baracco M, Baracco S, Bovo E, Dal Cin A, Fiore AR, Greco A, Guzzinati S, Monetti D, Rosano A, Stocco C, Tognazzo
Il calcolo del VAR operativo mediante la metodologia stocastica parametrica. Simona Cosma
 Il calcolo del VAR operativo mediante la metodologia stocastica parametrica Simona Cosma Contenuti Il VAR operativo: inquadramento concettuale La metodologia attuariale EVT (Extreme Value Theory) Il VAR
Il calcolo del VAR operativo mediante la metodologia stocastica parametrica Simona Cosma Contenuti Il VAR operativo: inquadramento concettuale La metodologia attuariale EVT (Extreme Value Theory) Il VAR
LA RENDITA. Roberto Arioli
 LA RENDITA un abito su misura La rendita complementare i requisiti di accesso Accesso alla pensione obbligatoria (Inps) Almeno 5 anni di permanenza nel fondo pensione Prestazioni pensionistiche complementari
LA RENDITA un abito su misura La rendita complementare i requisiti di accesso Accesso alla pensione obbligatoria (Inps) Almeno 5 anni di permanenza nel fondo pensione Prestazioni pensionistiche complementari
Le assicurazioni sulla salute. Dott.ssa Donatella Rossi corso di Tecnica Attuariale per le Assicurazioni Prof.ssa Anna Maria Palazzo a.a.
 Le assicurazioni sulla salute Dott.ssa Donatella Rossi corso di Tecnica Attuariale per le Assicurazioni Prof.ssa Anna Maria Palazzo a.a. 2012/2013 Forme di copertura assicurative che intervengono a fronte
Le assicurazioni sulla salute Dott.ssa Donatella Rossi corso di Tecnica Attuariale per le Assicurazioni Prof.ssa Anna Maria Palazzo a.a. 2012/2013 Forme di copertura assicurative che intervengono a fronte
13/04/2015. x k (X + Y) Il numeratore non è necessariamente incluso nel denominatore. Tassi standardizzati
 Relazione tra quantità indipendenti tra loro È il quoziente di due numeri Il numeratore non è necessariamente incluso nel denominatore Suddividere una popolazione in due gruppi di soggetti con differenti
Relazione tra quantità indipendenti tra loro È il quoziente di due numeri Il numeratore non è necessariamente incluso nel denominatore Suddividere una popolazione in due gruppi di soggetti con differenti
Definizione di indicatore
 INDICATORI Definizione di indicatore Natura un parametro o una specie (chimica, fisica, biologica) Caratteristica fondamentale ha una relazione stretta, razionale o empirica, con un fenomeno o una caratteristica
INDICATORI Definizione di indicatore Natura un parametro o una specie (chimica, fisica, biologica) Caratteristica fondamentale ha una relazione stretta, razionale o empirica, con un fenomeno o una caratteristica
CONFIDENZIALE DISTRIBUZIONE LIMITATA. Assicurazioni Long Term Care : il punto di vista attuariale e riassicurativo
 Assicurazioni Long Term Care : il punto di vista attuariale e riassicurativo AIMAV Ital Brokers - Swiss - Swiss Re Re Milano, Roma, 11 Ottobre 9 Giugno 2011 LTC LTC 1 Agenda La non autosufficienza Aspetti
Assicurazioni Long Term Care : il punto di vista attuariale e riassicurativo AIMAV Ital Brokers - Swiss - Swiss Re Re Milano, Roma, 11 Ottobre 9 Giugno 2011 LTC LTC 1 Agenda La non autosufficienza Aspetti
Università degli Studi della Calabria Corso di tecnica attuariale delle assicurazioni sociali. Le assicurazioni sulla salute
 Università degli Studi della Calabria Corso di tecnica attuariale delle assicurazioni sociali Le assicurazioni sulla salute 1 Le assicurazioni sulla salute fanno parte delle Assicurazioni di persone Forme
Università degli Studi della Calabria Corso di tecnica attuariale delle assicurazioni sociali Le assicurazioni sulla salute 1 Le assicurazioni sulla salute fanno parte delle Assicurazioni di persone Forme
Conoscere le assicurazioni Gli elementi costitutivi dell assicurazione. Copertina
 Copertina 1/21 Indice e obiettivo 2/21 Introduzione In questa lezione vedremo che cos è il rischio e come viene gestito dalla Compagnia assicurativa. Le assicurazioni, infatti, sono nate proprio per aiutare
Copertina 1/21 Indice e obiettivo 2/21 Introduzione In questa lezione vedremo che cos è il rischio e come viene gestito dalla Compagnia assicurativa. Le assicurazioni, infatti, sono nate proprio per aiutare
Lezione 12. Statistica. Alfonso Iodice D Enza Università degli studi di Cassino. Lezione 12. A. Iodice.
 discrete uniforme Bernoulli Poisson Statistica Alfonso Iodice D Enza iodicede@unicas.it Università degli studi di Cassino () Statistica 1 / 56 Outline discrete uniforme Bernoulli Poisson 1 2 discrete 3
discrete uniforme Bernoulli Poisson Statistica Alfonso Iodice D Enza iodicede@unicas.it Università degli studi di Cassino () Statistica 1 / 56 Outline discrete uniforme Bernoulli Poisson 1 2 discrete 3
Veneto. Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni
 COMUNICATO STAMPA ROMA, 26 APRILE 2016 Veneto Alcuni risultati relativi al Veneto evidenziati dall analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute
COMUNICATO STAMPA ROMA, 26 APRILE 2016 Veneto Alcuni risultati relativi al Veneto evidenziati dall analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute
SMID a.a. 2004/2005 Corso di Metodi Statistici in Biomedicina Prognosi clinica 28/2/2005
 SMID a.a. 2004/2005 Corso di Metodi Statistici in Biomedicina Prognosi clinica 28/2/2005 Formulazione La prognosi non è altro che la stima della probabilità di un certo esito Quando il medico fa una previsione
SMID a.a. 2004/2005 Corso di Metodi Statistici in Biomedicina Prognosi clinica 28/2/2005 Formulazione La prognosi non è altro che la stima della probabilità di un certo esito Quando il medico fa una previsione
Lazio. Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni
 COMUNICATO STAMPA ROMA, 26 APRILE 2016 Lazio Alcuni risultati relativi al Lazio evidenziati dall analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute
COMUNICATO STAMPA ROMA, 26 APRILE 2016 Lazio Alcuni risultati relativi al Lazio evidenziati dall analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute
Definizione Impiego Esempi Fonti:
 I rapporti statistici II parte Tassi: generici specifici standardizzati Definizione Impiego Esempi Fonti: Numeri indici: semplici composti TASSI Nel caso di popolazioni p statistiche, le relative statistiche
I rapporti statistici II parte Tassi: generici specifici standardizzati Definizione Impiego Esempi Fonti: Numeri indici: semplici composti TASSI Nel caso di popolazioni p statistiche, le relative statistiche
STATISTICA (2) ESERCITAZIONE Dott.ssa Antonella Costanzo
 STATISTICA (2) ESERCITAZIONE 7 11.03.2014 Dott.ssa Antonella Costanzo Esercizio 1. Test di indipendenza tra mutabili In un indagine vengono rilevate le informazioni su settore produttivo (Y) e genere (X)
STATISTICA (2) ESERCITAZIONE 7 11.03.2014 Dott.ssa Antonella Costanzo Esercizio 1. Test di indipendenza tra mutabili In un indagine vengono rilevate le informazioni su settore produttivo (Y) e genere (X)
DOCUMENTO SULLE RENDITE. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione LABORFONDS nella seduta del 29/03/2016
 DOCUMENTO SULLE RENDITE Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione LABORFONDS nella seduta del 29/03/2016 DOCUMENTO SULLE RENDITE Il presente documento disciplina le prestazioni pensionistiche
DOCUMENTO SULLE RENDITE Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione LABORFONDS nella seduta del 29/03/2016 DOCUMENTO SULLE RENDITE Il presente documento disciplina le prestazioni pensionistiche
Analisi economico-finanziaria degli investimenti
 Analisi economico-finanziaria degli investimenti Lezione 2 I flussi di cassa e I principali criteri decisionali per l analisi finanziaria Economia Applicata all ingegneria a.a. 2015-16 Prof.ssa Carmela
Analisi economico-finanziaria degli investimenti Lezione 2 I flussi di cassa e I principali criteri decisionali per l analisi finanziaria Economia Applicata all ingegneria a.a. 2015-16 Prof.ssa Carmela
SMID a.a. 2004/2005 Corso di Metodi Statistici in Biomedicina Regressione di Cox 7/3/2005
 SMID a.a. 2004/2005 Corso di Metodi Statistici in Biomedicina Regressione di Cox 7/3/2005 Procedura di Mantel-Haenszel Dati relativi a pazienti maschi nel primo anno di follow-up stratificati per età e
SMID a.a. 2004/2005 Corso di Metodi Statistici in Biomedicina Regressione di Cox 7/3/2005 Procedura di Mantel-Haenszel Dati relativi a pazienti maschi nel primo anno di follow-up stratificati per età e
SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New
 SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New NOME PRODOTTO PROTEZIONE MUTUI - New Revisione prodotto post evidenze di mercato a seguito Lettera Ivass/Bankit LE COMPAGNIE BCC Assicurazioni S.p.A BCC Vita S.p.A
SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New NOME PRODOTTO PROTEZIONE MUTUI - New Revisione prodotto post evidenze di mercato a seguito Lettera Ivass/Bankit LE COMPAGNIE BCC Assicurazioni S.p.A BCC Vita S.p.A
MATEMATICA FINANZIARIA RISCHI: RAPPRESENTAZIONE E GESTIONE (CENNI)
 Matematica Finanziaria, a.a. 2011/2012 p. 1/315 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTA DI ECONOMIA MATEMATICA FINANZIARIA RISCHI: RAPPRESENTAZIONE E GESTIONE (CENNI) ANNAMARIA OLIVIERI a.a. 2011/2012
Matematica Finanziaria, a.a. 2011/2012 p. 1/315 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTA DI ECONOMIA MATEMATICA FINANZIARIA RISCHI: RAPPRESENTAZIONE E GESTIONE (CENNI) ANNAMARIA OLIVIERI a.a. 2011/2012
RETI DI TELECOMUNICAZIONE
 RETI DI TELECOMUNICAZIONE Modelli delle Sorgenti di Traffico Generalità Per la realizzazione di un modello analitico di un sistema di telecomunicazione dobbiamo tenere in considerazione 3 distinte sezioni
RETI DI TELECOMUNICAZIONE Modelli delle Sorgenti di Traffico Generalità Per la realizzazione di un modello analitico di un sistema di telecomunicazione dobbiamo tenere in considerazione 3 distinte sezioni
l Inps in cifre La gestione del fondo parasubordinati prevede un avanzo di esercizio pari mln.
 l Inps in cifre (sintesi a cura dello Spi-Cgil Emilia Romagna su dati bilancio preventivo Inps 2013 e Rapporto Istat -Inps 2012 sulla coesione sociale) Sulla base dei dati negativi dei fondi diversi da
l Inps in cifre (sintesi a cura dello Spi-Cgil Emilia Romagna su dati bilancio preventivo Inps 2013 e Rapporto Istat -Inps 2012 sulla coesione sociale) Sulla base dei dati negativi dei fondi diversi da
Informazioni e ipotesi utilizzate per la stima PREVALENTEMENTE OBBLIGAZIONARIO/PROTEZIONE 3,40% BILANCIATO/EQUILIBRIO 2,80%
 Fondaereo - Fondo Pensione Fondo pensione negoziale iscritto all Albo COVIP al n. 2167 Stima della Pensione Complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo
Fondaereo - Fondo Pensione Fondo pensione negoziale iscritto all Albo COVIP al n. 2167 Stima della Pensione Complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo
Statistica Applicata all edilizia: il modello di regressione
 Statistica Applicata all edilizia: il modello di regressione E-mail: orietta.nicolis@unibg.it 27 aprile 2009 Indice Il modello di Regressione Lineare 1 Il modello di Regressione Lineare Analisi di regressione
Statistica Applicata all edilizia: il modello di regressione E-mail: orietta.nicolis@unibg.it 27 aprile 2009 Indice Il modello di Regressione Lineare 1 Il modello di Regressione Lineare Analisi di regressione
BASILICATA. Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni
 COMUNICATO STAMPA ROMA, 26 APRILE 2016 BASILICATA Alcuni risultati relativi alla Basilicata evidenziati dall analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto
COMUNICATO STAMPA ROMA, 26 APRILE 2016 BASILICATA Alcuni risultati relativi alla Basilicata evidenziati dall analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto
1. L efficienza tecnica e allocativa: concetti base
 Manuale del sistema di valutazione della performance degli ospedali lombardi ISBN 978-88-548-5343-0 DOI 10.4399/97888548534308 pag. 63 67 (novembre 2012) Efficienza PAOLO BERTA, GIANMARIA MARTINI, GIORGIO
Manuale del sistema di valutazione della performance degli ospedali lombardi ISBN 978-88-548-5343-0 DOI 10.4399/97888548534308 pag. 63 67 (novembre 2012) Efficienza PAOLO BERTA, GIANMARIA MARTINI, GIORGIO
LTC, scenari e prospettive per il mercato italiano
 LTC, scenari e prospettive per il mercato italiano India, 29 Settembre 2010 Francesco Fidanza: Dirigente Responsabile Previdenza Corporate e Clienti Istituzionali 1 Indice La popolazione anziana in Europa
LTC, scenari e prospettive per il mercato italiano India, 29 Settembre 2010 Francesco Fidanza: Dirigente Responsabile Previdenza Corporate e Clienti Istituzionali 1 Indice La popolazione anziana in Europa
Struttura della popolazione Italiana Anni 1972, 2010, 2050
 Struttura della popolazione Italiana Anni 1972, 2010, 2050 La struttura per sesso ed età E una caratteristica fondamentale delle popolazioni umane poichè ha un impatto considerevole sui processi sanitari,
Struttura della popolazione Italiana Anni 1972, 2010, 2050 La struttura per sesso ed età E una caratteristica fondamentale delle popolazioni umane poichè ha un impatto considerevole sui processi sanitari,
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 25.10.2016 Deducibilità spese mediche e di assistenza specifica La Risoluzione n. 79/E Categoria: Irpef Sottocategoria: Deduzioni A cura di
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 25.10.2016 Deducibilità spese mediche e di assistenza specifica La Risoluzione n. 79/E Categoria: Irpef Sottocategoria: Deduzioni A cura di
Le proiezioni demografiche per la determinazione delle regole europee sul debito pubblico
 Le proiezioni demografiche per la determinazione delle regole europee sul debito pubblico Elena Masi Dipartimento del Tesoro MEF Ageing Working Group Commissione Europea 14 ottobre 2016, Prato Convegno
Le proiezioni demografiche per la determinazione delle regole europee sul debito pubblico Elena Masi Dipartimento del Tesoro MEF Ageing Working Group Commissione Europea 14 ottobre 2016, Prato Convegno
APPENDICE N. 1 ALLA CONVENZIONE N. 5988 POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA VITA Contraente: Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI
 APPENDICE N. 1 ALLA CONVENZIONE N. 5988 POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA VITA Contraente: Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI Con la presente Appendice N. 1 alla convenzione 5988, ai sensi dell Art.
APPENDICE N. 1 ALLA CONVENZIONE N. 5988 POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA VITA Contraente: Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI Con la presente Appendice N. 1 alla convenzione 5988, ai sensi dell Art.
Deutsche Bank Partnership Banking PBC Una banca. Tanti servizi. Mille vantaggi.
 Partnership Banking PBC Partnership Banking PBC Una banca. Tanti servizi. Mille vantaggi. Panoramica Mutui Responsabile Regionale Mutui ipotecari ai privati Agenda 1 Cos è il Mutuo 2 Il compromesso e le
Partnership Banking PBC Partnership Banking PBC Una banca. Tanti servizi. Mille vantaggi. Panoramica Mutui Responsabile Regionale Mutui ipotecari ai privati Agenda 1 Cos è il Mutuo 2 Il compromesso e le
Epidemiologia del tumore del polmone in Veneto. Periodo
 maggio 2016, SER Sistema Epidemiologico Regionale Azienda ULSS 4 Alto Vicentino Area Sanità e Sociale - Sezione Controlli Governo e Personale SSR Regione Veneto Epidemiologia del tumore del polmone in
maggio 2016, SER Sistema Epidemiologico Regionale Azienda ULSS 4 Alto Vicentino Area Sanità e Sociale - Sezione Controlli Governo e Personale SSR Regione Veneto Epidemiologia del tumore del polmone in
L assicurazione agricola contro gli infortuni
 L assicurazione agricola contro gli infortuni L assicurazione agricola contro gli infortuni è concepita come assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; sono quindi coperti non solo il gerente d azienda
L assicurazione agricola contro gli infortuni L assicurazione agricola contro gli infortuni è concepita come assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; sono quindi coperti non solo il gerente d azienda
CALABRIA. Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni
 COMUNICATO STAMPA ROMA, 26 APRILE 2016 CALABRIA Alcuni risultati relativi alla Calabria evidenziati dall analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto
COMUNICATO STAMPA ROMA, 26 APRILE 2016 CALABRIA Alcuni risultati relativi alla Calabria evidenziati dall analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto
Molise. Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni
 ROMA, 26 APRILE 2016 Molise Alcuni risultati relativi al Molise evidenziati dall analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute ASPETTI
ROMA, 26 APRILE 2016 Molise Alcuni risultati relativi al Molise evidenziati dall analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute ASPETTI
IL MODELLO FLaIR. Descrizione sintetica del modello
 IL MODELLO FLaIR Descrizione sintetica del modello Il modello idrologico FLaIR (Forecasting of Landslides Induced by Rainfalls), proposto da Sirangelo e Versace nel 992, costituisce uno strumento di interpretazione
IL MODELLO FLaIR Descrizione sintetica del modello Il modello idrologico FLaIR (Forecasting of Landslides Induced by Rainfalls), proposto da Sirangelo e Versace nel 992, costituisce uno strumento di interpretazione
Prestito chirografario a privati a tasso fisso. Dipendenti Provincia di Lecce
 Modulo n.mepp 27 Agg. n. 1 Data aggiornamento 14.02.2013 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati - Tasso Fisso Dipendenti Provincia di Lecce Prodotto venduto da UniCredit Società
Modulo n.mepp 27 Agg. n. 1 Data aggiornamento 14.02.2013 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati - Tasso Fisso Dipendenti Provincia di Lecce Prodotto venduto da UniCredit Società
RISOLUZIONE N. 76/E. Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
 RISOLUZIONE N. 76/E Roma, 16 settembre 2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Chiarimenti in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione
RISOLUZIONE N. 76/E Roma, 16 settembre 2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Chiarimenti in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione
Le tue ttime ragioni per stare con noi
 Le tue ott ttime ragioni per stare con noi Sussidio per protesi odontoiatriche, ortofoniche, ortopediche Il sussidio, che vale anche per ogni membro della famiglia a carico, è pari al 60% della spesa sostenuta
Le tue ott ttime ragioni per stare con noi Sussidio per protesi odontoiatriche, ortofoniche, ortopediche Il sussidio, che vale anche per ogni membro della famiglia a carico, è pari al 60% della spesa sostenuta
Berica Doppia Formula: la nuova polizza vita multiramo
 Berica Doppia Formula: la nuova polizza vita multiramo Un prodotto al passo con il trend di mercato Uno strumento per un investimento personalizzato, diversificato e flessibile Una polizza innovativa che
Berica Doppia Formula: la nuova polizza vita multiramo Un prodotto al passo con il trend di mercato Uno strumento per un investimento personalizzato, diversificato e flessibile Una polizza innovativa che
L ASSISTENZA AI NON AUTOSUFFICIENTI. Roma Aprile 2016
 1 L ASSISTENZA AI NON AUTOSUFFICIENTI Roma Aprile 2016 Panoramica STORIA DELLA CASDIC La Casdic, nata nel 1992, è la Cassa Nazionale per il Personale Dipendente del Settore del Credito. In qualità di Cassa
1 L ASSISTENZA AI NON AUTOSUFFICIENTI Roma Aprile 2016 Panoramica STORIA DELLA CASDIC La Casdic, nata nel 1992, è la Cassa Nazionale per il Personale Dipendente del Settore del Credito. In qualità di Cassa
Assicurazioni sulla salute
 Assicurazioni sulla salute Assicurazioni di persone Forme di copertura assicurative che intervengono a fronte di situazioni che si vengono a creare in seguito ad alterazioni del normale stato di salute
Assicurazioni sulla salute Assicurazioni di persone Forme di copertura assicurative che intervengono a fronte di situazioni che si vengono a creare in seguito ad alterazioni del normale stato di salute
OPEN FUND NUOVA TIRRENA FONDO PENSIONE APERTO
 FASE DI ACCUMULO Rendimento atteso dei comparti (1)(3) : OPEN FUND NUOVA TIRRENA FONDO PENSIONE APERTO Fondo pensione aperto iscritto all'albo COVIP al n. 72 STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE (Progetto
FASE DI ACCUMULO Rendimento atteso dei comparti (1)(3) : OPEN FUND NUOVA TIRRENA FONDO PENSIONE APERTO Fondo pensione aperto iscritto all'albo COVIP al n. 72 STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE (Progetto
Proposta per un corso su Modelli stocastici di ALM per la gestione delle imprese di assicurazione sulla vita e fondi pensione CISA 12 luglio 2012
 Proposta per un corso su Modelli stocastici di ALM per la gestione delle imprese di assicurazione sulla vita e fondi pensione CISA 12 luglio 2012 Proponente:Paolo De Angelis Riferimenti normativi: settore
Proposta per un corso su Modelli stocastici di ALM per la gestione delle imprese di assicurazione sulla vita e fondi pensione CISA 12 luglio 2012 Proponente:Paolo De Angelis Riferimenti normativi: settore
Qual è il sistema previdenziale in vigore in Italia e come si calcola la pensione?
 In questa pagina potete trovare una raccolta di domande e risposte sui lineamenti generali di un sistema pensionistico. Cos è la previdenza? Chi si occupa della previdenza in Italia? Che cos è la pensione?
In questa pagina potete trovare una raccolta di domande e risposte sui lineamenti generali di un sistema pensionistico. Cos è la previdenza? Chi si occupa della previdenza in Italia? Che cos è la pensione?
UP GRADE INFORTUNI 2016/2017
 Comitati Provinciali F.I.P.A.V. Comitato Regionale Veneto Integrazione Assicurativa per le Società Sportive della Pallavolo dei Comitati Provinciali di Padova, Vicenza, Treviso Regionale Veneto UP GRADE
Comitati Provinciali F.I.P.A.V. Comitato Regionale Veneto Integrazione Assicurativa per le Società Sportive della Pallavolo dei Comitati Provinciali di Padova, Vicenza, Treviso Regionale Veneto UP GRADE
DOCUMENTO SULLE RENDITE
 Iscritto all Albo dei Fondi Pensione 1^ Sez. Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - numero 1146 DOCUMENTO SULLE RENDITE - Documento approvato dal Consiglio di amministrazione del 25 maggio 2016 - Fondo
Iscritto all Albo dei Fondi Pensione 1^ Sez. Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - numero 1146 DOCUMENTO SULLE RENDITE - Documento approvato dal Consiglio di amministrazione del 25 maggio 2016 - Fondo
CENTO STELLE REALE Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP al n.
 CENTO STELLE REALE Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP al n. 5052 Documento sulle rendite Il presente documento integra il contenuto
CENTO STELLE REALE Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP al n. 5052 Documento sulle rendite Il presente documento integra il contenuto
XVII Riunione Annuale AIRTUM
 XVII Riunione Annuale AIRTUM Bolzano 20-22 marzo 2013 PROBABILITA DI MORTE PER CANCRO IN PRESENZA DI ALTRE CAUSE DI MORTE E. Coviello, C. Buzzoni, E. Crocetti Introduzione Un paziente affetto da tumore
XVII Riunione Annuale AIRTUM Bolzano 20-22 marzo 2013 PROBABILITA DI MORTE PER CANCRO IN PRESENZA DI ALTRE CAUSE DI MORTE E. Coviello, C. Buzzoni, E. Crocetti Introduzione Un paziente affetto da tumore
6061 Scienza delle Finanze Cleam- Classe 2. Il sistema pensionistico (2)
 6061 Scienza delle Finanze Cleam- Classe 2 Il sistema pensionistico (2) Il sistema pensionistico italiano Tappe principali: Sistema pre-amato 1992: riforma Amato 1995: riforma Dini 2004: Riforma Maroni
6061 Scienza delle Finanze Cleam- Classe 2 Il sistema pensionistico (2) Il sistema pensionistico italiano Tappe principali: Sistema pre-amato 1992: riforma Amato 1995: riforma Dini 2004: Riforma Maroni
I modelli di proiezione della mortalità
 Giornata degli attuari delle pensioni Gruppo di lavoro dei percettori pensioni/rendite I modelli di proiezione della mortalità Susanna Levantesi Sapienza Università di Roma susanna.levantesi@uniroma1.it
Giornata degli attuari delle pensioni Gruppo di lavoro dei percettori pensioni/rendite I modelli di proiezione della mortalità Susanna Levantesi Sapienza Università di Roma susanna.levantesi@uniroma1.it
Previdenza e Assistenza (I pilastro) Previdenza complementare (II pilastro) Assistenza sanitaria integrativa e LTC (III pilastro)
 Previdenza e Assistenza (I pilastro) Previdenza complementare (II pilastro) Assistenza sanitaria integrativa e LTC (III pilastro) Abano Terme, 25 ottobre 2013 Prestazioni a favore dell iscritto Incentivi
Previdenza e Assistenza (I pilastro) Previdenza complementare (II pilastro) Assistenza sanitaria integrativa e LTC (III pilastro) Abano Terme, 25 ottobre 2013 Prestazioni a favore dell iscritto Incentivi
La riforma per la sostenibilità
 Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti La riforma per la sostenibilità Roma, 9 aprile 2010 1 Finanziamento e modalità di calcolo delle pensioni
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti La riforma per la sostenibilità Roma, 9 aprile 2010 1 Finanziamento e modalità di calcolo delle pensioni
FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI PRIVATI
 INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. Via Ottavio Serena, n. 13-70022 - Altamura (BA) Tel.:080/8710268 -Fax: 080/8710745 [trasparenza@bppb.it/www.bppb.it] Iscrizione all
INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. Via Ottavio Serena, n. 13-70022 - Altamura (BA) Tel.:080/8710268 -Fax: 080/8710745 [trasparenza@bppb.it/www.bppb.it] Iscrizione all
Sommario. Capitolo 1 I dati e la statistica 1. Capitolo 2 Statistica descrittiva: tabelle e rappresentazioni grafiche 25
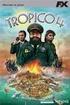 Sommario Presentazione dell edizione italiana Prefazione xv xiii Capitolo 1 I dati e la statistica 1 Statistica in pratica: BusinessWeek 1 1.1 Le applicazioni in ambito aziendale ed economico 3 Contabilità
Sommario Presentazione dell edizione italiana Prefazione xv xiii Capitolo 1 I dati e la statistica 1 Statistica in pratica: BusinessWeek 1 1.1 Le applicazioni in ambito aziendale ed economico 3 Contabilità
CASSA FORENSE L ASSISTENZA. Regolamento per l assistenza in vigore dal 1 gennaio 2016
 CASSA FORENSE L ASSISTENZA Regolamento per l assistenza in vigore dal 1 gennaio 2016 Prestazioni in caso di bisogno a) erogazioni in caso di bisogno individuale b) trattamenti a favore di titolari di pensione
CASSA FORENSE L ASSISTENZA Regolamento per l assistenza in vigore dal 1 gennaio 2016 Prestazioni in caso di bisogno a) erogazioni in caso di bisogno individuale b) trattamenti a favore di titolari di pensione
Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato)
 (Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma
(Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma
Il costi sanitari del tabagismo in della Provincia di Sondrio
 Il costi sanitari del tabagismo in della Provincia di Sondrio 1) Giorni di vita si a causa del in Provincia di Sondrio Materiali e metodi E stato utilizzato il Sistema Informativo di Mortalità dell ASL
Il costi sanitari del tabagismo in della Provincia di Sondrio 1) Giorni di vita si a causa del in Provincia di Sondrio Materiali e metodi E stato utilizzato il Sistema Informativo di Mortalità dell ASL
La valutazione dei rischi. Corso di risk management Prof. Giuseppe D Onza
 La valutazione dei rischi Corso di risk management Prof. Giuseppe D Onza LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E un attività che caratterizza la gestione dei rischi finalizzata ad apprezzare la gravità dei fenomeni
La valutazione dei rischi Corso di risk management Prof. Giuseppe D Onza LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E un attività che caratterizza la gestione dei rischi finalizzata ad apprezzare la gravità dei fenomeni
AMBITO DISTRETTUALE DI ARCISATE
 PIANO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2013 Premessa La Regione Lombardia con la DGR116/2013 determinazioni in ordine all istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglie e dei suoi componenti
PIANO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2013 Premessa La Regione Lombardia con la DGR116/2013 determinazioni in ordine all istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglie e dei suoi componenti
L epidemiologia nei secoli
 Epidemiologia Studia la distribuzione delle malattie nelle popolazioni ed i fattori che ne influenzano l insorgere e la diffusione. L epidemiologia nei secoli V sec. A.C.: Ippocrate osserva che alcune
Epidemiologia Studia la distribuzione delle malattie nelle popolazioni ed i fattori che ne influenzano l insorgere e la diffusione. L epidemiologia nei secoli V sec. A.C.: Ippocrate osserva che alcune
Due possibilità di polizze assicurative per le guide iscritte a Confesercenti.
 Due possibilità di polizze assicurative per le guide iscritte a Confesercenti. 1) Polizza Infortuni Unipol a 25,00 annui per gli iscritti a Confesercenti - 2017. Confesercenti, per venire incontro alle
Due possibilità di polizze assicurative per le guide iscritte a Confesercenti. 1) Polizza Infortuni Unipol a 25,00 annui per gli iscritti a Confesercenti - 2017. Confesercenti, per venire incontro alle
Applicazione della monetizzazione: un esempio
 Valutazione economica degli effetti sanitari dell inquinamento atmosferico: la metodologia dell EEA Taranto 23 24 luglio 2012 Applicazione della monetizzazione: un esempio Paola Biasi (Facoltà di Economia
Valutazione economica degli effetti sanitari dell inquinamento atmosferico: la metodologia dell EEA Taranto 23 24 luglio 2012 Applicazione della monetizzazione: un esempio Paola Biasi (Facoltà di Economia
Diego Vanuzzo CENTRO DI PREVENZIONE UDINE DIREZIONE CENTRALE SALUTE FRIULI
 II sistemi di valutazione nei programmi di prevenzione delle malattie cardiovascolari, della diffusione delle malattie infettive nelle Regioni del Triveneto Indicatori di performance e di risultato t nei
II sistemi di valutazione nei programmi di prevenzione delle malattie cardiovascolari, della diffusione delle malattie infettive nelle Regioni del Triveneto Indicatori di performance e di risultato t nei
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI CALUSCO D ADDA ANNO 2009.
 COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI CALUSCO D ADDA ANNO 2009. RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA Premesso che
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI CALUSCO D ADDA ANNO 2009. RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA Premesso che
Il Taeg = 0. Trasparenza e credito ai consumatori ABISERVIZI S.p.A. - Riproduzione vietata - Tutti i diritti sono riservati.
 e credito ai consumatori 5 Il Taeg k = n 1 1 + TAEG TAEG ( F k )) tk tk = 0 2015 ABISERVIZI S.p.A. - Riproduzione vietata - Tutti i diritti sono riservati. INDICE La formula finanziaria Le ipotesi di calcolo
e credito ai consumatori 5 Il Taeg k = n 1 1 + TAEG TAEG ( F k )) tk tk = 0 2015 ABISERVIZI S.p.A. - Riproduzione vietata - Tutti i diritti sono riservati. INDICE La formula finanziaria Le ipotesi di calcolo
Statistiche in breve
 Statistiche in breve A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Novembre 2016 Anno 2015 Cittadini Extracomunitari Nell anno 2015 il numero di cittadini extracomunitari 1 conosciuti all INPS,
Statistiche in breve A cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale Novembre 2016 Anno 2015 Cittadini Extracomunitari Nell anno 2015 il numero di cittadini extracomunitari 1 conosciuti all INPS,
Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato)
 (Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma
(Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma
FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO ECOENERGY A CONDOMINI
 INFORMAZIONI SULLA BANCA Offerta Fuori Sede Promotore Finanziario Nome e Cognome Nr. Iscrizione Albo CHE COS È IL FINANZIAMENTO (pag. 1 di 11) PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 14/03/2016 1- A TASSO FISSO
INFORMAZIONI SULLA BANCA Offerta Fuori Sede Promotore Finanziario Nome e Cognome Nr. Iscrizione Albo CHE COS È IL FINANZIAMENTO (pag. 1 di 11) PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 14/03/2016 1- A TASSO FISSO
Piano di base I della Cassa pensioni Posta
 Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base I sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base I sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto
- Tel: Indice Corso 60 ore
 Indice Corso 60 ore Modulo 1 - La disciplina delle imprese di assicurazione Le fonti normative del diritto delle assicurazioni Principi e struttura del Codice delle Assicurazioni Le condizioni di accesso
Indice Corso 60 ore Modulo 1 - La disciplina delle imprese di assicurazione Le fonti normative del diritto delle assicurazioni Principi e struttura del Codice delle Assicurazioni Le condizioni di accesso
Introduzione alla Regressione Logistica
 Introduzione alla Regressione Logistica Contenuto regressione lineare semplice e multipla regressione logistica lineare semplice La funzione logistica Stima dei parametri Interpretazione dei coefficienti
Introduzione alla Regressione Logistica Contenuto regressione lineare semplice e multipla regressione logistica lineare semplice La funzione logistica Stima dei parametri Interpretazione dei coefficienti
La Guida alle C O P E R T U R E
 La Guida alle C O P E R T U R E INDICE 1. Infortuni Professionali 2. Infortuni Extra Professionali 3. Long Term Care 4. Inabilità 5. Ex aderenti Fondo Previdenza CARIVE 6. R.C. Famiglia iscritti a LIBERO
La Guida alle C O P E R T U R E INDICE 1. Infortuni Professionali 2. Infortuni Extra Professionali 3. Long Term Care 4. Inabilità 5. Ex aderenti Fondo Previdenza CARIVE 6. R.C. Famiglia iscritti a LIBERO
STATISTICA ESERCITAZIONE
 STATISTICA ESERCITAZIONE Dott. Giuseppe Pandolfo 1 Giugno 2015 Esercizio 1 Una fabbrica di scatole di cartone evade il 96% degli ordini entro un mese. Estraendo 300 campioni casuali di 300 consegne, in
STATISTICA ESERCITAZIONE Dott. Giuseppe Pandolfo 1 Giugno 2015 Esercizio 1 Una fabbrica di scatole di cartone evade il 96% degli ordini entro un mese. Estraendo 300 campioni casuali di 300 consegne, in
b) E necessario formulare delle ipotesi per calcolare l intervallo di confidenza ottenuto al punto a? (motivare brevemente la risposta):
 ESERCIZIO 1 Una grande banca vuole stimare l ammontare medio di denaro che deve essere corrisposto dai correntisti che hanno il conto scoperto. Si seleziona un campione di 100 clienti su cui si osserva
ESERCIZIO 1 Una grande banca vuole stimare l ammontare medio di denaro che deve essere corrisposto dai correntisti che hanno il conto scoperto. Si seleziona un campione di 100 clienti su cui si osserva
EPIDEMIOLOGIA DEL TUMORE DELLA PROSTATA IN VENETO
 dicembre 2014 EPIDEMIOLOGIA DEL TUMORE DELLA PROSTATA IN VENETO Registro Tumori del Veneto Baracco M, Baracco S, Bovo E, Dal Cin A, Fiore AR, Greco A, Guzzinati S, Monetti D, Rosano A, Stocco C, Tognazzo
dicembre 2014 EPIDEMIOLOGIA DEL TUMORE DELLA PROSTATA IN VENETO Registro Tumori del Veneto Baracco M, Baracco S, Bovo E, Dal Cin A, Fiore AR, Greco A, Guzzinati S, Monetti D, Rosano A, Stocco C, Tognazzo
Stima preliminare del PIL I trimestre 2009
 5 maggio 2009 Stima preliminare del PIL I trimestre 2009 In conformità con i requisiti del programma SDDS del Fondo monetario internazionale, l Istat diffonde un calendario annuale dei comunicati stampa
5 maggio 2009 Stima preliminare del PIL I trimestre 2009 In conformità con i requisiti del programma SDDS del Fondo monetario internazionale, l Istat diffonde un calendario annuale dei comunicati stampa
Le pensioni nel Le pensioni da lavoro
 Le pensioni nel 2012 Le pensioni da lavoro Integrazione al minimo Le pensioni liquidate col sistema retributivo o col sistema misto, in presenza di determinate condizioni di reddito, vengono integrate
Le pensioni nel 2012 Le pensioni da lavoro Integrazione al minimo Le pensioni liquidate col sistema retributivo o col sistema misto, in presenza di determinate condizioni di reddito, vengono integrate
3.1 Classificazione dei fenomeni statistici Questionari e scale di modalità Classificazione delle scale di modalità 17
 C L Autore Ringraziamenti dell Editore Elenco dei simboli e delle abbreviazioni in ordine di apparizione XI XI XIII 1 Introduzione 1 FAQ e qualcos altro, da leggere prima 1.1 Questo è un libro di Statistica
C L Autore Ringraziamenti dell Editore Elenco dei simboli e delle abbreviazioni in ordine di apparizione XI XI XIII 1 Introduzione 1 FAQ e qualcos altro, da leggere prima 1.1 Questo è un libro di Statistica
Sistema assicurativo e sostenibilità del servizio sanitario nazionale
 Sistema assicurativo e sostenibilità del servizio sanitario nazionale Maria Bianca Farina Presidente ANIA 11 Forum Risk Management in Sanità FIRENZE FORTEZZA DA BASSO PADIGLIONE SPADOLINI 1 dicembre 2016
Sistema assicurativo e sostenibilità del servizio sanitario nazionale Maria Bianca Farina Presidente ANIA 11 Forum Risk Management in Sanità FIRENZE FORTEZZA DA BASSO PADIGLIONE SPADOLINI 1 dicembre 2016
