Siamo certi che tutti i pazienti con fibrillazione atriale e CHA 2 DS 2 -VASc score 1 debbano essere anticoagulati?
|
|
|
- Orsola Galli
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 EDITORIALE Siamo certi che tutti i pazienti con fibrillazione atriale e CHA 2 DS 2 -VASc score 1 debbano essere anticoagulati? Giuseppe Di Pasquale, Silvia Zagnoni U.O. Cardiologia, Ospedale Maggiore, Bologna G Ital Cardiol 2015;16(11): Il rischio di ictus nella fibrillazione atriale (FA) non è omogeneo e varia dallo 0.4% al 12% per anno. Numerosi score per la stratificazione del rischio tromboembolico sono stati proposti negli ultimi 10 anni e il CHA 2 DS 2 -VASc score, che rappresenta un evoluzione del CHADS 2 score, è quello che si è imposto nella pratica clinica dopo il suo recepimento da parte delle più recenti linee guida della FA 1. Le linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) 2012 raccomandano la terapia anticoagulante orale (TAO) nei pazienti di sesso maschile con CHA 2 DS 2 -VASc 1 e nelle donne con score 2 2. Le linee guida nord-americane AHA/ACC/HRS 2014 raccomandano la TAO per i pazienti con FA di entrambi i sessi con CHA 2 DS 2 -VASc 2, mentre non raccomandano una specifica strategia terapeutica nei pazienti con CHA 2 DS 2 -VASc 1, lasciando al clinico la scelta tra anticoagulazione, aspirina o nessuna terapia 3. Nel corso della stesura delle linee guida italiane AIAC sulla FA le indicazioni per la TAO nei pazienti con CHA 2 DS 2 -VASc 1 sono state oggetto di ampio dibattito e la posizione finale è stata quella di una raccomandazione di classe IIb, un down - grade rispetto al livello di raccomandazione IIa delle linee guida ESC 4. Le linee guida ESC sottolineano tuttavia che nei pazienti con CHA 2 DS 2 -VASc 1 le decisioni per la TAO con antagonisti della vitamina K (AVK) o nuovi anticoagulanti orali (NAO) dovrebbero essere prese valutando anche il rischio emorragico e le preferenze del paziente. Le linee guida ESC 2012 ampliano di fatto le indicazioni alla TAO che risulta raccomandata in oltre il 90% dei pazienti con FA indipendentemente dal pattern (parossistica, persistente, permanente). È verosimile che questo ampliamento delle indicazioni alla TAO sia stato in parte incoraggiato dall avvento dei NAO che rendono la TAO nei pazienti con FA più accessibile e più sicura. La disponibilità dei NAO avrebbe in qualche modo fatto abbassare il livello dell asticella decisionale per la TAO, rendendola disponibile per un più ampio numero di pazienti 5. Voci maligne adombrano tuttavia il sospetto di conflitti di interesse degli estensori delle linee guida con le industrie produttrici dei NAO ovviamente interessate ad un ampliamento della popolazione dei pazienti con FA da considerare per la prescrizione della TAO Il Pensiero Scientifico Editore Ricevuto ; accettato Gli autori dichiarano nessun conflitto di interessi. Per la corrispondenza: Dr. Giuseppe Di Pasquale U.O. Cardiologia, Ospedale Maggiore, Largo Bartolo Nigrisoli 2, Bologna giuseppe.dipasquale@ausl.bo.it È necessario inoltre considerare che i pazienti con FA e CHA 2 DS 2 -VASc 1 non rappresentano una categoria omogenea. A titolo di esempio basti considerare due ipotetici scenari: uomo di 64 anni con ipertensione arteriosa severa e ipertrofia ventricolare sinistra con FA permanente e uomo di 54 anni con ipertensione arteriosa lieve e due episodi anamnestici di FA parossistica di breve durata. Entrambi i pazienti hanno un CHA 2 DS 2 -VASc score 1 per la presenza di ipertensione, indipendentemente dal pattern della FA. Recentemente il dogma che la FA parossistica comporti lo stesso rischio tromboembolico della FA persistente e permanente è stato messo in discussione. È inoltre emersa l evidenza che la frequenza e la durata degli episodi di FA, il cosiddetto burden di FA, abbia un peso importante nel determinare il rischio tromboembolico del singolo paziente 6,7. STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO TROMBOEMBOLICO NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE L utilizzo di score di rischio per definire l indicazione alla TAO è ormai consolidato nelle principali linee guida internazionali. Il sistema CHADS 2 score inizialmente utilizzato si basa sulla valutazione di cinque parametri: scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, età 75 anni, diabete mellito (1 punto) e anamnesi di pregresso ictus o attacco ischemico transitorio (TIA) (2 punti). Dal 2010 è stato introdotto il punteggio CHA 2 DS 2 -VASc, validato attraverso studi retrospettivi di registro e di popolazione, che meglio definisce il rischio soprattutto nelle fasce di basso punteggio CHADS 2, consentendo di individuare pazienti con FA a rischio tromboembolico veramente basso (Tabella 1) 1,8-12. Il CHA 2 DS 2 -VASc score introduce nuove variabili rispetto a quelle tradizionali (sesso femminile, malattia vascolare intesa come pregresso infarto, arteriopatia periferica o placche aortiche) ed assegna un punto per età 65 anni e due punti per età 75 anni e pregresso ictus/tia 1. Con questo metodo di stratificazione del rischio tromboembolico è possibile identificare pazienti a basso rischio (CHA 2 DS 2 -VASc =0) che certamente non si beneficerebbero della TAO e riclassificare i pazienti con CHADS 2 =0 che invece possiedono fattori di rischio aggiuntivi (CHA 2 DS 2 -VASc 1 o 2) per i quali attualmente viene consigliata la TAO. Le più recenti linee guida ESC raccomandano l utilizzo della TAO per pazienti con punteggio CHA 2 DS 2 -VASc 1, purché l unico fattore di rischio non sia il sesso femminile 2. L applicazione di queste raccomandazioni nella pratica clinica tuttavia solleva spesso delle perplessità nella valutazione del bilancio rischio-beneficio della TAO nel singolo paziente con score CHA 2 DS 2 -VASc 1 ed è argomento di discussione nella comunità scientifica
2 ANTICOAGULAZIONE NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE CON CHA 2 DS 2 -VASC 1 Tabella 1. Incidenza di ictus per anno stratificata per punteggio CHA 2 DS 2 -VASc. Lip et al. 1 Olesen et al. 8 Coppens et al. 9 Friberg et al. 11 Lip et al. 10 Lip et al Terapia No TAO (ASA 74%) No TAO (ASA 34%) ASA ± clopidogrel Nessuna terapia Nessuna terapia Gruppo No terapia CHA 2 DS 2 -VASc ( ) - - 0,37 c 0.55 e ( ) 2.01 ( ) 0.9 ( ) b 1.55 d 1.34 e ( ) 3.71 ( ) 2.0 ( ) ( ) 5.92 ( ) 2.4 ( ) a ( ) 9.27 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ASA, acido acetilsalicilico; TAO, terapia anticoagulante orale. a rischio per punteggio 3-4; b incidenza di solo ictus ischemico; c rischio per intention-to-treat (ITT) e continued treatment (CT): 0.37% e 0.49%; d rischio per ITT: 1.55%, CT: 1.46; e follow-up a 5 anni. In un analisi sui 4670 pazienti con CHADS 2 score 1 randomizzati a trattamento antiaggregante piastrinico con aspirina associata o meno a clopidogrel negli studi ACTIVE-W, ACTIVE-A e AVERROES i pazienti con CHA 2 DS 2 -VASc score 1 costituivano il 26%. Per questi pazienti il rischio tromboembolico è risultato particolarmente basso (intorno all 1%), tanto da far porre agli stessi autori il dubbio dell appropriatezza di una eventuale terapia anticoagulante in considerazione del bilancio rischio-beneficio 9. Il rischio tromboembolico nei pazienti con CHA 2 DS 2 -VASc score 1 varia in maniera anche significativa nelle diverse serie di pazienti presi in considerazione ed è stato in parte ridimensionato in alcuni studi recentemente pubblicati. I dati di validazione del punteggio CHA 2 DS 2 -VASc ricavati dagli studi di popolazione effettuati sul registro danese, sono stati in parte confermati in una recente analisi su pazienti. Nei pazienti con CHA 2 DS 2 -VASc 1 (o 2 se di sesso femminile) non trattati è stato documentato un rischio di ictus pari a 1.55% a 1 anno. Nello stesso gruppo il rischio emorragico al termine del follow-up è risultato pari a 1.51% nei pazienti non trattati, 1.74% nei pazienti trattati con aspirina e 2.19% nei pazienti in TAO, dato non trascurabile se si considera il rischio tromboembolico relativamente basso 10. Un recente studio condotto da Friberg et al. 11 ha valutato invece l impatto della definizione utilizzata per valutare gli eventi tromboembolici. Analizzando in modo retrospettivo pazienti non trattati con FA e punteggio CHA 2 DS 2 - VASc 1 del registro nazionale svedese e restringendo l analisi al solo ictus ischemico (escludendo TIA, ictus indeterminato, embolia sistemica e tromboembolia polmonare), il rischio di ictus annuo è risultato % nelle donne con CHA 2 DS 2 -VASc 2 e % negli uomini con CHA 2 DS 2 -VASc 1, ponendo questi pazienti in una condizione di beneficio clinico netto potenzialmente sfavorevole in caso di TAO 11. In vari studi di popolazione si è evidenziato come i fattori di rischio inseriti nel CHA 2 DS 2 -VASc score non hanno uguale peso nella stratificazione del rischio tromboembolico (Tabella 2) 2. In un recente lavoro, Olesen et al. 14 hanno evidenziato come risulti essere più elevata l incidenza di eventi correlata a fattori di rischio come il diabete e l età, rispetto agli altri fattori CHA 2 DS 2 -VASc considerati singolarmente. Analogamente una recente analisi su un ampia popolazione di pazienti non anticoagulati di sesso maschile con CHA 2 DS 2 -VASc 1 o di sesso Tabella 2. Hazard ratio all analisi multivariata per i fattori di rischio di ictus. HR (IC 95%) Età (anni) < (riferimento) ( ) ( ) Sesso femminile 1.17 ( ) Pregresso ictus 2.81 ( ) Patologia vascolare 1.14 ( ) Pregresso infarto 1.09 ( ) Pregresso bypass aortocoronarico 1.19 ( ) Arteriopatia periferica 1.22 ( ) Ipertensione arteriosa 1.17 ( ) Scompenso cardiaco (storia di) 0.98 ( ) Diabete mellito 1.19 ( ) HR, hazard ratio; IC, intervallo di confidenza. Modificata da Camm et al. 2. femminile con CHA 2 DS 2 -VASc 2, proveniente dai dati del registro del National Health Insurance Research Database di Taiwan, ha documentato come in pazienti con un solo fattore di rischio il rischio di ictus sia significativamente più elevato nei soggetti che acquisivano tale punteggio per età anni (hazard ratio [HR] 3.08) e per diabete mellito (HR 2.65) 15. Uno studio recente effettuato sulla popolazione danese, utilizzando un diverso modello di valutazione del beneficio clinico netto ha confermato l assenza di vantaggio nell utilizzo di TAO nei pazienti con CHA 2 DS 2 -VASc =0 e ha mostrato una superiorità della terapia con warfarin rispetto al non trattamento nei pazienti con CHA 2 DS 2 -VASc 1 nel follow-up ad 1 anno, mentre in quello a 5 anni il beneficio, pur rimanendo a favore della TAO, si avvicina alla neutralità 12. BILANCIO RISCHIO-BENEFICIO DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE NEI PAZIENTI CON FIBRILLAZIONE ATRIALE E CHA 2 DS 2 -VASc 1: COME RENDERE PIÙ ACCURATA LA STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO TROMBOEMBOLICO I pazienti con FA e CHA 2 DS 2 -VASc 1 non hanno tutti lo stesso rischio tromboembolico. È proponibile pertanto un ulteriore 609
3 G DI PASQUALE, S ZAGNONI stratificazione del rischio al loro interno, utilizzando parametri non compresi nello score. L insufficienza renale è tra i fattori di rischio noti per aumentare il rischio tromboembolico nei pazienti con FA. Piccini et al. 16 hanno validato nella popolazione dello studio ROCKET- AF e ATRIA uno score di rischio comprendente la valutazione della clearance della creatinina (R 2 CHADS 2 ): l inclusione del fattore clearance <60 ml/min è risultata un potente predittore di ictus nei pazienti con FA, consentendo la riclassificazione del 6.2% dei pazienti precedentemente valutati a basso rischio con il CHA 2 DS 2 -VASc score. Il pattern della FA (parossistica, persistente, permanente) non è mai stato incluso nella stratificazione del rischio tromboembolico della FA raccomandata dalle linee guida. L utilizzo della TAO nella pratica clinica è costantemente più basso nei pazienti con FA parossistica rispetto a quelli con FA persistente o permanente 17. Questo comportamento è stato sempre considerato inappropriato e stigmatizzato dalle linee guida e dalle iniziative educazionali delle società scientifiche. Esistono tuttavia evidenze recenti che mettono in discussione il postulato dell equivalenza del rischio tromboembolico associato ai diversi pattern di FA. Vanassche et al. 18 in un lavoro recente accompagnato da uno stimolante editoriale di commento 19 hanno analizzato l incidenza di ictus ed embolia sistemica in 6563 pazienti con FA trattati con aspirina negli studi ACTIVE-A e AVERROES. L incidenza annuale di ictus ischemico è stata 2.1%, 3.0% e 4.2% rispettivamente per la FA parossistica, persistente e permanente, con un HR aggiustato di 1.83 (p<0.001) per la FA permanente vs la parossistica e 1.44 (p=0.02) per la FA persistente vs la parossistica. Un altra analisi recente effettuata all interno dello studio ROCKET-AF ha dimostrato che i pazienti con FA persistente hanno avuto un incidenza più elevata di ictus ed embolia sistemica (2.18 vs 1.73% per anno, p=0.048) e di mortalità totale (4.78 vs 3.52%, p=0.006). L incidenza di emorragie maggiori è stata simile e l incidenza di ictus nei due tipi di FA non è risultata differente in relazione al trattamento con rivaroxaban o warfarin. Tale rilievo è consistente in tutte le classi di rischio CHADS 2 score, anche se per i criteri di inclusione utilizzati nello studio, i pazienti con basso rischio tromboembolico non erano rappresentati in questa popolazione 20. È evidente che questi dati non impattano la gestione dei pazienti con FA a rischio tromboembolico moderato-alto per i quali il rapporto rischio-beneficio della TAO non è oggetto di discussione. Al contrario, nei pazienti con FA a basso rischio tromboembolico quali quelli con CHA 2 DS 2 -VASc 1 il pattern di FA, finora non preso in considerazione, potrebbe rendere più accurata la stratificazione del rischio tromboembolico, soprattutto se utilizzato in associazione ad altri marker come quelli ecocardiografici ed i biomarker infiammatori ed emocoagulativi. Nei pazienti con FA parossistica può essere valutato il burden dell aritmia, argomento per il quale esiste oggi un grande interesse ed un acceso dibattito. Diversi studi hanno correlato la durata degli episodi di FA parossistica con il rischio tromboembolico proponendo vari cut-off arbitrari di durata (6 min, 5.5h, 24h) al di sopra dei quali il rischio tromboembolico diventa significativo. In generale questi studi concordano nello stabilire un effetto dose-risposta, nel senso che durata e quantità maggiore di FA comportano un maggiore rischio di ictus. Lo studio condotto da Boriani et al. 6 su 568 pazienti con FA parossistica portatori di dispositivi (pacemaker DDDR con possibilità di registrare il tempo trascorso in FA giornalmente) ha di- mostrato un elevata sensibilità dello score CHA 2 DS 2 -VASc nella definizione del rischio tromboembolico, ma una ridotta specificità in particolare nei pazienti a basso rischio. Il modello che combina la valutazione del CHA 2 DS 2 -VASc score e del burden di FA ne aumenta sensibilmente la specificità (specificità 42%, C-statistic 0.91, p<0.0001). Questo studio conferma il dato riscontrato nella più ampia popolazione dello studio TRENDS. Lo studio prospettico condotto su oltre 3000 pazienti aveva riscontrato un rischio aumentato di ictus nei pazienti con episodi di FA parossistica della durata di almeno 5.5h, anche dopo aggiustamento per il profilo di rischio CHADS 2 (gruppo high AF burden ; HR 2.2) 21. Recentemente un analisi condotta sui dati provenienti da tre grandi studi prospettici (TRENDS, PANORAMA ed Italian Clinical Sevice Registry Project) ha analizzato pazienti senza FA permanente con dispositivo di cardiostimolazione impiantato. In questo gruppo per ogni ora di FA in più nelle 24h è stato dimostrato un aumento del 3% del rischio relativo di ictus 7. Il trasferimento di queste acquisizioni nella pratica clinica non è certamente semplice. Tuttavia ne deriva il messaggio che nei pazienti con CHA 2 DS 2 -VASc 1 e sporadici episodi di FA parossistica le indicazioni alla TAO dovrebbero essere attentamente valutate nel singolo caso, considerando anche il burden aritmico. Un aiuto per il clinico nella definizione del rischio tromboembolico di un paziente con rischio medio-basso secondo i criteri CHA 2 DS 2 -VASc può venire dai dati di ECG, imaging e biomarker. Dal punto di vista dell ECG l impatto prognostico dell ipertrofia ventricolare sinistra è stato indagato sulla popolazione dello studio RE-LY. L ipertrofia ventricolare sinistra definita secondo i criteri ECG di Cornell (onda R in avl + onda S in V3 >2.0 mv nelle donne e >2.4 mv negli uomini) correla in modo statisticamente significativo con il rischio di ictus, di morte per causa cardiovascolare e mortalità per tutte le cause, indipendentemente dallo score di rischio. Inoltre, all analisi multivariata, l inserimento di questa variabile nella stratificazione del rischio tromboembolico aumenta il valore prognostico del CHA 2 DS 2 -VASc score 22. Avvalendosi delle diverse tecniche di imaging è possibile studiare sia le dimensioni che la funzione dell atrio sinistro, componente fondamentale nella patogenesi del cardioembolismo. Tra i fattori più noti correlati al rischio tromboembolico e alle recidive aritmiche vi è la dilatazione atriale sinistra, che può già essere efficacemente studiata con l ecocardiografia trans - toracica. L utilizzo dell ecocardiografia transtoracica nella definizione del rischio tromboembolico della FA è storicamente limitato alla valutazione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro, in quanto vi sono robuste evidenze sul contributo di questo parametro nell aumento del rischio. Nel CHA 2 DS 2 -VASc score una frazione di eiezione del ventricolo sinistro <40% viene utilizzata come surrogato per la definizione dello scompenso cardiaco come fattore di rischio tromboembolico. L ecocardiografia consente in realtà di rilevare altri parametri utili per la stratificazione del rischio tromboembolico, quali il volume atriale sinistro e la morfologia e funzione dell auricola sinistra Tra le tecniche ecocardiografiche di più recente introduzione per la valutazione della funzione atriale sinistra vi è lo strain e strain rate. Uno studio caso-controllo condotto su una piccola popolazione di pazienti con basso profilo di rischio tromboembolico ma che avevano presentato ictus o TIA, ha dimostrato nei pazienti con pregresso evento ischemico cerebrale la pre- 610
4 ANTICOAGULAZIONE NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE CON CHA 2 DS 2 -VASC 1 senza di valori di strain significativamente ridotti rispetto al gruppo senza eventi con uguale punteggio CHADS L auricola sinistra può essere più accuratamente esplorata attraverso l ecocardiografia transesofagea, in particolare se si utilizza l ecocardiografia transesofagea tridimensionale che permette una più precisa definizione della geometria e volume auricolare e ricostruzioni anatomiche molto accurate anche in casi di auricola plurilobata 23. Uno dei fenomeni associati alla trombosi dell auricola è la presenza di eco-contrasto spontaneo o effetto smoke. Questo fenomeno, legato alla bassa velocità di flusso a livello dell auricola sinistra, è attribuito alla formazione di microaggregati di cellule ematiche che, interagendo con le proteine plasmatiche, costituiscono un milieu favorente la formazione di trombi. La presenza di eco-contrasto spontaneo e la sua intensità correlano con riduzione di velocità di flusso, dilatazione atriale sinistra e incidenza di eventi tromboembolici 25. La risonanza magnetica costituisce uno strumento sempre più utilizzato per valutare le strutture cardiache. Per quanto riguarda l atrio sinistro nei pazienti con FA può fornire importanti informazioni non solo per l accuratezza della valutazione dimensionale e morfologica 26 ma anche per la possibilità di caratterizzazione tissutale. In studi caso-controllo eseguiti con valutazione volumetrica dell auricola sinistra mediante risonanza magnetica è stato dimostrato come nei pazienti con eventi tromboembolici vi fosse una maggiore dilatazione auricolare sinistra e come il rischio di ictus fosse particolarmente elevato nei soggetti con volume dell auricola sinistra 34 cm Anche l estensione della fibrosi dell atrio sinistro studiata alla risonanza magnetica correla in modo diretto con il rischio di trombosi dell auricola. Il rimodellamento atriale, inoltre, risulta aumentare con l aumento del punteggio CHA 2 DS 2 -VASc, dimostrando una stretta correlazione tra lo studio morfologico e la valutazione clinica 28. Diversi studi hanno analizzato il ruolo dei biomarker, sia come predittori della comparsa o recidiva di FA che come possibili indicatori di rischio tromboembolico. In uno studio condotto su 3120 pazienti appartenenti alla coorte dello studio Framingham tra i vari marker analizzati (peptide natriuretico cerebrale [BNP], D-dimero, proteina C-reattiva, omocisteina, renina, aldosterone, microalbuminuria) solo il BNP si è rivelato predittore della comparsa di FA nel follow-up 29. Relativamente alla stratificazione del rischio tromboembolico, in un analisi condotta sulla popolazione dello studio RE-LY troponina I e NTproBNP sono risultati fattori di rischio indipendenti per ictus e morte da tutte le cause 30. Per quanto riguarda i marker emocoagulativi, il D-dimero è stato proposto come fattore di rischio tromboembolico aggiuntivo e per monitorare pazienti ad alto rischio. In uno studio condotto in pazienti con FA non valvolare in TAO con un tempo nel Tabella 3. Stratificazione del rischio tromboembolico nei pazienti con CHA 2 DS 2 -VASc 1 (o 2 se donne): fattori aggiuntivi da utilizzare nella valutazione clinica. Burden FA Monitoraggio ECG Holter Loop recorder Monitoraggio remoto in portatori di dispositivi ECG Ipertrofia ventricolare sinistra Imaging Effetto smoke intra-atriale e trombosi atriale sinistra Disfunzione atrio e auricola sinistra Placche aortiche complicate Disfunzione sistolica VS (FEVS <40%) Fibrosi atriale sinistra Biomarker e marker coagulativi Creatinina e GFR PCR, troponina, D-dimero Neuroimaging Lesioni ischemiche silenti alla RM Microbleed HITS al Doppler transcranico FA, fibrillazione atriale; FEVS, frazione di eiezione ventricolare sinistra; GFR, velocità di filtrazione glomerulare; HITS, segnali transitori ad alta intensità; PCR, proteina C-reattiva; RM, risonanza magnetica; VS, ventricolo sinistro. range terapeutico adeguato è stato dimostrato che l incremento del D-dimero correlava sia con il profilo clinico, aumentando all aumentare del CHADS 2 score, che con il rischio di ictus 31. CONCLUSIONI Nei pazienti con FA e con CHA 2 DS 2 -VASc score 1 (CHA 2 DS 2 - VASc score 2 se donne) le indicazioni alla TAO non dovrebbero essere automatiche, ma decise nel singolo paziente dopo una più accurata stratificazione del rischio tromboembolico che dovrebbe tenere conto anche del pattern di FA. Ai fini delle scelte terapeutiche dovrebbero essere considerati anche altri marker di rischio tromboembolico non inclusi nello score CHA 2 DS 2 -VASc (Tabella 3). Tra i numerosi marker proposti quelli più facilmente applicabili nella pratica clinica sono l ipertrofia ventricolare sinistra all ECG e gli indici di volume e funzione atriale sinistra all ecocardiografia transtoracica. Nei pazienti con FA parossistica la valutazione del burden di FA attraverso il monitoraggio Holter prolungato o dispositivi impiantabili è in grado di identificare pazienti a basso rischio tromboembolico per i quali l indicazione alla TAO può essere discutibile. BIBLIOGRAFIA 1. Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R, Lane DA, Crijns HJ. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factorbased approach: the Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation. Chest 2010;137: Camm J, Lip GY, De Caterina R, et al focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. Eur Heart J 2012;33: January CT, Wann LS, Alpert JS, et al AHA/ACC/HRS Guideline for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation 2014;130: e Raviele A, Disertori M, Alboni P, et al. Linee guida AIAC per la gestione e il trattamento della fibrillazione atriale. Aggiornamento G Ital Cardiol 2013;14:
5 G DI PASQUALE, S ZAGNONI 5. Eckman MH, Singer DE, Rosand J, Greenberg SM. Moving the tipping point: the decision to anticoagulate patients with atrial fibrillation. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2011;4: Boriani G, Botto GL, Padeletti L, et al.; Italian AT-500 Registry Investigators. Improving stroke risk stratification using the CHADS 2 and CHA 2 DS 2 -VASc risk scores in patients with paroxysmal atrial fibrillation by continuous arrhythmia burden monitoring. Stroke 2011;42: Boriani G, Glotzer TV, Santini M, et al. Device-detected atrial fibrillation and risk for stroke: an analysis of >10,000 patients from the SOS AF project (Stroke prevention Strategies based on Atrial Fibrillation information from implanted devices). Eur Heart J 2014;35: Olesen JB, Lip GY, Hansen ML, et al. Validation of risk stratification schemes for predicting stroke and thromboembolism in patients with atrial fibrillation: nationwide cohort study. BMJ 2011;342:d Coppens M, Eikelboom JW, Hart RG, et al. The CHA 2 DS 2 -VASc score identifies those patients with atrial fibrillation and a CHADS 2 score of 1 who are unlikely to benefit from oral anticoagulant therapy. Eur Heart J 2013;34: Lip GY, Skjøth F, Rasmussen LH, Larsen TB. Oral anticoagulation, aspirin, or no therapy in patients with nonvalvular AF with 0 or 1 stroke risk factor based on the CHA 2 DS 2 -VASc score. J Am Coll Cardiol 2015;65: Friberg L, Skeppholm M, Terént A. Benefit of anticoagulation unlikely in patients with atrial fibrillation and a CHA 2 DS 2 - VASc score of 1. J Am Coll Cardiol 2015; 65: Lip GY, Skjøth F, Nielsen PB, Larsen TB. Non-valvular atrial fibrillation patients with none or one additional risk factor of the CHA 2 DS 2 -VASc score. A comprehensive net clinical benefit analysis for warfarin, aspirin, or no therapy. Thromb Haemost 2015;114: Huisman MV. Patients with atrial fibrillation and a CHA 2 DS 2 -VASc score of 1: are they at low or high stroke risk? J Am Coll Cardiol 2015;65: Olesen JB, Torp-Pedersen C. Stroke risk in atrial fibrillation: do we anticoagulate CHADS 2 or CHA 2 DS 2 -VASc 1, or higher? Thromb Haemost 2015;113: Chao TF, Liu CJ, Wang KL, et al. Should atrial fibrillation patients with 1 additional risk factor of the CHA 2 DS 2 -VASc score (beyond sex) receive oral anticoagulation? J Am Coll Cardiol 2015;65: Piccini JP, Stevens SR, Chang Y, et al. Renal dysfunction as a predictor of stroke and systemic embolism in patients with nonvalvular atrial fibrillation: validation of the R 2 CHADS 2 index in the ROCKET AF (Rivaroxaban Once-daily, oral, direct factor Xa inhibition Compared with vitamin K antagonism for prevention of stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation) and ATRIA (AnTicoagulation and Risk factors In Atrial fibrillation) study cohorts. Circulation 2013; 127: Di Pasquale G, Mathieu G, Maggioni AP, et al.; ATA AF Investigators. Current presentation and management of 7148 patients with atrial fibrillation in cardiology and internal medicine hospital centers: the ATA AF study. Int J Cardiol 2013;167: Vanassche T, Lauw MN, Eikelboom JW, et al. Risk of ischaemic stroke according to pattern of atrial fibrillation: analysis of 6563 aspirin-treated patients in ACTIVE-A and AVERROES. Eur Heart J 2015;36: Arkin JM, Kowey PR. Does atrial fibrillation pattern affect stroke risk? Data dredging to help the clinician. Eur Heart J 2015;36: Steinberg BA, Hellkamp AS, Lokhnygina Y, et al.; ROCKET-AF Steering Committee and Investigators. Higher risk of death and stroke in patients with persistent vs paroxysmal atrial fibrillation: results from the ROCKET-AF trial. Eur Heart J 2015;36: Glotzer TV, Daoud EG, Wyse DG, et al. The relationship between daily atrial tachyarrhythmia burden from implantable device diagnostics and stroke risk: the TRENDS study. Circ Arrhythm Electrophysiol 2009;2: Verdecchia P, Reboldi G, Di Pasquale G, et al.; RE-LY Study Investigators. Prognostic usefulness of left ventricular hypertrophy by electrocardiography in patients with atrial fibrillation (from the Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulant Therapy Study). Am J Cardiol 2014;113: Providencia R, Trigo J, Paiva L, Barra S. The role of echocardiography in thromboembolic risk assessment of patients with nonvalvular atrial fibrillation. J Am Soc Echocardiogr 2013;26: Azemi T, Rabdiya VM, Ayirala SR, Mc- Cullough LD, Silverman DI. Left atrial strain is reduced in patients with atrial fibrillation, stroke or TIA, and low risk CHADS 2 scores. J Am Soc Echocardiogr 2012;25: Di Pasquale G, Urbinati G, Pinelli G. New echocardiographic markers of embolic risk in atrial fibrillation. Cerebrovascular Diseases 1995;5: Di Biase L, Santangeli P, Anselmino M, et al. Does the left atrial appendage morphology correlate with the risk of stroke in patients with atrial fibrillation? Results from a multicenter study. J Am Coll Cardiol 2012; 60: Burrell LD, Horne BD, Anderson JL, Muhlestein JB, Whisenant BK. Usefulness of left atrial appendage volume as a predictor of embolic stroke in patients with atrial fibrillation. Am J Cardiol 2013;112: Han FT, Akoum N, Marrouche N. Value of magnetic resonance imaging in guiding atrial fibrillation management. Can J Cardiol 2013;29: Schnabel RB, Larson MG, Yamamoto JF, et al. Relations of biomarkers of distinct pathophysiological pathways and atrial fibrillation incidence in the community. Circulation 2010;121: Hijazi Z, Oldgren J, Andersson U, et al. Cardiac biomarkers are associated with an increased risk of stroke and death in patients with atrial fibrillation: a Randomized Evaluation of Long-term Anticoagulation Therapy (RE-LY) substudy. Circulation 2012; 125: Sadanaga T, Kohsaka S, Ogawa S. D- dimer levels in combination with clinical risk factors can effectively predict subsequent thromboembolic events in patients with atrial fibrillation during oral anticoagulant therapy. Cardiology 2010;117:
Le raccomandazioni ESC/EHRA 2012 per la profilassi antitromboembolica nella fibrillazione atriale. Paolo Busacca Direttore UOC Cardiologia Urbino
 Le raccomandazioni ESC/EHRA 2012 per la profilassi antitromboembolica nella fibrillazione atriale Paolo Busacca Direttore UOC Cardiologia Urbino ESC GUIDELINES 2010 Anticoagulazione Stratificazione rischio
Le raccomandazioni ESC/EHRA 2012 per la profilassi antitromboembolica nella fibrillazione atriale Paolo Busacca Direttore UOC Cardiologia Urbino ESC GUIDELINES 2010 Anticoagulazione Stratificazione rischio
Anticoagulazione nella fase post-acuta nella cardioversione elettrica. G. M. Francese. U.O. C. di Cardiologia Garibaldi-Nesima Catania
 GARIBALDI-NESIMA, CT- ITALY Anticoagulazione nella fase post-acuta nella cardioversione elettrica G. M. Francese U.O. C. di Cardiologia Garibaldi-Nesima Catania www.escardio.org/guidelines GARIBALDI-NESIMA,
GARIBALDI-NESIMA, CT- ITALY Anticoagulazione nella fase post-acuta nella cardioversione elettrica G. M. Francese U.O. C. di Cardiologia Garibaldi-Nesima Catania www.escardio.org/guidelines GARIBALDI-NESIMA,
Fibrillazione Atriale e Ictus Cardiembolico
 Fibrillazione Atriale e Ictus Cardiembolico ISPAF Indagine Sicoa su Pazienti con Fibrillazione Atriale Maurizio Volterrani IRCCS San Raffaele Roma Incidenza di FA per età Incidenza (per 1000 anni-persona)
Fibrillazione Atriale e Ictus Cardiembolico ISPAF Indagine Sicoa su Pazienti con Fibrillazione Atriale Maurizio Volterrani IRCCS San Raffaele Roma Incidenza di FA per età Incidenza (per 1000 anni-persona)
RISCHIO EMBOLICO NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE
 LA CHIUSURA PERCUTANEA DELL AURICOLA SINISTRA NELLA PREVENZIONE DELL EMBOLIA CARDIOGENA RISCHIO EMBOLICO NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE Gianluca Gonzi Parma, 21 Gennaio 2014 Caso clinico (Francesca) 48 anni
LA CHIUSURA PERCUTANEA DELL AURICOLA SINISTRA NELLA PREVENZIONE DELL EMBOLIA CARDIOGENA RISCHIO EMBOLICO NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE Gianluca Gonzi Parma, 21 Gennaio 2014 Caso clinico (Francesca) 48 anni
Il rischio tromboembolico nella fibrillazione atriale
 Il rischio tromboembolico nella fibrillazione atriale Giovanni Tarsi AO Ospedali Riuniti Marche Nord Fibrillazione atriale: dimensione del problema 1 2% della popolazione. > 6 milioni di europei, con previsioni
Il rischio tromboembolico nella fibrillazione atriale Giovanni Tarsi AO Ospedali Riuniti Marche Nord Fibrillazione atriale: dimensione del problema 1 2% della popolazione. > 6 milioni di europei, con previsioni
CardioLucca2014 Heart Celebration Lucca, novembre 2014 Palazzo Ducale Sala Ademollo
 10 Meeting Nazionale CardioLucca2014 Heart Celebration Lucca, 27-29 novembre 2014 Palazzo Ducale Sala Ademollo I Simposio 27 novembre 2014 ore 14:30-15:50 La gestione del rischio tromboembolico nella fibrillazione
10 Meeting Nazionale CardioLucca2014 Heart Celebration Lucca, 27-29 novembre 2014 Palazzo Ducale Sala Ademollo I Simposio 27 novembre 2014 ore 14:30-15:50 La gestione del rischio tromboembolico nella fibrillazione
Prevenzione del rischio cerebro-vascolare ischemico. Gianfranco Delogu Ospedale N.S. di Bonaria San Gavino Monreale ASSL Sanluri
 Prevenzione del rischio cerebro-vascolare ischemico Gianfranco Delogu Ospedale N.S. di Bonaria San Gavino Monreale ASSL Sanluri L ictus rappresenta la principale causa di disabilità e la seconda più frequente
Prevenzione del rischio cerebro-vascolare ischemico Gianfranco Delogu Ospedale N.S. di Bonaria San Gavino Monreale ASSL Sanluri L ictus rappresenta la principale causa di disabilità e la seconda più frequente
Le complicanze tromboemboliche nella fibrillazione atriale trattata con cardioversione elettrica Dott.
 25-05-2018 Le complicanze tromboemboliche nella fibrillazione atriale trattata con cardioversione elettrica Dott.ssa Ernesta Dores La maggior parte degli ictus cerebrali che insorgono in pazienti con fibrillazione
25-05-2018 Le complicanze tromboemboliche nella fibrillazione atriale trattata con cardioversione elettrica Dott.ssa Ernesta Dores La maggior parte degli ictus cerebrali che insorgono in pazienti con fibrillazione
CHADSVASC ALTO IN ASSENZA DI FIBRILLAZIONE ATRIALE. NAO SI, NAO NO
 CHADSVASC ALTO IN ASSENZA DI FIBRILLAZIONE ATRIALE. NAO SI, NAO NO Gian Piero Perna Dipartimento Scienze Cardiovascolari Cardiologia Ospedaliera e UTIC Ospedali Riuniti di Ancona Refining Clinical Risk
CHADSVASC ALTO IN ASSENZA DI FIBRILLAZIONE ATRIALE. NAO SI, NAO NO Gian Piero Perna Dipartimento Scienze Cardiovascolari Cardiologia Ospedaliera e UTIC Ospedali Riuniti di Ancona Refining Clinical Risk
European Heart Journal (2010)
 European Heart Journal (2010) Definizione Aritmia Cardiaca che presenta le seguenti caratteristiche: 1) assoluta irregolarità degli intervalli RR 2) Assenza di una onda P identificabile (talvolta può essere
European Heart Journal (2010) Definizione Aritmia Cardiaca che presenta le seguenti caratteristiche: 1) assoluta irregolarità degli intervalli RR 2) Assenza di una onda P identificabile (talvolta può essere
Lo studio RE-LY Efficacia e sicurezza nella prevenzione dell ictus
 Lo studio RE-LY Efficacia e sicurezza nella prevenzione dell ictus Antonino Rotolo UOC di Cardiologia II AOUP - Meta-analysis: Antithrombotic Therapy to Prevent Stroke in Patients Who Have Nonvalvular
Lo studio RE-LY Efficacia e sicurezza nella prevenzione dell ictus Antonino Rotolo UOC di Cardiologia II AOUP - Meta-analysis: Antithrombotic Therapy to Prevent Stroke in Patients Who Have Nonvalvular
L importanza di una più accurata stratificazione del rischio tromboembolico nei pazienti con FA e CHA 2 DS 2 VASc Score 1 (2 nelle donne).
 L importanza di una più accurata stratificazione del rischio tromboembolico nei pazienti con FA e CHA 2 DS 2 VASc Score 1 (2 nelle donne). Tommaso L. Usai Roma 23 settembre 2017 Background Sebbene l utilizzo
L importanza di una più accurata stratificazione del rischio tromboembolico nei pazienti con FA e CHA 2 DS 2 VASc Score 1 (2 nelle donne). Tommaso L. Usai Roma 23 settembre 2017 Background Sebbene l utilizzo
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE NEI PAZIENTI MOLTO ANZIANI CON FIBRILLAZIONE ATRIALE: È REALMENTE SICURA?
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO di MEDICINA - DIMED - CLINICA GERIATRICA Granziera S, Marigo L, Bertozzo G, Rossi K, Petruzzellis F, Gesmundo A, Infante T, Pletti S, Simioni F, Nante G, Manzato
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO di MEDICINA - DIMED - CLINICA GERIATRICA Granziera S, Marigo L, Bertozzo G, Rossi K, Petruzzellis F, Gesmundo A, Infante T, Pletti S, Simioni F, Nante G, Manzato
Nuovi anticoagulanti nelle valvulopatie, sempre sicuri?
 Nuovi anticoagulanti nelle valvulopatie, sempre sicuri? Quando una FA si definisce non valvolare La definizione di fibrillazione atriale (FA) non valvolare si incontra nei primi studi sull anticoagulazione
Nuovi anticoagulanti nelle valvulopatie, sempre sicuri? Quando una FA si definisce non valvolare La definizione di fibrillazione atriale (FA) non valvolare si incontra nei primi studi sull anticoagulazione
I dati ottenuti mediante l impiego delle carte del rischio non definiscono in. del singolo individuo
 La revisione delle carte del rischio cardiovascolare I dati ottenuti mediante l impiego delle carte del rischio non definiscono in modo accurato il rischio cardiovascolare del singolo individuo Relative
La revisione delle carte del rischio cardiovascolare I dati ottenuti mediante l impiego delle carte del rischio non definiscono in modo accurato il rischio cardiovascolare del singolo individuo Relative
Fibrillazione atriale non valvolare insorta entro le 48 ore: anticoagulazione dei pazienti a basso rischio.
 Fibrillazione atriale non valvolare insorta entro le 48 ore: anticoagulazione dei pazienti a basso rischio. Quando ci troviamo di fronte ad un paziente con fibrillazione atriale non valvolare (senza protesi
Fibrillazione atriale non valvolare insorta entro le 48 ore: anticoagulazione dei pazienti a basso rischio. Quando ci troviamo di fronte ad un paziente con fibrillazione atriale non valvolare (senza protesi
Capitolo 3.2. La valutazione economica dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NOACs) nella prevenzione di ictus in pazienti con fibrillazione atriale (SPAF)
 La valutazione economica dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NOACs) nella prevenzione di ictus in pazienti con fibrillazione atriale (SPAF) Analisi di Budget Impact a livello nazionale e regionale 159 Analisi
La valutazione economica dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NOACs) nella prevenzione di ictus in pazienti con fibrillazione atriale (SPAF) Analisi di Budget Impact a livello nazionale e regionale 159 Analisi
Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie
 Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie Dr Marchi Rita Medico di Medicina Generale Presidente S.I.M.G di Ferrara 24 settembre 2016 Dati ISTAT 2012-2013,
Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie Dr Marchi Rita Medico di Medicina Generale Presidente S.I.M.G di Ferrara 24 settembre 2016 Dati ISTAT 2012-2013,
I limiti degli score di rischio trombotico ed emorragico nel paziente fragile con fibrillazione atriale
 Torino 08 Maggio 2018 I limiti degli score di rischio trombotico ed emorragico nel paziente fragile con fibrillazione atriale Fabrizio UGO Ospedale San Giovanni Bosco Torino ESC Guidelines 2016 Lo Score
Torino 08 Maggio 2018 I limiti degli score di rischio trombotico ed emorragico nel paziente fragile con fibrillazione atriale Fabrizio UGO Ospedale San Giovanni Bosco Torino ESC Guidelines 2016 Lo Score
CHA 2 DS 2 -VASC ALTO IN ASSENZA DI FIBRILLAZIONE ATRIALE. NAO SÌ, NAO NO
 CHA 2 DS 2 -VASC ALTO IN ASSENZA DI FIBRILLAZIONE ATRIALE. NAO SÌ, NAO NO G. P. Perna Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Cardiologia Ospedaliera e UTIC, Ospedali Riuniti di Ancona. Abstract Il CHA
CHA 2 DS 2 -VASC ALTO IN ASSENZA DI FIBRILLAZIONE ATRIALE. NAO SÌ, NAO NO G. P. Perna Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Cardiologia Ospedaliera e UTIC, Ospedali Riuniti di Ancona. Abstract Il CHA
La fibrillazione atriale in rosa
 La fibrillazione atriale in rosa E proprio vero che le donne rischiano l ictus più degli uomini? Paolo Verdecchia, F.A.C.C., F.E.S.C., F.A.H.A. Hospital of Assisi Department of Medicine Via Valentin Müller,
La fibrillazione atriale in rosa E proprio vero che le donne rischiano l ictus più degli uomini? Paolo Verdecchia, F.A.C.C., F.E.S.C., F.A.H.A. Hospital of Assisi Department of Medicine Via Valentin Müller,
LA CHIUSURA DELL AURICOLA: l opinione dell esperto del Centro Emostasi
 MARTEDI DELL ORDINE 21 Gennaio 2014 L A CHIUSURA PERCUTANEA DELL AURICOLA SINISTRA NELLA PREVENZIONE DELL EMBOLIA CARDIOGENA LA CHIUSURA DELL AURICOLA: l opinione dell esperto del Centro Emostasi Roberto
MARTEDI DELL ORDINE 21 Gennaio 2014 L A CHIUSURA PERCUTANEA DELL AURICOLA SINISTRA NELLA PREVENZIONE DELL EMBOLIA CARDIOGENA LA CHIUSURA DELL AURICOLA: l opinione dell esperto del Centro Emostasi Roberto
SINDROME CORONARICA ACUTA
 SINDROME CORONARICA ACUTA Terapia antiaggregante e anticoagulante Quale e per quanto tempo Silvia Brach Prever Cardiologia Ospedale San Giovanni Bosco STUDI SUGLI ANTIAGGREGANTI Terapia antiaggregante
SINDROME CORONARICA ACUTA Terapia antiaggregante e anticoagulante Quale e per quanto tempo Silvia Brach Prever Cardiologia Ospedale San Giovanni Bosco STUDI SUGLI ANTIAGGREGANTI Terapia antiaggregante
TERAPIA ANTIAGGREGANTE
 TERAPIA ANTIAGGREGANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO DI TROMBOSI DI STENT RISCHIO DI COMPLICANZE EMORRAGICHE Duplice terapia antiaggregante - cenni storici - STARS Primary Endpoint (%) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5
TERAPIA ANTIAGGREGANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO DI TROMBOSI DI STENT RISCHIO DI COMPLICANZE EMORRAGICHE Duplice terapia antiaggregante - cenni storici - STARS Primary Endpoint (%) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5
EMOCLINIC SYMPOSIUM Sulle sponde del Ticino Budano Carlo, MD Cardiologia Universitaria Molinette Dipartimento Cardiovascolare
 Monitoraggio diagnostico: Loop Recorder impiantabili, esterni... ed altro EMOCLINIC SYMPOSIUM Sulle sponde del Ticino Budano Carlo, MD Cardiologia Universitaria Molinette Dipartimento Cardiovascolare First
Monitoraggio diagnostico: Loop Recorder impiantabili, esterni... ed altro EMOCLINIC SYMPOSIUM Sulle sponde del Ticino Budano Carlo, MD Cardiologia Universitaria Molinette Dipartimento Cardiovascolare First
Maria Antonietta Lepore Indagini sperimentali sui nuovi anticoagulanti orali. Meccanismo di azione e interazioni farmacologiche
 A06 Maria Antonietta Lepore Indagini sperimentali sui nuovi anticoagulanti orali Meccanismo di azione e interazioni farmacologiche Copyright MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it
A06 Maria Antonietta Lepore Indagini sperimentali sui nuovi anticoagulanti orali Meccanismo di azione e interazioni farmacologiche Copyright MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it
Scompenso cardiaco cronico, terapia antitrombotica e rischio emorragico
 Lo Scompenso Cardiaco Cronico (SCC): un modello di collaborazione ospedale-territorio per la qualità dell'assistenza e l'economia delle risorse Scompenso cardiaco cronico, terapia antitrombotica e rischio
Lo Scompenso Cardiaco Cronico (SCC): un modello di collaborazione ospedale-territorio per la qualità dell'assistenza e l'economia delle risorse Scompenso cardiaco cronico, terapia antitrombotica e rischio
Studio SENIORS Trial sull effetto di nebivololo su mortalità e ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari in pazienti anziani con insufficienza
 Trial sull effetto di nebivololo su mortalità e ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari in pazienti anziani con insufficienza cardiaca (1) Introduzione (1) Età media dei pazienti con insufficienza
Trial sull effetto di nebivololo su mortalità e ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari in pazienti anziani con insufficienza cardiaca (1) Introduzione (1) Età media dei pazienti con insufficienza
Up-dating sui nuovi anticoagulanti orali LUCA MASOTTI MEDICINA INTERNA SMN
 Up-dating sui nuovi anticoagulanti orali LUCA MASOTTI MEDICINA INTERNA SMN 2 Dabigatran Apixaban Edoxaban Rivaroxaban Target IIa (thrombin) Xa Xa 3Xa 628 KD pro-drug Molecular weight 471 KD drug 460 KD
Up-dating sui nuovi anticoagulanti orali LUCA MASOTTI MEDICINA INTERNA SMN 2 Dabigatran Apixaban Edoxaban Rivaroxaban Target IIa (thrombin) Xa Xa 3Xa 628 KD pro-drug Molecular weight 471 KD drug 460 KD
Pasquale Di Martino MMG ASL NA3 SUD Coop. Ippocrate
 LA PREVENZIONE DEL TROMBOEMBOLISMO NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE: ANALISI RETROSPETTIVA SULLE PRESCRIZIONI DELLA TAO NELLA COOPERATIVA IPPOCRATE ASL NA 3 SUD. PROGETTO DI INTEGRAZIONE OSPEDALE- TERRITORIO.
LA PREVENZIONE DEL TROMBOEMBOLISMO NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE: ANALISI RETROSPETTIVA SULLE PRESCRIZIONI DELLA TAO NELLA COOPERATIVA IPPOCRATE ASL NA 3 SUD. PROGETTO DI INTEGRAZIONE OSPEDALE- TERRITORIO.
Dott. R. Nangah UOC Cardiologia ULSS 4 Veneto Orientale Direttore Dott. F. Di Pede
 Fibrillazione Atriale: antiaritmici e anticoagulanti a vita però l ablazione può risolvere tutto. Dott. R. Nangah UOC Cardiologia ULSS 4 Veneto Orientale Direttore Dott. F. Di Pede La Prevalenza della
Fibrillazione Atriale: antiaritmici e anticoagulanti a vita però l ablazione può risolvere tutto. Dott. R. Nangah UOC Cardiologia ULSS 4 Veneto Orientale Direttore Dott. F. Di Pede La Prevalenza della
Diagnostica non invasiva nello scompenso cardiaco
 Diagnostica non invasiva nello scompenso cardiaco Federico Vancheri Medicina Interna, Ospedale S.Elia, Caltanissetta Questo paziente ha uno scompenso cardiaco? VARIAZIONE NEL TEMPO DEI RICOVERI PER INFARTO
Diagnostica non invasiva nello scompenso cardiaco Federico Vancheri Medicina Interna, Ospedale S.Elia, Caltanissetta Questo paziente ha uno scompenso cardiaco? VARIAZIONE NEL TEMPO DEI RICOVERI PER INFARTO
LA COMPETENZA INFERMIERISTICA NELLA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ALLA LUCE DELLA INTRODUZIONE DEI NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI
 LA COMPETENZA INFERMIERISTICA NELLA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ALLA LUCE DELLA INTRODUZIONE DEI NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI Il sottoscritto Battaglieri Alessandro In qualità di relatore all'
LA COMPETENZA INFERMIERISTICA NELLA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ALLA LUCE DELLA INTRODUZIONE DEI NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI Il sottoscritto Battaglieri Alessandro In qualità di relatore all'
PT ELIQUIS (apixaban) E Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibilità O Campo obbligatorio
 PT ELIQUIS (apixaban) E Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibilità Campo obbligatorio RP E_DC RF RV FT Registrazione Paziente Eleggibilità e Dati Clinici Richiesta Farmaco RiValutazione Fine Trattamento
PT ELIQUIS (apixaban) E Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibilità Campo obbligatorio RP E_DC RF RV FT Registrazione Paziente Eleggibilità e Dati Clinici Richiesta Farmaco RiValutazione Fine Trattamento
ADVANCES IN CARDIAC ARRHYTHMIAS and GREAT INNOVATIONS IN CARDIOLOGY XXVI Giornate Cardiologiche Torinesi Torino, ottobre2014
 ADVANCES IN CARDIAC ARRHYTHMIAS and GREAT INNOVATIONS IN CARDIOLOGY XXVI Giornate Cardiologiche Torinesi Torino, 23 25 ottobre2014 THE ITALIAN EXPERIENCE WITH DABIGATRAN Pasquale Perrone Filardi Università
ADVANCES IN CARDIAC ARRHYTHMIAS and GREAT INNOVATIONS IN CARDIOLOGY XXVI Giornate Cardiologiche Torinesi Torino, 23 25 ottobre2014 THE ITALIAN EXPERIENCE WITH DABIGATRAN Pasquale Perrone Filardi Università
Commento allo studio COMPASS
 APPROFONDIMENTI, 19 settembre 2017 Commento allo studio COMPASS A cura di Maurizio Del Pinto Lo studio Compass, recentemente pubblicato sul New England Journal of Medicine (1), è un ampio studio clinico
APPROFONDIMENTI, 19 settembre 2017 Commento allo studio COMPASS A cura di Maurizio Del Pinto Lo studio Compass, recentemente pubblicato sul New England Journal of Medicine (1), è un ampio studio clinico
START-Register Primi Dati Nazionali. Emilia Antonucci
 START-Register Primi Dati Nazionali Emilia Antonucci OBIETTIVO -Registro informatizzato, prospettico osservazionale -Raccogliere in modo standardizzato informazioni cliniche sull impiego dei diversi farmaci
START-Register Primi Dati Nazionali Emilia Antonucci OBIETTIVO -Registro informatizzato, prospettico osservazionale -Raccogliere in modo standardizzato informazioni cliniche sull impiego dei diversi farmaci
I nuovi antiaggreganti piastrinici: dai trial alla pratica clinica
 Scuola di Specializzazione in Malattie dell Apparato Cardiovascolare I nuovi antiaggreganti piastrinici: dai trial alla pratica clinica Antonino Rotolo 12 febbraio 2013 SPA: Spontaneous Platelet Aggregation
Scuola di Specializzazione in Malattie dell Apparato Cardiovascolare I nuovi antiaggreganti piastrinici: dai trial alla pratica clinica Antonino Rotolo 12 febbraio 2013 SPA: Spontaneous Platelet Aggregation
APPLICAZIONE DI UN MODELLO DI PREVISIONE DI RISCHIO PER FIBRILLAZIONE ATRIALE IN SEDE AMBULATORIALE
 FACOLTA DI APPLICAZIONE DI UN MODELLO DI PREVISIONE DI RISCHIO PER FIBRILLAZIONE ATRIALE IN SEDE AMBULATORIALE RELATORE: Chiar.mo Prof DOMENICO RISSO CORRELATORE: Dr. Andrea Stimamiglio Anno Accademico
FACOLTA DI APPLICAZIONE DI UN MODELLO DI PREVISIONE DI RISCHIO PER FIBRILLAZIONE ATRIALE IN SEDE AMBULATORIALE RELATORE: Chiar.mo Prof DOMENICO RISSO CORRELATORE: Dr. Andrea Stimamiglio Anno Accademico
La lenta accettazione dei NAO in Italia : analisi critica di un problema
 La lenta accettazione dei NAO in Italia : analisi critica di un problema Luigi Oltrona Visconti Divisione di Cardiologia IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo Pavia Atrial Fibrillation Valvular Atrial
La lenta accettazione dei NAO in Italia : analisi critica di un problema Luigi Oltrona Visconti Divisione di Cardiologia IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo Pavia Atrial Fibrillation Valvular Atrial
Sessione 3.1 Il controllo farmacologico
 Modulo 3 La prevenzione secondaria Sessione 3.1 Il controllo farmacologico durata: 30 min. 0 di 11 Obiettivi di apprendimento della sessione conoscere le tecniche di controllo farmacologico a LT descrivere
Modulo 3 La prevenzione secondaria Sessione 3.1 Il controllo farmacologico durata: 30 min. 0 di 11 Obiettivi di apprendimento della sessione conoscere le tecniche di controllo farmacologico a LT descrivere
Anticoagulazione oggi e domani: quali evidenze? Cosa cambia?
 Anticoagulazione oggi e domani: quali evidenze? Cosa cambia? Piercarla SCHINCO Specialista in Medicina Interna Specialista in Ematologia Esperta in Trombosi ed Emostasi FA è il più comune disturbo del
Anticoagulazione oggi e domani: quali evidenze? Cosa cambia? Piercarla SCHINCO Specialista in Medicina Interna Specialista in Ematologia Esperta in Trombosi ed Emostasi FA è il più comune disturbo del
NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI NEL CARDIOPATICO ISCHEMICO
 + Gianluca Secchi Giovanni Meliota NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI NEL CARDIOPATICO ISCHEMICO Guardando il passato un tuffo nel futuro Scuola di specializzazione in Malattie dell Apparato Cardiovascolare Università
+ Gianluca Secchi Giovanni Meliota NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI NEL CARDIOPATICO ISCHEMICO Guardando il passato un tuffo nel futuro Scuola di specializzazione in Malattie dell Apparato Cardiovascolare Università
Fibrillazione atriale come principale fattore di rischio: il punto di vista del cardiologo Prof. Francesco Romeo
 Fibrillazione atriale come principale fattore di rischio: il punto di vista del cardiologo Prof. Francesco Romeo Cattedra di Cardiologia Università degli Studi di Roma- Tor Vergata Fibrillazione atriale:
Fibrillazione atriale come principale fattore di rischio: il punto di vista del cardiologo Prof. Francesco Romeo Cattedra di Cardiologia Università degli Studi di Roma- Tor Vergata Fibrillazione atriale:
Stratificazione del Rischio Embolico ed Emorragico nell Anziano
 Simposio I nuovi Anticoagulanti Orali: nella Fibrillazione Atriale Stratificazione del Rischio Embolico ed Emorragico nell Anziano Niccolò Marchionni Cattedra di Geriatria, Università di Firenze SOD di
Simposio I nuovi Anticoagulanti Orali: nella Fibrillazione Atriale Stratificazione del Rischio Embolico ed Emorragico nell Anziano Niccolò Marchionni Cattedra di Geriatria, Università di Firenze SOD di
Capitolo 4. I confronti indiretti tra i Nuovi Anticoagulanti Orali (NOACs)
 I confronti indiretti tra i Nuovi Anticoagulanti Orali (NOACs) 171 I diversi Nuovi Anticoagulanti Orali sono stati studiati in trial e popolazioni non comparabili I trial di comparazione dei Nuovi Anticoagulanti
I confronti indiretti tra i Nuovi Anticoagulanti Orali (NOACs) 171 I diversi Nuovi Anticoagulanti Orali sono stati studiati in trial e popolazioni non comparabili I trial di comparazione dei Nuovi Anticoagulanti
Impatto sulla funzione renale dei diversi anticoagulanti orali in pazienti con fibrillazione atriale
 Impatto sulla funzione renale dei diversi anticoagulanti orali in pazienti con fibrillazione atriale Introduzione Fino a pochi anni fa, gli antagonisti della vitamina K (AVK), costituivano l unica opzione
Impatto sulla funzione renale dei diversi anticoagulanti orali in pazienti con fibrillazione atriale Introduzione Fino a pochi anni fa, gli antagonisti della vitamina K (AVK), costituivano l unica opzione
L utilizzo dei DOACs nella pratica clinica
 L utilizzo dei DOACs nella pratica clinica Prof. Riccardo Raddino Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica Università degli Studi di Brescia Cattedra e U.O.
L utilizzo dei DOACs nella pratica clinica Prof. Riccardo Raddino Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica Università degli Studi di Brescia Cattedra e U.O.
Nuovi Anticoagulanti per la Fibrillazione Atriale Dalla Prescrizione al Follow-up
 Nuovi Anticoagulanti per la Fibrillazione Atriale Dalla Prescrizione al Follow-up Paolo Verdecchia, F.A.C.C., F.E.S.C., F.A.H.A. Hospital of Assisi Department of Medicine Via Valentin Müller, 1 06081 -
Nuovi Anticoagulanti per la Fibrillazione Atriale Dalla Prescrizione al Follow-up Paolo Verdecchia, F.A.C.C., F.E.S.C., F.A.H.A. Hospital of Assisi Department of Medicine Via Valentin Müller, 1 06081 -
Approccio al paziente con fibrillazione atriale. Clinica Medica
 Approccio al paziente con fibrillazione atriale Clinica Medica Elementi essenziali Irregolarmente irregolare Frequenza cardiaca di solito elevata Spesso associata con cardiopalmo (esordio acuto) o facile
Approccio al paziente con fibrillazione atriale Clinica Medica Elementi essenziali Irregolarmente irregolare Frequenza cardiaca di solito elevata Spesso associata con cardiopalmo (esordio acuto) o facile
PT Xarelto (rivaroxaban)- FANV. E ai fini dell'eleggibili tà. O Campo obbligatorio
 PT Xarelto (rivaroxaban)- FANV Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibili tà Campo obbligatorio NTA BN: la presente scheda, una volta stampata, in nessun caso può essere utilizzata per Registrazione Paziente
PT Xarelto (rivaroxaban)- FANV Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibili tà Campo obbligatorio NTA BN: la presente scheda, una volta stampata, in nessun caso può essere utilizzata per Registrazione Paziente
Attuale Gestione della Terapia Anticoagulante
 Attuale Gestione della Terapia Anticoagulante Furio Colivicchi Dipartimento Cardiovascolare ACO S.Filippo Neri Roma Dicumarolici e Prevenzione dello Stroke nella FA non valvolare Per oltre 60 anni gli
Attuale Gestione della Terapia Anticoagulante Furio Colivicchi Dipartimento Cardiovascolare ACO S.Filippo Neri Roma Dicumarolici e Prevenzione dello Stroke nella FA non valvolare Per oltre 60 anni gli
Nuovi anticoagulanti orali per la prevenzione dello stroke in FA: un analisi dell anno appena trascorso e di quello che verrà
 I nuovi anticoagulanti orali (cosiddetti NOAC o novel oral anticoagulant ) hanno modificato significativamente l approccio alla prevenzione dello stroke nella fibrillazione atriale non valvolare (FANV).
I nuovi anticoagulanti orali (cosiddetti NOAC o novel oral anticoagulant ) hanno modificato significativamente l approccio alla prevenzione dello stroke nella fibrillazione atriale non valvolare (FANV).
PT PRADAXA (dabigatran) E Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibilità O Campo obbligatorio
 cognome) Tel. e-mail Cognome me CF Data di nascita PT PRADAXA (dabigatran) Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibilità Campo obbligatorio RP Registrazione Paziente NTA BN: la presente scheda, una volta
cognome) Tel. e-mail Cognome me CF Data di nascita PT PRADAXA (dabigatran) Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibilità Campo obbligatorio RP Registrazione Paziente NTA BN: la presente scheda, una volta
Efficacia e sicurezza dei nuovi anticoagulanti orali rispetto agli anticoagulanti anti-vitamina K : risultati di uno studio prospettico
 Efficacia e sicurezza dei nuovi anticoagulanti orali rispetto agli anticoagulanti anti-vitamina K : risultati di uno studio prospettico osservazionale multicentrico italiano Marco Marietta AOU Modena.
Efficacia e sicurezza dei nuovi anticoagulanti orali rispetto agli anticoagulanti anti-vitamina K : risultati di uno studio prospettico osservazionale multicentrico italiano Marco Marietta AOU Modena.
Documento informativo: dispositivo WATCHMAN per la chiusura dell auricola atriale sinistra (LAA)
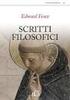 Documento informativo: dispositivo WATCHMAN per la chiusura dell auricola atriale sinistra (LAA) Informazioni su WATCHMAN La fibrillazione atriale (FA) in sé non è una patologia potenzialmente letale,
Documento informativo: dispositivo WATCHMAN per la chiusura dell auricola atriale sinistra (LAA) Informazioni su WATCHMAN La fibrillazione atriale (FA) in sé non è una patologia potenzialmente letale,
Considerazioni sulla scelta antitrombotica della FA nello scompenso cardiaco
 Considerazioni sulla scelta antitrombotica della FA nello scompenso cardiaco Paolo Colonna, MD FESC FANMCO Cardiology Hospital, Policlinico of Bari PROBE ROCKET AF 14264 73 60 3.5 0 13 87% 55 17.5 62 35.5
Considerazioni sulla scelta antitrombotica della FA nello scompenso cardiaco Paolo Colonna, MD FESC FANMCO Cardiology Hospital, Policlinico of Bari PROBE ROCKET AF 14264 73 60 3.5 0 13 87% 55 17.5 62 35.5
FIBRILLAZIONE ATRIALE
 FIBRILLAZIONE ATRIALE DEFINIZIONE La fibrillazione atriale è un aritmia sopraventricolare caratterizzata da desincronizzazione elettrica completa Vi corrisponde la perdita della funzione emodinamica (compromissione
FIBRILLAZIONE ATRIALE DEFINIZIONE La fibrillazione atriale è un aritmia sopraventricolare caratterizzata da desincronizzazione elettrica completa Vi corrisponde la perdita della funzione emodinamica (compromissione
Allegato 1 al Decreto n. 115 del 21 aprile 2011 pag. 1/11
 giunta regionale Allegato 1 al Decreto n. 115 del 21 aprile 2011 pag. 1/11 MODELLO PER L ACQUIZIONE DEI DATI RELATIVI AI PAZIENTI CON STE VALVOLARE AORTICA NELLA REGIONE DEL VENETO 1. STRUTTURA DEMINAZIONE
giunta regionale Allegato 1 al Decreto n. 115 del 21 aprile 2011 pag. 1/11 MODELLO PER L ACQUIZIONE DEI DATI RELATIVI AI PAZIENTI CON STE VALVOLARE AORTICA NELLA REGIONE DEL VENETO 1. STRUTTURA DEMINAZIONE
NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI NEL PAZIENTE ANZIANO GV GAUDIO PRES NAZIONALE CFC
 NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI NEL PAZIENTE ANZIANO GV GAUDIO PRES NAZIONALE CFC Come e perché è cambiato il paradigma terapeutico Risposta adattativa Rapida ionico-genomica Remodelling cellulare reversibile
NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI NEL PAZIENTE ANZIANO GV GAUDIO PRES NAZIONALE CFC Come e perché è cambiato il paradigma terapeutico Risposta adattativa Rapida ionico-genomica Remodelling cellulare reversibile
Sinossi Studio MAS TITOLO DELLO STUDIO CODICE DELLO STUDIO
 Sinossi Studio MAS TITOLO DELLO STUDIO CODICE DELLO STUDIO SPONSOR BACKGROUND E RAZIONALE Misura dei livelli di anticoagulazione in pazienti con fibrillazione atriale in trattamento con farmaci anticoagulanti
Sinossi Studio MAS TITOLO DELLO STUDIO CODICE DELLO STUDIO SPONSOR BACKGROUND E RAZIONALE Misura dei livelli di anticoagulazione in pazienti con fibrillazione atriale in trattamento con farmaci anticoagulanti
Terapia Anticoagulante
 Terapia Anticoagulante Terapia Trombosi arteriose Sindrome coronarica acuta Arteriopatie periferiche Altri distretti Embolia polmonare Trombosi venose profonde Profilassi Cardioembolismo Protesi valvolari
Terapia Anticoagulante Terapia Trombosi arteriose Sindrome coronarica acuta Arteriopatie periferiche Altri distretti Embolia polmonare Trombosi venose profonde Profilassi Cardioembolismo Protesi valvolari
La gestione integrata dei trattamenti anticoagulanti: la collaborazione fra Centri Trombosi e MMG
 La gestione integrata dei trattamenti anticoagulanti: la collaborazione fra Centri Trombosi e MMG Il Coinvolgimento attivo del Medico di Medicina Generale Damiano Parretti SIMG, Responsabile Area Cardiovascolare
La gestione integrata dei trattamenti anticoagulanti: la collaborazione fra Centri Trombosi e MMG Il Coinvolgimento attivo del Medico di Medicina Generale Damiano Parretti SIMG, Responsabile Area Cardiovascolare
Vasculopatie venose. Dr. Giovanni Papa Coordinatore FIMMG FORMAZIONE LAZIO
 Vasculopatie venose Dr. Giovanni Papa Coordinatore FIMMG FORMAZIONE LAZIO CASO CLINICO Manfredi, 63 anni Anamnesi patologica remota: Ipertensione arteriosa Dislipidemia Insufficienza venosa di grado lieve
Vasculopatie venose Dr. Giovanni Papa Coordinatore FIMMG FORMAZIONE LAZIO CASO CLINICO Manfredi, 63 anni Anamnesi patologica remota: Ipertensione arteriosa Dislipidemia Insufficienza venosa di grado lieve
Prevenzione secondaria: terapia farmacologica a lungo termine. Ictus Cerebrale: Linee Guida Italiane di Prevenzione e Trattamento
 Prevenzione secondaria: terapia farmacologica a lungo termine Ictus Cerebrale: Linee Guida Italiane di Prevenzione e Trattamento Per migliorare l implementazione delle misure di prevenzione secondaria
Prevenzione secondaria: terapia farmacologica a lungo termine Ictus Cerebrale: Linee Guida Italiane di Prevenzione e Trattamento Per migliorare l implementazione delle misure di prevenzione secondaria
Cosa non fare in un paz. asintomatico con riscontro di fibrillazione atriale
 13 Congresso Nazionale AIAC, Bologna - 10/12 Marzo 2016 Cosa non fare in un paz. asintomatico con riscontro di fibrillazione atriale Antonio Raviele, MD, FESC, FHRS Presidente ALFA Alleanza per la Lotta
13 Congresso Nazionale AIAC, Bologna - 10/12 Marzo 2016 Cosa non fare in un paz. asintomatico con riscontro di fibrillazione atriale Antonio Raviele, MD, FESC, FHRS Presidente ALFA Alleanza per la Lotta
La sorveglianza dei pazienti in Terapia Anticoagulante Orale. Indicazioni alla Terapia Anticoagulante Orale. Dott Daniela Poli 17 giugno 2008
 La sorveglianza dei pazienti in Terapia Anticoagulante Orale Indicazioni alla Terapia Anticoagulante Orale Dott Daniela Poli 17 giugno 2008 Indicazione Protesi valvolari cardiache Intervallo terapeutico
La sorveglianza dei pazienti in Terapia Anticoagulante Orale Indicazioni alla Terapia Anticoagulante Orale Dott Daniela Poli 17 giugno 2008 Indicazione Protesi valvolari cardiache Intervallo terapeutico
L identificazione dei soggetti a rischio
 Fibrillazione Atriale: up to date L identificazione dei soggetti a rischio Dipart. Scienze Biomed. Chirurg. Università Verona Sezione Medicina Interna C Per prevenire efficacemente la fibrillazione atriale
Fibrillazione Atriale: up to date L identificazione dei soggetti a rischio Dipart. Scienze Biomed. Chirurg. Università Verona Sezione Medicina Interna C Per prevenire efficacemente la fibrillazione atriale
Peptidi natriuretici cerebrali: nuovi biomarkers per la diagnosi differenziale e la stratificazione di rischio della sincope
 Peptidi natriuretici cerebrali: nuovi biomarkers per la diagnosi differenziale e la stratificazione di rischio della sincope Franca Dipaola Istituti Clinici di Perfezionamento Sesto S.G. (Milano) Santa
Peptidi natriuretici cerebrali: nuovi biomarkers per la diagnosi differenziale e la stratificazione di rischio della sincope Franca Dipaola Istituti Clinici di Perfezionamento Sesto S.G. (Milano) Santa
La prevenzione del tromboembolismo nella fibrillazione atriale non valvolare: cosa offrono i nuovi anticoagulanti orali
 La prevenzione del tromboembolismo nella fibrillazione atriale non valvolare: cosa offrono i nuovi anticoagulanti orali Sabato 16 novembre 2013 Hotel Tonnara di Bonagia Valderice (TP) Presidente del Congresso
La prevenzione del tromboembolismo nella fibrillazione atriale non valvolare: cosa offrono i nuovi anticoagulanti orali Sabato 16 novembre 2013 Hotel Tonnara di Bonagia Valderice (TP) Presidente del Congresso
Campo obbligatorio ai E
 Campo obbligatorio ai E LIXIANA (edoxaban)- fini dell'eleggibilità Ictus ed Embolia stemica, Prevenzione nei pz con FANV Campo obbligatorio RP Registrazione Paziente EDC Eleggibilità e Dati Clinici NTA
Campo obbligatorio ai E LIXIANA (edoxaban)- fini dell'eleggibilità Ictus ed Embolia stemica, Prevenzione nei pz con FANV Campo obbligatorio RP Registrazione Paziente EDC Eleggibilità e Dati Clinici NTA
La tempistica nella rivascolarizzazione
 La tempistica nella rivascolarizzazione A. Nicolino 1 1 2 2 ECG Ecocardiogramma 3 3 Stratificazione del Rischio 4 4 5 5 RISK Score Strumento (statisticamente derivato) per misurare (quantitativamente)
La tempistica nella rivascolarizzazione A. Nicolino 1 1 2 2 ECG Ecocardiogramma 3 3 Stratificazione del Rischio 4 4 5 5 RISK Score Strumento (statisticamente derivato) per misurare (quantitativamente)
La Fibrillazione Atriale
 IL PRONTO SOCCORSO TRA MENÙ FISSO E PIATTI DI STAGIONE Ferrara, 7 giugno 2014 La Fibrillazione Atriale Giovanni B. Vigna Dipartimento Medico - U.O. Medicina Interna Universitaria Azienda Ospedaliera -
IL PRONTO SOCCORSO TRA MENÙ FISSO E PIATTI DI STAGIONE Ferrara, 7 giugno 2014 La Fibrillazione Atriale Giovanni B. Vigna Dipartimento Medico - U.O. Medicina Interna Universitaria Azienda Ospedaliera -
Caso clinico: Prevenzione dell ictus in un paziente con fibrillazione atriale non valvolare di nuova diagnosi
 OTTIMIZZIAMO L IMPIEGO DEI NAO Caso clinico: Prevenzione dell ictus in un paziente con fibrillazione atriale non valvolare di nuova diagnosi Dott.ssa Rosaria Nappo U.O. Cardiologia II Ospedale Maggiore
OTTIMIZZIAMO L IMPIEGO DEI NAO Caso clinico: Prevenzione dell ictus in un paziente con fibrillazione atriale non valvolare di nuova diagnosi Dott.ssa Rosaria Nappo U.O. Cardiologia II Ospedale Maggiore
La funzione renale e il paziente anticoagulato Dr.ssa Maria Zanazzi. Specialista in NEFROLOGIA MEDICA
 La funzione renale e il paziente anticoagulato Dr.ssa Maria Zanazzi Specialista in NEFROLOGIA MEDICA Epidemia di malattia renale cronica (CKD) Epidemia di malattie croniche Cancro Infarto del Miocardio
La funzione renale e il paziente anticoagulato Dr.ssa Maria Zanazzi Specialista in NEFROLOGIA MEDICA Epidemia di malattia renale cronica (CKD) Epidemia di malattie croniche Cancro Infarto del Miocardio
L uso degli score nella valutazione del paziente con. Raimondo De Cristofaro
 L uso degli score nella valutazione del paziente con fibrillazione atriale Raimondo De Cristofaro Servizio Malattie Emorragiche e Trombotiche Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Polo di Oncologia
L uso degli score nella valutazione del paziente con fibrillazione atriale Raimondo De Cristofaro Servizio Malattie Emorragiche e Trombotiche Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Polo di Oncologia
Scompenso Cardiaco tra Ormoni e Clinica 5 Marzo 2010
 Scompenso Cardiaco tra Ormoni e Clinica 5 Marzo 2010 Diagnostica strumentale nello scompenso cardiaco Dott.ssa Benedetta Thiébat Premessa: la diagnosi di scompenso cardiaco è una diagnosi CLINICA! Ma l
Scompenso Cardiaco tra Ormoni e Clinica 5 Marzo 2010 Diagnostica strumentale nello scompenso cardiaco Dott.ssa Benedetta Thiébat Premessa: la diagnosi di scompenso cardiaco è una diagnosi CLINICA! Ma l
Conseguenze economiche con i NAO
 1 11 Congresso Nazionale CARD (22-24 maggio 2013) La fibrillazione atriale ed i possibili cambiamenti nelle cure domiciliari indotti dall uso dei nuovi farmaci anticoagulanti orali Conseguenze economiche
1 11 Congresso Nazionale CARD (22-24 maggio 2013) La fibrillazione atriale ed i possibili cambiamenti nelle cure domiciliari indotti dall uso dei nuovi farmaci anticoagulanti orali Conseguenze economiche
Anticoagulazione nella chirurgia non cardiaca. Dr.ssa Luciana Lombardo U.O. CARDIOLOGIA OSP. TAORMINA
 Anticoagulazione nella chirurgia non cardiaca Dr.ssa Luciana Lombardo U.O. CARDIOLOGIA OSP. TAORMINA Terapia anticoagulante e gestione peri - operatoria Rischio trombo-embolico Rischio sanguinamenti Storia
Anticoagulazione nella chirurgia non cardiaca Dr.ssa Luciana Lombardo U.O. CARDIOLOGIA OSP. TAORMINA Terapia anticoagulante e gestione peri - operatoria Rischio trombo-embolico Rischio sanguinamenti Storia
Documento ANMCO su prevenzione del. anticoagulanti orali
 Documento ANMCO su prevenzione del tromboembolismo nella FA e ruolo dei nuovi anticoagulanti orali Paolo Colonna, MD FESC FANMCO Cardiology Hospital, Policlinico of Bari 1. Fisiopatologia del tromboembolismo
Documento ANMCO su prevenzione del tromboembolismo nella FA e ruolo dei nuovi anticoagulanti orali Paolo Colonna, MD FESC FANMCO Cardiology Hospital, Policlinico of Bari 1. Fisiopatologia del tromboembolismo
STUDIO OSSERVAZIONALE. Introduzione. Francesco Del Zotti 1, Giobatta Gottardi 2, Guglielmo Frapporti 1, Alessio Micchi 1, Luisa Zanolla 3
 STUDIO OSSERVAZIONALE Fibrillazione atriale non valvolare: valutazione del rischio tromboembolico e del trattamento antitrombotico in una popolazione di pazienti in medicina generale Francesco Del Zotti
STUDIO OSSERVAZIONALE Fibrillazione atriale non valvolare: valutazione del rischio tromboembolico e del trattamento antitrombotico in una popolazione di pazienti in medicina generale Francesco Del Zotti
Edoxaban: il quarto moschettiere
 UPDATE FIBRILLAZIONE ATRIALE Edoxaban: il quarto moschettiere Roberta Rossini USC Cardiologia ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo, ITALY Conflicts of interest Payment as an individual for consulting fee or
UPDATE FIBRILLAZIONE ATRIALE Edoxaban: il quarto moschettiere Roberta Rossini USC Cardiologia ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo, ITALY Conflicts of interest Payment as an individual for consulting fee or
Il percorso del paziente candidato a chiusura percutanea dell auricola sinistra Esperienza del San Giovanni Bosco. Dr Francesco Colombo
 Il percorso del paziente candidato a chiusura percutanea dell auricola sinistra Esperienza del San Giovanni Bosco Dr Francesco Colombo PREMESSE Premessa n 1 Premessa n 2 Wolf PA, Arch Intern Med 1987;
Il percorso del paziente candidato a chiusura percutanea dell auricola sinistra Esperienza del San Giovanni Bosco Dr Francesco Colombo PREMESSE Premessa n 1 Premessa n 2 Wolf PA, Arch Intern Med 1987;
Utilizzo degli anticoagulanti orali non vitamina K dipendenti (Nuovi. Antiacoagulanti Orali-NAO) nella malattia tromboembolica venosa
 Utilizzo degli anticoagulanti orali non vitamina K dipendenti (Nuovi Antiacoagulanti Orali-NAO) nella malattia tromboembolica venosa C.Mazzone, G.Sola Nei mesi scorsi al rivaroxaban (Xarelto) si sono successivamente
Utilizzo degli anticoagulanti orali non vitamina K dipendenti (Nuovi Antiacoagulanti Orali-NAO) nella malattia tromboembolica venosa C.Mazzone, G.Sola Nei mesi scorsi al rivaroxaban (Xarelto) si sono successivamente
Scores nella Fibrillazione atriale. - il buono - il brutto -il cattivo
 Scores nella Fibrillazione atriale - il buono - il brutto -il cattivo Si muore di FA? No, non subito... Tasso di mortalità globale per anno Predictive Value of the CHA 2 DS 2 -VASc Score in Atrial Fibrillation
Scores nella Fibrillazione atriale - il buono - il brutto -il cattivo Si muore di FA? No, non subito... Tasso di mortalità globale per anno Predictive Value of the CHA 2 DS 2 -VASc Score in Atrial Fibrillation
PROCESSO AI GRANDI TRIAL. Lo studio X-VeRT. U.O. Cardiologia Ospedaliera, Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico, Bari 2
 PROCESSO AI GRANDI TRIAL Lo studio X-VeRT Paolo Colonna 1, Rossella Troccoli 1, Giovanni Luca Botto 2 1 U.O. Cardiologia Ospedaliera, Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico, Bari 2 U.O.
PROCESSO AI GRANDI TRIAL Lo studio X-VeRT Paolo Colonna 1, Rossella Troccoli 1, Giovanni Luca Botto 2 1 U.O. Cardiologia Ospedaliera, Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico, Bari 2 U.O.
Ictus e FA, LIXIANA è altrettanto efficace e più sicuro del warfarin
 Ictus e FA, LIXIANA è altrettanto efficace e più sicuro del warfarin Congresso ESC 2017 - Ictus e fibrillazione atriale, anche nei pazienti a più alto rischio LIXIANA è altrettanto efficace e più sicuro
Ictus e FA, LIXIANA è altrettanto efficace e più sicuro del warfarin Congresso ESC 2017 - Ictus e fibrillazione atriale, anche nei pazienti a più alto rischio LIXIANA è altrettanto efficace e più sicuro
EBPM in Gravidanza: Storia di una 648 Elvira Grandone. I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza S. Giovanni Rotondo (FG)
 EBPM in Gravidanza: Storia di una 648 Elvira Grandone I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza S. Giovanni Rotondo (FG) PAZIENTE T.A., anni 27 CASO CLINICO N. 1 2 PREGRESSI ABORTI PRECOCI NO FAMILIARITA
EBPM in Gravidanza: Storia di una 648 Elvira Grandone I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza S. Giovanni Rotondo (FG) PAZIENTE T.A., anni 27 CASO CLINICO N. 1 2 PREGRESSI ABORTI PRECOCI NO FAMILIARITA
Relatore. L assetto Lipidico : le origini del rischio cardiovascolare. del Gruppo Donna. Valeria Manicardi Montecchio- AUSl di RE
 1 Giornata Nazionale del Gruppo Donna L assetto Lipidico : le origini del rischio cardiovascolare? Relatore Valeria Manicardi Montecchio- AUSl di RE 1 Giornata Nazionale del Gruppo Donna Olbia, 16 e 17
1 Giornata Nazionale del Gruppo Donna L assetto Lipidico : le origini del rischio cardiovascolare? Relatore Valeria Manicardi Montecchio- AUSl di RE 1 Giornata Nazionale del Gruppo Donna Olbia, 16 e 17
Diabete Mellito Tipo 2 e Rischio CV: Uptodate della Gestione Clinica Albano laziale 9 giugn0 2018
 Diabete Mellito Tipo 2 e Rischio CV: Uptodate della Gestione Clinica Albano laziale 9 giugn0 2018 Il sottoscritto Rinaldo Guglielmi ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo
Diabete Mellito Tipo 2 e Rischio CV: Uptodate della Gestione Clinica Albano laziale 9 giugn0 2018 Il sottoscritto Rinaldo Guglielmi ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo
Capitolo 2.3. La Fibrillazione Atriale Non Valvolare e l ictus. L evidenza di un bisogno clinico non ancora soddisfatto
 La Fibrillazione Atriale Non Valvolare e l ictus L evidenza di un bisogno clinico non ancora soddisfatto 90 Prescrizione dei VKA per la prevenzione dello Stroke nella Fibrillazione Atriale Non Valvolare
La Fibrillazione Atriale Non Valvolare e l ictus L evidenza di un bisogno clinico non ancora soddisfatto 90 Prescrizione dei VKA per la prevenzione dello Stroke nella Fibrillazione Atriale Non Valvolare
PROCESSO AI GRANDI TRIAL. Lo studio ARISTOTLE
 PROCESSO AI GRANDI TRIAL Lo studio ARISTOTLE Giuseppe Di Pasquale 1, Raffaele De Caterina 2 1 U.O. di Cardiologia, Ospedale Maggiore, Bologna 2 Istituto di Cardiologia, Università degli Studi Gabriele
PROCESSO AI GRANDI TRIAL Lo studio ARISTOTLE Giuseppe Di Pasquale 1, Raffaele De Caterina 2 1 U.O. di Cardiologia, Ospedale Maggiore, Bologna 2 Istituto di Cardiologia, Università degli Studi Gabriele
Il Management delle Sindromi Coronarie Acute oggi Il paziente anziano e con IRC grave
 Il Management delle Sindromi Coronarie Acute oggi Il paziente anziano e con IRC grave Filippo M. Sarullo U.O. di Riabilitazione Cardiovascolare Ospedale Buccheri La Ferla FBF Palermo NSTE-ACS: ETA & Mortalità
Il Management delle Sindromi Coronarie Acute oggi Il paziente anziano e con IRC grave Filippo M. Sarullo U.O. di Riabilitazione Cardiovascolare Ospedale Buccheri La Ferla FBF Palermo NSTE-ACS: ETA & Mortalità
Emorragia cerebrale in paziente anziano con comorbosità in terapia anticoagulante
 Emorragia cerebrale in paziente anziano con comorbosità in terapia anticoagulante Dr.ssa Giulia Rivasi Dipartimento di Geriatria AOU Careggi, Università degli Studi di Firenze Sig. Giuliano, 76 anni ü
Emorragia cerebrale in paziente anziano con comorbosità in terapia anticoagulante Dr.ssa Giulia Rivasi Dipartimento di Geriatria AOU Careggi, Università degli Studi di Firenze Sig. Giuliano, 76 anni ü
RM cardiaca: può sostituire la CVG nella diagnosi eziologica di cardiopatia dilatativa?
 RM cardiaca: può sostituire la CVG nella diagnosi eziologica di cardiopatia dilatativa? Dott. Nicola Giunta Ospedale Civico-Palermo Valderice, 2 ottobre 2015 Cardiomiopatia dilatativa Eziologia ischemica
RM cardiaca: può sostituire la CVG nella diagnosi eziologica di cardiopatia dilatativa? Dott. Nicola Giunta Ospedale Civico-Palermo Valderice, 2 ottobre 2015 Cardiomiopatia dilatativa Eziologia ischemica
La Trombosi venosa profonda, l embolia polmonare, la fibrillazione atriale non valvolare: ruolo dei nuovi anticoagulanti orali nella pratica clinica
 La Trombosi venosa profonda, l embolia polmonare, la fibrillazione atriale non valvolare: ruolo dei nuovi anticoagulanti orali nella pratica clinica 10 aprile e 19 Giugno 2018 - Clinica Villa dei fiori,
La Trombosi venosa profonda, l embolia polmonare, la fibrillazione atriale non valvolare: ruolo dei nuovi anticoagulanti orali nella pratica clinica 10 aprile e 19 Giugno 2018 - Clinica Villa dei fiori,
DOAC: dosaggi appropriati e follow-up
 DOAC: dosaggi appropriati e follow-up Daniela Poli Bologna 5 ottobre 2017 INDICAZIONI all uso dei DOAC Profilassi del TEV in chirurgia ortopedica Fibrillazione atriale non valvolare Trattamento del tromboembolismo
DOAC: dosaggi appropriati e follow-up Daniela Poli Bologna 5 ottobre 2017 INDICAZIONI all uso dei DOAC Profilassi del TEV in chirurgia ortopedica Fibrillazione atriale non valvolare Trattamento del tromboembolismo
GESTIONE PERI-PROCEDURALE DEI PAZIENTI IN TERAPIA CON I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI
 GESTIONE PERI-PROCEDURALE DEI PAZIENTI IN TERAPIA CON I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI La corretta valutazione del rischio emorragico e trombotico riveste una importanza fondamentale per la gestione ottimale
GESTIONE PERI-PROCEDURALE DEI PAZIENTI IN TERAPIA CON I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI La corretta valutazione del rischio emorragico e trombotico riveste una importanza fondamentale per la gestione ottimale
Profilassi e percorsi gestionali dell endocardite: qualcosa è cambiato? Dr. Enrico Cecchi Ospedale Maria Vittoria di Torino.
 Profilassi e percorsi gestionali dell endocardite: qualcosa è cambiato? Dr. Enrico Cecchi Ospedale Maria Vittoria di Torino. 1. NELLE LINEE-GUIDA ESC 2009 LA PROFILASSI ANTIBIOTICA NELLE PROCEDURE ODONTOIATRICHE
Profilassi e percorsi gestionali dell endocardite: qualcosa è cambiato? Dr. Enrico Cecchi Ospedale Maria Vittoria di Torino. 1. NELLE LINEE-GUIDA ESC 2009 LA PROFILASSI ANTIBIOTICA NELLE PROCEDURE ODONTOIATRICHE
