Lecture Slides will be available at: didattica_fisica/cosmic_rays1718/
|
|
|
- Adriana Martinelli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Lecture Slides will be available at: didattica_fisica/cosmic_rays1718/ E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 1
2 Fiandrini Cosmic Rays 17/18 Un modello di Accelerazione dei RC con E>100TeV L energia massima fornita ai RC dalle SN 100 Z TeV Il ginocchio è indice di qualcosa che varia: interazioni, propagazione, sorgenti Consideriamo un modello a cui a variare è la sorgente: PULSAR Una Pulsar è una giovane stella di neutroni (NS) rapidamente ruotante rispetto ad un asse. Una NS ha un altissima densità (quella dei nuclei), massa pari a 1.4 M (massa sole), e raggio R NS 10 km Supponendo un campo magnetico della stella prima del collasso pari a B B 10-2 T, per la legge di Gauss: B NS = B R R NS T T
3 E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 3
4 Fiandrini Cosmic Rays 17/18 La velocità di rotazione delle pulsar è nota sperimentalmente, e può essere facilmente stimata: GM 2 R = Mω NSR ω NS s La Pulsar fornisce energia tramite induzione EM. L energia massima fornita ad una particella di carica Ze: EMax = Ze ε dx = Ze Bωo L L/ c PULSAR: Massima energia acquisita dalla particella accelerata nel caso di p (Z=1), B=10 8 T, ω=10 3 s -1, R=10 km E Max = = Ze Bω L 19 = 1.6( J ) = 10 o ( C) ev / c = 8 ( T ) 10 3 ( s 1 ) [ 4 10 ( m) ] 2
5 Potenza richiesta per i RC di energia > 1000 TeV Possono poche Pulsar nella Galassia alimentare i RC di energia compresa tra <E o <10 19 ev? ρ ( ) Potenza richiesta per un flusso stazionario: CR > Eo V P( > E o ) = τ ( > E F o ) G La densità di energia: ρ 4 3 cr ( > 100TeV ) 10 ev cm Una sorgente di tale potenza può alimentare tutto il flusso di RC galattici nell intervallo <E o < E plausibile? Fiandrini Cosmic Rays 17/18
6 Fiandrini Cosmic Rays 17/18 Luminosità osservata in r-x Le sorgenti binarie di r-x hanno una potenza rivelata dell ordine di erg/ s E plausibile che (poche) sorgenti così potenti possano fornire la stessa quantità di energia sotto forma di RC di E>1000 TeV Attenzione: le pulsar hanno una vita media stimata di circa 10 7 anni.
7 Fiandrini Cosmic Rays 17/18 I RC di Energia Estrema >10 18 Ev (Extragalattici?) Accelerazione SN Pulsars, vento galattico AGN, top-down??
8 E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 8
9 Fiandrini Cosmic Rays Confinamento dei RC E>10 19 ev (richiamo) Confinamento dovuto al campo magnetico Galattico. Il raggio di curvatura di un nucleo di carica (Ze) in B: mv 2 /r = pv/r = ZevB/c r = E/(ZeB) r( kpc) E( EeV) ZB( µ G) Per un protone di E~10 19 ev, r~3.3 kpc (corrisponde a ~10 spessore galattico) Un Fe potrebbe restare confinato a ev r=10(eev)/26 3(µG) 100 pc
10 Confinamento 2 (richiamo) ~ ev: RC ben confinati nella galassia ev: sorgenti extragalattiche ~ ev la deviazione nella galassia è inferiore ad 1 Fiandrini Cosmic Rays 17/18
11 Volume di confinamento dei RC di origine extragalattico: il Cut-off di Greisen (GZK) Fiandrini Cosmic Rays 17/18 L universo è permeato dalla Radiazione Cosmica di Fondo a 3 o K (CMBR) à GHz CMBR: fotoni di energia Eγ CMBR = hν = 2π MeV s Hz= ev La densità dei fotoni di fondo è ~400/cm 3 Il fondo di radiazione pone un limite sulla distanza massima da cui i RC possono provenire.
12 G reisen Z atsepin K uzmin cutoff Soglia per reazioni di fotoproduzione Fotoproduzione: Protoni di alta energia possono interagire con fotoni, producendo un pione: γ CMBR +p Δ * (1236) n+π + p+π 0 È necessario essere sopra la soglia di fotoproduzione nel sistema del CM: E 0 FP 300 MeV Il processo ha una sezione d urto in risonanza σ 0 P 250 µb Fiandrini Cosmic Rays 17/18
13 Fiandrini Cosmic Rays 17/18 Sezione d urto per la Δ
14 Soglia per la fotoproduzione (FP) Vogliamo determinare il valore di γ tale che si abbia un valore E PF o > 300 MeV La trasformazione di Lorentz tra i due SdR: x E FP 0 = γ ( E CMBR γ + CMBR = γeγ (1 + vp / Fiandrini Cosmic Rays 17/18 v c) p c E CMBR γ 2γE ) = CMBR γ ' V ' = γ ( x0 + 1 ) c 0 x E FP 0 = Soglia fotoproduzione (~300 MeV) E γ CMBR =Energia fotone =hν γ = boost Lorentz del protone
15 Dalla relazione, si ricava il valore di γ necessario per la fotoproduzione nel sistema di riferimento del laborarorio γ FP = E 300MeV CMBR 4 2E ev γ L energia di soglia per i protoni per produrre π è quindi GZK 20 2 E0 = γ ( mpc ) 3 10 Se l energia del protone supera E o GZK, si innesca la FP. In ogni processo, il p perde circa 1/10 della sua energia Nota la densità numerica della CMBR (n γ =400 cm -3 ), si stima il cammino libero medio del p: λ = ( σ γ Fiandrini Cosmic Rays 17/18 ev 1 25 pnγ ) = 10 cm = 3Mpc 11
16 Si può dunque stimare che i p NON possano giungere da distanze superiori a 10 3 Mpc = 30 Mpc Figura: Risultato di calcoli dettagliati. Log[ λ (Mpc)] Fiandrini Cosmic Rays 17/18 Log[E(eV)]
17 Fiandrini Cosmic Rays 17/18 5 Gpc Closest AGNs L Universo NON è trasparente ai protoni di altissima energia L Universo NON è trasparente ai fotoni di alta energia Galactic radius (15 kpc)
18 Fiandrini Cosmic Rays 17/18 Ricerca delle sorgenti Nella reazione di fotoproduzione (responsabile del cutoff di GZK) sono prodotti π ±, π 0 che decadono: π + ν µ µ + ν µ ν µ ν e e + π 0 γγ Neutrini e fotoni di altissima energia possono quindi essere studiati per confermare il meccanismo GZK, e per localizzare le sorgenti di RC a E > ev Il RC di più alta energia osservato: ev (?) Se le sorgenti non possono essere troppo lontane (<30 Mpc), possiamo cercare di localizzarle tramite: à Studi di anisotropia con esperimenti di RC à Confronto con altre misure astronomiche
19 Da dove vengono le particelle che osserviamo, ie quali sono le sorgenti? Quali sono i processi che danno luogo alle popolazioni osservate? Qual'e' la distribuzione di materia e campi magnetici negli oggetti che emettono e nel mezzo in cui le particelle si propagano e come influenza le osservabili dei RC? E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 19
20 Fiandrini Cosmic Rays 17/18 20
21 Formation and Interactions of CR's Energy Supply: gravitational, nuclear, ELM,... Provide energy for particles Shock & Hydromagnetic waves, ELM Fields, Turbulent B fields,... Store and transport energy Processes transfer a fraction of E to particles: injection and acceleration Particles interact with Relativistic particles = Cosmic rays interstellar, intergalactic medium Matter B Fields Photons Ionization Nuclear interactions Bremsstrahlung E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 Synchrotron & curvature radiation Inverse Compton & Thomson Scattering Self-Absorbtion 21
22 L'ambiente locale q Per capire l'origine dei RC occorre avere un'idea dell'ambiente in cui essi si propagano E che contiene i siti in cui avvengono i processi di accelerazione Il sistema solare si trova nella Via Lattea, la nostra galassia (ma non tutte le sorgenti sono contenute nella galassia in particolare per i fotoni che sono neutri) E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 22
23 Local environment: Milky Way Almost everything we see in the night sky belongs to the Milky Way We see most of the Milky Way as a faint band of light across the sky From the outside, our Milky Way might look very much like our cosmic neighbor, the Andromeda galaxy E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 23
24 For thousands of years, mankind could see this sky Optical band E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 24
25 E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 25
26 E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 26
27 The Structure of the Milky Way Galactic Plane 10 5 ly or 31 kpc Not to scale! Galactic Center 300 pc ( 1000 ly) (uncertain) The structure is hard to determine because: 1) We are inside 2) Distance measurements are difficult 3) Our view towards the center is obscured by gas and dust E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 The Milky Way is the second-largest galaxy in the Local Group, with its stellar disk approximately 100,000 ly (30 kpc) in diameter, and, on average, approximately 1,000 ly (0.3 kpc) thick. As a guide to the relative physical scale of the Milky Way, if the Solar System out to Neptune were the size of a US quarter (25mm), the Milky Way would be approximately the size of the continental United States. It looks like a very thin disk with a thickness or halo height << with respect to the disk radius (something like an old long-playing disk) 27
28 Superclusters L'ammasso Le L'intero Il Lo 5000 galassie 250 Gruppo La spazio galassia anni Universo satelliti Locale locale di luce Virgo galassie m 13.7 miliardi di anni luce 4 Gpc E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 28
29 ~28000 E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 29
30 E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 30
31 The Mass of the Milky Way ly Estimates of the TOTAL mass of the Milky Way vary, depending upon the method and data used. Estimated in the range M and M which is about half the mass of the Andromeda Galaxy. Most of the mass is dark matter. A dark matter halo is spread out relatively uniformly to a distance beyond one hundred kiloparsecs from the Galactic Center. Models of the Milky Way suggest that its total mass is M. More-recent studies indicate a mass as large as M and as small as M. The total stars mass is estimated to be between M and M. There is also interstellar gas, comprising 90% H and 10% He by mass, with 2/3 of the H in atomic form and the remaining 1/3 as molecular hydrogen. The mass of this gas is between 10%and 15% of the total mass of the galaxy's stars. Interstellar dust accounts for an additional 1% of the total mass of the gas. E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 31
32 Notazione per la ionizzazione Notation for Degrees of Ionization Suffix Ionization Examples Chemist's Notation I Not ionized (neutral) H I, He I H, He II Singly ionized H II, He II H +, He + III Doubly ionized He III, O III He ++, O ++ E. Fiandrini Cosmic Rays 32
33 Galaxy Milky Way we can see is made of: q Stars q Dust q Cold and hot gas of the InterStellar Medium q Magnetic Fields q Cosmic rays (...and dark matter...) E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 33
34 Multiwavelength vision must be used to see different components of the galaxy E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 34
35 Constituents of the ISM E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 35
36 Polvere interstellare: estinzione The interstellar extinction curve Interstellar extinction - absorption plus scattering - UV extinction implies small (100 nm) grains - Vis. Extinction implies normal (1000 nm) grains - n(a)da ~ a -3.5 da - Silicates plus carbonaceous grains - Mass dust/mass gas ~ Dense gas larger grains with icy mantles - Normal n d /n ~ Radio IR visible UV E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 36
37 Gas interstellare n Il gas interstellare o intragalattico (IG) è il mezzo in cui si formano le stelle. n Contribuisce per il 5% alla massa della Galassia Fiandrini Cosmic Rays 17/18 37
38 Nubi Gassose Scoperte con astronomia radio Il gas viene riscaldato da vari meccanismi: - Esplosioni di SN - Radiazione U.V. da stelle giganti - Eccitazione/ionizzazione da RC Si raffredda con altri meccanismi: - Bremsstrhalung (gas caldi, K>10 7 K) - Diseccitazione 10 4 K<T<10 7 K - Emissione termica Fiandrini Cosmic Rays 17/18 38
39 E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 39
40 Hyperfine splitting Neutral H consists of a single proton (p) and single e-. p and e- also have spin. The spin of the e-and p can be in either direction - in the classical analogy they are rotating clockwise or anticlockwise around a given axis. They may both have their spin oriented in the same direction or in opposite directions. Because of magnetic interactions between the particles, a H atom having the spins of the e- and p aligned in the same direction (parallel) has slightly more energy than one where the spins of the e- and p are in opposite directions (antiparallel). The lowest orbital energy state of atomic H has hyperfine splitting arising from the spins of the proton and electron changing from a parallel to antiparallel configuration. This transition is highly forbidden with an extremely small probability of s 1. This means that the time for a single isolated atom of neutral H to undergo this transition is 10 7 years and so is unlikely to be seen in a lab on Earth. However, as the total number of atoms of neutral H in the ISM is very large, this emission line is easily observed by radio telescopes. The resulting emitted radiation has a frequency of MHz, corresponding to a λ = 21 cm E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 40
41 Radio Observations 21-cm radio observations reveal the distribution of neutral hydrogen throughout the galaxy Sun Galactic Center Distances to hydrogen clouds determined through radial-velocity measurements (Doppler effect!) Neutral hydrogen concentrated in spiral arms E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 41
42 Distribuzione di idrogeno neutro nella Galassia Fiandrini Cosmic Rays 17/18 42
43 Densità media Figura 17.2 libro del mezzo Interstellare ρ IG = 1 p/cm 3 = =1.6x10-24 g/cm 3 Fiandrini Cosmic Rays 17/18 43
44 Radio View of the Milky Way Interstellar dust does not absorb radio waves We can observe any direction throughout the Milky Way at radio waves Radio map at a wavelength of 21 cm, tracing neutral hydrogen E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 44
45 Hydrogen comprises 90% of the matter in the ISM. Most diffuse H is in the form of HI in the disk with some in the halo. Atomic Hydrogen HI The thin layer of HI gas can be detected either by UV absorption lines and through the 21 cm line (forbidden hyperfine structure transition). E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 45
46 Molecular Hydrogen H 2 H 2 The very thin layer of cold gas clouds is studied mostly via CO line transitions (mm waves, 2.6 mm). Molecular clouds are associated with star-forming regions. E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 46
47 E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 47
48 Physical state of the cool ISM and HI emission Because the density of the ISM is low, the particles have a large mean free path λ = cm n σ n H c H collision cross sec tion : σ 10 cm E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 c
49 The typical velocity v of the particles is 3 m v 2 H = k T B 2 The collision timescale then is: 1/2 1/2 1 v 2kBT 12 nh T 1 c nh c 7 10 s 3 λ 3m H cm K τ = = σ = For T 100 and n 1cm 3 = Κ H = we obtain about 1 collision in 500 yrs. Because of the low temperatures, the energy available from collisions is of order 0.01 ev whereas H and He need 10eV and 21 ev, respectively to be excited Most atoms will be in their ground state. And collisions do not play any role in the gas E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 49
50 Structure of the Milky Way Distribution of dust Sun Distribution of stars and neutral hydrogen Bar Ring E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 50
51 galactic bulge Distribution of Stars Interstellar dust is visible E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 51
52 Infrared View of the Milky Way Near infrared image Nuclear bulge Galactic Plane Interstellar dust (absorbing optical light) emits mostly infrared Infrared emission is not strongly absorbed and provides a clear view throughout the Milky Way E. Fiandrini Cosmic Rays 17/18 52
Fondamenti di Astrofisica. Alessandro Marconi
 Alessandro Marconi La Via Lattea Ottico (~4000-7000 Å) Infrarosso (~1-4 μm) Il Centro Galattico nell IR Piano del Disco Galattico Ammasso di Stelle nel centro galattico! Centro Galattico 3 Osservazioni
Alessandro Marconi La Via Lattea Ottico (~4000-7000 Å) Infrarosso (~1-4 μm) Il Centro Galattico nell IR Piano del Disco Galattico Ammasso di Stelle nel centro galattico! Centro Galattico 3 Osservazioni
Cosmic-ray energy spectrum. TRACER Balloon Flight Mc Murdo, Antarctica Dec. 12 th 26 th, g/cm 2
 5. Misure sui RAGGI COSMICI tramite Sciami Estesi. Corso Astrofisica delle Particelle Prof. Maurizio Spurio Università di Bologna. A.a. 2009/10 1 Outline Produzione di Sciami in Atmosfera ( 5.1, 5.1, 5.25.2
5. Misure sui RAGGI COSMICI tramite Sciami Estesi. Corso Astrofisica delle Particelle Prof. Maurizio Spurio Università di Bologna. A.a. 2009/10 1 Outline Produzione di Sciami in Atmosfera ( 5.1, 5.1, 5.25.2
COMPOSIZIONE dei RAGGI COSMICI
 COMPOSIZIONE dei RAGGI COSMICI Composizione dei Raggi Cosmici Struttura della Composizione e' simile alla composizione media del sistema solare con alcune IMPORTANTI ANOMALIE: Elementi leggeri (Li, Be,
COMPOSIZIONE dei RAGGI COSMICI Composizione dei Raggi Cosmici Struttura della Composizione e' simile alla composizione media del sistema solare con alcune IMPORTANTI ANOMALIE: Elementi leggeri (Li, Be,
MAGIC...una finestra sull'universo. seconda parte
 MAGIC......una finestra sull'universo seconda parte L'emissione della Via Lattea Il cielo ad altissima energia Come sono prodotti i raggi gamma? Emissione termica (equilibrio) --> esempio luce (IR) di
MAGIC......una finestra sull'universo seconda parte L'emissione della Via Lattea Il cielo ad altissima energia Come sono prodotti i raggi gamma? Emissione termica (equilibrio) --> esempio luce (IR) di
La Fisica nello Spazio: Astroparticelle
 La Fisica nello Spazio: Astroparticelle Elisa Antolini Università di Perugia & INAF Dario Gasparrini INFN sez. Perugia ASI Science Data Center Fisica delle Astroparticelle Radiazione elettromagnetica ad
La Fisica nello Spazio: Astroparticelle Elisa Antolini Università di Perugia & INAF Dario Gasparrini INFN sez. Perugia ASI Science Data Center Fisica delle Astroparticelle Radiazione elettromagnetica ad
osservati raggi cosmici di altissima energia
 osservati raggi cosmici di altissima energia protoni e gamma di altissima energia Gamma Ray Burst origine galattica origine extragalattica origine sconosciuta 10 20 ev! 17 Joules Dati AGASA (1999) Raggi
osservati raggi cosmici di altissima energia protoni e gamma di altissima energia Gamma Ray Burst origine galattica origine extragalattica origine sconosciuta 10 20 ev! 17 Joules Dati AGASA (1999) Raggi
Astronomia Parte I Proprietà fondamentali delle stelle
 Astronomia 016-17 Parte I Proprietà fondamentali delle stelle 1 PARTE I Proprietà fondamentali delle stelle Radiazione continua dalle stelle Brillanza. Spettro elettromagnetico. Legge di Planck. Indici
Astronomia 016-17 Parte I Proprietà fondamentali delle stelle 1 PARTE I Proprietà fondamentali delle stelle Radiazione continua dalle stelle Brillanza. Spettro elettromagnetico. Legge di Planck. Indici
Rivedere soprattutto i test in italiano della prime due pagine e quelli in inglese, che richiedono dei calcoli delle pagine 9 e inizio 10.
 Rivedere soprattutto i test in italiano della prime due pagine e quelli in inglese, che richiedono dei calcoli delle pagine 9 e inizio 10. La linea spettrale Ly è vista nello spettro visibile per una:
Rivedere soprattutto i test in italiano della prime due pagine e quelli in inglese, che richiedono dei calcoli delle pagine 9 e inizio 10. La linea spettrale Ly è vista nello spettro visibile per una:
Gaia and the large spectroscopic surveys: the New Milky Way
 Gaia and the large spectroscopic surveys: the New Milky Way Sofia Randich + 6 ricercatori, 1 assegnista, 1 studente) INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri The Milky Way NGC1362 credit ESO The Milky
Gaia and the large spectroscopic surveys: the New Milky Way Sofia Randich + 6 ricercatori, 1 assegnista, 1 studente) INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri The Milky Way NGC1362 credit ESO The Milky
07b - Principi di Astrofisica Buchi Neri nei nuclei galattici
 07b - Principi di Astrofisica Buchi Neri nei nuclei galattici Metodi diretti per misurare MBH Moto di singole particelle test! Moti propri delle stelle e velocità radiali Via Lattea Velocità radiali di
07b - Principi di Astrofisica Buchi Neri nei nuclei galattici Metodi diretti per misurare MBH Moto di singole particelle test! Moti propri delle stelle e velocità radiali Via Lattea Velocità radiali di
Fisica Nucleare e Subnucleare II Lezioni n. 7, 8
 Fisica Nucleare e Subnucleare II Lezioni n. 7, 8 - Interazioni tra adroni a basse energie. Sezione d urto per interazione forte. -Risonanze, formula di Breit-Wigner. -La risonanza Δ e la fisica dei raggi
Fisica Nucleare e Subnucleare II Lezioni n. 7, 8 - Interazioni tra adroni a basse energie. Sezione d urto per interazione forte. -Risonanze, formula di Breit-Wigner. -La risonanza Δ e la fisica dei raggi
Piero Galeotti, University of Torino 1
 Piero Galeotti, University of Torino 1 Sottoterra si può studiare la componente penetrante dei raggi cosmici P,α, A π, π, K, K p, n e± γ EAS ± 0 ± 0 µ ±? Neutrini da supernove ν ~ e( νe) ν ( ~ τ ντ ) ν
Piero Galeotti, University of Torino 1 Sottoterra si può studiare la componente penetrante dei raggi cosmici P,α, A π, π, K, K p, n e± γ EAS ± 0 ± 0 µ ±? Neutrini da supernove ν ~ e( νe) ν ( ~ τ ντ ) ν
Fondamenti di Astrofisica
 Fondamenti di Astrofisica Lezione 12 AA 2010/2011 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Hubble Ultra-Deep Field (HUDF) Come visto nella prima lezione l HUDF è l esposizione più profonda
Fondamenti di Astrofisica Lezione 12 AA 2010/2011 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Hubble Ultra-Deep Field (HUDF) Come visto nella prima lezione l HUDF è l esposizione più profonda
Onda. A = ampiezza. = lunghezza d onda distanza tra due max o min successivi. = frequenza numero di oscillazioni in 1 sec. Lunghezza d'onda e Ampiezza
 Onda A Lunghezza d'onda e Ampiezza = lunghezza d onda distanza tra due max o min successivi A = ampiezza = frequenza numero di oscillazioni in 1 sec. c = velocità di propagazione della luce nel vuoto (3
Onda A Lunghezza d'onda e Ampiezza = lunghezza d onda distanza tra due max o min successivi A = ampiezza = frequenza numero di oscillazioni in 1 sec. c = velocità di propagazione della luce nel vuoto (3
Il lato oscuro dell universo
 Gran Sasso Science Institute - L'Aquila 25-26 Ottobre 2018 Nuovi orizzonti di una scienza in divenire Il lato oscuro dell universo Marco Bersanelli Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Milano
Gran Sasso Science Institute - L'Aquila 25-26 Ottobre 2018 Nuovi orizzonti di una scienza in divenire Il lato oscuro dell universo Marco Bersanelli Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Milano
Astrofisica e particelle elementari
 Astrofisica e particelle elementari aa 2007-08 Lezione 10 Bruno Borgia RAGGI GAMMA 2 ASSORBIMENTO γ Assorbimento dovuto alle interazioni dei gamma con la radiazione di fondo e con l infrarosso.!(k 1 )
Astrofisica e particelle elementari aa 2007-08 Lezione 10 Bruno Borgia RAGGI GAMMA 2 ASSORBIMENTO γ Assorbimento dovuto alle interazioni dei gamma con la radiazione di fondo e con l infrarosso.!(k 1 )
Fondamenti di Astrofisica. Alessandro Marconi
 Alessandro Marconi Contatti, Bibliografia e Lezioni Prof. Alessandro Marconi Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio, Largo E. Fermi 2 email: marconi@arcetri.astro.it, alessandro.marconi@unifi.it
Alessandro Marconi Contatti, Bibliografia e Lezioni Prof. Alessandro Marconi Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio, Largo E. Fermi 2 email: marconi@arcetri.astro.it, alessandro.marconi@unifi.it
Astronomia Lezione 23/1/2012
 Astronomia Lezione 23/1/2012 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Slides: oberon.roma1.infn.it/alessandro/ Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics
Astronomia Lezione 23/1/2012 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Slides: oberon.roma1.infn.it/alessandro/ Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics
The Sun our star. Il sole
 The Sun our star Il sole Modalità di propagazione del calore Irraggiamento Convezione - Conduzione Heat transfer Convection: the transfer of heat through a fluid (liquid or gas) caused by molecular motion
The Sun our star Il sole Modalità di propagazione del calore Irraggiamento Convezione - Conduzione Heat transfer Convection: the transfer of heat through a fluid (liquid or gas) caused by molecular motion
Astronomia Osservativa C!
 Astronomia Osservativa C! Mezzo interstellare! Pianeti! Astrobiologia! Astronomia Osservativa C, ISM 1, Vladilo (2011)! 1! Introduzione allo studio del Mezzo Interstellare! Lezione ISM 1! G. Vladilo! Astronomia
Astronomia Osservativa C! Mezzo interstellare! Pianeti! Astrobiologia! Astronomia Osservativa C, ISM 1, Vladilo (2011)! 1! Introduzione allo studio del Mezzo Interstellare! Lezione ISM 1! G. Vladilo! Astronomia
Fisica ed Astrofisica dei Raggi Cosmici. II parte 18 febbraio 2010 prof. Mariagrazia Fabbri
 Fisica ed Astrofisica dei Raggi Cosmici II parte 18 febbraio 2010 prof. Mariagrazia Fabbri mariagrazia.fabbri@libero.it 1 Sommario 1. I Raggi Cosmici i. Generalità e prime osservazioni ii. Misure dirette
Fisica ed Astrofisica dei Raggi Cosmici II parte 18 febbraio 2010 prof. Mariagrazia Fabbri mariagrazia.fabbri@libero.it 1 Sommario 1. I Raggi Cosmici i. Generalità e prime osservazioni ii. Misure dirette
Cap.1. argomenti del corso. il filo conduttore è il ruolo della gravità. forze gravitazionali ed elettromagnetiche. Teorema del Viriale
 Cap.1 argomenti del corso Teorema del Viriale forze gravitazionali ed elettromagnetiche la gravità equilibrata dalla pressione nelle stelle: stelle normali, produzione di energia termonucleare; nane bianche
Cap.1 argomenti del corso Teorema del Viriale forze gravitazionali ed elettromagnetiche la gravità equilibrata dalla pressione nelle stelle: stelle normali, produzione di energia termonucleare; nane bianche
Fondamenti di Astrofisica
 Fondamenti di Astrofisica Lezione 13 AA 2010/2011 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Le curve di rotazione delle spirali Consideriamo una galassia a spirale (a disco) e misuriamo le
Fondamenti di Astrofisica Lezione 13 AA 2010/2011 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Le curve di rotazione delle spirali Consideriamo una galassia a spirale (a disco) e misuriamo le
B8 Principi di Astrofisica Radio-loud AGNs
 B8 Principi di Astrofisica Radio-loud AGNs Radio-loud AGN definiti come L 5GHz > 10 24 W/Hz Ma definizione arbitraria: AGN che presentano luminosità radio più basse presentano caratterisiche simile ai
B8 Principi di Astrofisica Radio-loud AGNs Radio-loud AGN definiti come L 5GHz > 10 24 W/Hz Ma definizione arbitraria: AGN che presentano luminosità radio più basse presentano caratterisiche simile ai
7. Nuclear models. 7.1 Fermi gas model. 7.2 Shell model
 7. Nuclear models 7.1 Fermi gas model 7. Shell model Fermi Gas Model Free electron gas: protons and neutrons moving quasi-freely within the nuclear volume different potentials wells for protons and neutrons.
7. Nuclear models 7.1 Fermi gas model 7. Shell model Fermi Gas Model Free electron gas: protons and neutrons moving quasi-freely within the nuclear volume different potentials wells for protons and neutrons.
Stelle e Neutrini: il centro del Sole
 Stelle e Neutrini: il centro del Sole Marco G. Giammarchi Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via Celoria 16 20133 Milano (Italy) marco.giammarchi@mi.infn.it http://pcgiammarchi.mi.infn.it/giammarchi/
Stelle e Neutrini: il centro del Sole Marco G. Giammarchi Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via Celoria 16 20133 Milano (Italy) marco.giammarchi@mi.infn.it http://pcgiammarchi.mi.infn.it/giammarchi/
Tolomeo. Piero Galeotti 1
 Tolomeo Piero Galeotti 1 Copernico Piero Galeotti 2 Piero Galeotti 3 Le dimensioni dell Universo (5) Via Lattea Modello a disco di William Herschel (1780) D=2 kpc Sole Piero Galeotti Fisica e l'universo,
Tolomeo Piero Galeotti 1 Copernico Piero Galeotti 2 Piero Galeotti 3 Le dimensioni dell Universo (5) Via Lattea Modello a disco di William Herschel (1780) D=2 kpc Sole Piero Galeotti Fisica e l'universo,
Evidenze astrofisiche di corpi collassati: Pulsar e Buchi Neri. Cristian Vignali Dipartimento di Fisica e Astronomia, Universita` di Bologna
 Evidenze astrofisiche di corpi collassati: Pulsar e Buchi Neri Cristian Vignali Dipartimento di Fisica e Astronomia, Universita` di Bologna Ad alte masse (>8, 25 M ) la stella termina la propria vita come
Evidenze astrofisiche di corpi collassati: Pulsar e Buchi Neri Cristian Vignali Dipartimento di Fisica e Astronomia, Universita` di Bologna Ad alte masse (>8, 25 M ) la stella termina la propria vita come
La neutrino-astronomia: alle frontiere della fisica dei raggi cosmici. Parte I. Otranto, 24 Settembre 2012
 a neutrino-astronomia: alle frontiere della fisica dei raggi cosmici Parte I Otranto, 24 Settembre 2012 arco Circella Istituto azionale di Fisica ucleare - Sezione di Bari marco.circella@ba.infn.it 1 a
a neutrino-astronomia: alle frontiere della fisica dei raggi cosmici Parte I Otranto, 24 Settembre 2012 arco Circella Istituto azionale di Fisica ucleare - Sezione di Bari marco.circella@ba.infn.it 1 a
06b Principi di Astrofisica Radio-loud AGNs
 06b Principi di Astrofisica Radio-loud AGNs Radio-loud AGN definiti come L 5GHz > 10 24 W/Hz Ma definizione arbitraria: AGN che presentano luminosità radio più basse presentano caratterisiche simile ai
06b Principi di Astrofisica Radio-loud AGNs Radio-loud AGN definiti come L 5GHz > 10 24 W/Hz Ma definizione arbitraria: AGN che presentano luminosità radio più basse presentano caratterisiche simile ai
Multi-frequency VLBA Polarimetry of GPS Quasar OQ172
 Multi-frequency VLBA Polarimetry of GPS Quasar OQ172 Liu, Yi Purple Mountain Observatory, CAS 01/06/15 1 Outline 1. Motivation 2. Observation 3. Results 4. Conclusion 01/06/15 2 Information of GPS OQ172
Multi-frequency VLBA Polarimetry of GPS Quasar OQ172 Liu, Yi Purple Mountain Observatory, CAS 01/06/15 1 Outline 1. Motivation 2. Observation 3. Results 4. Conclusion 01/06/15 2 Information of GPS OQ172
Astrofisica e particelle elementari
 Astrofisica e particelle elementari aa 2007-08 Lezione 5 Bruno Borgia SCOPERTA DEI RAGGI COSMICI (1) Alla fine del 1800 i fisici, studiando la conducibilità dei gas con gli elettroscopi a foglioline d
Astrofisica e particelle elementari aa 2007-08 Lezione 5 Bruno Borgia SCOPERTA DEI RAGGI COSMICI (1) Alla fine del 1800 i fisici, studiando la conducibilità dei gas con gli elettroscopi a foglioline d
Tolomeo. Piero Galeotti 1
 Tolomeo Piero Galeotti 1 Copernico Piero Galeotti 2 Piero Galeotti 3 Le dimensioni dell Universo (5) Via Lattea Modello a disco di William Herschel (1780) D=2 kpc Sole Piero Galeotti Fisica e l'universo,
Tolomeo Piero Galeotti 1 Copernico Piero Galeotti 2 Piero Galeotti 3 Le dimensioni dell Universo (5) Via Lattea Modello a disco di William Herschel (1780) D=2 kpc Sole Piero Galeotti Fisica e l'universo,
Esercizio 1 I mesoni K + possono essere prodotti attraverso la reazione γ + p K + + Λ su protoni fermi.
 Esercizio 1 I mesoni K + possono essere prodotti attraverso la reazione γ + p K + + Λ su protoni fermi. Determinare l energia minima del fotone nel laboratorio per cui la reazione avviene Λ decade in volo
Esercizio 1 I mesoni K + possono essere prodotti attraverso la reazione γ + p K + + Λ su protoni fermi. Determinare l energia minima del fotone nel laboratorio per cui la reazione avviene Λ decade in volo
valori di alcune costanti calcolate teoricamente
 valori di alcune costanti calcolate teoricamente pag. 33 raggio dell universo osservabile attuale R ua 4,475 0 9 al 33 età dell universo attuale T ua 3,88 0 9 a 33 valore massimo della velocità di espansione
valori di alcune costanti calcolate teoricamente pag. 33 raggio dell universo osservabile attuale R ua 4,475 0 9 al 33 età dell universo attuale T ua 3,88 0 9 a 33 valore massimo della velocità di espansione
Le Galassie. Lezione 8
 Le Galassie Lezione 8 Proprietà di una galassia E possibile ottenere spettri ed immagini di una galassia a tutte le lunghezze d onda (dal radio ai raggi X). Si possono quindi avere due tipi di osservazioni
Le Galassie Lezione 8 Proprietà di una galassia E possibile ottenere spettri ed immagini di una galassia a tutte le lunghezze d onda (dal radio ai raggi X). Si possono quindi avere due tipi di osservazioni
Single-rate three-color marker (srtcm)
 3. Markers Pag. 1 The Single Rate Three Color Marker (srtcm) can be used as component in a Diffserv traffic conditioner The srtcm meters a traffic stream and marks its packets according to three traffic
3. Markers Pag. 1 The Single Rate Three Color Marker (srtcm) can be used as component in a Diffserv traffic conditioner The srtcm meters a traffic stream and marks its packets according to three traffic
FAM. = 5 4 Mc2 = E C = 5 2 Mc2 1 v2. c 2. 2 M 2M) = 1 2 Mc2
 Serie 19: Soluzioni FAM C. Ferrari Esercizio 1 Collisione completamente anelastica Utilizziamo la conservazione dell energia e della quantità di moto (sistema isolato) in cui trattiamo A e B all inizio
Serie 19: Soluzioni FAM C. Ferrari Esercizio 1 Collisione completamente anelastica Utilizziamo la conservazione dell energia e della quantità di moto (sistema isolato) in cui trattiamo A e B all inizio
Fisica delle AstroParticelle. Aldo Morselli INFN Roma 2 e Dipartimento di Fisica Università di Roma "Tor Vergata"
 Fisica delle AstroParticelle Aldo Morselli INFN Roma 2 e Dipartimento di Fisica Università di Roma "Tor Vergata" Cosa Riceviamo dal Cielo Radiazione Elettromagnetica Raggi Cosmici Neutrini Particelle Esotiche
Fisica delle AstroParticelle Aldo Morselli INFN Roma 2 e Dipartimento di Fisica Università di Roma "Tor Vergata" Cosa Riceviamo dal Cielo Radiazione Elettromagnetica Raggi Cosmici Neutrini Particelle Esotiche
I Raggi Cosmici alle energie estreme dallo spazio (Cosmic ray at extreme energy from space)
 I Raggi Cosmici alle energie estreme dallo spazio (Cosmic ray at extreme energy from space) Relatore : Mario Bertaina Co-Relatore : Piero Galeotti Lo spettro dei raggi cosmici 2,7 E Ha delle variazioni
I Raggi Cosmici alle energie estreme dallo spazio (Cosmic ray at extreme energy from space) Relatore : Mario Bertaina Co-Relatore : Piero Galeotti Lo spettro dei raggi cosmici 2,7 E Ha delle variazioni
Astrofisica e particelle elementari
 Astrofisica e particelle elementari aa 2007-08 Lezione 7 Bruno Borgia RC SECONDARI (1) Propagazione di particelle in atmosfera descritta da equazioni di trasporto, RC secondari prodotti in atmosfera dai
Astrofisica e particelle elementari aa 2007-08 Lezione 7 Bruno Borgia RC SECONDARI (1) Propagazione di particelle in atmosfera descritta da equazioni di trasporto, RC secondari prodotti in atmosfera dai
Astronomia Parte I Proprietà fondamentali delle stelle
 Astronomia 2017-18 Parte I Proprietà fondamentali delle stelle 8 Masse stellari Relazione massa-luminosità per stelle di MS (relazione empirica): 288 stelle binarie L L M M α α 3.5 α 2 α 4 α 3 M < 0.3M
Astronomia 2017-18 Parte I Proprietà fondamentali delle stelle 8 Masse stellari Relazione massa-luminosità per stelle di MS (relazione empirica): 288 stelle binarie L L M M α α 3.5 α 2 α 4 α 3 M < 0.3M
FISICA del NUCLEO. A numero di massa Z numero atomico (numero protoni) N numero di neutroni. Nuclide: uguale Z e uguale A (dunque anche N)
 FISICA del NUCLEO A numero di massa Z numero atomico (numero protoni) N numero di neutroni A=Z+N Nuclide: uguale Z e uguale A (dunque anche N) Isotopi: uguale Z Isotoni: uguale N Isobari: uguale A Isomeri:
FISICA del NUCLEO A numero di massa Z numero atomico (numero protoni) N numero di neutroni A=Z+N Nuclide: uguale Z e uguale A (dunque anche N) Isotopi: uguale Z Isotoni: uguale N Isobari: uguale A Isomeri:
Radiazioni ionizzanti
 Dipartimento di Fisica a.a. 2004/2005 Fisica Medica 2 Radiazioni ionizzanti 11/3/2005 Struttura atomica Atomo Nucleo Protone 10 10 m 10 14 m 10 15 m ev MeV GeV 3 3,0 0,3 0 0 0 Atomo Dimensioni lineari
Dipartimento di Fisica a.a. 2004/2005 Fisica Medica 2 Radiazioni ionizzanti 11/3/2005 Struttura atomica Atomo Nucleo Protone 10 10 m 10 14 m 10 15 m ev MeV GeV 3 3,0 0,3 0 0 0 Atomo Dimensioni lineari
AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION
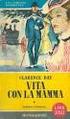 AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION PDF Click button to download
AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION PDF Click button to download
Attività sperimentali di fisica astroparticellare presso laboratori INFN e INAF
 Fermi XENON @LNGS Auger Argentina Attività sperimentali di fisica astroparticellare presso laboratori INFN e INAF M. Bertaina CTA ARGO, Tibet KASCADE-Grande Germania JEM-EUSO Cosa sono i raggi cosmici:
Fermi XENON @LNGS Auger Argentina Attività sperimentali di fisica astroparticellare presso laboratori INFN e INAF M. Bertaina CTA ARGO, Tibet KASCADE-Grande Germania JEM-EUSO Cosa sono i raggi cosmici:
Fisica nucleare e subnucleare 1 appello 26 gennaio 2011
 Fisica nucleare e subnucleare 1 appello 26 gennaio 2011 Problema 1 Per studiare la reazione: γ + p n + π +, un fascio di fotoni di energia 300 MeV e intensità I = 10 8 s -1 incide su un bersagio di idrogeno
Fisica nucleare e subnucleare 1 appello 26 gennaio 2011 Problema 1 Per studiare la reazione: γ + p n + π +, un fascio di fotoni di energia 300 MeV e intensità I = 10 8 s -1 incide su un bersagio di idrogeno
LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI
 Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and
Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and
Il mezzo circumnucleare: NLR/BLR. Monday, January 9, 12
 Il mezzo circumnucleare: NLR/BLR SED ottica/uv di un AGN di tipo 1 2 SED ottica/uv di un AGN di tipo 1 Principali righe in emissione H 6564 Ly 1216 H 4861 Mg II 2800 C IV 1549 Fe II ~5400 C III] 1909 [O
Il mezzo circumnucleare: NLR/BLR SED ottica/uv di un AGN di tipo 1 2 SED ottica/uv di un AGN di tipo 1 Principali righe in emissione H 6564 Ly 1216 H 4861 Mg II 2800 C IV 1549 Fe II ~5400 C III] 1909 [O
S ν = c 4 u ν. S ν dν = c 8π h ν e hν. k B T. S λ = 2π λ 5 c2 h
 Corso di Introduzione alla Fisica Quantistica (f) Esercizi: Maggio 2006 (con soluzione) i) Un filamento emette radiazione che ha una lunghezza d onda massima λ Max = 15000 10 8 cm. Considerando di approssimare
Corso di Introduzione alla Fisica Quantistica (f) Esercizi: Maggio 2006 (con soluzione) i) Un filamento emette radiazione che ha una lunghezza d onda massima λ Max = 15000 10 8 cm. Considerando di approssimare
Lezione 2 Condizioni fisiche per la produzione di energia per mezzo di fusione termonucleare controllata
 Lezione Condizioni fisiche per la produzione di energia per mezzo di fusione termonucleare controllata G. Bosia Universita di Torino 1 Plasma termo-nucleare Definizione : Un plasma termo nucleare e un
Lezione Condizioni fisiche per la produzione di energia per mezzo di fusione termonucleare controllata G. Bosia Universita di Torino 1 Plasma termo-nucleare Definizione : Un plasma termo nucleare e un
Galassie Anomale : Starburst. Lezione 9
 Galassie Anomale : Starburst Lezione 9 Formazione stellare Traccianti di formazione stellare traccianti di stelle OB Le stelle OB sono caratterizzate da una luminosità molto elevata ed emettono principalmente
Galassie Anomale : Starburst Lezione 9 Formazione stellare Traccianti di formazione stellare traccianti di stelle OB Le stelle OB sono caratterizzate da una luminosità molto elevata ed emettono principalmente
La Fisica Astro-Particellare
 La Fisica Astro-Particellare Alessandro Petrolini La Fisica Astro-Particellare La fisica AstroParticellare sta al confine tra: AstroFisica e Fisica delle Particelle Elementari. Studia problemi tipicamente
La Fisica Astro-Particellare Alessandro Petrolini La Fisica Astro-Particellare La fisica AstroParticellare sta al confine tra: AstroFisica e Fisica delle Particelle Elementari. Studia problemi tipicamente
College Algebra. Logarithms: Denitions and Domains. Dr. Nguyen November 9, Department of Mathematics UK
 College Algebra Logarithms: Denitions and Domains Dr. Nguyen nicholas.nguyen@uky.edu Department of Mathematics UK November 9, 2018 Agenda Logarithms and exponents Domains of logarithm functions Operations
College Algebra Logarithms: Denitions and Domains Dr. Nguyen nicholas.nguyen@uky.edu Department of Mathematics UK November 9, 2018 Agenda Logarithms and exponents Domains of logarithm functions Operations
Nuclei Galattici Attivi e Buchi Neri. Lezione 11
 Nuclei Galattici Attivi e Buchi Neri Lezione 11 Galassie Normali La radiazione elettromagnetica emessa dalle galassie normali è quasi interamente prodotta dai processi di evoluzione stellare: Ottico-UV-vicinoIR:
Nuclei Galattici Attivi e Buchi Neri Lezione 11 Galassie Normali La radiazione elettromagnetica emessa dalle galassie normali è quasi interamente prodotta dai processi di evoluzione stellare: Ottico-UV-vicinoIR:
Universo in evoluzione. Universo statico. modifica delle equazioni di campo della R.G. costante cosmologica. Albert Einstein
 1917 G µν = k T µν Universo in evoluzione Universo statico modifica delle equazioni di campo della R.G. Albert Einstein G µν Λ g µν = k T µν costante cosmologica 1922 G µν = k T µν Universo in espansione
1917 G µν = k T µν Universo in evoluzione Universo statico modifica delle equazioni di campo della R.G. Albert Einstein G µν Λ g µν = k T µν costante cosmologica 1922 G µν = k T µν Universo in espansione
La nostra galassia: la Via Lattea. Lezione 13
 La nostra galassia: la Via Lattea Lezione 13 Sommario La struttura della Galassia. Osservazioni in ottico, infrarosso e radio. Disco, sferoide (bulge) e alone. Popolazioni stellari. Braccia a spirale.
La nostra galassia: la Via Lattea Lezione 13 Sommario La struttura della Galassia. Osservazioni in ottico, infrarosso e radio. Disco, sferoide (bulge) e alone. Popolazioni stellari. Braccia a spirale.
07/02/2011. Elementi di Biomeccanica Statica, Cinetica, Esercizi sull analisi delle forze. Mechanics. Statics constant state of motion
 Elementi di Biomeccanica Statica, Cinetica, Esercizi sull analisi delle forze Mechanics Statics constant state of motion Dynamics acceleration present Kinetics of motionless systems Constant velocity systems
Elementi di Biomeccanica Statica, Cinetica, Esercizi sull analisi delle forze Mechanics Statics constant state of motion Dynamics acceleration present Kinetics of motionless systems Constant velocity systems
Prova Scritta del Corso di Fisica Nucleare e Subnucleare 2 - AA 2018/2019
 Prova Scritta del Corso di Fisica Nucleare e Subnucleare 2 - AA 2018/2019 6 Settembre 2019 - Versione 4 NOME E COGNOME: CANALE: 1. Nel 1966, due anni doo la scoerta della radiazione cosmica di fondo (CMB
Prova Scritta del Corso di Fisica Nucleare e Subnucleare 2 - AA 2018/2019 6 Settembre 2019 - Versione 4 NOME E COGNOME: CANALE: 1. Nel 1966, due anni doo la scoerta della radiazione cosmica di fondo (CMB
Present day Accelerators
 Present day Accelerators Introduction The history of accelerators Need for Accelerators Center of mass v.fixed target Linear accelerators Proton synchrotrons CERN 25 GeV PS SPS Electron synchrotrons HERA
Present day Accelerators Introduction The history of accelerators Need for Accelerators Center of mass v.fixed target Linear accelerators Proton synchrotrons CERN 25 GeV PS SPS Electron synchrotrons HERA
10b - Principi di Astrofisica Struttura su larga scala Ammassi e gruppi di galassie
 10b - Principi di Astrofisica Struttura su larga scala Ammassi e gruppi di galassie Le galassie non sono distribuite uniformemente nel cielo bensì tendono a raggrupparsi in gruppi e in ammassi The Cfa
10b - Principi di Astrofisica Struttura su larga scala Ammassi e gruppi di galassie Le galassie non sono distribuite uniformemente nel cielo bensì tendono a raggrupparsi in gruppi e in ammassi The Cfa
Physics [for life science] by examples Draft 0. Problems:
![Physics [for life science] by examples Draft 0. Problems: Physics [for life science] by examples Draft 0. Problems:](/thumbs/95/125565255.jpg) Physics [for life science] by examples Draft 0 Problems: Problem 1: The average height of vertical jumps from standing still is about h=0.6 m for volleyball defenders. Find their initial vertical velocity,
Physics [for life science] by examples Draft 0 Problems: Problem 1: The average height of vertical jumps from standing still is about h=0.6 m for volleyball defenders. Find their initial vertical velocity,
La componente elettronica dei Raggi Cosmici
 Giorgio Sironi Dipartimento di Fisica G. Occhialini Universita` degli Studi di Milano Bicocca Savona 18-02-2011 1 1911 : scoperta a terra si osserva un flusso di circa 100 particelle/m 2 sec sr composto
Giorgio Sironi Dipartimento di Fisica G. Occhialini Universita` degli Studi di Milano Bicocca Savona 18-02-2011 1 1911 : scoperta a terra si osserva un flusso di circa 100 particelle/m 2 sec sr composto
DATI TECNICI TECHNICAL DATA 385 Dimensioni d'ingombro Overall dimensions Versione 6S (3S, 4S) 6S version (3S, 4S)
 Dimensioni d'ingombro Overall dimensions Versione 6S (3S, 4S) 6S version (3S, 4S) N. DT6K0E 3 20 530 1230 453,5 130 90 2450 0 700 2320 6400 7 147 1210 249 347 347 975 528 500,5 419 719 220 500 min 870
Dimensioni d'ingombro Overall dimensions Versione 6S (3S, 4S) 6S version (3S, 4S) N. DT6K0E 3 20 530 1230 453,5 130 90 2450 0 700 2320 6400 7 147 1210 249 347 347 975 528 500,5 419 719 220 500 min 870
Probability Distributions T O P I C # 1
 Probability Distributions ١ T O P I C # 1 Discrete Random Variable A discrete random variable is a variable that can assume only a countable number of values Many possible outcomes: number of complaints
Probability Distributions ١ T O P I C # 1 Discrete Random Variable A discrete random variable is a variable that can assume only a countable number of values Many possible outcomes: number of complaints
Cosmic Rays at Extreme Energies The Pierre Auger Observatory
 Cosmic Rays at Extreme Energies The Pierre Auger Observatory Ezio Menichetti Dip. di Fisica Sperimentale, Universita di Torino INFN, Sez. di Torino Lecture 1 Outline Lecture 1 The High End of the Cosmic
Cosmic Rays at Extreme Energies The Pierre Auger Observatory Ezio Menichetti Dip. di Fisica Sperimentale, Universita di Torino INFN, Sez. di Torino Lecture 1 Outline Lecture 1 The High End of the Cosmic
in collaborazione con Sabrina Campregher e Cristiana Bianchi 5th LAPBOOK
 in collaborazione con Sabrina Campregher e Cristiana Bianchi 5 th LAPBOOK 5 th LAPBOOK Un lapbook per ognuno dei tre macro-argomenti disciplinari affrontati nel corso dell anno, da costruire progressivamente
in collaborazione con Sabrina Campregher e Cristiana Bianchi 5 th LAPBOOK 5 th LAPBOOK Un lapbook per ognuno dei tre macro-argomenti disciplinari affrontati nel corso dell anno, da costruire progressivamente
Emissione termica della polvere
 Emissione termica della polvere corpo nero assorbimento nell IR k(λ) λ 2 L dust ( ) M dust ( )=M dust B(,T)k( ) Qual e la temperatura dei grani? a 2 Q abs UV F UV =4 a 2 Q abs IR SB T 4 B(,T)= ( ) k( )
Emissione termica della polvere corpo nero assorbimento nell IR k(λ) λ 2 L dust ( ) M dust ( )=M dust B(,T)k( ) Qual e la temperatura dei grani? a 2 Q abs UV F UV =4 a 2 Q abs IR SB T 4 B(,T)= ( ) k( )
LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI
 Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and
Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and
Proprietà fisiche del Mezzo Interstellare Diffuso!
 Proprietà fisiche del Mezzo Interstellare Diffuso! Lezione ISM 3! G. Vladilo! Astronomia Osservativa C, ISM 3, Vladilo (2011)! 1! Il Mezzo Interstellare come laboratorio di fisica! Fisica delle basse densità!
Proprietà fisiche del Mezzo Interstellare Diffuso! Lezione ISM 3! G. Vladilo! Astronomia Osservativa C, ISM 3, Vladilo (2011)! 1! Il Mezzo Interstellare come laboratorio di fisica! Fisica delle basse densità!
Astrofisica galattica Lezione 3
 Astrofisica galattica Lezione 3 Maurizio Tomasi maurizio.tomasi@unimi.it Dipartimento di Fisica Università degli studi di Milano 6 Aprile 2016 Parte I Il mezzo interstellare (ISM) Il piano galattico L
Astrofisica galattica Lezione 3 Maurizio Tomasi maurizio.tomasi@unimi.it Dipartimento di Fisica Università degli studi di Milano 6 Aprile 2016 Parte I Il mezzo interstellare (ISM) Il piano galattico L
Fiori di campo. Conoscere, riconoscere e osservare tutte le specie di fiori selvatici più note
 Fiori di campo. Conoscere, riconoscere e osservare tutte le specie di fiori selvatici più note M. Teresa Della Beffa Click here if your download doesn"t start automatically Fiori di campo. Conoscere, riconoscere
Fiori di campo. Conoscere, riconoscere e osservare tutte le specie di fiori selvatici più note M. Teresa Della Beffa Click here if your download doesn"t start automatically Fiori di campo. Conoscere, riconoscere
Appassionati di Tecnologia del Calore
 FORNI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL OVENS Appassionati di Tecnologia del Calore Heat Technology Enthusiasts Forni a infrarosso UNITA' DI TERMOREGOLAZIONE AD ONDE ELETTROMAGNETICHE PER IMPIANTI DI ESTRUSIONE
FORNI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL OVENS Appassionati di Tecnologia del Calore Heat Technology Enthusiasts Forni a infrarosso UNITA' DI TERMOREGOLAZIONE AD ONDE ELETTROMAGNETICHE PER IMPIANTI DI ESTRUSIONE
Astronomia Osservativa C
 Astronomia Osservativa C Mezzo interstellare Pianeti Astrobiologia Astronomia Osservativa C, ISM 1, Vladilo (2011) 1 Introduzione allo studio del Mezzo Interstellare Lezione ISM 1 G. Vladilo Astronomia
Astronomia Osservativa C Mezzo interstellare Pianeti Astrobiologia Astronomia Osservativa C, ISM 1, Vladilo (2011) 1 Introduzione allo studio del Mezzo Interstellare Lezione ISM 1 G. Vladilo Astronomia
Sistemi di coordinate[1]
![Sistemi di coordinate[1] Sistemi di coordinate[1]](/thumbs/54/34146361.jpg) Sistemi di coordinate[1] Coordinate equatoriali: ascensione retta e declinazione Ascensione retta R.A. (α); declinazione δ δ = distanza angolare di un astro dall equatore celeste (positiva a nord) α =
Sistemi di coordinate[1] Coordinate equatoriali: ascensione retta e declinazione Ascensione retta R.A. (α); declinazione δ δ = distanza angolare di un astro dall equatore celeste (positiva a nord) α =
UNIVERSO STATICO E UNIVERSO IN ESPANSIONE
 L UNIVERSO INDICE ARGOMENTI: BIG BANG UNIVERSO STATICO E IN ESPANSIONE TEORIA DELLO STATO STAZIONARIO TEORIA DELLA MATERIA OSCURA LE STELLE E LA LORO EVOLUZIONE STELLE DOPPIE BUCHI NERI UNIVERSI PARALLELI
L UNIVERSO INDICE ARGOMENTI: BIG BANG UNIVERSO STATICO E IN ESPANSIONE TEORIA DELLO STATO STAZIONARIO TEORIA DELLA MATERIA OSCURA LE STELLE E LA LORO EVOLUZIONE STELLE DOPPIE BUCHI NERI UNIVERSI PARALLELI
Sommario. 1. I Raggi Cosmici Alcuni effetti dei RC sulla vita quotidiana. i. Generalità e prime osservazioni ii. iii.
 Sommario 1. I Raggi Cosmici i. Generalità e prime osservazioni ii. Misure dirette e composizione chimica a. La nostra Galassia b. Le Supernovae originano i RC iii. Misure Indirette a. Possibili sorgenti
Sommario 1. I Raggi Cosmici i. Generalità e prime osservazioni ii. Misure dirette e composizione chimica a. La nostra Galassia b. Le Supernovae originano i RC iii. Misure Indirette a. Possibili sorgenti
Rivelatori Caratteristiche generale e concetti preliminari
 Rivelatori Caratteristiche generale e concetti preliminari Stage Residenziale 2012 Indice Caratteristiche generali sensibilità, risposta, spettro d ampiezza, risoluzione energetica, efficienza, tempo morto
Rivelatori Caratteristiche generale e concetti preliminari Stage Residenziale 2012 Indice Caratteristiche generali sensibilità, risposta, spettro d ampiezza, risoluzione energetica, efficienza, tempo morto
 Astroparticle and Neutrino Physics Group Dipartimento di Fisica Teorica dell Università di Torino Istituto Nazionale Fisica Nucleare, Sezione di Torino Nicolao Fornengo Carlo Giunti Fiorenza Donato Stefano
Astroparticle and Neutrino Physics Group Dipartimento di Fisica Teorica dell Università di Torino Istituto Nazionale Fisica Nucleare, Sezione di Torino Nicolao Fornengo Carlo Giunti Fiorenza Donato Stefano
Distribuzione Galattica del Mezzo Interstellare" Fasi interstellari: evidenze osservative!
 Distribuzione Galattica del Mezzo Interstellare" Fasi interstellari: evidenze osservative! Lezione ISM 2! G. Vladilo! Astronomia Osservativa C, ISM 2, Vladilo (2011)! 1! Distribuzione del gas interstellare
Distribuzione Galattica del Mezzo Interstellare" Fasi interstellari: evidenze osservative! Lezione ISM 2! G. Vladilo! Astronomia Osservativa C, ISM 2, Vladilo (2011)! 1! Distribuzione del gas interstellare
Unità 2 - L ambiente celeste
 Unità 2 - L ambiente celeste 1 2 1. La Sfera celeste Stelle in rotazione 3 Posizione delle stelle Pc Distanza alla quale un corpo celeste ha una parallasse p di 1 di arco 4 1 UA 1 al = 9,3 x 10 15 m =
Unità 2 - L ambiente celeste 1 2 1. La Sfera celeste Stelle in rotazione 3 Posizione delle stelle Pc Distanza alla quale un corpo celeste ha una parallasse p di 1 di arco 4 1 UA 1 al = 9,3 x 10 15 m =
Assorbimento di fotoni e passaggio a stati eccitati
 Assorbimento di fotoni e passaggio a stati eccitati E S 3 S T 3 S 1 T T 1 S 0 Diagramma di Jablonski - possibili processi di eccitazione (assorbimento, ν = E/h) Condizione necessaria: hν = E - Sufficiente?
Assorbimento di fotoni e passaggio a stati eccitati E S 3 S T 3 S 1 T T 1 S 0 Diagramma di Jablonski - possibili processi di eccitazione (assorbimento, ν = E/h) Condizione necessaria: hν = E - Sufficiente?
Interazioni dei Fotoni (γ) effetto fotoelettrico, Compton (incluso Thomson e Rayleigh), creazione coppie e+e-, reazioni nucleari (trascurabile)
 Interazioni dei Fotoni (γ) effetto fotoelettrico, Compton (incluso Thomson e Rayleigh), creazione coppie e+e-, reazioni nucleari (trascurabile) Again: Electromagnetic spectrum Name λ (m) ν (Hz) Origin
Interazioni dei Fotoni (γ) effetto fotoelettrico, Compton (incluso Thomson e Rayleigh), creazione coppie e+e-, reazioni nucleari (trascurabile) Again: Electromagnetic spectrum Name λ (m) ν (Hz) Origin
Tutti i colori dell Universo. Roberto Battiston INFN e Universita di Perugia Laboratori di Frascati 6 ottobre 2004
 Tutti i colori dell Universo Roberto Battiston INFN e Universita di Perugia Laboratori di Frascati 6 ottobre 2004 1 2 3 L universo si studia osservando le informazioni = particelle che esso ci invia 4
Tutti i colori dell Universo Roberto Battiston INFN e Universita di Perugia Laboratori di Frascati 6 ottobre 2004 1 2 3 L universo si studia osservando le informazioni = particelle che esso ci invia 4
LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI
 Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and
Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and
Finite Model Theory / Descriptive Complexity: bin
 , CMPSCI 601: Recall From Last Time Lecture 19 Finite Model Theory / Descriptive Compleity: Th: FO L DSPACE Fagin s Th: NP SO. bin is quantifier-free.!#"$&% ('*), 1 Space 0 1 ) % Time $ "$ $ $ "$ $.....
, CMPSCI 601: Recall From Last Time Lecture 19 Finite Model Theory / Descriptive Compleity: Th: FO L DSPACE Fagin s Th: NP SO. bin is quantifier-free.!#"$&% ('*), 1 Space 0 1 ) % Time $ "$ $ $ "$ $.....
Nuclei Galattici Attivi e Buchi Neri. Lezione 15
 Nuclei Galattici Attivi e Buchi Neri Lezione 15 Buchi neri nei nuclei galattici Nell ipotesi che gli AGN siano alimentati da accrescimento di massa su un buco nero l attività AGN deva lasciare un resto
Nuclei Galattici Attivi e Buchi Neri Lezione 15 Buchi neri nei nuclei galattici Nell ipotesi che gli AGN siano alimentati da accrescimento di massa su un buco nero l attività AGN deva lasciare un resto
ECOLE POLYTECHNIQlE FEDERALE DE LAUSANNE
 ).> ECOLE POLYTECHNIQlE.>.> FEDERALE DE LAUSANNE case class : Int : Int : Boolean : String : String : Boolean : Boolean val = case class : Int : Boolean : Boolean : Boolean : Int val = val = val = =>
).> ECOLE POLYTECHNIQlE.>.> FEDERALE DE LAUSANNE case class : Int : Int : Boolean : String : String : Boolean : Boolean val = case class : Int : Boolean : Boolean : Boolean : Int val = val = val = =>
Astronomia Parte II Struttura stellare
 Astronomia 017-18 Parte II Struttura stellare 13 P( E) Fusione nucleare exp[ E / kt b / 1/ E ] P ( E) B E / kt e P ( E) e T b/ E 1/ Dipendenza esponenziale da T Piccoli cambiamenti in T producono forti
Astronomia 017-18 Parte II Struttura stellare 13 P( E) Fusione nucleare exp[ E / kt b / 1/ E ] P ( E) B E / kt e P ( E) e T b/ E 1/ Dipendenza esponenziale da T Piccoli cambiamenti in T producono forti
Modello Cosmologico Standard Paola M. Battaglia
 Modello Cosmologico Standard Paola M. Battaglia l alba dell universo I primi risultati cosmologici del satellite Planck Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Fisica 11 aprile 2013 Cosmologia
Modello Cosmologico Standard Paola M. Battaglia l alba dell universo I primi risultati cosmologici del satellite Planck Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Fisica 11 aprile 2013 Cosmologia
Lucio Paternò Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Catania
 Lucio Paternò Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Catania EINSTEIN 1915 Nascita della Relatività Generale e della Cosmologia Moderna R - g R + g = (8 G/c 4 )T R tensore di curvatura di Ricci
Lucio Paternò Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Catania EINSTEIN 1915 Nascita della Relatività Generale e della Cosmologia Moderna R - g R + g = (8 G/c 4 )T R tensore di curvatura di Ricci
Divagazioni sulla fisica delle particelle. La struttura della materia Le particelle fondamentali Le interazioni fondamentali
 Divagazioni sulla fisica delle particelle La fisica delle particelle come pretesto per fare alcune semplici considerazioni di fisica La struttura della materia Le particelle fondamentali Le interazioni
Divagazioni sulla fisica delle particelle La fisica delle particelle come pretesto per fare alcune semplici considerazioni di fisica La struttura della materia Le particelle fondamentali Le interazioni
Numerical Heat and Mass Transfer
 Master Degree in Mechanical Engineering Numerical Heat and Mass Transfer 16 Convective Heat Transfer Fausto Arpino f.arpino@unicas.it Forced convection over a flat plate Assuming steady-state regime, two-dimensional
Master Degree in Mechanical Engineering Numerical Heat and Mass Transfer 16 Convective Heat Transfer Fausto Arpino f.arpino@unicas.it Forced convection over a flat plate Assuming steady-state regime, two-dimensional
Galassie, Quasar e Buchi neri
 Galassie, Quasar e Buchi neri Stefano Ciroi Università degli Studi di Padova Asiago, 25 Febbraio 2016 La Via Lattea Nord Sud Scheda tecnica della Via Lattea Galassia a spirale barrata Diametro circa 30
Galassie, Quasar e Buchi neri Stefano Ciroi Università degli Studi di Padova Asiago, 25 Febbraio 2016 La Via Lattea Nord Sud Scheda tecnica della Via Lattea Galassia a spirale barrata Diametro circa 30
Le Galassie. Lezione 4
 Le Galassie Lezione 4 Il potenziale gravitazionale Dalla brillanza superficiale (con alcune assunzioni) si può determinare la densità di massa (a meno del fattore Υ, ovvero il rapporto M/L). In generale,
Le Galassie Lezione 4 Il potenziale gravitazionale Dalla brillanza superficiale (con alcune assunzioni) si può determinare la densità di massa (a meno del fattore Υ, ovvero il rapporto M/L). In generale,
Enrico Silva - diritti riservati - Non è permessa, fra l altro, l inclusione anche parziale in altre opere senza il consenso scritto dell autore
 Atomo Raggio atomico (Å) Atomi: diversi e uguali Raggi atomici: sostanzialmente simili per tutti gli atomi. perché? Non è permessa, in particolare, la riproduzione anche perché parziale proprio quella
Atomo Raggio atomico (Å) Atomi: diversi e uguali Raggi atomici: sostanzialmente simili per tutti gli atomi. perché? Non è permessa, in particolare, la riproduzione anche perché parziale proprio quella
Exam of DIGITAL ELECTRONICS June 21 st, 2012 Prof. Marco Sampietro
 Exam of DIGITAL ELECTRONICS June 21 st, 2012 Prof. Marco Sampietro Student I.D. number NAME Si consideri il circuito digitale combinatorio della figura seguente. La tensione d alimentazione è 5V e la soglia
Exam of DIGITAL ELECTRONICS June 21 st, 2012 Prof. Marco Sampietro Student I.D. number NAME Si consideri il circuito digitale combinatorio della figura seguente. La tensione d alimentazione è 5V e la soglia
M-LOCK Serratura magnetica per porte in vetro a battente. M-LOCK Magnetic lock for glass swing doors
 M-LOCK Serratura magnetica per porte in vetro a battente M-LOCK Magnetic lock for glass swing doors M-Lock Serratura Magnetica M-Lock the Magnetic Lock Vantaggi 31 mm Dimensioni estremamente ridotte Ingombro
M-LOCK Serratura magnetica per porte in vetro a battente M-LOCK Magnetic lock for glass swing doors M-Lock Serratura Magnetica M-Lock the Magnetic Lock Vantaggi 31 mm Dimensioni estremamente ridotte Ingombro
