ANALISI COSTI - BENEFICI
|
|
|
- Eugenia Gianni
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ANALISI COSTI - BENEFICI
2 ANALISI COSTI BENEFICI Fondamento dell ANALISI COSTI BENEFICI è l idea che un progetto o una politica possono essere considerati validi dal punto di vista della società se i benefici generati superano i costi
3 OGGETTO DELLA ANALISI CB L Analisi Costi Benefici può essere applicata a POLITICHE (programmi di formazione professionale, di credito alle imprese, di screening sanitario) Oltre che a PROGETTI di investimento (realizzazione di strade, ferrovie, ospedali, parchi)
4 ACB EX ANTE La valutazione può essere ex-ante: si valuta se è opportuno implementare la politica o il progetto In altri termini si valuta se quella specifica destinazione dei fondi sia preferibile rispetto a soluzioni alternative Il risultato può portare alla decisione di selezionare una opzione progettuale, oppure di rimanere nello status quo.
5 ACB EX POST La valutazione può anche essere fatta ex-post: si valuta se determinate scelte di politica o di progetto sono risultate vantaggiose per la società Lo scopo può essere quello di esaminare a fondo i processi decisionali che hanno condotto alla scelta, e, se l ACB ex post produce un risultato negativo, correggerli. In ogni caso l ACB ex post fornisce informazioni su ciò che contribuisce (o meno) al benessere sociale
6 L ANALISI COSTI-BENEFICI E L ECONOMIA DEL BENESSERE L analisi costi-benefici sociale serve per stabilire se un progetto presenti o meno benefici per la società. Dovrebbe offrire ai politici la possibilità di fare ciò che i mercati che funzionano in modo corretto fanno automaticamente: allocare le risorse per un progetto sino a che il beneficio sociale marginale eguagli il costo sociale marginale. L economia del benessere è il fondamento teorico della analisi costi-benefici.
7 L ANALISI COSTI-BENEFICI E L ECONOMIA DEL BENESSERE L economia del benessere fornisce un quadro teorico utile per permettere all operatore pubblico di scegliere quali progetti realizzare: costruire nuovi edifici scolastici, iniziare un programma di screening del tumore al seno o finanziare il trasporto pubblico. Confrontando la funzione del benessere sociale con o senza la realizzazione di un particolare progetto, il politico può stabilire se il benessere aumenterà o meno con la realizzazione del progetto: in caso affermativo, il progetto potrà essere realizzato. L analisi costi-benefici consiste in una serie di operazioni che servono a determinare il valore monetario del benessere sociale in presenza o in assenza del progetto.
8 Funzione del Benessere Sociale Come possiamo misurare il Benessere Sociale ed il Costo Sociale derivanti da una certa scelta pubblica? La misurazione dei costi e benefici finanziari è relativamente semplice (basta misurare gli importi finanziari in entrata ed uscita associati alla realizzazione di un certo intervento) La misurazione di altri costi e benefici, per esempio quelli che rappresentano delle esternalità, o quelli che associati a beni non di mercato, quali ambiente o salute, è più complessa Per la misurazione di questi valori occorre utilizzare specifici strumenti dell Economia Pubblica
9 FONDAMENTI DI ECONOMIA PUBBLICA Le basi microeconomiche dell Economia Pubblica
10 L EQUILIBRIO DI MERCATO P 1 Prezzo Offerta - La CURVA DI OFFERTA è CRESCENTE perché ALL AUMENTARE DEL PREZZO AUMENTA LA QUANTITÀ OFFERTA (i produttori trovano più conveniente vendere quantità maggiori quando il prezzo aumenta). P 2 Q 1 Q 2 Domanda Quantità - La CURVA DI DOMANDA è DECRESCENTE perché, SE IL PREZZO AUMENTA, LA QUANTITÀ DOMANDATA DIMINUISCE.
11 Curva di offerta e costo marginale CMeT CMeV CMa P=Rma Le imprese concorrenziali hanno curve di costo marginale crescenti, almeno per i livelli di produzione per i quali si collocano sul mercato La curva di offerta di breve periodo è la porzione di curva di costo marginale al di sopra della curva dei costi medi variabili La curva di offerta di lungo periodo è la porzione della curva di costo marginale al di sopra della curva dei costi medi totali Se, come nell esempio in figura, il prezzo è al di sotto della curva dei costi medi totali, l impresa non copre i costi fissi: nel lungo periodo uscirà dal mercato La situazione di equilibrio di lungo periodo per l impresa concorrenziale corrisponde a prezzo= CMeT: l impresa non avrà né profitti né perdite
12 SCELTA OTTIMALE E CURVA DI DOMANDA La curva di domanda indica la quantità di beni che viene domandata per ciascun livello di prezzo (ad esempio, al prezzo P 1 la quantità domandata sarà Q 1 etc.). Vedendola in modo inverso, la si può interpretare come DISPONIBILITÀ A PAGARE da parte dei consumatori per ciascuna quantità di bene. Per capire da dove deriva quest ultima, consideriamo le CURVE DI INDIFFERENZA e il VINCOLO DI BILANCIO. Nel seguente grafico poniamo, sull asse delle X e delle Y, due beni di consumo (ad esempio, cibo e abbigliamento). x 2 x 2 A x 2 B x 2 C 0 A B x 1 A x 1 B x 1 C C x 1
13 Le curve in giallo sono CURVE DI INDIFFERENZA. Prendiamo i panieri (ossia le combinazioni dei due beni) A, B, C. Ogni punto nel grafico rappresenta un paniere dei due beni: - se ci si sposta verso l origine degli assi, le quantità di entrambi i beni sono inferiori; - se ci si sposta verso destra e verso l alto, le quantità di entrambi i beni aumentano. Ad esempio, se partiamo da B: - se ci si sposta solo verso destra, x 1 aumenta, mentre x 2 rimane costante; - se ci si sposta solo verso l alto, si ha esattamente l effetto contrario: x 2 aumenta, mentre x 1 rimane costante; - se ci si sposta in una qualunque area compresa tra le due rette che partono da B, invece, aumentano sia x 1 che x 2 (o almeno uno dei due, nel caso limite in cui si sia proprio su una delle due rette). Le due rette dividono dunque lo spazio del diagramma in due parti: una coi panieri in cui almeno uno dei due beni è presente in quantità maggiore rispetto a B; l altra che, viceversa, rappresenta i panieri che sono inferiori. Le curve d indifferenza hanno ANDAMENTO CRESCENTE: quelle che stanno in alto e a destra rispetto alla curva di partenza (di cui fanno parte i panieri A, B e C) rappresentano panieri superiori e quindi combinazioni preferite rispetto alla prima curva. Questo è il senso della freccia riportata in figura rivolta verso destra e verso l alto. Si noti che B STA SULLA STESSA CURVA D INDIFFERENZA DI A E C: ciò significa che SONO UGUALMENTE PREFERITI dall individuo, ossia danno esattamente lo stesso livello di soddisfazione e di benessere.
14 ULTERIORI FORME DELLE CURVE DI INDIFFERENZA Le curve viste sino ad ora sono quelle standard. In alcuni casi quando i beni sono perfettamente complementari o perfetti sostituti - esse assumono però una forma differente. 1) Nel caso di BENI PERFETTAMENTE COMPLEMENTARI, le curve di indifferenza assumono la forma riportata in figura. Come si vede nel grafico, in A si hanno a disposizione le quantità x 1 A e x 2 A. Andando verso destra, aumenta x 1 mentre x 2 rimane invariato: dal momento che si resta sempre lungo una stessa curva d indifferenza, il livello di utilità rimane fisso. Quindi, se aumento la quantità di uno solo dei due beni ma non faccio variare l altro, rimango allo stesso livello di utilità (di benessere) e le mie possibilità di consumo non stanno variando. È quel che avviene nel caso in cui i beni siano perfettamente complementari, ossia debbano necessariamente essere consumati insieme, in coppia (ad esempio, scarpa destra e scarpa sinistra). Anche in questo caso, comunque, il benessere aumenta andando verso l alto e verso destra.
15 2) Nel caso di BENI PERFETTI SOSTITUTI, le curve di indifferenza assumono la forma riportata in figura. Questo è il caso opposto rispetto al precedente. I 3 panieri (A, B, C) stanno esattamente sulla stessa curva di indifferenza, ossia generano lo stesso livello di utilità. A (in cui abbiamo sia x 1 sia x 2 ) dà la stessa soddisfazione di B (in cui abbiamo solo x 1 e zero di x 2 ) e di C (in cui invece abbiamo solo x 2 ). Si deve quindi trattare di beni perfetti sostituti (ad esempio, benzina, sale, farina, di una marca piuttosto che di un altra ) N.B.: Il fatto che siano o meno perfetti sostituti dipende comunque dalle preferenze e dalle utilità individuali.
16 La diversa forma delle curve di indifferenza mostra come questi beni sono considerati dagli individui, ossia le preferenze degli individui per questi beni. Se i beni sono abbastanza sostituibili l uno con l altro si hanno le CURVE STANDARD : il fatto che siano convesse verso l origine significa, in generale, che la combinazione più equilibrata dei 2 beni è preferita ad una in cui ci sia molto dell uno e poco dell altro. Le CURVE ad ANGOLO mostrano la preferenza massima per avere la combinazione dei 2. Le RETTE mostrano invece una indifferenza per la combinazione, in quanto i beni sono perfettamente sostituibili l uno con l altro.
17 IL VINCOLO DI BILANCIO Consideriamo ora il vincolo di bilancio. x 2 - Le curve gialle rappresentano le curve d indifferenza. - La retta rossa è invece il VINCOLO DI BILANCIO, che indica quanto possiede l individuo in termini dei due beni, ossia i PANIERI CHE L INDIVIDUO SI PUÒ PERMETTERE. x 2 A x 2 B x 1 A A x 1 B B C x 1
18 Ne segue che: - se l individuo spende tutto il suo reddito (che chiamiamo m, quantità di moneta a disposizione ) per acquistare x 1, ci si troverebbe sull intercetta sull asse delle ascisse (asse x); - se l individuo spende tutto il suo reddito per acquistare x 2, ci si troverebbe sull intercetta sull asse delle ordinate (asse y); - gli altri punti rappresentano combinazioni dei due beni che l individuo, date le sue risorse, ha potuto acquistare. La RETTA DI BILANCIO si indica come: m = p 1 * x 1 + p 2 * x 2 Da ciò ne segue che: x 2 = m p 1 x 1 p 2 = m p 2 - p 1 p 2 * x 1
19 Esempio: Ho 20 euro a disposizione con cui posso acquistare solo x 1 o x 2 o una combinazione dei 2 beni. Avrò: 20 = 2*x 1 + 1*x 2 Di conseguenza: - se acquisto solo x 1 me ne posso permettere 10; - se acquisto solo x 2 me ne posso permettere 20. Per trovare le altre combinazioni, risolvo per x 2 : x 2 = 20 2 x 1 1 Sostituendo a x 1 delle quantità, trovo per differenza le quantità di x 2 che mi posso permettere. Esempio: se m= 20, p 1 = 2 e p 2 = 4 avrò: 20 = 2*x 1 + 4*x 2 4*x 2 = 20 2 x 1 x 2 = * x 1 x 2 = x 1
20 Ritornando al grafico, possiamo osservare che: - in A e in B l individuo si può permettere di acquistare quei panieri perché si trovano sul vincolo di bilancio, ma il benessere è maggiore in B che in A perché B è su una curva di indifferenza più alta; Più precisamente, il punto B È IL PUNTO DI UTILITÀ MASSIMA CHE L INDIVIDUO PUÒ RAGGIUNGERE IN BASE AL SUO VINCOLO DI BILANCIO, PERCHÉ È IL PUNTO DI TANGENZA CON LE CURVE DI INDIFFERENZA. Oltre quel punto andiamo su aree che sono fuori budget, ossia che comportano una spesa che quell individuo non si può permettere.
21 Come abbiamo visto, LA QUANTITÀ OTTIMALE, che corrisponde alla scelta ottimale dell individuo, SI INDIVIDUA GRAFICAMENTE NEL PUNTO DI TANGENZA TRA LA CURVA DI INDIFFERENZA E IL VINCOLO DI BILANCIO. IL FATTO CHE SIANO TANGENTI SIGNIFICA CHE IN QUEL PUNTO HANNO LA STESSA PENDENZA. NEL PUNTO E, dunque, LA PENDENZA DELLA RETTA DI BILANCIO E DELLA CURVA DI INDIFFERENZA SONO UGUALI. PENDENZA DELLA RETTA DI BILANCIO E DELLA CURVA DI INDIFFERENZA
22 Nel grafico precedente, dunque, NEL PUNTO «E» LA CURVA D INDIFFERENZA HA UNA PENDENZA PARI a quella del vincolo di bilancio e quindi AL RAPPORTO TRA I PREZZI. - LA PENDENZA DEL VINCOLO DI BILANCIO LA RETTA DEL VINCOLO DI BILANCIO HA SEMPRE LA STESSA PENDENZA, appunto perché è una retta, e la sua pendenza è data dall angolo indicato in nero. Quest angolo, da un punto di vista economico, È UGUALE AL RAPPORTO TRA I PREZZI, - p 1 p 2 (col segno meno, perché ha pendenza negativa). Il VINCOLO DI BILANCIO è infatti una retta data da: m = p 1 * x 1 + p 2 * x 2 da cui segue che: x 2 = m p 2 - p 1 p 2 * x 1.. con m p 2 = intercetta di una retta e - p 1 p 2 = coefficiente angolare Per cui: - se x 1 = 0 x 2 = m p p 1 p 2 = RAPPORTO TRA I PREZZI = INTERCETTA SU ASSE Y
23 - LA PENDENZA DELLA CURVA DI INDIFFERENZA Dal punto di vista economico, i punti della curva di indifferenza rappresentano l utilità che quei panieri danno al consumatore e che deve essere sempre la stessa (ossia quei panieri sono indifferenti per il consumatore). Come vediamo nel grafico, A e B sono però fuori dal vincolo di bilancio; E è il paniere che il consumatore può ottenere al minimo costo possibile ma che gli dà la stessa utilità rispetto ad A e B. Considerando la pendenza della curva di indifferenza, vediamo nel grafico che, nello spostarmi da A ad E, sto riducendo x 2 e sto aumentando x 1 (quindi sto scambiando x 2 con x 1 ): è uno scambio che mi rende ugualmente soddisfatto, che mi dà lo stesso livello di benessere. In altri termini, è quanto x 2 sono disposto a cedere per avere una certa quantità aggiuntiva di x 1, rimanendo ad uno stesso livello di benessere, ossia di soddisfazione.
24 IL SAGGIO MARGINALE DI SOSTITUZIONE Questo concetto rappresenta il cosiddetto SAGGIO MARGINALE DI SOSTITUZIONE, che ci dice appunto QUANTO IL CONSUMATORE È DISPOSTO A CEDERE DI UN CERTO BENE x 2 PER AVERE UN UNITÀ INCREMENTALE DEL BENE x 1, RIMANENDO ALLO STESSO LIVELLO DI SODDISFAZIONE. Utilizzando uno stesso spostamento sull asse delle x, potremmo vedere come, nello spostarmi da E a B, sono disposto a cedere molto meno di x 2 che non nel passaggio da A ad E (dove invece ero disposto a cedere parecchio). Questo perché preferisco avere un consumo abbastanza equilibrato dei 2 beni, piuttosto che avere moltissimo dell uno e pochissimo dell altro. Curve del genere rappresentano, in generale, preferenze per combinazioni dei 2 beni, piuttosto che per consumi specializzati dell uno o dell altro bene. N.B.: La pendenza ripida nella parte alta della curva d indifferenza rappresenta un saggio marginale di sostituzione molto elevato.
25 Saggio marginale di sostituzione e scelta ottimale L INDIVIDUO, MASSIMIZZANDO LA SUA UTILITÀ, CERCA DI INDIVIDUARE LA COMBINAZIONE DI BENI CHE GLI PERMETTE DI SODDISFARE IL VINCOLO DI BILANCIO Sceglie il paniere di acquisto che gli dà LA MASSIMA UTILITÀ POSSIBILE. Questo si trova nel punto in cui la retta di bilancio è tangente alla curva di indifferenza Nel punto di scelta ottimale la pendenza della retta di bilancio è esattamente uguale alla pendenza della curva di indifferenza, E dunque il rapporto tra i prezzi è esattamente uguale al saggio marginale di sostituzione Si noti che: IL RAPPORTO TRA I PREZZI È QUANTO, nel mercato, IO DEVO CEDERE DI UN BENE x 2 PER ACQUISTARE UN UNITÀ AGGIUNTIVA DI x 1 (è quello che il venditore mi chiede di cedere); IL SAGGIO MARGINALE DI SOSTITUZIONE È, invece, QUANTO IO SONO DISPOSTO A CEDERE DI x 2 PER UN UNITÀ AGGIUNTIVA DI x 1. Ne segue che, NEL PUNTO DI SCELTA OTTIMALE, QUANTO IO, DATE LE MIE PREFERENZE, SAREI DISPOSTO A CEDERE DI x 2 PER UNA UNITÀ ADDIZIONALE DI x 1 È ESATTAMENTE UGUALE A QUANTO IL MERCATO MI CHIEDE DI CEDERE.
26 Scelta ottimale e vincolo di bilancio Per parlare in termini di efficienza dobbiamo considerare il vincolo dei prezzi. Consideriamo il seguente grafico e 2 differenti vincoli di bilancio (m = p 1 * x 1 + p 2 * x 2 ): 1) Indicato in blu: 20 = 2 * x * x 2 - In questo caso le intercette (ottenute ipotizzando di acquistare o solo x 1 o solo x 2 ) sono pari a 10 e 10; 2) Indicato in rosso: 20 = 4 * x * x 2 - L intercetta sull asse delle ascisse (data da m p 1 ) è uguale a 5; l intercetta sull asse delle ordinate (data da m p 2 ) è uguale a 10 (è quindi la stessa ottenuta con l altro vincolo di bilancio).
27 COSTRUZIONE DELLA CURVA DI DOMANDA x 2 A B La seconda retta di bilancio si trova più vicina all asse Y, quindi rappresenta un bilancio inferiore. Dato che il punto ottimale si trova nel punto in cui la retta è tangente al vincolo di bilancio, ora che il vincolo di bilancio è più ripido il punto di tangenza si troverà più in alto (paniere B) Se il prezzo di x 1 dovesse aumentare ancora, avremmo un altro vincolo di bilancio (verde) ed un nuovo punto di scelta ottimale (A) C Ciò significa che si ha una riduzione della quantità domandata di x 1, il che non stupisce, dal momento che nella seconda equazione il suo prezzo è raddoppiato x 1 Se uniamo tutti i punti di scelta ottimale ottenuti al variare del vincolo di bilancio otteniamo la curva di domanda del bene x 1 : la quantità di bene domandata per ogni dato livello del prezzo
28 SCELTA OTTIMALE E CURVA DI DOMANDA La curva ha andamento negativo: QUANDO IL PREZZO DI UN BENE AUMENTA, SI RIDUCE LA QUANTITÀ DOMANDATA, concetto che graficamente è dato dalla PENDENZA NEGATIVA DELLA CURVA DI DOMANDA.
29 Curva di domanda, DAP, SMS, Prezzo di Riserva La curva di domanda è quindi composta da tutti i punti di scelta ottimale, che rappresentano anche i diversi Saggi Marginale di Sostituzione tra il bene considerato e gli altri beni, ai diversi livelli di consumo del bene. La curva di domanda si può anche interpretare come la curva che rappresenta i diversi SMS del bene, al variare della quantità consumata del bene stesso Disponibilità a Pagare, Prezzo di Riserva, Saggio Marginale di Sostituzione tra il bene e tutti gli altri beni di consumo, sono concetti interscambiabili
30
31 Quantità di verde pubblico (mq*100) Disponibilità A Pagare (DAP) di Caterina Disponibilità A Pagare (DAP) di Nicola Disponibilità A Pagare (DAP) della società P P P D Caterina D Nicola D società Q Q Q
32 Misure di variazione del benessere: Variazione Compensativa E l ammontare che l individuo è disposto a pagare (DAP) o ad accettare (DAA) per la REALIZZAZIONE dell intervento. Per esempio, se l intervento conduce ad un miglioramento del benessere, è la DAP che terrebbe la persona allo stesso livello di benessere iniziale (prima dell intervento) Se l intervento conduce ad un peggioramento del benessere, è la DAA che terrebbe la persona allo stesso livello di benessere iniziale (prima dell intervento)
33 VARIAZIONE COMPENSATIVA
34 Misure di variazione del benessere: Variazione Equivalente E l ammontare che l individuo è disposto a pagare (DAP) o ad accettare (DAA) per la NON REALIZZAZIONE dell intervento. Per esempio, se l intervento conduce ad un peggioramento del benessere, è la DAP che terrebbe la persona allo stesso livello di benessere finale (che si avrebbe dopo dell intervento) Se l intervento conduce ad un miglioramento del benessere, è la DAA che terrebbe la persona allo stesso livello di benessere finale (che si avrebbe dopo l intervento)
35 VARIAZIONE EQUIVALENTE
36 Variazioni di benessere e diritti di «proprietà» Progetto Vale il principio «chi inquina paga» Non vale il principio «chi inquina paga» Il progetto produce inquinamento CV/WTA se si fa la comunità deve ricevere una somma EV/WTP se non si fa la comunità deve pagare una somma Il progetto elimina l inquinamento EV/WTA se non si fa la comunità deve ricevere una somma CV/WTP se si fa la comunità deve pagare una somma
37 Variazioni di benessere e diritti di «proprietà»: qual è la priorità sociale? Progetto Priorità per salute e ambiente Priorità per il lavoro Installazione nuove vasche fanghi rossi CV/WTA se si fa i pro-ambiente devono ricevere una somma CV/WTP se si fa i pro-lavoro devono pagare una somma EV/WTP se non si fa i proambiente devono pagare una somma EV/WTA se non si fa i pro-lavoro devono ricevere una somma
38 Willingness to pay La DAP (WTP) è definita come l ammontare che deve essere pagato da una persona per tenere il suo livello di benessere costante in seguito ad un miglioramento avvenuto (variazione compensativa) V ( y WTP, p, q1; Z) V ( y, p, q; Z) o ad un peggioramento evitato (variazione equivalente) V ( y WTP, p, q ; Z ) V ( y, p, q 2; Z ) V denota la funzione di utilità indiretta, y è il reddito, p è un vettore di prezzi dei beni acquistati dall individuo, q e q 1 sono diversi livelli di qualità o quantità del bene in esame (q 1 >q>q 2 => q 1 si riferisce ad un miglioramento della qualità ambientale, q 2 ad un peggioramento della qualità ambientale), Z è un vettore di caratteristiche individuali.
39 Willingness to accept La DAA (WTA) è definita come l ammontare che deve essere pagato ad una persona per tenere il suo livello di benessere costante in seguito ad un peggioramento avvenuto (variazione compensativa): V ( y WTA, p, q2; Z) V ( y, p, q; Z) o ad un miglioramento non effettuato (variazione equivalente): V ( y WTA, p, q ; Z ) V ( y, p, q 1; Z )
40 WTP e WTA Nelle equazioni della WTP e WTA, l utilità dipende da caratteristiche individuali che influiscono sul trade-off tra reddito e qualità ambientale. Quindi WTP o WTA dipenderanno: 1. dal livello qualitativo iniziale e finale del bene ambientale 2. dal reddito dell individuo 3. dai prezzi di mercato degli altri beni; 4. dalle altre caratteristiche (e preferenze) dell individuo.
41 Valutazione monetaria di beni non di mercato Il calcolo dei costi e dei benefici di un programma o di un progetto pubblico può essere particolarmente complicato perché i prezzi di mercato non riflettono i costi e i benefici sociali.
42 Il prezzo ombra Nell analisi finanziaria privata si applicano i prezzi di mercato. Nell analisi di progetti da parte del settore pubblico occorre considerare anche gli effetti determinati dal progetto, per i quali non è disponibile un prezzo di mercato Oppure il prezzo di mercato non riflette il vero valore del bene
43 Prezzi ombra Mercato Differenza tra Prezzo di Mercato e Prezzo Ombra Spiegazione Lavoro Il prezzo ombra da assegnare è inferiore al salario di mercato quando c è disoccupazione. Non si ha perdita di output in altre produzioni quando si assumono lavoratori disoccupati; il costo marginale sociale è inferiore al salario di mercato. Prodotti forestali Il prezzo ombra da assegnare al beneficio è superiore al prezzo di mercato del legname Il prezzo del legname non include i benefici sociali derivanti dall assorbimento CO2, o da altri valori ambientali e ricreativi prodotti dal bosco. Acciaio Il prezzo ombra da assegnare al costo dell acciaio è più alto del prezzo di mercato Il produttore di acciaio non tiene conto dei costi dell inquinamento (su salute, ambiente, beni culturali, etc.).
44 Prezzi ombra Per alcuni indicatori non si osserva un prezzo di mercato. Tra i casi più rilevanti: IL VALORE DEL TEMPO, IL VALORE DELLA VITA, IL VALORE DELL AMBIENTE Quanto vale il tempo impiegato in coda presso lo sportello di un ufficio, o nel traffico cittadino? Quanto vale una diminuzione della incidenza tumorale derivante da una riduzione di emissioni inquinanti? Quanto vale il mantenimento della biodiversità in un ecosistema?
45 45 Categorie di Valori Ambientali Valore d Uso (UV): p.es. Valore ricreativo, turistico, alimentare, energetico, etc. Valore di Esistenza (EV): diamo valore ad un bene ambientale a prescindere dall uso che possiamo farne, presente o futuro Valore di Opzione (OV): valore che diamo alla possibilità di usare il bene nel futuro Valore di Quasi Opzione (QOV): valore che diamo al tempo di attesa prima di intervenire su un bene ambientale (p.es. per ottenere tutte le informazioni necessarie) Valore di Eredità (BV): (trasmissione del bene ambientale alle generazioni future)
46 Valore economico totale Valore Economico Totale (TEV) = Valore d Uso + Valore di Esistenza + Valore di Opzione + Valore di Quasi Opzione + Valore di Eredità TEV = UV+EV+OV+QOV+BV
47 Determinazione dei Prezzi ombra In alcuni casi si può fare ricorso ad una valutazione basata sul costo del danno: p.es. un aumento di inquinanti nell'atmosfera induce vari danni quantificabili monetariamente come una maggior spesa sanitaria, una maggior spesa per più frequenti interventi di restauro di monumenti, etc. In alternativa a quest approccio si possono adottare degli approcci indiretti che implicano una indagine sulle preferenze della popolazione, i cui principali sono: - I metodi basati sulle preferenze dichiarate: Valutazione Contingente, Esperimenti di Scelta - I metodi basati sulle preferenze rivelate: Costo di Viaggio, Prezzi Edonici
ECONOMIA DEL BENESSERE
 ECONOMIA DEL BENESSERE Economia del Benessere L economia del Benessere studia il modo in cui l allocazione delle risorse influisce sul benessere economico degli individui che compongono la società Acquirenti
ECONOMIA DEL BENESSERE Economia del Benessere L economia del Benessere studia il modo in cui l allocazione delle risorse influisce sul benessere economico degli individui che compongono la società Acquirenti
Curva di domanda, DAP, SMS, Prezzo di Riserva
 Curva di domanda, DAP, SMS, Prezzo di Riserva La curva di domanda è quindi composta da tutti i punti di scelta ottimale, che rappresentano anche i diversi Saggi Marginale di Sostituzione tra il bene considerato
Curva di domanda, DAP, SMS, Prezzo di Riserva La curva di domanda è quindi composta da tutti i punti di scelta ottimale, che rappresentano anche i diversi Saggi Marginale di Sostituzione tra il bene considerato
FONDAMENTI DI ECONOMIA PUBBLICA. Le basi microeconomiche dell Economia Pubblica
 FONDMENTI DI ECONOMI PUBBLIC Le basi microeconomiche dell Economia Pubblica Funzioni del settore pubblico Il ruolo del settore pubblico si esercita in tre funzioni: Funzione di stabilizzazione: Politiche
FONDMENTI DI ECONOMI PUBBLIC Le basi microeconomiche dell Economia Pubblica Funzioni del settore pubblico Il ruolo del settore pubblico si esercita in tre funzioni: Funzione di stabilizzazione: Politiche
CONSUMO. 3. Il Saggio Marginale di Sostituzione (SMS)
 CONSUMO 1. Le Preferenze del Consumatore 2. Curve di Indifferenza 3. Il Saggio Marginale di Sostituzione (SMS) 4. La Funzione di Utilità Utilità Marginale e Utilità Marginale Decrescente Utilità Marginale
CONSUMO 1. Le Preferenze del Consumatore 2. Curve di Indifferenza 3. Il Saggio Marginale di Sostituzione (SMS) 4. La Funzione di Utilità Utilità Marginale e Utilità Marginale Decrescente Utilità Marginale
Capitolo 3. Il comportamento del consumatore
 Capitolo 3 Il comportamento del consumatore La funzione di Utilità totale Proprietà: Funzione crescente Funzione concava U=U(C,V) Slide 2 Utilità Totale funzione di utilità totale Cibo Slide 3 Funzione
Capitolo 3 Il comportamento del consumatore La funzione di Utilità totale Proprietà: Funzione crescente Funzione concava U=U(C,V) Slide 2 Utilità Totale funzione di utilità totale Cibo Slide 3 Funzione
Curve di indifferenza Curve di indifferenza regolari o well-behaved Saggio Marginale di Sostituzione (SMS) La curva Prezzo-consumo
 Curve di indifferenza. La curva di indifferenza rappresenta l insieme delle combinazioni di due beni x1 e x2 che generano lo stesso livello di soddisfazione. In assenza di assunzioni particolari sul sistema
Curve di indifferenza. La curva di indifferenza rappresenta l insieme delle combinazioni di due beni x1 e x2 che generano lo stesso livello di soddisfazione. In assenza di assunzioni particolari sul sistema
Il comportamento del consumatore
 Il comportamento del consumatore Le preferenze del consumatore I vincoli di bilancio La scelta del consumatore Utilità marginale e scelta del consumatore 1 L obiettivo è quello di descrivere come i consumatori
Il comportamento del consumatore Le preferenze del consumatore I vincoli di bilancio La scelta del consumatore Utilità marginale e scelta del consumatore 1 L obiettivo è quello di descrivere come i consumatori
Il comportamento del consumatore
 Il comportamento del consumatore Le preferenze del consumatore I vincoli di bilancio La scelta del consumatore Utilità marginale e scelta del consumatore 1 L obiettivo è quello di descrivere come i consumatori
Il comportamento del consumatore Le preferenze del consumatore I vincoli di bilancio La scelta del consumatore Utilità marginale e scelta del consumatore 1 L obiettivo è quello di descrivere come i consumatori
Le scelte di consumo, il vincolo di bilancio
 Le scelte di consumo, il vincolo di bilancio 1 Le scelte di consumo Due assunzioni fondamentali: i consumatori ricevono soddisfazione dall acquisto di beni e servizi i consumatori si presentano sul mercato
Le scelte di consumo, il vincolo di bilancio 1 Le scelte di consumo Due assunzioni fondamentali: i consumatori ricevono soddisfazione dall acquisto di beni e servizi i consumatori si presentano sul mercato
Il comportamento del consumatore
 Il comportamento del consumatore Le preferenze del consumatore I vincoli di bilancio La scelta del consumatore Utilità marginale e scelta del consumatore 1 L obiettivo è quello di descrivere come i consumatori
Il comportamento del consumatore Le preferenze del consumatore I vincoli di bilancio La scelta del consumatore Utilità marginale e scelta del consumatore 1 L obiettivo è quello di descrivere come i consumatori
Lezione 3 Le preferenze del consumatore
 Lezione 3 Le preferenze del consumatore Argomenti Introduzione all analisi del comportamento del consumatore Le preferenze del consumatore Le curve di indifferenza Il Saggio Marginale di Sostituzione Curve
Lezione 3 Le preferenze del consumatore Argomenti Introduzione all analisi del comportamento del consumatore Le preferenze del consumatore Le curve di indifferenza Il Saggio Marginale di Sostituzione Curve
EQUILIBRIO DI MERCATO, POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE
 EQUILIBRIO DI MERCATO, POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE CONTROLLO dei PREZZI Vi sono situazioni in cui il principio di efficienza si scontra con quello di equità. Considerazioni di tipo normativo possono
EQUILIBRIO DI MERCATO, POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE CONTROLLO dei PREZZI Vi sono situazioni in cui il principio di efficienza si scontra con quello di equità. Considerazioni di tipo normativo possono
L EQUILIBRIO DEL CONSUMATORE PROF. MATTIA LETTIERI
 L EQUILIBRIO DEL CONSUMATORE PROF. MATTIA LETTIERI Indice 1 IL SAGGIO MARGINALE DI SOSTITUIONE ----------------------------------------------------------------------- 3 2 BENI COMPLEMENTARI E BENI PERFETTAMENTE
L EQUILIBRIO DEL CONSUMATORE PROF. MATTIA LETTIERI Indice 1 IL SAGGIO MARGINALE DI SOSTITUIONE ----------------------------------------------------------------------- 3 2 BENI COMPLEMENTARI E BENI PERFETTAMENTE
Preferenze del consumatore. Assiomi Utilità totale e marginale Curva di indifferenza: pendenza e posizione nel piano
 Preferenze del consumatore Assiomi Utilità totale e marginale Curva di indifferenza: pendenza e posizione nel piano Le preferenze del consumatore Dobbiamo capire perché la domanda individuale e quella
Preferenze del consumatore Assiomi Utilità totale e marginale Curva di indifferenza: pendenza e posizione nel piano Le preferenze del consumatore Dobbiamo capire perché la domanda individuale e quella
Elenco dei simboli più comunemente usati in economia politica
 Elenco dei simboli più comunemente usati in economia politica Simboli matematici m Coefficiente angolare di una retta generica Misura la pendenza della retta; se ha segno positivo la retta è crescente,
Elenco dei simboli più comunemente usati in economia politica Simboli matematici m Coefficiente angolare di una retta generica Misura la pendenza della retta; se ha segno positivo la retta è crescente,
MICROECONOMIA. Prof.ssa Carla Massidda
 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale A.A. 2015-2016 MICROECONOMIA Prof.ssa Carla Massidda Argomenti
Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale A.A. 2015-2016 MICROECONOMIA Prof.ssa Carla Massidda Argomenti
ECONOMIA APPLICATA ALL INGEGNERIA (Docente: Prof. Ing. Donato Morea)
 ESERCIZIO n. 1 - Scelte di consumo (scelta ottimale, variazione di prezzo, variazione di reddito) Un consumatore ha preferenze rappresentate dalla seguente funzione di utilità: a) Determinare la scelta
ESERCIZIO n. 1 - Scelte di consumo (scelta ottimale, variazione di prezzo, variazione di reddito) Un consumatore ha preferenze rappresentate dalla seguente funzione di utilità: a) Determinare la scelta
Corso di Scelte degli individui, strategie d impresa e strutture di mercato Facoltà di Giurisprudenza LIUC Prof.ssa Donatella Porrini - a.a.
 Corso di Scelte degli individui, strategie d impresa e strutture di mercato Facoltà di Giurisprudenza LIUC Prof.ssa Donatella Porrini - a.a. 2014-2015 SECONDA LEZIONE 38 MARZO 2015 2016 L EQUILIBRIO DEL
Corso di Scelte degli individui, strategie d impresa e strutture di mercato Facoltà di Giurisprudenza LIUC Prof.ssa Donatella Porrini - a.a. 2014-2015 SECONDA LEZIONE 38 MARZO 2015 2016 L EQUILIBRIO DEL
Capitolo 3 La scelta razionale del consumatore
 Capitolo 3 La scelta razionale del consumatore OBIETTIVI Comprendere il meccanismo decisionale che genera la domanda : Tracciare il vincolo di bilancio del consumatore Costruire la curva di indifferenza
Capitolo 3 La scelta razionale del consumatore OBIETTIVI Comprendere il meccanismo decisionale che genera la domanda : Tracciare il vincolo di bilancio del consumatore Costruire la curva di indifferenza
Introduzione. Teoria della scelta del consumatore. Modello di scelta del consumatore
 Introduzione Teoria della scelta del consumatore Modello di scelta del consumatore Come il consumatore formula i piani di scelta ottima di consumo? E come varia questa scelta al variare dei Prezzi e del
Introduzione Teoria della scelta del consumatore Modello di scelta del consumatore Come il consumatore formula i piani di scelta ottima di consumo? E come varia questa scelta al variare dei Prezzi e del
Domande 1. La domanda e l offerta del bene 1 sono date rispettivamente da:
 Domande 1. La domanda e l offerta del bene 1 sono date rispettivamente da: DD SS 10 0,2 2 2 5 0,5 a) Calcolare la quantità e il prezzo di equilibrio sapendo che il reddito a disposizione del consumatore
Domande 1. La domanda e l offerta del bene 1 sono date rispettivamente da: DD SS 10 0,2 2 2 5 0,5 a) Calcolare la quantità e il prezzo di equilibrio sapendo che il reddito a disposizione del consumatore
Esercitazione 4 del 22/03/2018
 Esercitazione 4 del 22/03/2018 Dott.ssa Sabrina Pedrini Esercizio 1 Il consumatore ha una funzione di utilità data da U= x 1/2 y 1/3. I prezzi dei due beni sono rispettivamente p x =4/3 e p y =1, mentre
Esercitazione 4 del 22/03/2018 Dott.ssa Sabrina Pedrini Esercizio 1 Il consumatore ha una funzione di utilità data da U= x 1/2 y 1/3. I prezzi dei due beni sono rispettivamente p x =4/3 e p y =1, mentre
Il comportamento del consumatore
 Capitolo 3 Il comportamento del consumatore A.A. 2010-2011 Microeconomia - Cap. 3-1 La Teoria del consumo Due ipotesi fondamentali nello studio del comportamento del consumatore: 1. Massimizzazione dell'utilità
Capitolo 3 Il comportamento del consumatore A.A. 2010-2011 Microeconomia - Cap. 3-1 La Teoria del consumo Due ipotesi fondamentali nello studio del comportamento del consumatore: 1. Massimizzazione dell'utilità
Capitolo 3 La scelta razionale del consumatore
 Capitolo 3 La scelta razionale del consumatore Il comportamento del consumatore Tre fasi distinte di analisi nello studio del comportamento del consumatore 1. Le preferenze del consumatore 2. I vincoli
Capitolo 3 La scelta razionale del consumatore Il comportamento del consumatore Tre fasi distinte di analisi nello studio del comportamento del consumatore 1. Le preferenze del consumatore 2. I vincoli
Il comportamento del consumatore
 Capitolo 3 Il comportamento del consumatore.. 2004-2005 Microeconomia - Cap. 3 Questo file per Power Point (visibile anche con OpenOffice ) siti e file può essere scaricato da web.econ.unito.it/terna/micro/
Capitolo 3 Il comportamento del consumatore.. 2004-2005 Microeconomia - Cap. 3 Questo file per Power Point (visibile anche con OpenOffice ) siti e file può essere scaricato da web.econ.unito.it/terna/micro/
La teoria delle scelte del consumatore
 La teoria delle scelte del consumatore La teoria delle scelte del consumatore Descrive come i consumatori distribuiscono i propri redditi tra differenti beni e servizi per massimizzare il proprio benessere.
La teoria delle scelte del consumatore La teoria delle scelte del consumatore Descrive come i consumatori distribuiscono i propri redditi tra differenti beni e servizi per massimizzare il proprio benessere.
Lezioni di Microeconomia
 Lezioni di Microeconomia Lezione 5 Le preferenze del consumatore Lezione 5: le preferenze del consumatore Slide 1 Il vincolo di bilancio individua tutti i panieri di beni (q 1 e q 2 ) accessibili dato
Lezioni di Microeconomia Lezione 5 Le preferenze del consumatore Lezione 5: le preferenze del consumatore Slide 1 Il vincolo di bilancio individua tutti i panieri di beni (q 1 e q 2 ) accessibili dato
Breve ripasso: La curva di domanda
 Breve ripasso: La curva di domanda 1 La curva di domanda identifica, per ogni dato livello del prezzo p, la quantità del bene y che il consumatore intende acquistare. p p a p b a uesta funzione del prezzo
Breve ripasso: La curva di domanda 1 La curva di domanda identifica, per ogni dato livello del prezzo p, la quantità del bene y che il consumatore intende acquistare. p p a p b a uesta funzione del prezzo
La Teoria della Domanda e comportamento del consumatore
 La Teoria della Domanda e comportamento del consumatore Il comportamento del consumatore Tre fasi distinte di analisi nello studio del comportamento del consumatore 1. Le preferenze del consumatore 2.
La Teoria della Domanda e comportamento del consumatore Il comportamento del consumatore Tre fasi distinte di analisi nello studio del comportamento del consumatore 1. Le preferenze del consumatore 2.
Soluzioni Esame di Microeconomia 26/06/17 Versione A parte I
 Soluzioni Esame di Microeconomia 26/06/17 Versione A parte I Un venditore di un bene X si confronta con una curva di domanda giornaliera Q = 2000-10P, dove P è il prezzo in centesimi di ciascuna unità
Soluzioni Esame di Microeconomia 26/06/17 Versione A parte I Un venditore di un bene X si confronta con una curva di domanda giornaliera Q = 2000-10P, dove P è il prezzo in centesimi di ciascuna unità
ANALISI COSTI - BENEFICI. Valutazione delle Politiche Pubbliche Anno Accademico
 ANALISI COSTI - BENEFICI Valutazione delle Politiche Pubbliche Anno Accademico 2017-18 ANALISI COSTI BENEFICI Fondamento dell ANALISI COSTI BENEFICI è l idea che un progetto o una politica possono essere
ANALISI COSTI - BENEFICI Valutazione delle Politiche Pubbliche Anno Accademico 2017-18 ANALISI COSTI BENEFICI Fondamento dell ANALISI COSTI BENEFICI è l idea che un progetto o una politica possono essere
Lezioni di Economia Politica
 Università degli Studi di Roma TRE - Dipartimento di Giurisprudenza Lezioni di Economia Politica Le scelte e l equilibrio del consumatore Giovanni Nicola De Vito Le scelte del consumatore Il consumatore
Università degli Studi di Roma TRE - Dipartimento di Giurisprudenza Lezioni di Economia Politica Le scelte e l equilibrio del consumatore Giovanni Nicola De Vito Le scelte del consumatore Il consumatore
Il comportamento del consumatore
 Unità 1 Il comportamento del consumatore 1 Definizione La teoria del consumatore analizza il comportamento del consumatore teso ad ottenere la massima utilità in presenza di un vincolo di bilancio 2 Preferenze
Unità 1 Il comportamento del consumatore 1 Definizione La teoria del consumatore analizza il comportamento del consumatore teso ad ottenere la massima utilità in presenza di un vincolo di bilancio 2 Preferenze
Esercitazione 3-19 marzo 2018
 MICROECONOMIA (F-N) Novelli Giacomo giacomo.novelli4@unibo.it Ricevimento: lunedì, 13-14:30, aula tutor, Strada Maggiore 45 Esercitazione 3-19 marzo 2018 ESERCIZI Esercizio 1 Un consumatore ha la seguente
MICROECONOMIA (F-N) Novelli Giacomo giacomo.novelli4@unibo.it Ricevimento: lunedì, 13-14:30, aula tutor, Strada Maggiore 45 Esercitazione 3-19 marzo 2018 ESERCIZI Esercizio 1 Un consumatore ha la seguente
La teoria del consumo: curve di indifferenza e vincolo di bilancio
 1 La teoria del consumo: curve di indifferenza e vincolo di bilancio Ipotesi di lavoro: Si consideri un economia a due beni; X e Y rappresentano rispettivamente le quantità del bene X e del bene Y; p X
1 La teoria del consumo: curve di indifferenza e vincolo di bilancio Ipotesi di lavoro: Si consideri un economia a due beni; X e Y rappresentano rispettivamente le quantità del bene X e del bene Y; p X
Domanda e Offerta Prof.ssa Sabrina Pedrini
 Domanda e Offerta rof.ssa Sabrina edrini Esercizio 1 Le curve di domanda e di offerta in un dato mercato per un dato bene sono rispettivamente: d 50 2p e s 10 p a) Determinate il prezzo e la quantità di
Domanda e Offerta rof.ssa Sabrina edrini Esercizio 1 Le curve di domanda e di offerta in un dato mercato per un dato bene sono rispettivamente: d 50 2p e s 10 p a) Determinate il prezzo e la quantità di
MICROECONOMIA. Prof.ssa Carla Massidda
 Università degli Studi di agliari Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche orso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale A.A. 2017-2018 IROEONOIA Prof.ssa arla assidda Argomenti Premessa
Università degli Studi di agliari Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche orso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale A.A. 2017-2018 IROEONOIA Prof.ssa arla assidda Argomenti Premessa
Il comportamento del consumatore
 Capitolo 3 Il comportamento del consumatore A.A. 2008-2009 Microeconomia - Cap. 3 Questo file (con nome cap_03.pdf) può essere scaricato da www.klips.it siti e file Provvisoriamente anche da web.econ.unito.it/terna/micro/
Capitolo 3 Il comportamento del consumatore A.A. 2008-2009 Microeconomia - Cap. 3 Questo file (con nome cap_03.pdf) può essere scaricato da www.klips.it siti e file Provvisoriamente anche da web.econ.unito.it/terna/micro/
ESERCITAZIONE N. 2 Equilibrio di mercato e scelte di consumo
 MICROECONOMIA CLEA A.A. 003-00 ESERCITAZIONE N. Equilibrio di mercato e scelte di consumo ESERCIZIO : Equilibrio di mercato con domanda rigida Le funzioni di domanda e di offerta sul mercato delle sigarette
MICROECONOMIA CLEA A.A. 003-00 ESERCITAZIONE N. Equilibrio di mercato e scelte di consumo ESERCIZIO : Equilibrio di mercato con domanda rigida Le funzioni di domanda e di offerta sul mercato delle sigarette
Microeconomia (C.L. Economia e Legislazione di Impresa); A.A. 2010/2011 Prof. C. Perugini
 Microeconomia (C.L. Economia e Legislazione di Impresa); A.A. 010/011 Prof. C. Perugini Esercitazione n.1 1 Obiettivi dell esercitazione Ripasso di matematica Non è una lezione di matematica! Ha lo scopo
Microeconomia (C.L. Economia e Legislazione di Impresa); A.A. 010/011 Prof. C. Perugini Esercitazione n.1 1 Obiettivi dell esercitazione Ripasso di matematica Non è una lezione di matematica! Ha lo scopo
La teoriadellasceltadel
 La teoriadellasceltadel consumatore Sommario del Capitolo 4 1. Il vincolo di bilancio 2. La scelta ottima 3. Preferenze rivelate(cenni) 4. Scelta intertemporale 2 Il vincolo di bilancio Si supponga che
La teoriadellasceltadel consumatore Sommario del Capitolo 4 1. Il vincolo di bilancio 2. La scelta ottima 3. Preferenze rivelate(cenni) 4. Scelta intertemporale 2 Il vincolo di bilancio Si supponga che
Capitolo 5 Consumatori e incentivi
 Capitolo 5 Consumatori e incentivi 1 (c) Pearson Italia S.p.A. - Anita Woolfolk, Psicologia dell'educazione Il problema del consumatore In che modo si decide che cosa acquistare?. Il problema si riferisce
Capitolo 5 Consumatori e incentivi 1 (c) Pearson Italia S.p.A. - Anita Woolfolk, Psicologia dell'educazione Il problema del consumatore In che modo si decide che cosa acquistare?. Il problema si riferisce
Curva di indifferenza
 Curva di indifferenza Individua le combinazioni di consumo che offrono al consumatore il medesimo livello di soddisfazione La pendenza della curva di indifferenza in qualsiasi punto corrisponde al rapporto
Curva di indifferenza Individua le combinazioni di consumo che offrono al consumatore il medesimo livello di soddisfazione La pendenza della curva di indifferenza in qualsiasi punto corrisponde al rapporto
La curva di domanda individuale
 Corso di Scienza Economica (Economia Politica) prof. G. Di Bartolomeo La curva di domanda individuale Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di Teramo Da che dipende la scelta Riprendiamo il
Corso di Scienza Economica (Economia Politica) prof. G. Di Bartolomeo La curva di domanda individuale Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di Teramo Da che dipende la scelta Riprendiamo il
Programma delle Lezioni 7-9 Marzo
 Università degli Studi di Bologna Facoltà di Scienze Politiche Corso di Laurea in Scienze Politiche, Sociali e Internazionali Microeconomia (A-E) Matteo Alvisi Parte 2(a) LA SCELTA OTTIMALE EL CONSUMATORE
Università degli Studi di Bologna Facoltà di Scienze Politiche Corso di Laurea in Scienze Politiche, Sociali e Internazionali Microeconomia (A-E) Matteo Alvisi Parte 2(a) LA SCELTA OTTIMALE EL CONSUMATORE
PARTE I MICROECONOMIA
 PARTE I MICROECONOMIA ESERCIZIO La quantità domandata di un certo bene è descritta dalla funzione mentre la quantità offerta è descritta dalla funzione a) determinare la configurazione di equilibrio del
PARTE I MICROECONOMIA ESERCIZIO La quantità domandata di un certo bene è descritta dalla funzione mentre la quantità offerta è descritta dalla funzione a) determinare la configurazione di equilibrio del
PREFERENZE. Finora ci siamo occupati di cosa è ammissibile (insieme di bilancio) Come avviene la scelta tra ciò che è ammissibile?
 PREFERENZE Finora ci siamo occupati di cosa è ammissibile (insieme di bilancio) Come avviene la scelta tra ciò che è ammissibile? Obiettivo della scelta è il PANIERE DI CONSUMO: dobbiamo descrivere completamente
PREFERENZE Finora ci siamo occupati di cosa è ammissibile (insieme di bilancio) Come avviene la scelta tra ciò che è ammissibile? Obiettivo della scelta è il PANIERE DI CONSUMO: dobbiamo descrivere completamente
Lezione 11 Argomenti
 Lezione 11 Argomenti La produzione nel lungo periodo: gli isoquanti di produzione La pendenza degli isoquanti e il Saggio Marginale di Sostituzione Tecnica (SMST) Isoquanti di produzione e SMST per fattori
Lezione 11 Argomenti La produzione nel lungo periodo: gli isoquanti di produzione La pendenza degli isoquanti e il Saggio Marginale di Sostituzione Tecnica (SMST) Isoquanti di produzione e SMST per fattori
Esame di Microeconomia CLEC - 14/06/2016. Versione A PARTE PRIMA
 Esame di Microeconomia CLEC - 14/06/2016 Versione A Corso AK - Peragine Corso LZ - Serlenga PARTE PRIMA NOME COGNOME MATRICOLA ISTRUZIONI L esame è composto da tre parti: 10 domande vero falso, 1 domanda
Esame di Microeconomia CLEC - 14/06/2016 Versione A Corso AK - Peragine Corso LZ - Serlenga PARTE PRIMA NOME COGNOME MATRICOLA ISTRUZIONI L esame è composto da tre parti: 10 domande vero falso, 1 domanda
Economia Politica Lezione 5
 Economia Politica Lezione 5 Sergio Vergalli vergalli@eco.unibs.it World Press Photo 2008 http://it.youtube.com/watch?v=7l4c4bxj6fk&feature=related Il consumatore Le dotazioni alternative tra cui
Economia Politica Lezione 5 Sergio Vergalli vergalli@eco.unibs.it World Press Photo 2008 http://it.youtube.com/watch?v=7l4c4bxj6fk&feature=related Il consumatore Le dotazioni alternative tra cui
Capitolo 3 La scelta razionale del consumatore. Robert H. Frank Microeconomia - 5 a Edizione Copyright The McGraw-Hill Companies, srl
 Capitolo 3 La scelta razionale del consumatore L'INSIEME OPPORTUNITÁ E IL VINCOLO DI BILANCIO Un paniere di beni rappresenta una combinazione di beni o servizi Il vincolo di bilancio o retta di bilancio
Capitolo 3 La scelta razionale del consumatore L'INSIEME OPPORTUNITÁ E IL VINCOLO DI BILANCIO Un paniere di beni rappresenta una combinazione di beni o servizi Il vincolo di bilancio o retta di bilancio
EQUILIBRIO DI MERCATO, POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE
 EQUILIBRIO DI MERCATO, POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE CONTROLLO dei PREZZI Vi sono situazioni in cui il principio di efficienza si scontra con quello di equità. Considerazioni di tipo normativo possono
EQUILIBRIO DI MERCATO, POLITICHE ECONOMICHE E BENESSERE CONTROLLO dei PREZZI Vi sono situazioni in cui il principio di efficienza si scontra con quello di equità. Considerazioni di tipo normativo possono
FUNZIONE DI UTILITÀ CURVE DI INDIFFERENZA (Cap. 3)
 FUNZIONE DI UTILITÀ CURVE DI INDIFFERENZA (Cap. 3) Consideriamo un agente che deve scegliere un paniere di consumo fra quelli economicamente ammissibili, posto che i beni di consumo disponibili sono solo
FUNZIONE DI UTILITÀ CURVE DI INDIFFERENZA (Cap. 3) Consideriamo un agente che deve scegliere un paniere di consumo fra quelli economicamente ammissibili, posto che i beni di consumo disponibili sono solo
MICROECONOMIA. Prof.ssa Carla Massidda
 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale A.A. 2015-2016 MICROECONOMIA Prof.ssa Carla Massidda Argomenti
Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale A.A. 2015-2016 MICROECONOMIA Prof.ssa Carla Massidda Argomenti
Tutte le precedenti sono vere Esercitazione 24 marzo 2010
 Al paniere costituito da (4 pizze, 8 birre) corrispondono un utilità marginale delle pizze pari a 14 e una utilità marginale delle birre pari a 12. Il prezzo delle pizze è 7 euro; ogni birra costa 6 euro.
Al paniere costituito da (4 pizze, 8 birre) corrispondono un utilità marginale delle pizze pari a 14 e una utilità marginale delle birre pari a 12. Il prezzo delle pizze è 7 euro; ogni birra costa 6 euro.
I Costi di Produzione
 I Costi di Produzione Misurazione del costi: di quali costi tenere conto? I costi nel breve periodo I costi nel lungo periodo Curve di costo nel lungo e nel breve periodo a confronto Produzione di due
I Costi di Produzione Misurazione del costi: di quali costi tenere conto? I costi nel breve periodo I costi nel lungo periodo Curve di costo nel lungo e nel breve periodo a confronto Produzione di due
Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11)
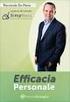 Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11) MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto economico
Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11) MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto economico
Esercitazioni di Economia politica Microeconomia
 5. IL LATO DELLA DOMANDA IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE Utilità, utilità marginale e regola della spesa razionale (richiami di teoria) L utilità è il grado di soddisfazione che gli individui traggono
5. IL LATO DELLA DOMANDA IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE Utilità, utilità marginale e regola della spesa razionale (richiami di teoria) L utilità è il grado di soddisfazione che gli individui traggono
Percorso C. La domanda e il consumatore. Le Relazioni internazionali
 Le Relazioni internazionali Percorso C La domanda e il consumatore Cerchiamo di costruire la curva di indifferenza ricorrendo ancora ad un esempio; questa volta però ci riferiremo a beni divisibili in
Le Relazioni internazionali Percorso C La domanda e il consumatore Cerchiamo di costruire la curva di indifferenza ricorrendo ancora ad un esempio; questa volta però ci riferiremo a beni divisibili in
Capitolo 11 Concorrenza perfetta. Robert H. Frank Microeconomia - 5 a Edizione Copyright The McGraw-Hill Companies, srl
 Capitolo 11 Concorrenza perfetta MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto contabile è
Capitolo 11 Concorrenza perfetta MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto contabile è
ECONOMIA APPLICATA ALL INGEGNERIA ESERCIZI DI MICROECONOMIA
 ECONOMIA APPLICATA ALL INGEGNERIA ESERCIZI DI MICROECONOMIA 1. Disegnare il vincolo di bilancio di un consumatore che dispone della somma di denaro M=240 da spendere nell acquisto di due beni, y 1 e y
ECONOMIA APPLICATA ALL INGEGNERIA ESERCIZI DI MICROECONOMIA 1. Disegnare il vincolo di bilancio di un consumatore che dispone della somma di denaro M=240 da spendere nell acquisto di due beni, y 1 e y
Capitolo 11 La concorrenza perfetta
 Capitolo 11 La concorrenza perfetta MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto contabile
Capitolo 11 La concorrenza perfetta MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto contabile
In che quantità verrà acquistato un bene?
 In che quantità verrà acquistato un bene? LEGGE DELLA DOMANDA Se il prezzo aumenta, la quantità domandata diminuisce Se il prezzo diminuisce, la quantità domandata aumenta L entità di tale aumento o diminuzione
In che quantità verrà acquistato un bene? LEGGE DELLA DOMANDA Se il prezzo aumenta, la quantità domandata diminuisce Se il prezzo diminuisce, la quantità domandata aumenta L entità di tale aumento o diminuzione
Microeconomia, Esercitazione 1. 1 Esercizi. 1.1 Equilibrio di mercato/ Equilibrio di mercato/2. A cura di Giuseppe Gori
 Microeconomia, Esercitazione 1. A cura di Giuseppe Gori (giuseppe.gori@unibo.it) 1 Esercizi. 1.1 Equilibrio di mercato/1 Le curve di domanda e di offerta in un dato mercato sono date da: p = 10 3q p =2+q
Microeconomia, Esercitazione 1. A cura di Giuseppe Gori (giuseppe.gori@unibo.it) 1 Esercizi. 1.1 Equilibrio di mercato/1 Le curve di domanda e di offerta in un dato mercato sono date da: p = 10 3q p =2+q
La Teoria Neoclassica del Consumatore
 La Teoria Neoclassica del Consumatore Prof. Gianni Cicia Dipartimento di Agraria Università di Napoli Federico II cicia@unina.it Istituzioni di Economia e Gestione dell Impresa Agraria e Forestale La teoria
La Teoria Neoclassica del Consumatore Prof. Gianni Cicia Dipartimento di Agraria Università di Napoli Federico II cicia@unina.it Istituzioni di Economia e Gestione dell Impresa Agraria e Forestale La teoria
Esercitazione 5. Domande
 Esercitazione 5 Domande 1. Supporre che un consumatore debba allocare il suo reddito nell acquisto di due beni, X e Y. La funzione di utilità di questo consumatore è pari a U = X Y (quindi, l utilità marginale
Esercitazione 5 Domande 1. Supporre che un consumatore debba allocare il suo reddito nell acquisto di due beni, X e Y. La funzione di utilità di questo consumatore è pari a U = X Y (quindi, l utilità marginale
SCELTA LA SCELTA OTTIMA DEL CONSUMATORE
 SCELTA LA SCELTA OTTIMA DEL CONSUMATORE Rappresentando in unico grafico il vincolo di bilancio e le curve di indifferenza del consumatore si determina la sua scelta ottimale La scelta ottima del consumatore
SCELTA LA SCELTA OTTIMA DEL CONSUMATORE Rappresentando in unico grafico il vincolo di bilancio e le curve di indifferenza del consumatore si determina la sua scelta ottimale La scelta ottima del consumatore
[ESEMPIO: UTILITA' TOTALE E MARGINALE ] UtMa
![[ESEMPIO: UTILITA' TOTALE E MARGINALE ] UtMa [ESEMPIO: UTILITA' TOTALE E MARGINALE ] UtMa](/thumbs/70/62125834.jpg) L'UTILITA' SECONDO MARSHALL Secondo Marshall l'utilità è soggettiva e misurabile, egli effettua l'analisi del singolo consumatore per capire L'equilibrio del consumatore, ovvero raggiungere la massima
L'UTILITA' SECONDO MARSHALL Secondo Marshall l'utilità è soggettiva e misurabile, egli effettua l'analisi del singolo consumatore per capire L'equilibrio del consumatore, ovvero raggiungere la massima
In una ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla e a una delle due domande a risposta aperta, e risolvere l esercizio.
 In una ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla e a una delle due domande a risposta aperta, e risolvere l esercizio. Domande a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione
In una ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla e a una delle due domande a risposta aperta, e risolvere l esercizio. Domande a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione
In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio.
 In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. Domande a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. Domande a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
Teoria del consumatore 2
 Teoria del consumatore 2 Preferenze Mappa di indifferenza È un campione rappresentativo dell insieme delle curve di indifferenza del consumatore, usato come riassunto grafico dell ordinamento dei panieri
Teoria del consumatore 2 Preferenze Mappa di indifferenza È un campione rappresentativo dell insieme delle curve di indifferenza del consumatore, usato come riassunto grafico dell ordinamento dei panieri
1) Il saggio marginale di sostituzione tra il bene x e il bene y rappresenta:
 Esercitazione 3 del 14 marzo 20117 Dott.ssa Sabrina Pedrini Domande a risposta multipla 1) Il saggio marginale di sostituzione tra il bene e il bene rappresenta: a) Il rapporto tra il prezzo del bene e
Esercitazione 3 del 14 marzo 20117 Dott.ssa Sabrina Pedrini Domande a risposta multipla 1) Il saggio marginale di sostituzione tra il bene e il bene rappresenta: a) Il rapporto tra il prezzo del bene e
1. Un consumatore, spendendo tutto il suo reddito, può acquistare 5 unità di x 1 e 18 unità di x 2, oppure 18 unità di x 1 e 5 unità di x 2.
 1. Un consumatore, spendendo tutto il suo reddito, può acquistare 5 unità di x 1 e 18 unità di x 2, oppure 18 unità di x 1 e 5 unità di x 2. Se spendesse tutto il suo reddito per acquistare il bene x 1,
1. Un consumatore, spendendo tutto il suo reddito, può acquistare 5 unità di x 1 e 18 unità di x 2, oppure 18 unità di x 1 e 5 unità di x 2. Se spendesse tutto il suo reddito per acquistare il bene x 1,
Domanda individuale e di mercato Prof.ssa Sabrina Pedrini
 Domanda individuale e di mercato Prof.ssa Sabrina Pedrini Esercizio Le preferenze di un consumatore sono determinate dalla funzione di utilità U = / / (, ) a. determinare la scelta ottimale del consumatore
Domanda individuale e di mercato Prof.ssa Sabrina Pedrini Esercizio Le preferenze di un consumatore sono determinate dalla funzione di utilità U = / / (, ) a. determinare la scelta ottimale del consumatore
In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio.
 In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. Domande a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. Domande a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
Domande ed Esercizi Corso di Istituzioni di Economia Politica
 Domande ed Esercizi Corso di Istituzioni di Economia Politica Simone D Alessandro Ottobre 2009 Indice 1 Teoria del Consumatore 1 1.1 Esercizi.............................. 1 2 Teoria della Produzione 3
Domande ed Esercizi Corso di Istituzioni di Economia Politica Simone D Alessandro Ottobre 2009 Indice 1 Teoria del Consumatore 1 1.1 Esercizi.............................. 1 2 Teoria della Produzione 3
Effetto reddito e sostituzione; domanda aggregata
 Esercitazione 3 del 9 marzo 2017 Dott.ssa Sabrina Pedrini Effetto reddito e sostituzione; domanda aggregata Domande a risposta multipla 1) Per effetto di sostituzione si intende: (a) La variazione totale
Esercitazione 3 del 9 marzo 2017 Dott.ssa Sabrina Pedrini Effetto reddito e sostituzione; domanda aggregata Domande a risposta multipla 1) Per effetto di sostituzione si intende: (a) La variazione totale
Lezione 5. La teoria della domanda
 Lezione 5 La teoria della domanda Sommario della Lezione 5 1. Scelta ottima e funzione di domanda 1. Il cambiamento di prezzo di un bene: l effetto sostituzione e l effetto reddito 1. Il cambiamento di
Lezione 5 La teoria della domanda Sommario della Lezione 5 1. Scelta ottima e funzione di domanda 1. Il cambiamento di prezzo di un bene: l effetto sostituzione e l effetto reddito 1. Il cambiamento di
2) Una curva di indifferenza misura e la sua inclinazione è uguale a
 Esercitazione 2 del 2 marzo 2016 Scelta del consumatore beni normali Dott.ssa Sabrina Pedrini Domande a risposta multipla 1) Il saggio marginale di sostituzione tra il bene x e il bene y rappresenta: a)
Esercitazione 2 del 2 marzo 2016 Scelta del consumatore beni normali Dott.ssa Sabrina Pedrini Domande a risposta multipla 1) Il saggio marginale di sostituzione tra il bene x e il bene y rappresenta: a)
Integrazioni al corso di Economia Politica (anno accademico ) Marianna Belloc
 Integrazioni al corso di Economia Politica (anno accademico 2013-2014) Marianna Belloc 1 L elasticità Come è già noto, la funzione di domanda di mercato indica la quantità che il mercato è disposto ad
Integrazioni al corso di Economia Politica (anno accademico 2013-2014) Marianna Belloc 1 L elasticità Come è già noto, la funzione di domanda di mercato indica la quantità che il mercato è disposto ad
Teoria della domanda domanda
 Teoria della domanda domanda Giancarlo Gozzi Dipartimento di Scienze Economiche Università di Bologna Febbraio 2018 Sommario Prezzi, reddito e funzioni di domanda Scelte del consumatore e analisi di statica
Teoria della domanda domanda Giancarlo Gozzi Dipartimento di Scienze Economiche Università di Bologna Febbraio 2018 Sommario Prezzi, reddito e funzioni di domanda Scelte del consumatore e analisi di statica
Sommario. Preferenze del consumatore Vincoli di bilancio Scelte del consumatore Utilità marginale e scelta del. consumatore
 Sommario La teoria delle scelte del consumatore Preferenze del consumatore Vincoli di bilancio Scelte del consumatore Utilità marginale e scelta del consumatore La teoria delle scelte del consumatore Descrive
Sommario La teoria delle scelte del consumatore Preferenze del consumatore Vincoli di bilancio Scelte del consumatore Utilità marginale e scelta del consumatore La teoria delle scelte del consumatore Descrive
Esercizi e domande di riepilogo
 Esercizi e domande di riepilogo Esercizio I.1.1. Si consideri un economia in cui lo Stato interviene tassando i ricchi e utilizzando il gettito fiscale così ottenuto per costruire scuole e ospedali. Tale
Esercizi e domande di riepilogo Esercizio I.1.1. Si consideri un economia in cui lo Stato interviene tassando i ricchi e utilizzando il gettito fiscale così ottenuto per costruire scuole e ospedali. Tale
Mercati Concorrenziali
 DOMANDA E OFFERTA Mercati Concorrenziali Un mercato è un insieme di acquirenti e di venditori di un determinato bene. Un mercato concorrenziale è un mercato in cui vi siano numerosi acquirenti e venditori
DOMANDA E OFFERTA Mercati Concorrenziali Un mercato è un insieme di acquirenti e di venditori di un determinato bene. Un mercato concorrenziale è un mercato in cui vi siano numerosi acquirenti e venditori
Capitolo 6. La produzione. A.A Microeconomia - Cap. 6-1
 Capitolo 6 La produzione A.A. 2010-2011 Microeconomia - Cap. 6-1 Il comportamento dell'impresa Tre fasi distinte di analisi nello studio del comportamento dell'impresa: 1. Tecnologia di produzione 2. I
Capitolo 6 La produzione A.A. 2010-2011 Microeconomia - Cap. 6-1 Il comportamento dell'impresa Tre fasi distinte di analisi nello studio del comportamento dell'impresa: 1. Tecnologia di produzione 2. I
Sommario. Preferenze del consumatore Vincoli di bilancio Scelte del consumatore Utilità marginale e scelta del. consumatore
 La teoria delle scelte del consumatore Sommario Preferenze del consumatore Vincoli di bilancio Scelte del consumatore Utilità marginale e scelta del consumatore La teoria delle scelte del consumatore Descrive
La teoria delle scelte del consumatore Sommario Preferenze del consumatore Vincoli di bilancio Scelte del consumatore Utilità marginale e scelta del consumatore La teoria delle scelte del consumatore Descrive
Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 3
 Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 3 I costi di produzione Mankiw, Capitolo 13 Premessa Nell analisi della legge dell offerta, vista fino a questo momento, abbiamo sinteticamente descritto le
Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 3 I costi di produzione Mankiw, Capitolo 13 Premessa Nell analisi della legge dell offerta, vista fino a questo momento, abbiamo sinteticamente descritto le
Teoria del comportamento del consumatore
 Teoria del comportamento del consumatore Lo scopo della teoria del consumatore è quello di individuare le condizioni per le quali la scelta di consumo può essere definita ottimale, dati i prezzi, un certo
Teoria del comportamento del consumatore Lo scopo della teoria del consumatore è quello di individuare le condizioni per le quali la scelta di consumo può essere definita ottimale, dati i prezzi, un certo
Capitolo 11 Concorrenza perfetta
 Capitolo 11 Concorrenza perfetta Concorrenza perfetta Le caratteristiche del mercato molti acquirenti e venditori nessuna azione di un singolo ha effetto sul prezzo di mercato le imprese sono price taker
Capitolo 11 Concorrenza perfetta Concorrenza perfetta Le caratteristiche del mercato molti acquirenti e venditori nessuna azione di un singolo ha effetto sul prezzo di mercato le imprese sono price taker
Microeconomia - Problem set 2 - soluzione
 Microeconomia - Problem set 2 - soluzione (Prof. Paolo Giordani - TA: Pierluigi Murro) 16 Aprile 2015 Esercizio 1. Le preferenze di un consumatore sono descritte dal saggio marginale di sostituzione SMS
Microeconomia - Problem set 2 - soluzione (Prof. Paolo Giordani - TA: Pierluigi Murro) 16 Aprile 2015 Esercizio 1. Le preferenze di un consumatore sono descritte dal saggio marginale di sostituzione SMS
Economia Politica ( ) Esercizi ripasso (1) Marianna Belloc
 Economia Politica (2014-2015) Esercizi ripasso (1) Marianna Belloc Esercizio 1: In un mercato perfettamente concorrenziale operano N = 100 imprese identiche caratterizzate dalla seguente funzione di costo
Economia Politica (2014-2015) Esercizi ripasso (1) Marianna Belloc Esercizio 1: In un mercato perfettamente concorrenziale operano N = 100 imprese identiche caratterizzate dalla seguente funzione di costo
ESERCITAZIONE 3 CURVA DI DOMANDA CURVE DI INDIFFERENZA VINCOLO DI BILANCIO
 ESERCITAZIONE 3 CURVA DI DOMANDA CURVE DI INDIFFERENZA VINCOLO DI BILANCIO 1. ESERCIZIO TIPO 1 CURVA DI DOMANDA ED ELASTICITÀ 1.1 Argomenti teorici da conoscere: 1. Curva di domanda: La funzione di domanda
ESERCITAZIONE 3 CURVA DI DOMANDA CURVE DI INDIFFERENZA VINCOLO DI BILANCIO 1. ESERCIZIO TIPO 1 CURVA DI DOMANDA ED ELASTICITÀ 1.1 Argomenti teorici da conoscere: 1. Curva di domanda: La funzione di domanda
Esonero di Microeconomia 06/04/17 VERSIONE A
 Esonero di Microeconomia 06/04/17 VERSIONE A Testo domanda 1 (fino a 12 punti): Considerate le seguenti funzioni di domanda e di offerta: Q =450 20P Q = 40P 150 a. determinare il prezzo e la domanda di
Esonero di Microeconomia 06/04/17 VERSIONE A Testo domanda 1 (fino a 12 punti): Considerate le seguenti funzioni di domanda e di offerta: Q =450 20P Q = 40P 150 a. determinare il prezzo e la domanda di
