B. Affinità tipologica
|
|
|
- Cipriano Coco
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 B. Affinità tipologica Due o più lingue si dicono tipologicamente affini quando presentano caratteristiche funzionali e strutturali simili, indipendentemente dalla dimensione spaziale e temporale. Non ha alcuna importanza che gli elementi fonologici, morfologici o sintattici comparati abbiano un'origine comune, quello che conta è la funzione che essi svolgono all'interno del rispettivo sistema linguistico. L'affinità tipologica perciò accomuna lingue anche lontanissime tra loro in termini storici e geografici e senza alcun contatto reciproco. P. es. l'ungherese e il somalo appartengono a famiglie diverse (quella uralica e quella afroasiatica) e ovviamente i loro parlanti non hanno mai avuto contatti. In entrambe però è presente il fenomeno dell'armonia vocalica e questo tratto fonologico comune le rende tipologicamente affini. La linguistica tipologica si occupa quindi, in base all'affinità sopra descritta, di individuare dei tipi linguistici, ossia modelli di sistema linguistico, e di classificare le lingue secondo tali tipi. Mentre la classificazione genealogica opera su base diacronica, attraverso la ricostruzione e l'indagine sulla preistoria delle lingue, la classificazione tipologica ha un'impostazione sincronica, basata su metodi di comparazione. Benché ovviamente gli elementi messi a confronto possano riguardare anche la fonologia, le classificazioni tipologiche più studiate e diffuse sono quella morfologica e quella sintattica. 1. Tipologia morfologica Un primo modo in cui individuare tipi linguistici diversi e quindi classificare tipologicamente le lingue è quello basato sulla morfologia, cioè sulla struttura della parola. In base alla struttura della parola distinguiamo 4 tipi morfologici linguistici: lingue isolanti, agglutinanti, flessive e polisintetiche. Lingue isolanti È detta isolante una lingua in cui la struttura della parola è la più semplice possibile. Le lingue isolanti non hanno morfologia flessionale, mentre hanno una morfologia derivazionale scarsa (o nulla). Ad ogni morfema corrisponde una parola e viceversa; p. es. a una parola che porta il significato lessicale viene accostata una che porta il significato grammaticale ecc. Tali lingue si chiamano isolanti perché isolano il significato di un messaggio in singole parole. Oltreché monomorfematiche, nel tipo isolante le parole sono anche spesso monosillabiche. Per osservare in pratica come funziona una lingua isolante analizziamo la frase cinese wǒ gěi tā mǎi le shū {io + DAT. + lui/lei + comprare + PASS. + libro} "gli/le ho comprato un libro": wǒ è il pronome di 1 a persona singolare; gěi può fungere da morfema lessicale col valore di "dare" oppure (come in questo caso) da morfema grammaticale di dativo, equivalente alle preposizioni italiane "a" o "per"; tā è il pronome di 3 a persona singolare; mǎi significa "comprare"; le è un morfema che indica azione passata; shū significa "libro". Come si può notare, manca totalmente qualsiasi traccia di flessione, ogni parola è immodificabile; le marche grammaticali
2 sono date da morfemi liberi o preposti (gěi, dativo) o posposti (le, passato). Inoltre l'ordine sintattico è necessariamente rigido, la funzione di soggetto di wǒ e quella di oggetto di shū così come la funzione di tutti gli altri elementi si desumono unicamente dalla loro posizione all'interno della frase; qualsiasi spostamento sintattico altererebbe il significato della frase o la renderebbe incomprensibile. Infatti, i significati e i valori di varia natura che in lingue di altro tipo sono codificati dalla morfologia, nelle lingue isolanti sono principalmente affidati al lessico e alla sintassi. Mancando i processi di derivazione, l'unica risorsa a disposizione del cinese per formare parole nuove è la composizione: p. es. unendo le parole zhōng "centro, in mezzo" e guó "paese" otteniamo Zhōngguó "Cina" (che per i Cinesi è il "Paese di mezzo"); aggiungendo ancora rén "persona" avremo zhōngguórén "Cinese". Molte parole del linguaggio tecnico-scientifico cinese sono formate col lessema diàn "elettricità", p. es. diànhuà {elettricità + parlare} "telefono", diànnǎo {elettricità + cervello} "computer", diàntī {elettricità + scala} "ascensore". Lingue flessive Le lingue flessive presentano parole tendenzialmente costituite da una base lessicale semplice (radice) oppure derivata, e da uno o più affissi flessionali, che veicolano diverse funzioni grammaticali. Sono presenti molti fenomeni di allomorfia e di fusione, per cui i singoli morfemi possono essere difficilmente identificabili. L'analisi morfologica delle lingue flessive è resa più difficile anche dalla possibilità che vi siano fenomeni di omonimia, sinonimia e polisemia di morfemi 1. Proprio per la caratteristica di riunire più significati su un solo morfema flessionale e di fondere assieme i morfemi rendendo spesso poco trasparente la struttura della parola, tali lingue vengono chiamate anche fusive. Si chiamano invece flessive perché caratterizzate da morfologia flessionale, che dà luogo a più forme flesse della stessa parola. Le principali famiglie linguistiche appartenenti al tipo flessivo sono quella indoeuropea e quella afroasiatica. Lingue agglutinanti Nelle lingue agglutinanti i morfemi vengono associati alle parole grazie alla giustapposizione, secondo il meccanismo morfologico dell'affissazione: la giustapposizione di più morfemi può dare luogo a una lunga catena di morfemi. A differenza delle lingue flessive, nelle quali ogni morfema può riunire in sé più significati (p. es. la desinenza -e di dell'italiano case indica tanto il femminile quanto il plurale), nelle lingue agglutinanti ogni affisso porta un solo significato (grammaticale). All'interno della parola i morfemi sono facilmente individuabili e separabili l'uno dall'altro. Sono relativamente rari i fenomeni di allomorfia e di omonimia tra morfemi e c'è nel complesso una notevole regolarità nella grammatica. Per esemplificare la differenza fra lingue flessive e agglutinanti mettiamo a confronto la declinazione delle parole latine lingua e opus con quella dei loro omologhi turchi dil "lingua" ed eser "opera": 1 Le lingue flessive organizzano i messaggi della comunicazione generalmente in radici lessicali (che hanno significato lessicale) e desinenze (che hanno significato grammaticale). Questa tendenza a fondere più significati in una stessa parola implica la possibilità di fondere più significati anche in uno stesso morfema.
3 Singolare Nominativo lingua opus dil eser Genitivo linguae operis dilin eserin Dativo linguae operī dile esere Accusativo linguam opus dili eseri Ablativo linguā opere dilden eserden Plurale Nominativo linguae opera diller eserler Genitivo linguārum operum dillerin eserlerin Dativo linguīs operibus dillere eserlere Accusativo linguās opera dilleri eserleri Ablativo linguīs operibus dillerden eserlerden Salta subito agli occhi che in una lingua flessiva come il latino le declinazioni sono fortemente differenziate: non c'è alcuna corrispondenza tra le desinenze casuali di lingua e quelle di opus, né tanto meno, all'interno della stessa declinazione, tra quelle di singolare e plurale (fra ae e ārum non v'è alcuna somiglianza, benché entrambe marchino il genitivo). Al contrario il turco, agglutinante, mostra un unico modello di flessione, estremamente regolare e valido sia per il singolare sia per il plurale (marcato dal morfema ler; ovviamente ciascun morfema ha vari allomorfi dovuti all'armonia vocalica). Le desinenze latine si fondono spesso con la vocale tematica distruggendo i confini di morfema, mentre quelle turche sono sempre facilmente separabili dalla radice. Infine in latino, come in tutte le lingue flessive, vari significati grammaticali si accumulano nello stesso morfema (l'am di linguam esprime inscindibilmente l'accusativo, il singolare e il femminile, ossia il caso, il numero e il genere), laddove nelle lingue agglutinanti i morfemi di solito hanno un valore univoco e una solo funzione, cioè ogni morfema ha un suo valore (vedi il turco, dove non esiste un "genitivo plurale" analogo al latino, ma una marca ler che indica il plurale, e solo quello, e una marca in che indica il genitivo, e solo quello). Lingue polisintetiche Le lingue polisintetiche sono quelle che hanno la struttura della parola più complessa. Come le lingue agglutinanti, hanno la parola formata da più morfemi attaccati assieme, ma (a differenza di queste, in cui una parola normalmente ha una sola radice lessicale) in una stessa parola compaiono due o più radici lessicali. Le parole delle lingue polisintetiche tendono dunque a corrispondere spesso a ciò che nelle altre lingue sarebbero frasi intere ("parola-frase"): all'opposto delle lingue isolanti, quelle polisintetiche realizzano nella morfologia valori semantici che di solito sono affidati al lessico. Rispetto alle lingue agglutinanti, quelle polisintetiche presentano fenomeni di fusione che rendono a volte poco trasparente la struttura delle parole, come nel tipo flessivo. Esempi particolarmente significativi di polisintesi sono quelli offerti dalle lingue nordamericane, come il seguente tratto dal paiute (lingua amerindiana parlata nello Utah): wiitokuchumpukurüganiyugwicantüm (naturalmente non tutte le "parole" del
4 paiute hanno questa eccezionale lunghezza), che significa "quelli che andranno a sedersi e a tagliare a pezzi con un coltello una mucca nera". Un'importante distinzione concernente la tipologia morfologica è quella tra lingue sintetiche, che tendono a combinare più morfemi in un'unica parola, e lingue analitiche, dove molte funzioni grammaticali vengono espresse da morfemi liberi e ognuna delle unità resta relativamente indipendente dalle altre. L'indice più alto di sintesi è rappresentato dalle lingue polisintetiche, quello più basso dalle lingue isolanti. L'opposizione sintetico/analitico si può riscontrare soprattutto all'interno dei tipi agglutinante e flessivo. P. es. il turco e il giapponese sono entrambi agglutinanti; vediamo però come la frase l'insegnante ha dato il libro al bambino si traduce in queste lingue: turco öğretmen çocuğa kitabı verdi insegnante-nom bambino-dat libro-acc ha dato giapponese sensei ga kodomo ni hon o kudasaimashita Come risulta evidente, mentre il turco appare pienamente sintetico, il giapponese mostra chiari tratti analitici, evidenziati dall'uso di morfemi liberi posposti (ga, ni, o) per marcare il caso. In conclusione va sottolineato come i confini che separano un tipo morfologico dall'altro non sono assolutamente netti e definiti. Il turco, ad esempio, che viene additato come lingua agglutinante par excellence, può presentare parole "monstre" quali şöhretlendirmediklerinizdendir "è uno di quelli che non avete reso famosi", che si attribuirebbero facilmente a una lingua polisintetica. Allo stesso modo lingue flessive presentano spesso tratti agglutinanti e viceversa. Insomma ben difficilmente le lingue rappresentano tipi morfologici puri, bensì tipi in maggiore o minore misura misti; se una lingua si definisce flessiva, ciò significa che i suoi tratti sono prevalentemente flessivi rispetto a quelli che potrebbero accomunarla a un altro tipo (v. sul Berruto i paragrafi Distinzione tra lingue analitiche e lingue sintetiche e Caratteri non flessivi dell'italiano, pagg ). 2. Tipologia sintattica e universali Tipologia dell'ordine dei costituenti Il fondatore della tipologia sintattica moderna è Joseph H. Greenberg ( ), linguista statunitense che ne gettò le basi nel 1963 con la pubblicazione dell'articolo intitolato "Alcuni universali della grammatica con particolare riferimento all'ordine degli elementi significativi" (Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements). Vengono definiti universali linguistici le caratteristiche condivise da tutte (o quasi) le lingue storico-naturali, indipendentemente dalle loro reciproche relazioni storiche o dai loro rapporti genetici. È inoltre importante che un universale linguistico non sia contraddetto dalle caratteristiche di nessuna lingua. P. es. affermazioni quali "non
5 esiste sistema fonologico che non comprenda sia vocali sia consonanti" oppure "categorie sintattiche come il nome e il verbo sono presenti nella struttura di ogni lingua nota" sono degli universali. Nel lavoro citato, Greenberg si è proposto di dedurre una serie di universali di natura grammaticale in base ad un'indagine basata essenzialmente su osservazioni sintattiche. A tale scopo, uno dei suoi criteri è stato quello di esaminare l'ordine basico di soggetto, verbo (o predicato verbale) e oggetto (o complemento diretto) in frasi dichiarative con soggetto e oggetto nominali. Per spiegarci meglio, facciamo un esempio traducendo la frase il gatto (soggetto, S) ha mangiato (verbo, V) il topo (oggetto, O) in inglese, turco e arabo: inglese turco arabo the cat (S) ate (V) the mouse (O) kedi (S) fareyi (O) yedi (V) akala (V) l-qittu (S) l-fa ra (O) Mentre l'inglese ha un ordine SVO (come quello italiano), il turco ce l'ha SOV ("il gatto il topo ha mangiato") e l'arabo VSO ("ha mangiato il gatto il topo"). Comparando le varie lingue del mondo, Greenberg ha notato che quasi tutte hanno uno di questi tre ordini. Secondo lui gli ordini VOS, OVS e OSV sono rarissimi o addirittura inesistenti, ma studi successivi hanno stabilito che l'ordine VOS è presente in diverse lingue e anche gli altri due appaiono marginalmente. 1) SOV è l'ordine più frequente (curdo, persiano, hindi, bengali, ungherese, turco, giapponese, coreano, tibetano, tamil, quechua ecc.); 2) seguito da SVO (le lingue romanze, l'inglese e altre lingue germaniche, le lingue slave, il greco, il finlandese, l'ebraico moderno, il vietnamita, il swahili ecc.); 3) VSO (gaelico, gallese, arabo, ebraico classico, maori ecc.) 4) VOS (malgascio lingua nazionale del Madagascar e alcune lingue dell'america Centrale). Almeno i 2/3 delle lingue del mondo hanno un ordine basico con il soggetto di prima posizione, mentre almeno i 4/5 delle lingue del mondo hanno il soggetto prima dell'oggetto. L'ordine OVS è poco attestato (soprattutto in alcune lingue caraibiche), mentre infine quello OSV è rarissimo (frequenza dell'1%) se non addirittura inesistente. Al maestro Yoda, personaggio extraterrestre della Saga di Star Wars, fanno parlare una lingua inventata con ordine OSV, cioè il più raro e meno probabile. Perché gli ordini basici predominanti sono SOV e SVO? Innanzitutto perché, come abbiamo visto, normalmente il soggetto di una frase coincide con il tema; e il tema, nell'ordine informativo dei costituenti di una frase, sta normalmente in prima posizione: quindi prima abbiamo il tema (= ciò di cui si parla), poi il rema (= ciò che si dice a proposito del tema). Infatti, questi due ordini predominanti hanno il soggetto in prima posizione. Inoltre, collegati in parte con questa condizione base, abbiamo due principi: a. il "principio di precedenza", secondo il quale il soggetto, data la sua prominenza e priorità logica, deve precedere l'oggetto; b. il "principio di adiacenza", secondo il quale il verbo e l'oggetto devono essere contigui, per via della relazione sintattica e semantica che c'è tra loro e della dipendenza diretta dell'oggetto dal verbo (questo principio è più debole rispetto al precedente). Oltre al criterio dell'ordine basico, Greenberg prende in considerazione altri due criteri:
6 1) L'uso da parte di una lingua di preposizioni oppure posposizioni. P. es. in latino cum è normalmente una preposizione (cum amicis meis "con i miei amici"), ma con certi pronomi personali viene posposto (tecum "con te", nobiscum "con noi") diventando così una posposizione. In genere una lingua usa o preposizioni o posposizioni. 2) La posizione degli aggettivi qualificativi in rapporto al nome. P. es. nelle lingue germaniche l'aggettivo precede il nome, invece in quelle romanze lo segue (sempre che abbia valore qualificativo, come in uomo buono; nel caso di buon uomo l'aggettivo ha valore attributivo). Scegliendo una campionatura di trenta lingue 2 e combinando i tre criteri, Greenberg ha ottenuto la seguente tabella: SVO SOV VSO Pr-A+N Pr-N+A Po-A+N Po-N+A (Pr = uso di preposizioni, Po = uso di posposizioni, A + N = l'aggettivo precede il nome, N + A = il nome precede l'aggettivo). Dalla tabella risulta quindi che tra le lingue SVO dieci sono preposizionali (quattro con l'ordine aggettivo + nome, sei il contrario) e tre posposizionali (una con l'ordine aggettivo + nome, due il contrario). Più interessanti sono i dati riguardanti gli altri tipi: tutte le lingue SOV appaiono posposizionali, tutte quelle VSO preposizionali (e con ordine N + A) 3. Sulla base di tali risultanze Greenberg ha potuto formulare gli universali seguenti: Se una lingua ha un ordine prevalente del tipo VSO, allora essa ha sempre preposizioni. (sul Berruto il n. 18, pag. 245) Con una frequenza di gran lunga più che casuale, le lingue con l'ordine normale SOV sono posposizionali. Con frequenza di gran lunga più che casuale, le lingue con l'ordine dominante VSO hanno l'aggettivo dopo il nome. Con l'aggiunta di numerosi altri criteri (posizione del genitivo, delle particelle interrogative, dell'ausiliare ecc.), Greenberg arriva ad enunciare 45 universali, di cui 25 sono puramente sintattici, mentre gli altri prendono in considerazione anche aspetti 2 Sette europee (italiano, norvegese, finlandese, gallese, serbo, greco moderno, basco), sette africane (yoruba, nubico, swahili, fulani, masai, songhai, berbero), nove asiatiche (turco, ebraico, burushaski, hindi, kannada, giapponese, thailandese, birmano, malese), cinque americane (maya, zapoteco, quechua, chibcha, guarani), due dell'oceania (maori, loritja). Il basco e il burushaski (parlato nel Caracorum, regione del Kashmir) sono lingue isolate, non apparentate con alcuna famiglia nota. Di queste trenta lingue, tredici sono SVO (italiano, norvegese, finlandese, greco moderno, serbo, yoruba, fulani, swahili, songhai, thailandese, malese, maya, guarani), undici SOV (basco, nubico, turco, burushaski, hindi, kannada, giapponese, birmano, quechua, chibcha, loritja), sei VSO ( gallese, ebraico, masai, berbero, zapoteco, maori). 3 Va tuttavia detto che, al di fuori delle trenta lingue campione, ce n'è qualcuna SOV preposizionale (p. es. persiano e amarico) e qualcuna VSO con ordine A + N.
7 morfologici. Molti di questi universali sono implicazionali, assumono cioè la forma «dato x in una particolare lingua, si trova sempre y», p. es.: Se il pronome complemento oggetto (l'oggetto pronominale) segue il verbo, allora anche il nome complemento oggetto (l'oggetto nominale) segue il verbo. (n. 20, pag. 245) Se una lingua presenta flessione, essa presenta sempre derivazione. (n. 12) Se una lingua ha la categoria grammaticale del genere, allora ha sempre la categoria del numero. (n. 14) L'approccio tipologico di Greenberg è stato molto criticato, soprattutto da parte dei generativisti, anche se in modo ingeneroso. Lo studioso americano ha il merito di aver indagato e confrontato, in modo perspicace e preciso, un numero incredibile di lingue, ottenendo risultati indubbiamente rilevanti. La sua tipologia dell'ordine basico è ormai diventata un "classico" e le etichette SVO, SOV, VSO vengono usate comunemente da tutti. Nonostante la tipologia sintattica sia ancora relativamente giovane rispetto a quella morfologica, che ha due secoli di storia alle spalle, è prevedibile che essa verrà sempre più utilizzata, anche nel campo della linguistica diacronica 4. 4 P. es. non mancano recenti studi sull'ordine basico (probabilmente SOV) dell'indoeuropeo ricostruito.
3. La classificazione tipologica
 3. La classificazione tipologica Due lingue sono tipologicamente correlate se manifestano una o più caratteristiche comuni questa correlazione è indipendente dal fatto che tali lingue siano apparentate
3. La classificazione tipologica Due lingue sono tipologicamente correlate se manifestano una o più caratteristiche comuni questa correlazione è indipendente dal fatto che tali lingue siano apparentate
Linguistica Generale (cod ), Modulo 1 Esame scritto del 12 settembre SOLUZIONI - Gruppo A
 Linguistica Generale (cod. 24169), Modulo 1 Esame scritto del 12 settembre 2019 - SOLUZIONI - Gruppo A 01A A quale dei seguenti studiosi si deve l elaborazione di un modello di classificazione delle funzioni
Linguistica Generale (cod. 24169), Modulo 1 Esame scritto del 12 settembre 2019 - SOLUZIONI - Gruppo A 01A A quale dei seguenti studiosi si deve l elaborazione di un modello di classificazione delle funzioni
La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico)
 La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo sono
La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo sono
3. La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico)
 3. La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo
3. La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo
Cenni di tipologia morfologica
 Linguistica Generale (cod. 24169), Modulo 1 - a.a. 2017-18 Materiale 3 Prof.ssa Federica Guerini Cenni di tipologia morfologica (1) Tipo morfologico nozione tradizionale elaborata nell 800; le lingue variano
Linguistica Generale (cod. 24169), Modulo 1 - a.a. 2017-18 Materiale 3 Prof.ssa Federica Guerini Cenni di tipologia morfologica (1) Tipo morfologico nozione tradizionale elaborata nell 800; le lingue variano
La tipologia sintattica
 La tipologia sintattica 1. La frase indipendente dichiarativa assertiva: l ordine di soggetto, verbo e oggetto 1) Parametri di indagine: a) posizione del soggetto (S) b) posizione dell oggetto diretto
La tipologia sintattica 1. La frase indipendente dichiarativa assertiva: l ordine di soggetto, verbo e oggetto 1) Parametri di indagine: a) posizione del soggetto (S) b) posizione dell oggetto diretto
Il latino pompeiano: quando la diacronia spiega la sincronia
 Il latino pompeiano: quando la diacronia spiega la sincronia P. Ramat (1984): L importanza di un esame delle iscrizioni pompeiane dal punto di vista linguistico è evidente: abbiamo a che fare con uno dei
Il latino pompeiano: quando la diacronia spiega la sincronia P. Ramat (1984): L importanza di un esame delle iscrizioni pompeiane dal punto di vista linguistico è evidente: abbiamo a che fare con uno dei
La tipologia linguistica
 Linguistica antropologica cod. 13151- a.a. 2014/2015 Mat. 6 La tipologia linguistica A. Introduzione (1) Classificazione delle lingue del mondo: le lingue del mondo possono essere classificate secondo
Linguistica antropologica cod. 13151- a.a. 2014/2015 Mat. 6 La tipologia linguistica A. Introduzione (1) Classificazione delle lingue del mondo: le lingue del mondo possono essere classificate secondo
Linguistica generale. a.a Federica Da Milano
 Linguistica generale a.a. 2014-2015 Federica Da Milano Le lingue afro-asiatiche (o camitosemitiche) Parlate da oltre 400 milioni di persone Territorio che va dalla Mesopotamia fino alla sponda africana
Linguistica generale a.a. 2014-2015 Federica Da Milano Le lingue afro-asiatiche (o camitosemitiche) Parlate da oltre 400 milioni di persone Territorio che va dalla Mesopotamia fino alla sponda africana
La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico)
 La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo sono
La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo sono
Area linguistica (o Sprachbund):
 Area linguistica (o Sprachbund): regione geografica in cui alcuni tratti linguistici si sono propagati a seguito di una profonda contaminazione interlinguistica, cioè a seguito del contatto tra le lingue
Area linguistica (o Sprachbund): regione geografica in cui alcuni tratti linguistici si sono propagati a seguito di una profonda contaminazione interlinguistica, cioè a seguito del contatto tra le lingue
La tipologia e gli universali
 La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
TIPOLOGIA LINGUISTICA
 TIPOLOGIA LINGUISTICA Introduzione: variazione interlinguistica ed metodi di indagine della tipologia linguistica La nozione di TIPO LINGUISTICO Risorse Introduzione Lezione basata su: N. Grandi [2003].
TIPOLOGIA LINGUISTICA Introduzione: variazione interlinguistica ed metodi di indagine della tipologia linguistica La nozione di TIPO LINGUISTICO Risorse Introduzione Lezione basata su: N. Grandi [2003].
La tipologia e gli universali
 La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME. Competenze specifiche Abilità Conoscenze ABILITÀ MORFO-SINTATTICHE
 OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE
 INDICE Premessa... XIII Abbreviazioni... XV INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE 1. Le lingue germaniche... 3 1.1 Le lingue germaniche moderne... 3 1.2 Le lingue germaniche antiche e la loro
INDICE Premessa... XIII Abbreviazioni... XV INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE 1. Le lingue germaniche... 3 1.1 Le lingue germaniche moderne... 3 1.2 Le lingue germaniche antiche e la loro
Anno Accademico 2017/2018
 Anno Accademico 2017/2018 LINGUISTICA GENERALE Anno immatricolazione 2017/2018 Anno offerta 2017/2018 Normativa Dipartimento Corso di studio Curriculum DM270 DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI LINGUE E CULTURE
Anno Accademico 2017/2018 LINGUISTICA GENERALE Anno immatricolazione 2017/2018 Anno offerta 2017/2018 Normativa Dipartimento Corso di studio Curriculum DM270 DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI LINGUE E CULTURE
LATINE DISCO ET LUDO CORSO di AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA LATINA PROGRAMMA
 LATINE DISCO ET LUDO CORSO di AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA LATINA PROGRAMMA 1^ Argomenti il latino che parliamo : - parole latine di uso quotidiano e modi di dire; -parole italiane
LATINE DISCO ET LUDO CORSO di AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA LATINA PROGRAMMA 1^ Argomenti il latino che parliamo : - parole latine di uso quotidiano e modi di dire; -parole italiane
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MANDRALISCA LICEO GINNASIO STATALE
 REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MANDRALISCA LICEO GINNASIO STATALE e I.P.S.S.E.O.A. - CEFALU Via Maestro Vincenzo Pintorno 27 - e-mail: [email protected]
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MANDRALISCA LICEO GINNASIO STATALE e I.P.S.S.E.O.A. - CEFALU Via Maestro Vincenzo Pintorno 27 - e-mail: [email protected]
LE PARTI DEL DISCORSO =
 LATINO LEZIONE 1 LE PARTI DEL DISCORSO = LE CATEGORIE IN CUI SONO RAGGRUPPATE LE PAROLE DI UNA LINGUA SULLA BASE DI CARATTERISTICHE COMUNI (forma, funzione, posizione nella frase, significato ecc.) Confrontiamo
LATINO LEZIONE 1 LE PARTI DEL DISCORSO = LE CATEGORIE IN CUI SONO RAGGRUPPATE LE PAROLE DI UNA LINGUA SULLA BASE DI CARATTERISTICHE COMUNI (forma, funzione, posizione nella frase, significato ecc.) Confrontiamo
1) Quali sono le due componenti del segno linguistico?
 1) Quali sono le due componenti del segno linguistico? 2) Trascrivere in IPA secondo la propria varietà di italiano regionale, le seguenti parole: incrocio, stazione, sbadiglio, praticamente 3) Indicare
1) Quali sono le due componenti del segno linguistico? 2) Trascrivere in IPA secondo la propria varietà di italiano regionale, le seguenti parole: incrocio, stazione, sbadiglio, praticamente 3) Indicare
PIANO DI LAVORO ANNUALE
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA Via Ada Negri, 14 10024 MONCALIERI (TO) Codice fiscale 84511990016 Sezione Liceale E.Majorana Sezione Tecnico Economica Scientifico - Linguistico A.Marro Via Ada
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA Via Ada Negri, 14 10024 MONCALIERI (TO) Codice fiscale 84511990016 Sezione Liceale E.Majorana Sezione Tecnico Economica Scientifico - Linguistico A.Marro Via Ada
DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013
 ISIS VINCENZO MANZINI PIANO DI LAVORO ANNUALE CLASSE : 1 A LL DISCIPLINA : LATINO DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013 Situazione della classe. La classe 1^ALL è formata da 22 allievi,
ISIS VINCENZO MANZINI PIANO DI LAVORO ANNUALE CLASSE : 1 A LL DISCIPLINA : LATINO DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013 Situazione della classe. La classe 1^ALL è formata da 22 allievi,
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA
 CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA Conoscere l ordine alfabetico; Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico; Riconoscere e isolare le vocali nelle parole che le contengono; Riconoscere
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA Conoscere l ordine alfabetico; Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico; Riconoscere e isolare le vocali nelle parole che le contengono; Riconoscere
LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE
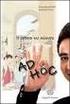 Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
2 LE PARTI DEL DISCORSO Le nove parti del discorso Caratteristiche delle parti del discorso 48 ESERCIZI 50 INDICE
 1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
Fonologia e ortografia
 Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
La padronanza linguistica, Academia Universa Press 2011 PARTE PRIMA FARE GRAMMATICA 1. INSEGNARE ANCORA LA GRAMMATICA?
 La padronanza linguistica, Academia Universa Press 2011 PARTE PRIMA FARE GRAMMATICA 1. INSEGNARE ANCORA LA GRAMMATICA? 2. LA TRADIZIONE Analisi grammaticale Analisi logica Analisi del periodo Analisi testuale
La padronanza linguistica, Academia Universa Press 2011 PARTE PRIMA FARE GRAMMATICA 1. INSEGNARE ANCORA LA GRAMMATICA? 2. LA TRADIZIONE Analisi grammaticale Analisi logica Analisi del periodo Analisi testuale
Linguistica Generale prof. dr. Giorgio Francesco Arcodia MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO
 Linguistica Generale prof. dr. Giorgio Francesco Arcodia MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO 1) Definire ed illustrare con esempi la nozione di ricorsività : 2) Identificare e descrivere i morfemi contenuti
Linguistica Generale prof. dr. Giorgio Francesco Arcodia MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO 1) Definire ed illustrare con esempi la nozione di ricorsività : 2) Identificare e descrivere i morfemi contenuti
Linguistica generale. a.a Federica Da Milano
 Linguistica generale a.a.2014-2015 Federica Da Milano La sintassi: frasi e enunciati La frase intesa come modulo di un testo è chiamata enunciato, per differenziarla dalla frase intesa come costruzione
Linguistica generale a.a.2014-2015 Federica Da Milano La sintassi: frasi e enunciati La frase intesa come modulo di un testo è chiamata enunciato, per differenziarla dalla frase intesa come costruzione
Scritture sillabiche scritture alfabetiche
 LA SCRITTURA I 1. Sistema di segni grafici (grafemi) che trasmette attraverso il canale visivo dei significati convenzionali. 2. La scrittura nasce molto dopo la comparsa del linguaggio verbale ( che ha
LA SCRITTURA I 1. Sistema di segni grafici (grafemi) che trasmette attraverso il canale visivo dei significati convenzionali. 2. La scrittura nasce molto dopo la comparsa del linguaggio verbale ( che ha
GLI UNIVERSALI LINGUISTICI
 GLI UNIVERSALI LINGUISTICI Universali assoluti: sanciscono la presenza (o l assenza) di una particolare proprietà in ogni lingua storico-naturale, senza fare riferimento ad alcun altro parametro e senza
GLI UNIVERSALI LINGUISTICI Universali assoluti: sanciscono la presenza (o l assenza) di una particolare proprietà in ogni lingua storico-naturale, senza fare riferimento ad alcun altro parametro e senza
Indice. Introduzione. Unità I. Unità 2. Unità Unità Unità Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica
 Indice Introduzione Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica Unità I 1.1. I1 latino lingua indoeuropea / 1.2. Le fasi della lingua latina / 11.1. L alfabeto latino / 11.2. La pronuncia del
Indice Introduzione Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica Unità I 1.1. I1 latino lingua indoeuropea / 1.2. Le fasi della lingua latina / 11.1. L alfabeto latino / 11.2. La pronuncia del
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO AREE DA SVILUPPARE. Riflettere sulla lingua
 1 CONTENUTI, ATTIVITÁ COMPETENZE IN USCITA Riflettere sulla lingua 1. Consolidare le principali convenzioni ortografiche. 2. Approfondire la conoscenza di: - articolo (partitivo) - nome (classificazione
1 CONTENUTI, ATTIVITÁ COMPETENZE IN USCITA Riflettere sulla lingua 1. Consolidare le principali convenzioni ortografiche. 2. Approfondire la conoscenza di: - articolo (partitivo) - nome (classificazione
Corso di cinese Lezione 3
 Corso di cinese Lezione 3 [email protected] November 20, 2002 1 I numeri líng zero yī uno èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ shí due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci Il numero due si pronuncia èr
Corso di cinese Lezione 3 [email protected] November 20, 2002 1 I numeri líng zero yī uno èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ shí due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci Il numero due si pronuncia èr
Il codice linguistico
 Laboratorio Linguistico Il Testo narrativo Il codice linguistico www.nicolanapolitano.altervista.org App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM Le funzioni e la
Laboratorio Linguistico Il Testo narrativo Il codice linguistico www.nicolanapolitano.altervista.org App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM Le funzioni e la
SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE. Anno scolastico
 SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Anno scolastico 2017-2018 Istituto Docente Materia Classe GESU - MARIA ROLLETTA CHIARA LATINO I LICEO CLASSICO Numero di studenti 3 1. COMPETENZE IN USCITA 1. L alunno
SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Anno scolastico 2017-2018 Istituto Docente Materia Classe GESU - MARIA ROLLETTA CHIARA LATINO I LICEO CLASSICO Numero di studenti 3 1. COMPETENZE IN USCITA 1. L alunno
PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO. Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto. Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia
 PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO Docenti Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto Insegnamento LINGUISTICA GENERALE Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia 1.1. Alfabeti e corrispondenza biunivoca;
PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO Docenti Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto Insegnamento LINGUISTICA GENERALE Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia 1.1. Alfabeti e corrispondenza biunivoca;
LINGUA E CULTURA GRECA PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV B ANNO SCOLASTICO
 LINGUA E CULTURA GRECA PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV B ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Libro di testo: P. Agazzi, M. Villardo Ellenistì, Corso di lingua e cultura greca, Manuale ed Esercizi vol.1, Zanichelli 2014,
LINGUA E CULTURA GRECA PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV B ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Libro di testo: P. Agazzi, M. Villardo Ellenistì, Corso di lingua e cultura greca, Manuale ed Esercizi vol.1, Zanichelli 2014,
OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, LATINO E GRECO AL GINNASIO
 DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, LATINO E GRECO AL GINNASIO ITALIANO CLASSE IV GINNASIALE 1. Leggere un testo in modo corretto ed espressivo. 2. Comprendere il senso globale di un testo narrativo poetico.
DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, LATINO E GRECO AL GINNASIO ITALIANO CLASSE IV GINNASIALE 1. Leggere un testo in modo corretto ed espressivo. 2. Comprendere il senso globale di un testo narrativo poetico.
5 Motivazioni funzionali
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 5 Motivazioni funzionali [Materiale di riferimento per questa parte: Croft 1990: capp. 3 (traduzione italiana in Cristofaro and Ramat 1999: cap.1) e 4; Cristofaro
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 5 Motivazioni funzionali [Materiale di riferimento per questa parte: Croft 1990: capp. 3 (traduzione italiana in Cristofaro and Ramat 1999: cap.1) e 4; Cristofaro
AppuntiBicoccaAppuntiBicoccaAppu ntibicoccaappuntibicoccaappuntibic occaappuntibicoccaappuntibicoccaa ppuntibicoccaappuntibicoccaappunt
 AppuntiBicoccaAppuntiBicoccaAppu ntibicoccaappuntibicoccaappuntibic occaappuntibicoccaappuntibicoccaa ppuntibicoccaappuntibicoccaappunt Struttura delle parole ibicoccaappuntibicoccaappuntibicoc Riassunto
AppuntiBicoccaAppuntiBicoccaAppu ntibicoccaappuntibicoccaappuntibic occaappuntibicoccaappuntibicoccaa ppuntibicoccaappuntibicoccaappunt Struttura delle parole ibicoccaappuntibicoccaappuntibicoc Riassunto
QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009
 QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009 RIFERIMENTI NORMATIVI INDICAZIONI NAZIONALI 2003 (OSA) L. n 53/2003 e D. Lgs 59/2004 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO 2007 QUADRO DI RIFERIMENTO
QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009 RIFERIMENTI NORMATIVI INDICAZIONI NAZIONALI 2003 (OSA) L. n 53/2003 e D. Lgs 59/2004 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO 2007 QUADRO DI RIFERIMENTO
GLOTTOLOGIA Giacomo Ferrari
 GLOTTOLOGIA Giacomo Ferrari [email protected] Unità 1: Delimitazione del dominio scientifico GLOTTOLOGIA Il termine Glottologia è stato creato circa un secolo e mezzo fa come pseudo-derivato dal greco
GLOTTOLOGIA Giacomo Ferrari [email protected] Unità 1: Delimitazione del dominio scientifico GLOTTOLOGIA Il termine Glottologia è stato creato circa un secolo e mezzo fa come pseudo-derivato dal greco
Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente, beneficiario, strumento, ecc.
 Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
014 5 Pragmatica Lingue per scopi speciali. [014 8] Abbreviazioni e simboli Filosofia e teoria
![014 5 Pragmatica Lingue per scopi speciali. [014 8] Abbreviazioni e simboli Filosofia e teoria 014 5 Pragmatica Lingue per scopi speciali. [014 8] Abbreviazioni e simboli Filosofia e teoria](/thumbs/54/33772292.jpg) T4 T4 014 301 Filosofia e teoria 014 301 8 Scuole, teorie, metodologie 014 301 82 Linguistica formale Notazione 01 dalla Tavola 1 come di seguito modificata Da non usare per scuole e teorie semantiche;
T4 T4 014 301 Filosofia e teoria 014 301 8 Scuole, teorie, metodologie 014 301 82 Linguistica formale Notazione 01 dalla Tavola 1 come di seguito modificata Da non usare per scuole e teorie semantiche;
1 PARTE I - IL PERIMETRO DELLA GRAMMATICA: LA LINGUA NELLA COMUNICA- ZIONE
 Indice generale XI XV XIX XX XXIII XXV XXVII XXVHI XXX Indice dei box e delle tabelle notevoli Introduzione Premessa. La grammatica: regole e scelte, strutture e funzioni 1. Regole e scelte 2. Strutture
Indice generale XI XV XIX XX XXIII XXV XXVII XXVHI XXX Indice dei box e delle tabelle notevoli Introduzione Premessa. La grammatica: regole e scelte, strutture e funzioni 1. Regole e scelte 2. Strutture
La classificazione tipologica prevede il raggruppamento delle lingue in base a somiglianze (e divergenze) strutturali
 Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2013 / 2014 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia ([email protected]) 1. La classificazione tipologica delle lingue La
Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2013 / 2014 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia ([email protected]) 1. La classificazione tipologica delle lingue La
2 PAGINA. 1 Il greco lingua flessiva. Radice, tema, desinenza 44 2 La flessione dei nomi. Le declinazioni. I casi e le loro funzioni 47 1 PAGINA
 I AVVERTENZA PAGINA III 0 PAGINA 1 1 PAGINA 15 1 L alfabeto greco 17 2 Spiriti, accenti e altri segni diacritici. I segni d interpunzione 21 3 Le vocali e i dittonghi 25 4 Le consonanti 27 5 L accento
I AVVERTENZA PAGINA III 0 PAGINA 1 1 PAGINA 15 1 L alfabeto greco 17 2 Spiriti, accenti e altri segni diacritici. I segni d interpunzione 21 3 Le vocali e i dittonghi 25 4 Le consonanti 27 5 L accento
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 2LC (V Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Periodo 1 Ripasso del programma svolto
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 2LC (V Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Periodo 1 Ripasso del programma svolto
TIPOLOGIA E SINTASSI: LA FRASE DICHIARATIVA l'ordine dei costituenti nella frase indipendente dichiarativa assertiva
 TIPOLOGIA E SINTASSI: LA FRASE DICHIARATIVA l'ordine dei costituenti nella frase indipendente dichiarativa assertiva 1. Parametri di indagine: a) posizione del soggetto (S) b) posizione dell oggetto diretto
TIPOLOGIA E SINTASSI: LA FRASE DICHIARATIVA l'ordine dei costituenti nella frase indipendente dichiarativa assertiva 1. Parametri di indagine: a) posizione del soggetto (S) b) posizione dell oggetto diretto
Apprendimento delle lingue seconde: percorsi, strategie, abilità (Didattica delle lingue moderne, OCI 1)
 Apprendimento delle lingue seconde: percorsi, strategie, abilità (Didattica delle lingue moderne, OCI 1) Anno accademico 2018/19 Prof. Elena Nuzzo La messa in grammatica del lessico Fase successiva > inizia
Apprendimento delle lingue seconde: percorsi, strategie, abilità (Didattica delle lingue moderne, OCI 1) Anno accademico 2018/19 Prof. Elena Nuzzo La messa in grammatica del lessico Fase successiva > inizia
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica. La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio. L articolo
 Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
La Morfologia. L aggettivo
 La Morfologia L aggettivo L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Esso concorda in genere e numero con il
La Morfologia L aggettivo L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Esso concorda in genere e numero con il
La Morfologia. L aggettivo. Pag. 164 CLASSE II C
 La Morfologia L aggettivo Pag. 164 CLASSE II C 2016-2017 L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Gli aggettivi
La Morfologia L aggettivo Pag. 164 CLASSE II C 2016-2017 L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Gli aggettivi
ISTITUTO DI ISTRUZIONE LORENZO GUETTI. Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna. Classe 1 SM PROGRAMMA DI LATINO
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE LORENZO GUETTI Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna Classe 1 SM PROGRAMMA DI LATINO Anno scolastico 2018/2019 Prof. Romeo Collini CONTENUTI INTRODUZIONE Parti
ISTITUTO DI ISTRUZIONE LORENZO GUETTI Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna Classe 1 SM PROGRAMMA DI LATINO Anno scolastico 2018/2019 Prof. Romeo Collini CONTENUTI INTRODUZIONE Parti
DIPARTIMENTO LETTERE CLASSICO LINGUISTICO DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico)
 Educazione linguistica: Educazione letteraria: Produzione scritta: DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico) morfologia: il verbo. Sintassi: gli elementi fondamentali di analisi della proposizione.
Educazione linguistica: Educazione letteraria: Produzione scritta: DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico) morfologia: il verbo. Sintassi: gli elementi fondamentali di analisi della proposizione.
Sociolinguistica A2 A.A.2005/06 ADA VALENTINI ESERCITAZIONI SULLE NOZIONI DI BASE Semantica, sintassi, tipologia, pragmatica
 Sociolinguistica A2 A.A.2005/06 ADA VALENTINI ESERCITAZIONI SULLE NOZIONI DI BASE Semantica, sintassi, tipologia, pragmatica 1. Dite quali rapporti semantici intercorrono tra le parole dei seguenti gruppi.
Sociolinguistica A2 A.A.2005/06 ADA VALENTINI ESERCITAZIONI SULLE NOZIONI DI BASE Semantica, sintassi, tipologia, pragmatica 1. Dite quali rapporti semantici intercorrono tra le parole dei seguenti gruppi.
Che cos è la linguistica?
 Che cos è la linguistica? Linguistica: scienza che studia il linguaggio e le lingue Linguaggio: insieme dei fenomeni di comunicazione e di espressione che si manifestano sia nel mondo umano sia al di fuori
Che cos è la linguistica? Linguistica: scienza che studia il linguaggio e le lingue Linguaggio: insieme dei fenomeni di comunicazione e di espressione che si manifestano sia nel mondo umano sia al di fuori
Cap. 4 Berruto / Cerruti LA SINTASSI. Linguistica generale ( ) - Chiari Pagina 1
 Cap. 4 Berruto / Cerruti LA SINTASSI Linguistica generale (2012-13) - Chiari Pagina 1 Sintassi l l È il livello di analisi che si occupa della struttura della frasi Il suo oggetto di studio è come si combinano
Cap. 4 Berruto / Cerruti LA SINTASSI Linguistica generale (2012-13) - Chiari Pagina 1 Sintassi l l È il livello di analisi che si occupa della struttura della frasi Il suo oggetto di studio è come si combinano
Indice generale. L organizzazione della frase PARTE I. 1 Che cos è la frase 12 Frasi senza verbo 13
 PARTE I L organizzazione della frase CAPITOLO 1 La frase 12 1 Che cos è la frase 12 Frasi senza verbo 13 Proviamo insieme 13 2 La frase come struttura predicativa 14 La frase minima 15 La frase semplice
PARTE I L organizzazione della frase CAPITOLO 1 La frase 12 1 Che cos è la frase 12 Frasi senza verbo 13 Proviamo insieme 13 2 La frase come struttura predicativa 14 La frase minima 15 La frase semplice
Introduzione, di Anna Giacalone Ramat e Paolo Ramat. I. Antichità indoeuropee, di Enrico Campanile. 11. I1 proto-indoeuropeo, di Culvert Watkins
 Introduzione, di Anna Giacalone Ramat e Paolo Ramat I. Antichità indoeuropee, di Enrico Campanile i. La ricostruzione della cultura degli Indoeuropei i. i. I1 metodo lessicalistico 1.2. I1 metodo testuale
Introduzione, di Anna Giacalone Ramat e Paolo Ramat I. Antichità indoeuropee, di Enrico Campanile i. La ricostruzione della cultura degli Indoeuropei i. i. I1 metodo lessicalistico 1.2. I1 metodo testuale
ISTITUTO: Liceo Classico CLASSE: I MATERIA: Italiano
 ISTITUTO: Liceo Classico CLASSE: I MATERIA: Italiano Modulo n 1 La comunicazione e il testo U.D. 1 La lingua: uno strumento per comunicare - La lingua e le lingue: varietà dell italiano; - La comunicazione
ISTITUTO: Liceo Classico CLASSE: I MATERIA: Italiano Modulo n 1 La comunicazione e il testo U.D. 1 La lingua: uno strumento per comunicare - La lingua e le lingue: varietà dell italiano; - La comunicazione
VIII. Indice. Unità 2 La semantica 20
 Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
AMICI SEMPRE IN ACCORDO NOME, ARTICOLO E AGGETTIVO
 AMICI SEMPRE IN ACCORDO NOME, ARTICOLO E AGGETTIVO Parte prima ISC "BETTI" FERMO PROGETTO PON INCLUSIONE Modulo 6 Miglioramento delle competenze di base di lingua e grammatica italiana Esperto prof.ssa
AMICI SEMPRE IN ACCORDO NOME, ARTICOLO E AGGETTIVO Parte prima ISC "BETTI" FERMO PROGETTO PON INCLUSIONE Modulo 6 Miglioramento delle competenze di base di lingua e grammatica italiana Esperto prof.ssa
1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare. 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare
 1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare 3 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: leggere 4 Modulo operativo: Le abilità linguistiche:
1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare 3 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: leggere 4 Modulo operativo: Le abilità linguistiche:
INDICE GENERALE Capitolo 1 - preliminari... 3 Capitolo 2 - Morfologia: preliminari... 12
 INDICE GENERALE Capitolo 1 - Preliminari... 3 1. L alfabeto latino...3 2. La pronunzia del latino...4 3. Vocali e semivocali...5 4. Dittonghi...6 5. La dieresi...7 6. L apofonia...7 7. Consonanti...7 8.
INDICE GENERALE Capitolo 1 - Preliminari... 3 1. L alfabeto latino...3 2. La pronunzia del latino...4 3. Vocali e semivocali...5 4. Dittonghi...6 5. La dieresi...7 6. L apofonia...7 7. Consonanti...7 8.
