Come è cambiata la gestione dell anemia per i pazienti in dialisi alla luce dello studio DOPPS
|
|
|
- Giorgio Pucci
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Studi DOPPS - Il punto di vista del Medico 27 Come è cambiata la gestione dell anemia per i pazienti in dialisi alla luce dello studio DOPPS A. Cavalli, G. Pontoriero SC Nefrologia e Dialisi, Ospedale Alessandro Manzoni, Lecco Introduzione La gestione dell anemia secondaria alla malattia renale cronica (Chronic Kidney Disease, o più brevemente CKD) è un aspetto che richiede la massima attenzione da parte del Nefrologo, rappresentando un abituale e grave complicanza della CKD la cui frequenza aumenta con il progressivo deteriorarsi della funzione renale. Di conseguenza, una larga percentuale di pazienti giunge ad iniziare il trattamento dialitico in uno stato di franca anemizzazione. Un certo grado di anemia, tuttavia, può instaurarsi precocemente nel corso dello sviluppo della CKD, specialmente in alcune categorie di pazienti, come i diabetici (1). La gestione dell anemia nei pazienti nefropatici ha subito una vera e propria rivoluzione nel corso degli ultimi venti anni, dopo l introduzione, nel 1989, della terapia con eritropoietina ricombinante umana che ha drasticamente ridotto la necessità di ricorrere a periodiche trasfusioni di sangue per evitare livelli di ematocrito eccessivamente bassi (2). Un corretto approccio alla terapia dell anemia associata alla malattia renale cronica è di fondamentale importanza per prevenire il rischio cardiovascolare nei pazienti nefropatici. Lo stato anemico, infatti, esercita la sua azione negativa sulla funzione cardiaca promuovendo lo sviluppo di una ipertrofia compensatoria del ventricolo sinistro che rappresenta un importante fattore di rischio di morbilità e mortalità cardiovascolare (3, 4). Nel corso degli ultimi anni sono state sviluppate varie linee guida internazionali per aiutare il medico ad ottimizzare e uniformare la gestione dell anemia nel paziente con CKD. Tra esse, le più note e diffuse sono le linee guida della National Kidney Foundation s Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) e le European Best Practice Guidelines (EBPG) dell ERA-EDTA (European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association) pubblicate, rispettivamente, negli Stati Uniti e in Europa (5, 6). Il DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study) è uno studio internazionale, prospettico e osservazionale, iniziato nel 1996, che raccoglie i dati di un vasto campione di pazienti emodializzati selezionati con procedura casuale (7). Il DOPPS è stato sviluppato per fornire informazioni riguardanti le pratiche correnti attinenti la gestione di molte problematiche emodialitiche, tra cui anche la gestione e il trattamento dell anemia. Lo studio si è sviluppato attraverso tre fasi successive di raccolta longitudinale di dati: mentre nel DOPPS I ( ) sono stati raccolti dati dai Centri dialisi di Francia, Germania, Italia, Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti e Giappone, nel DOPPS II ( ) e III ( ) il campione dello studio è stato allargato fino a comprendere anche Centri dialisi di Belgio, Canada, Svezia, Australia e Nuova Zelanda. Fornendo risultati derivati da una popolazione molto vasta di pazienti emodializzati, il DOPPS ha permesso di valutare come l introduzione di linee guida internazionali abbia significativamente cambiato la gestione dell anemia di origine renale nel corso degli anni. Il DOPPS rappresenta l esempio classico di come studi osservazionali ben disegnati, in accordo a criteri metodologici chiari e specifici, possano permettere di ottenere delle informazioni di buona qualità nell ambito della pratica clinica quotidiana (8). In questa rassegna riportiamo gli aspetti più interessanti che l analisi di questo studio ha fornito sul trattamento e la gestione dell anemia nei pazienti emodializzati.
2 28 Wichtig Editore 2010 Livelli di emoglobina e terapia con eritropoietina Nel corso delle tre fasi del DOPPS è emerso un aumento significativo della concentrazione media di emoglobina nei pazienti emodializzati, pur in presenza di sensibili differenze tra i diversi Paesi coinvolti nello studio (9). Infatti, nel DOPPS I il valore medio di emoglobina (Hb) era compreso tra 9,7 e 11,4 g/dl (dati rispettivamente di Giappone e Stati Uniti); nel DOPPS II i livelli di Hb erano compresi tra 10,1 (in Giappone) e 12 g/dl (in Svezia), nel DOPPS III si è, infine, registrata una ulteriore tendenza verso l alto della correzione dell anemia (range della Hb 10,5-12 g/dl), con l eccezione della Svezia, che aveva livelli di Hb più alti nel DOPPS II, rispetto al DOPPS III (9). Anche la percentuale di pazienti con emoglobina superiore o uguale a 12 g/dl (limite superiore del target di emoglobina attualmente raccomandato dalle linee guida internazionali)(10) è andata progressivamente crescendo nel corso degli anni nella maggior parte dei paesi DOPPS, superando anche il 50% in Belgio, Spagna, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda (9). È importante sottolineare come i dati sopra riportati si riferiscano a pazienti emodializzati prevalenti, cioè stabili in trattamento dialitico, perché il valore medio di emoglobina nei pazienti emodializzati incidenti, cioè all inizio del trattamento dialitico, è sempre sensibilmente più basso, anche di 2 g/dl, rispetto a pazienti già da tempo stabilizzati in trattamento emodialitico (8). Nel corso dei primi mesi dopo l inizio della dialisi, infatti, si verifica un aumento significativo dei valori di emoglobina oltre che della percentuale di utilizzo di eritropoietina ma sono necessari vari mesi per raggiungere un grado di correzione dell anemia pari a quanto raccomandato nelle linee guida(8). Parallelamente all incremento dei valori medi di emoglobina è stato registrato un significativo incremento della dose media di agenti stimolanti l eritropoiesi (ESA) in quasi tutti i Paesi DOPPS, anche dopo aver tenuto conto dei principali fattori che possono agire sull eritropoiesi (Fig. 1) (9). L entità di aumento nella dose di ESA tra il DOPPS I e il III variava tra il 9,6% del Giappone e il 106,6% della Francia, mentre il primato in termini di dosaggio medio di eritropoietina e di pazienti trattati con elevate dosi di eritropoietina è sempre stato appannaggio degli Stati Uniti (9), probabilmente in virtù delle peculiari caratteristiche cliniche e dialitiche (alta percentuale di soggetti con diabete mellito, comorbidità cardio-vascolare ed elevato numero di pazienti con protesi vascolare come accesso emodialitico) tipiche della popolazione americana (Tab. I). Quello che emerge chiaramente dall analisi dei dati DOPPS è un associazione diretta tra dosaggi di ESA e valori medi di emoglobina. Una valutazione di qualche anno fa ha messo in evidenza come le principali caratteristiche dei pazienti che richiedevano più elevati dosaggi di ESA erano: bassi valori di saturazione della transferrina e di albuminemia, elevato peso corporeo, giovane età, sesso femminile, presenza di comorbilità (cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco cronico, altre patologie cardiovascolari, disturbi psichiatrici, dispnea, patologia renale diversa dalla malattia policistica, sanguinamento gastroenterico nell anno precedente), utilizzo di un catetere quale accesso vascolare dialitico, bassi valori di emoglobina e somministrazione endovenosa dell ESA (11). Di rilievo è inoltre Fig. 1 - Dose media di ESA (unità di eritropoietina per via endovenosa alla settimana) e livelli di emoglobina nei diversi Paesi partecipanti a DOPPS I, II e III.
3 29 Tabella I - Cambiamenti percentuali ed assoluti nel dosaggio medio di ESA nei diversi stati partecipanti al DOPPS I, II e III il fatto che i pazienti giapponesi presentino costantemente livelli di emoglobina inferiori rispetto agli altri soggetti partecipanti al DOPPS e ricevano una dose media di ESA inferiore. Questo riscontro è in parte giustificabile dalle ridotte dimensioni corporee dei pazienti orientali e dalla minor severità dei fattori di comorbilità associati alla CKD con conseguente minore resistenza all eritropoietina e, quindi, la necessità di più basse dosi di ESA. Tuttavia, i più bassi livelli di emoglobina del Giappone riflettono anche le indicazioni delle linee guida locali che raccomandano un target di emoglobina più basso rispetto a quanto consigliato dalle linee guida occidentali e altri aspetti di tecnica di prelievo e di politica di rimborso dell eritropoietina (12). Anemia e terapia marziale Nei pazienti con CKD, la terapia marziale non solo corregge la carenza di un fondamentale microelemento catalitico dell organismo, ma soprattutto rappresenta un indispensabile adiuvante alla terapia con eritropoietina per raggiungere e mantenere i livelli di emoglobina stabili e in target (13). Dopo la pubblicazione dei risultati dello studio TREAT (Trial to Reduce Cardiovascular Events with Aranesp Therapy) (14), che ha messo in luce alcuni aspetti critici della terapia con ESA in corso di malattia renale cronica, la somministrazione integrata di ferro ed ESA è diventata un elemento cardine per l ottimizzazione della correzione dell anemia secondaria alla insufficienza renale elevando la supplementazione marziale a ruolo di fondamentale rilievo. Secondo i dati DOPPS del 2004, la percentuale di pa- zienti emodializzati prevalenti in terapia con ferro per via endovenosa era molto eterogenea nei vari Paesi, variando tra il 38% del Giappone e l 89% del Belgio (10). Tuttavia, anche nei Paesi in cui vi era un elevata percentuale di pazienti con supplementazione marziale endovena, una percentuale consistente di soggetti (31-38%) continuava a presentare valori di saturazione della transferrina inferiore al 20% e, quindi, indicativi di carenza marziale, secondo le linee guida K/DOQI e le EBPG. Non è stata individuata una significativa associazione dei valori di saturazione della transferrina né con la percentuale di pazienti che ricevevano ferro endovena né con il numero di dosi di ferro endovena somministrate nell arco di quattro mesi. Questo dato conferma la presenza di un significativo deficit delle scorte marziali nei soggetti emodializzati, malgrado una rilevante parte di essi riceva periodiche supplementazioni di ferro endovena (11). La percentuale di pazienti in terapia con ferro endovena si è dimostrata direttamente correlata al valore di emoglobina medio rilevato nel Centro dialisi. I più recenti dati a nostra disposizione, cioè quelli del DOPPS III (15), mostrano una tendenza verso più elevate percentuali di utilizzo della terapia marziale endovena nella maggior parte dei Paesi, con l eccezione di Belgio, Svezia, Spagna e Germania che mostravano un elevata frequenza di ricorso alla terapia marziale endovena già nelle precedenti fasi del DOPPS. Anche nelle due nazioni che nel 2003 presentavano le percentuali più basse (Giappone e Italia) si è assistito a un incremento rilevante del numero di pazienti trattati con ferro per via endovenosa (dal 38 al 43,8% e dal 53 al 63,3%, rispettivamente)(15). Tuttavia, non si è parallelamente assistito a un aumento dei valori mediani di
4 30 Wichtig Editore 2010 Tabella II - Andamento dei valori medi di ferro somministrato per via endovenosa nei diversi stati partecipanti al DOPPS I, II e III saturazione della transferrina negli anni. La dose media mensile di ferro somministrato endovena nel corso delle diverse fasi del DOPPS è aumentato significativamente in quattro Paesi (Canada, Francia, Italia e Svezia), ed è diminuita in maniera rilevante solo negli Stati Uniti. Attualmente, in Svezia e in Francia vengono somministrate le dosi più elevate di ferro (>300 mg/mese), mentre in Giappone non viene superato il dosaggio di 100 mg/ mese (9) (Tab. II). Per quanto riguarda i parametri utilizzati nel monitoraggio delle scorte marziali, va sottolineato il progressivo aumento nei valori mediani di ferritinemia e la riduzione della percentuale di pazienti con livelli di ferritinemia inferiore a 100 ng/ml nel corso delle diverse fasi DOPPS, con trend più o meno marcati, ma comuni a tutti i Paesi partecipanti allo studio (11, 15). Anche nel caso della gestione della terapia marziale il DOPPS ha evidenziato significativi cambiamenti nella pratica clinica quotidiana che, almeno in parte, rispecchiano le raccomandazioni delle attuali linee guida a garantire più adeguate scorte marziali. Il DOPPS, inoltre, ha messo in luce alcuni aspetti su cui è ancora aperta la discussione, come la difficoltà nel raggiungere i target desiderati e il limite nella somministrazione di elevati dosaggi di ferro. Fig. 2 - Associazione tra valori di emoglobina e andamento del rischio relativo di morte in pazienti emodializzati.
5 31 Anemia e outcome Un contributo rilevante fornito dal DOPPS è stato il riscontro di una stretta associazione tra elevati livelli di emoglobina e riduzione di morbilità e mortalità nei pazienti emodializzati (11, 16). Questo dato è stato però messo in discussione da alcuni studi e trial, anche randomizzati, che hanno ottenuto risultati discordanti e a volte opposti rispetto al DOPPS. Alcuni di questi studi, tuttavia, sono caratterizzati da alcuni limiti, come l eccessiva selezione della popolazione in studio, che ne rendono i risultati non facilmente generalizzabili alla popolazione emodialitica in toto (17). Il DOPPS ha esaminato un ampia popolazione di pazienti emodializzati utilizzando analisi statistiche che consentono la correzioni dei risultati sulla base di alcune caratteristiche dei pazienti, quali l eziologia della CKD, le comorbilità, il tasso di ospedalizzazione, la tipologia di accesso vascolare, la modalità dialitica (18), particolarmente importanti quando si valuta la gestione dell anemia nella pratica clinica. Il DOPPS ha documentato che, indipendentemente da fattori potenzialmente confondenti, in generale, il rischio relativo di morte e ospedalizzazione erano ridotti rispettivamente del 5% e 6% per ogni gr/dl di aumento dei valori di emoglobina rispetto al basale. Va notato tuttavia che il rischio di sviluppare l outcome ospedalizzazione e/o morte variava a seconda dei valori di emoglobina considerati, essendo molto marcato nei casi più severi di anemia (rischio relativo di morte 1,26, p=0,04, e di ospedalizzazione 1,55, p<0,0001, per valori di emoglobina <8 g/dl), e pressoché inesistente per valori di emoglobina >12 g/dl (rischio relativo di morte 0,92, p=0,19, rispetto a valori di emoglobina 11-11,9 g/dl, e assenza di differenze riguardo il tasso di ospedalizzazione) (Fig. 2). Questi interessanti risultati rimanevano validi anche in un analisi svolta a livello di Centro, ovvero prendendo in considerazione i valori medi di emoglobina nelle varie Unità di dialisi: i Centri con più basso rischio di morte e ospedalizzazione erano quelli con valori medi di emoglobina più alti. Anemia e politica sanitaria Uno degli scopi del DOPPS è l analisi di diversi aspetti della pratica emodialitica con particolare attenzione a quegli ambiti che alla luce delle più recenti acquisizioni assumono maggiore rilevanza clinica. Per quanto riguarda il trattamento dell anemia secondaria a CKD la pubblicazione di alcuni trial clinici randomizzati (14, 19, 20) ha messo in dubbio la sicurezza e i possibili benefici associati al raggiungimento di valori di emoglobina su- periori a 12 g/dl, situazione non infrequente se si considera che oltre il 50% dei pazienti emodializzati negli Stati Uniti (9) presenta simili livelli di emoglobina. Per questo motivo, una recente analisi (9) ha preso in considerazione i dati delle tre fasi del DOPPS per valutare quale ruolo avesse giocato nel progressivo incremento dei valori di emoglobina la modalità di rimborso della terapia con ESA. In generale, nei Paesi DOPPS sono state messe in atto delle politiche di controllo per scoraggiare un ingiustificato aumento della terapia con ESA. Tutti i Paesi DOPPS, ad eccezione di Francia e Spagna, attuano delle restrizioni di rimborso all introduzione della terapia con ESA richiedendo un certo grado di anemia o la presenza di sintomi secondari ad essa prima di poter ricorrere a questo tipo di trattamento. I risultati dello studio DOPPS non hanno, tuttavia, individuato una chiara correlazione tra queste limitazioni e il trend di aumento nell utilizzo degli ESA. Una volta iniziata la terapia con ESA, il rimborso del farmaco è spesso limitato a un massimo di dose che varia tra le unità/settimana del Giappone e le unità/mese ( unità/settimana) degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti vengono applicate delle restrizioni nel rimborso della terapia quando si mantengono i valori di emoglobina oltre il target per un prolungato periodo di tempo (ad esempio, un ematocrito superiore al 37,5% per tre mesi). Questo provvedimento ha in parte sortito l effetto desiderato, infatti, benché gli Stati Uniti fossero l unico Paese DOPPS che prevedesse, nel 2006, un aumento di spesa per la terapia con ESA, l aumento del suo consumo è stato nettamente inferiore a quanto registrato negli altri Paesi. In Germania, un utilizzo di ESA maggiore di quanto previsto determina un mancato pagamento del farmaco. In Canada, Italia, Spagna e Giappone il costo della terapia rientra generalmente nel budget complessivo a disposizione del Centro dialisi, per cui un aumento ingiustificato di ESA determina una riduzione delle risorse economiche destinate ad altre finalità. Nonostante questo, Canada, Italia e Spagna hanno mostrato il trend più significativo di aumento dell uso di ESA. In alcuni altri Paesi (Canada, Svezia e Stati Uniti), invece, si richiede al paziente di contribuire al pagamento della terapia con ESA somministratagli. Dall indagine condotta nei Centri DOPPS non sembra si possa attribuire il trend di crescita di utilizzo degli ESA né a spinte provenienti dalle case farmaceutiche né a possibili benefici economici derivanti dal raggiungimento dei target di correzione dell anemia. Nonostante le politiche sanitarie nazionali siano tutte sostanzialmente concordi nello scoraggiare l aumento ingiustificato della terapia con ESA, in nessun Paese DOPPS si è verificato un calo nel consumo di questa categoria di farmaci e
6 32 Wichtig Editore 2010 ciò suggerisce che, a livello internazionale, la scelta dei nefrologi a favore di un completo e robusto trattamento dell anemia secondaria a CKD è prevalente rispetto a ragioni di tipo meramente economico anche quando queste potrebbero portare a vantaggi personali. Conclusioni Nel corso degli anni, il DOPPS ha fornito numerose informazioni sui più vari aspetti riguardanti il trattamento emodialitico compreso anche la gestione dell anemia secondaria a CKD. In questo ambito è risultato evidente un trend verso una maggior adesione a quanto raccomandato dalle linee guida internazionali come dimostrato dall aumento dei valori medi di emoglobina e di utilizzo degli ESA e una maggiore attenzione a garantire adeguate scorte marziali. Oltre a rappresentare una valida cartina di torna-sole dell attività emodialitica internazionale, il DOPPS ha permesso di evidenziare associazioni molto interessanti dal punto di vista clinico, mostrando come i valori di emoglobina siano fortemente associati con il rischio di ospedalizzazione e morte nei pazienti emodializzati. L opportunità di raccogliere un ampia messe di dati clinici da una vasta coorte di soggetti in trattamento emodialitico in vari Paesi evoluti e la possibilità di analizzarli con sofisticate metodologie statistiche, alla luce di una dettagliata descrizione di vari fattori di comorbilità, ha permesso al DOPPS di ottenere risultati validi e scientificamente coerenti che permettono di monitorare l implementazione delle linee guida nella pratica clinica quotidiana e sviluppare nuove ipotesi di ricerca da testare in studi clinici controllati. di molte problematiche attinenti l emodialisi, tra cui anche il trattamento dell anemia. Nel corso degli anni, il DOPPS ha evidenziato una crescente aderenza nei confronti di quanto raccomandato dalle linee guida internazionali, come dimostrato dall aumento dei valori medi di emoglobina, dall utilizzo di ESA in una percentuale crescente di pazienti e da una maggiore attenzione a garantire adeguate scorte marziali. Il DOPPS, inoltre, ha messo in risalto una rilevante associazione tra valori di emoglobina e rischio di ospedalizzazione e morte nei pazienti emodializzati. Oggigiorno il DOPPS rappresenta, anche nel campo della gestione dell anemia secondaria alla CKD, un importante riferimento scientifico, che dimostra come uno studio osservazionale, eseguito in accordo ad adeguati criteri metodologici, possa diventare uno strumento informativo, credibile e capace di suggerire nuove ipotesi da testare in successivi studi clinici controllati. Parole chiave: Anemia, DOPPS, Malattia renale cronica, ESA. Indirizzo degli Autori: Giuseppe Pontoriero, MD S.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale Alessandro Manzoni via Dell Eremo, 9/ Lecco g.pontoriero@ospedale.lecco.it Riassunto L anemia è una frequente complicanza della malattia renale cronica (Chronic Kidney Disease, o più brevemente CKD) e rappresenta un importante fattore di rischio cardiovascolare che aggrava ulteriormente la prognosi dei pazienti nefropatici. Gli agenti stimolanti l eritropoiesi (ESA) e la supplementazione marziale rappresentano i cardini su cui attualmente si basa la terapia di questa complicanza della CKD. Il Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS) studio internazionale, prospettico, osservazionale è stato avviato nel 1996 per raccogliere informazioni riguardanti le pratiche cliniche di gestione bibliografia 1. Astor BC, Muntner P, Levin A, Eustace JA, Coresh J. Association of kidney function with anemia: the third National Health and Nutrition Examination Survey ( ). Arch Intern Med 2002; 162: US Renal Data System. USRDS Annual Data Report, treatment modalities. Am J Kidney Dis 1994; 24(Suppl 2): S Levin A, Thompson CR, Ethier J, et al. Left ventricular mass index increase in early renal disease: impact of decline in hemoglobin. Am J Kidney Dis 1999; 34: Foley RN, Parfrey PS, Harnett JD, et al. Clinical and echocardiographic disease in patients starting end-stage renal disease therapy. Kidney Int 1995; 47:
7 33 5. National Kidney Foundation. K/DOQI Clinical Practice Guidelines update. Am J Kidney Dis 2001; 37(Suppl 1): S European Best Practice Guidelines for the management of anemia in patients with chronic renal failure. Working party for European Best Practice Guidelines for the management of anemia in patients with chronic kidney failure. Nephrol Dial Transplant 1999; 14(Suppl 5): S Young EW, Goodkin DA, Mapes DL, et al. The Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS): an international Hemodialysis study. Kidney Int 2000; 57(Suppl): S Locatelli F, Pisoni RL, Akizawa T, et al. Anemia management for hemodialysis patients: Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) guidelines and Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS) findings. Am J Kidney Dis 2004; 44(Suppl 2): S McFarlane P, Pisoni RL, Eichleay MA, Wald R, Port FK, Mendelssohn D. International trends in erythropoietin use and haemoglobin levels in hemodialysis patients. Kidney Int 2010; 78: Locatelli F, Aljama P, Canaud B, et al; Anaemia Working Group of European Renal Best Practice (ERBP). Target haemoglobin to aim for with erythropoiesis-stimulating agents: a position statement by ERBP following publication of the Trial to reduce cardiovascular events with Aranesp therapy (TREAT) study. Nephrol Dial Transplant 2010; 25(9): Pisoni RL, Bragg-Gresham JL, Young EW, et al. Anemia management and outcomes from 12 countries in the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Am J Kidney Dis 2004; 44: Port FK, Pisoni RL, Bommer J, et al. Improving Outcomes for Dialysis Patients in the International Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study. Clin J Am Soc Nephrol 2006; 1: Del Vecchio L, Cavalli A, Tucci B, Locatelli F. Chronic kidney disease-associated anemia: new remedies. Curr Opin Investig Drugs 2010; 11(9): Pfeffer MA, Burdmann EA, Chen CY, et al. A trial of darbepoetin alfa in type 2 diabetes and chronic kidney disease. N Engl J Med 2009; 361(21): Annual Report of the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study: Hemodialysis Data Arbor Research Collaborative for Health, Ann Arbor, MI. dopps.org/annualreport/html/iron_iv_c_mostrec2009.htm (accesso il 28 Settembre 2010). 16. Locatelli F, Pisoni RL, Combe C, et al. Anemia in hemodialysis patients of five European Countries: Association with morbidity and mortality in the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Nephrol Dial Transplant 2004; 19: Locatelli F, Andrulli S, Del Vecchio L. Difficulties of implementing clinical guidelines in medical practice. Nephrol Dial Transplant 2000; 15: Goodkin DA, Bragg-Gresham JL, Koenig KG, et al. Association of comorbid conditions and mortality in hemodialysis patients in Europe, Japan, and the United States: The Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). J Am Soc Nephrol 2003; 14: Besarab A, Bolton WK, Browne JK, et al. The effects of normal as compared with low hematocrit values in patients with cardiac disease who are receiving hemodialysis and epoetin. N Engl J Med 1998; 339(9): Singh AK. Does the TREAT give the boot to ESAs in the treatment of CKD anemia? J Am Soc Nephrol 2010; 21: 2-6.
Le alterazioni del metabolismo calcio-fosforo nei pazienti in dialisi: il contributo dello Studio DOPPS. Il punto di vista del Medico
 36 Studi DOPPS Le alterazioni del metabolismo calcio-fosforo nei pazienti in dialisi: il contributo dello Studio DOPPS. Il punto di vista del Medico M. Limardo, G. Pontoriero Divisione di Nefrologia, Dialisi
36 Studi DOPPS Le alterazioni del metabolismo calcio-fosforo nei pazienti in dialisi: il contributo dello Studio DOPPS. Il punto di vista del Medico M. Limardo, G. Pontoriero Divisione di Nefrologia, Dialisi
Studio SENIORS Trial sull effetto di nebivololo su mortalità e ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari in pazienti anziani con insufficienza
 Trial sull effetto di nebivololo su mortalità e ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari in pazienti anziani con insufficienza cardiaca (1) Introduzione (1) Età media dei pazienti con insufficienza
Trial sull effetto di nebivololo su mortalità e ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari in pazienti anziani con insufficienza cardiaca (1) Introduzione (1) Età media dei pazienti con insufficienza
L aggiornamento pubblicato nel marzo del 2007 è stato integrato con la pubblicazione della prima lista di farmaci essenziali ad uso pediatrico
 Nel 1977, l Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblica il primo report sui farmaci essenziali. Indicato con l acronimo WHO TRS 615, il report tecnico costituisce la prima lista di farmaci essenziali
Nel 1977, l Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblica il primo report sui farmaci essenziali. Indicato con l acronimo WHO TRS 615, il report tecnico costituisce la prima lista di farmaci essenziali
ANEMIA: LINEE GUIDA A CONFRONTO
 GiornaleItaliano di Nefrologia / Anno 26 n. 6, 2009 / pp. 686-694 LINEE GUIDA A CONFRONTO ANEMIA: LINEE GUIDA A CONFRONTO GIN FAD L. Del Vecchio Dipartimento di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale,
GiornaleItaliano di Nefrologia / Anno 26 n. 6, 2009 / pp. 686-694 LINEE GUIDA A CONFRONTO ANEMIA: LINEE GUIDA A CONFRONTO GIN FAD L. Del Vecchio Dipartimento di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale,
Approccio Terapeutico all iperglicemia a digiuno e postprandiale. Irene Brandolin S.C. Medicina Interna E.O. Ospedali Galliera Savona, 23 Marzo 2013
 Approccio Terapeutico all iperglicemia a digiuno e postprandiale Irene Brandolin S.C. Medicina Interna E.O. Ospedali Galliera Savona, 23 Marzo 2013 La triade glicemica nella gestione del diabete Glicemia
Approccio Terapeutico all iperglicemia a digiuno e postprandiale Irene Brandolin S.C. Medicina Interna E.O. Ospedali Galliera Savona, 23 Marzo 2013 La triade glicemica nella gestione del diabete Glicemia
Il paziente con problema renale: non solo Insufficienza Renale Cronica ma Malattia Renale Cronica
 Il paziente con problema renale: non solo Insufficienza Renale Cronica ma Malattia Renale Cronica I miei riferimenti per questa relazione: le linee-guida nazionali e internazionali Clinical Practice Guidelines
Il paziente con problema renale: non solo Insufficienza Renale Cronica ma Malattia Renale Cronica I miei riferimenti per questa relazione: le linee-guida nazionali e internazionali Clinical Practice Guidelines
Conegliano: / / Piergianni Calzavara UOC di Nefrologia e Dialisi
 Conegliano: 14-10-2015 / 28-10-2015 / 18-11-2015 Piergianni Calzavara UOC di Nefrologia e Dialisi Stadio MRC Descrizione VFG I Danno renale con VFG normale > 90 II Lieve 60-89 III Moderata 30-59 IV Severa
Conegliano: 14-10-2015 / 28-10-2015 / 18-11-2015 Piergianni Calzavara UOC di Nefrologia e Dialisi Stadio MRC Descrizione VFG I Danno renale con VFG normale > 90 II Lieve 60-89 III Moderata 30-59 IV Severa
La Salute raggiungibile per...
 La Salute raggiungibile per... 79 Nota introduttiva per la lettura delle patologie La scelta di descrivere le patologie più frequenti attraverso l analisi dell andamento dei ricoveri ospedalieri è stata
La Salute raggiungibile per... 79 Nota introduttiva per la lettura delle patologie La scelta di descrivere le patologie più frequenti attraverso l analisi dell andamento dei ricoveri ospedalieri è stata
Gruppo di lavoro per l appropriatezza prescrittiva ospedale/territorio Documento finale - giugno 2014
 Gruppo di lavoro per l appropriatezza prescrittiva ospedale/territorio Documento finale - giugno 2014 Prescrizione di farmaci Classe C10AA (inibitori della HMG CoA reduttasi) L indicazione regionale è
Gruppo di lavoro per l appropriatezza prescrittiva ospedale/territorio Documento finale - giugno 2014 Prescrizione di farmaci Classe C10AA (inibitori della HMG CoA reduttasi) L indicazione regionale è
I biosimilari tra presente e futuro. L impatto nella pratica clinica. dei biosimilari in: Nefrologia. G. Brunori. Trento
 I biosimilari tra presente e futuro L impatto nella pratica clinica dei biosimilari in: Nefrologia G. Brunori Trento Corso di formazione manageriale per dirigenti sanitari 2 marzo 2010 Valutazione della
I biosimilari tra presente e futuro L impatto nella pratica clinica dei biosimilari in: Nefrologia G. Brunori Trento Corso di formazione manageriale per dirigenti sanitari 2 marzo 2010 Valutazione della
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO MEDICI DI MEDICINA GENERALE
 AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO MEDICI DI MEDICINA GENERALE Sabato 24/10/ 2015 TITOLO DEL CORSO: vaccinazioni Responsabile del corso Dr. Tesei Fiorenzo Rsponsabile Scientifico Dr.ssa lorena Angelini Referente
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO MEDICI DI MEDICINA GENERALE Sabato 24/10/ 2015 TITOLO DEL CORSO: vaccinazioni Responsabile del corso Dr. Tesei Fiorenzo Rsponsabile Scientifico Dr.ssa lorena Angelini Referente
La BPCO e le comorbilità. Federico Sciarra
 La BPCO e le comorbilità Federico Sciarra La BPCO, essendo una malattia cronica con caratteristiche di infiammazione sistemica, facilmente coesiste con altre patologie sia acute che croniche, che influenzano
La BPCO e le comorbilità Federico Sciarra La BPCO, essendo una malattia cronica con caratteristiche di infiammazione sistemica, facilmente coesiste con altre patologie sia acute che croniche, che influenzano
ESERCIZIO FISICO NEI PAZIENTI DIALIZZATI
 ESERCIZIO FISICO NEI PAZIENTI DIALIZZATI F.A. Di Domenica - S. Oldani Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione Istituto Ortopedico G. Pini, Milano Per molti anni è stata sconsigliata l attività
ESERCIZIO FISICO NEI PAZIENTI DIALIZZATI F.A. Di Domenica - S. Oldani Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione Istituto Ortopedico G. Pini, Milano Per molti anni è stata sconsigliata l attività
Quali sono le ultime novità in tema di terapia marziale?
 Giornale di Tecniche Nefrologiche & Dialitiche 2014; 26 ( 3): 296-300 DOI: 10.5301/GTND.2014.12699 TN&D Journal club Quali sono le ultime novità in tema di terapia marziale? Andrea Cavalli, Giuseppe Pontoriero
Giornale di Tecniche Nefrologiche & Dialitiche 2014; 26 ( 3): 296-300 DOI: 10.5301/GTND.2014.12699 TN&D Journal club Quali sono le ultime novità in tema di terapia marziale? Andrea Cavalli, Giuseppe Pontoriero
La gestione dell Accesso Vascolare nei pazienti in dialisi: il contributo dello Studio DOPPS
 Studi DOPPS - Il punto di vista del Medico 27 La gestione dell Accesso Vascolare nei pazienti in dialisi: il contributo dello Studio DOPPS S. Libardi, G. Bacchini e G. Pontoriero S.C. Nefrologia e Dialisi,
Studi DOPPS - Il punto di vista del Medico 27 La gestione dell Accesso Vascolare nei pazienti in dialisi: il contributo dello Studio DOPPS S. Libardi, G. Bacchini e G. Pontoriero S.C. Nefrologia e Dialisi,
Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie
 Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie Dr Marchi Rita Medico di Medicina Generale Presidente S.I.M.G di Ferrara 24 settembre 2016 Dati ISTAT 2012-2013,
Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie Dr Marchi Rita Medico di Medicina Generale Presidente S.I.M.G di Ferrara 24 settembre 2016 Dati ISTAT 2012-2013,
Ipertensione: i dati dell Osservatorio epidemiologico cardiovascolare/health Examination Survey
 Ipertensione: i dati dell Osservatorio epidemiologico cardiovascolare/health Examination Survey Luigi Palmieri, Chiara Donfrancesco, Serena Vannucchi, Cinzia Lo Noce, Francesco Dima, Simona Giampaoli -
Ipertensione: i dati dell Osservatorio epidemiologico cardiovascolare/health Examination Survey Luigi Palmieri, Chiara Donfrancesco, Serena Vannucchi, Cinzia Lo Noce, Francesco Dima, Simona Giampaoli -
Farmaci biologici nel trattamento della psoriasi: differenze nei criteri di valutazione tra USA e UE.
 Farmaci biologici nel trattamento della psoriasi: differenze nei criteri di valutazione tra USA e UE. Renato Bertini Malgarini, Giuseppe Pimpinella, Luca Pani 10 dicembre 2012- Istituto Superiore di Sanità
Farmaci biologici nel trattamento della psoriasi: differenze nei criteri di valutazione tra USA e UE. Renato Bertini Malgarini, Giuseppe Pimpinella, Luca Pani 10 dicembre 2012- Istituto Superiore di Sanità
Health Literacy nelle persone con diabete Risultati PASSI
 Health Literacy nelle persone con diabete Risultati PASSI 2012-2015 XL Congresso dell Associazione Italiana di Epidemiologia Torino, 19 21 ottobre 2016 «Le evidenze in epidemiologia: una storia lunga 40
Health Literacy nelle persone con diabete Risultati PASSI 2012-2015 XL Congresso dell Associazione Italiana di Epidemiologia Torino, 19 21 ottobre 2016 «Le evidenze in epidemiologia: una storia lunga 40
Il governo clinico dei pazienti con MRC: Progetto R.I.S. A. Zamboni
 Il governo clinico dei pazienti con MRC: Progetto R.I.S. A. Zamboni Agenda Il progetto Nazionale Il percorso diagnostico terapeutico Il ruolo del MMG I primi risultati del self-audit I benefici del progetto
Il governo clinico dei pazienti con MRC: Progetto R.I.S. A. Zamboni Agenda Il progetto Nazionale Il percorso diagnostico terapeutico Il ruolo del MMG I primi risultati del self-audit I benefici del progetto
NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI (EMA) E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)
 NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI (EMA) E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Agosto 2012 Comunicazione diretta agli operatori sanitari sull associazione tra
NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI (EMA) E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Agosto 2012 Comunicazione diretta agli operatori sanitari sull associazione tra
L insufficienza renale cronica mild to moderate e la gravidanza La gravidanza nelle donne con malattia renale cronica con GFR>30 ml/min
 L insufficienza renale cronica mild to moderate e la gravidanza La gravidanza nelle donne con malattia renale cronica con GFR>30 ml/min Monica Limardo Divisione di Nefrologia e Dialisi Ospedale A. Manzoni
L insufficienza renale cronica mild to moderate e la gravidanza La gravidanza nelle donne con malattia renale cronica con GFR>30 ml/min Monica Limardo Divisione di Nefrologia e Dialisi Ospedale A. Manzoni
Effetti del Trattamento Insulinico Intensivo nei pazienti diabetici (glicemia 198 mg/dl) con STE- MI.
 Effetti del Trattamento Insulinico Intensivo nei pazienti diabetici (glicemia 198 mg/dl) con STE- MI. Riduzione rischio relativo:31% DIGAMI study JACC 1995;26:57-65 65 I pazienti con diabete mellito hanno
Effetti del Trattamento Insulinico Intensivo nei pazienti diabetici (glicemia 198 mg/dl) con STE- MI. Riduzione rischio relativo:31% DIGAMI study JACC 1995;26:57-65 65 I pazienti con diabete mellito hanno
Una Medicina su Misura
 2 aprile 2011 Una Medicina su Misura Ogni paziente ha la sua Malattia Dott.ssa Sara Mazzoldi Una Medicina su Misura per In questa parte prenderemo in esame 3 tipi di pazienti: paziente con diabete mellito
2 aprile 2011 Una Medicina su Misura Ogni paziente ha la sua Malattia Dott.ssa Sara Mazzoldi Una Medicina su Misura per In questa parte prenderemo in esame 3 tipi di pazienti: paziente con diabete mellito
Colchicina nella prevenzione degli eventi cardiovascolari
 Revisione Cochrane 2016 Colchicina nella prevenzione degli eventi cardiovascolari Hemkens LG, Ewald H, Gloy VL, et al. Colchicine for prevention of cardiovascular events. Cochrane Database Syst Rev 2016;1:CD011047.
Revisione Cochrane 2016 Colchicina nella prevenzione degli eventi cardiovascolari Hemkens LG, Ewald H, Gloy VL, et al. Colchicine for prevention of cardiovascular events. Cochrane Database Syst Rev 2016;1:CD011047.
QUALIFICARE LA PERFORMANCE CLINICA NEL PAZIENTE ANEMICO DIALIZZATO
 QUALIFICARE LA PERFORMANCE CLINICA NEL PAZIENTE ANEMICO DIALIZZATO Dr.ssa Laura Pavone Spunto iniziale Il Trattamento dell anemia nel paziente emodializzato è stato individuato quale argomento di prioritario
QUALIFICARE LA PERFORMANCE CLINICA NEL PAZIENTE ANEMICO DIALIZZATO Dr.ssa Laura Pavone Spunto iniziale Il Trattamento dell anemia nel paziente emodializzato è stato individuato quale argomento di prioritario
Stato nutrizionale e abitudini alimentari
 Stato nutrizionale e abitudini alimentari Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; l eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio rilevante
Stato nutrizionale e abitudini alimentari Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; l eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio rilevante
Fattori di rischio comuni a uomini e donne
 Uomini e donne: affari di cuore Varese, 3 Dicembre 2014 Fattori di rischio comuni a uomini e donne Andrea M. Maresca Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università degli Studi dell Insubria
Uomini e donne: affari di cuore Varese, 3 Dicembre 2014 Fattori di rischio comuni a uomini e donne Andrea M. Maresca Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università degli Studi dell Insubria
Alimentazione. Qual è lo stato nutrizionale della popolazione? Quante e quali persone sono in eccesso ponderale?
 Alimentazione Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; l eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio rilevante per le principali patologie
Alimentazione Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; l eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio rilevante per le principali patologie
STIMA DOPPS DELL IMPATTO DELLE LINEE GUIDA SULLA SOPRAVVIVENZA IN EMODIALISI IN ITALIA
 p. 221-229 Pontoriero:Ravani 22-05-2007 10:10 Pagina 221 GIORNALE ITALIANO DI NEFROLOGIA / ANNO 24 N. 3, 2007 / PP. 221-229 RICERCA STIMA DOPPS DELL IMPATTO DELLE LINEE GUIDA SULLA SOPRAVVIVENZA IN EMODIALISI
p. 221-229 Pontoriero:Ravani 22-05-2007 10:10 Pagina 221 GIORNALE ITALIANO DI NEFROLOGIA / ANNO 24 N. 3, 2007 / PP. 221-229 RICERCA STIMA DOPPS DELL IMPATTO DELLE LINEE GUIDA SULLA SOPRAVVIVENZA IN EMODIALISI
Allegato III Modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo
 Allegato III Modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo Nota: le modifiche di questo riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo sono
Allegato III Modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo Nota: le modifiche di questo riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo sono
nell insufficienza renale prima della dialisi
 Trattamento dell anemia nell insufficienza renale prima della dialisi Alberto Albertazzi Federica Ravera In caso di mancata consegna restituire al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa. Periodicità
Trattamento dell anemia nell insufficienza renale prima della dialisi Alberto Albertazzi Federica Ravera In caso di mancata consegna restituire al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa. Periodicità
EPOETINA DELTA ( )
 EPOETINA DELTA (12-02-2008) Specialità: Dynepo (Shite Italia) Forma farmaceutica: 6 sir pronte 1.000U/0,5 ml - Prezzo: euro 84.64 6 sir pronte 2.000U/0,5 ml - Prezzo: euro 169.37 6 sir pronte 3.000U/0,3
EPOETINA DELTA (12-02-2008) Specialità: Dynepo (Shite Italia) Forma farmaceutica: 6 sir pronte 1.000U/0,5 ml - Prezzo: euro 84.64 6 sir pronte 2.000U/0,5 ml - Prezzo: euro 169.37 6 sir pronte 3.000U/0,3
IL PAZIENTE EMODIALIZZATO:
 IL PAZIENTE EMODIALIZZATO: UNA STORIA FRAGILE Federica Manescalchi S.S. EMODIALISI SMN GIORNATE MEDICHE DI SANTA MARIA NUOVA 28/09/2012 MEDLINE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FRAILTY AND DIALYSIS PAZIENTE FRAGILE????????????????
IL PAZIENTE EMODIALIZZATO: UNA STORIA FRAGILE Federica Manescalchi S.S. EMODIALISI SMN GIORNATE MEDICHE DI SANTA MARIA NUOVA 28/09/2012 MEDLINE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FRAILTY AND DIALYSIS PAZIENTE FRAGILE????????????????
IL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RENALE GENERALE CRONICA NELL OTTICA DELLA MEDICINA. Ricerca. GAETANO D AMBROSIO Medico di Medicina Generale, SIMG Bari
 Ricerca IL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA NELL OTTICA DELLA MEDICINA GENERALE GAETANO D AMBROSIO Medico di Medicina Generale, SIMG Bari Un abbondante letteratura 1-4 ha documentato come il ricorso
Ricerca IL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA NELL OTTICA DELLA MEDICINA GENERALE GAETANO D AMBROSIO Medico di Medicina Generale, SIMG Bari Un abbondante letteratura 1-4 ha documentato come il ricorso
Prevenzione e controllo delle malattie croniche nella Cooperazione e nei Migranti
 Prevenzione e controllo delle malattie croniche nella Cooperazione e nei Migranti Toscana - Senegal: la salute come filo conduttore Firenze, 19 novembre 2015 Federica Manescalchi Miriam Valiani Giuseppe
Prevenzione e controllo delle malattie croniche nella Cooperazione e nei Migranti Toscana - Senegal: la salute come filo conduttore Firenze, 19 novembre 2015 Federica Manescalchi Miriam Valiani Giuseppe
AGGIORNAMENTI SULLA Vitamina D
 AGGIORNAMENTI SULLA Vitamina D Approviggionamento di Vitamin D Livelli di vitamina D nel sangue Metabolismo Vitamina D e mortalità VitaminaD e fratture Vitamina D e cancro Vitamina D ed altre patologie
AGGIORNAMENTI SULLA Vitamina D Approviggionamento di Vitamin D Livelli di vitamina D nel sangue Metabolismo Vitamina D e mortalità VitaminaD e fratture Vitamina D e cancro Vitamina D ed altre patologie
Supplementazione di calcio. Marco Di Monaco Presidio Sanitario San Camillo, Torino
 Supplementazione di calcio Marco Di Monaco Presidio Sanitario San Camillo, Torino Dichiarazione di trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali
Supplementazione di calcio Marco Di Monaco Presidio Sanitario San Camillo, Torino Dichiarazione di trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali
Documento PTR n. 119 relativo a:
 Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Commissione Regionale del Farmaco (D.G.R. 1540/2006, 2129/2010 e 490/2011) Documento PTR n. 119 relativo a: MEDICINALI ORIGINATOR E BIOSIMILARI DELL ERITROPOIETINA
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Commissione Regionale del Farmaco (D.G.R. 1540/2006, 2129/2010 e 490/2011) Documento PTR n. 119 relativo a: MEDICINALI ORIGINATOR E BIOSIMILARI DELL ERITROPOIETINA
Fibrillazione atriale e pazienti diabetici che richiedono insulina
 Fibrillazione atriale e pazienti diabetici che richiedono insulina Fibrillazione atriale, i pazienti diabetici che richiedono insulina presentano un aumentato rischio di ictus e embolia sistemica I pazienti
Fibrillazione atriale e pazienti diabetici che richiedono insulina Fibrillazione atriale, i pazienti diabetici che richiedono insulina presentano un aumentato rischio di ictus e embolia sistemica I pazienti
Gli obiettivi glicemici nel paziente diabetico e iperglicemico ospedalizzato
 Gli obiettivi glicemici nel paziente diabetico e iperglicemico ospedalizzato Maria Del Ben Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche Sapienza Università Roma L iperglicemia è di frequente riscontro
Gli obiettivi glicemici nel paziente diabetico e iperglicemico ospedalizzato Maria Del Ben Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche Sapienza Università Roma L iperglicemia è di frequente riscontro
HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ INTRODUZIONE
 HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ INTRODUZIONE 1 Aids in Italia e in Europa 2 HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ AIDS IN ITALIA E IN EUROPA Giovanni Rezza Centro Operativo Aids - Istituto Superiore di Sanità
HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ INTRODUZIONE 1 Aids in Italia e in Europa 2 HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ AIDS IN ITALIA E IN EUROPA Giovanni Rezza Centro Operativo Aids - Istituto Superiore di Sanità
Come considerano il proprio peso le persone intervistate?
 Situazione nutrizionale e abitudini alimentari Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; l eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio rilevante
Situazione nutrizionale e abitudini alimentari Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; l eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio rilevante
La terapia anti- ipertensiva ed ipolipidemizzante nel diabetico ad alto rischio
 La terapia anti- ipertensiva ed ipolipidemizzante nel diabetico ad alto rischio Maurizio Cappelli Bigazzi Cattedra di Cardiologia - A.O. Monaldi II Università di Napoli Nei diabetici, le complicanze macrovascolari,
La terapia anti- ipertensiva ed ipolipidemizzante nel diabetico ad alto rischio Maurizio Cappelli Bigazzi Cattedra di Cardiologia - A.O. Monaldi II Università di Napoli Nei diabetici, le complicanze macrovascolari,
Comorbosità CIRS (Cumulative illness Rating Scale) IDS (Index of Disease Severity) CCI (Charlson Comorbidity index)
 Comorbosità CIRS (Cumulative illness Rating Scale) IDS (Index of Disease Severity) CCI (Charlson Comorbidity index) Epidemiologia della multimorbosità nell anziano Riguarda 1/4 della popolazione generale
Comorbosità CIRS (Cumulative illness Rating Scale) IDS (Index of Disease Severity) CCI (Charlson Comorbidity index) Epidemiologia della multimorbosità nell anziano Riguarda 1/4 della popolazione generale
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L INSERIMENTO DI FARMACI NON PRESENTI NEL PTR
 RICHIESTA DI INSERIMENTO IN PTR DI METOSSI POLIETILEN GLICOLE-EPOETINA BETA ATC B03XA03 (MIRCERA ) Presentate da Componente della Commissione PTR In data marzo 2008 e luglio 2009 Per le seguenti motivazioni:
RICHIESTA DI INSERIMENTO IN PTR DI METOSSI POLIETILEN GLICOLE-EPOETINA BETA ATC B03XA03 (MIRCERA ) Presentate da Componente della Commissione PTR In data marzo 2008 e luglio 2009 Per le seguenti motivazioni:
La valutazione economica della Prevenzione: spesa o investimento. Prof.ssa Maria Triassi
 La valutazione economica della Prevenzione: spesa o investimento Prof.ssa Maria Triassi LA PREVENZIONE Aumenta il livello di salute Risparmio risorse LA PREVENZIONE Aumenta il livello di salute LA CURA
La valutazione economica della Prevenzione: spesa o investimento Prof.ssa Maria Triassi LA PREVENZIONE Aumenta il livello di salute Risparmio risorse LA PREVENZIONE Aumenta il livello di salute LA CURA
ALCUNI DATI SULLE PATOLOGIE CRONICHE. Fonti: Elaborazioni da OMS, Istat, Sic Sanità in cifre
 ALCUNI DATI SULLE PATOLOGIE CRONICHE Fonti: Elaborazioni da OMS, Istat, Sic Sanità in cifre LE MALATTIE CARDIO VASCOLARI Le malattie cardiovascolari ogni anno provocano oltre 17 milioni di decessi (7,2
ALCUNI DATI SULLE PATOLOGIE CRONICHE Fonti: Elaborazioni da OMS, Istat, Sic Sanità in cifre LE MALATTIE CARDIO VASCOLARI Le malattie cardiovascolari ogni anno provocano oltre 17 milioni di decessi (7,2
Lo studio DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study): risultati della coorte italiana
 Giornale Italiano di Nefrologia / Anno 22 n. 5, 2005 / pp. 494-502 Fatti, Opinioni e Altro Lo studio DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study): risultati della coorte italiana G. Pontoriero
Giornale Italiano di Nefrologia / Anno 22 n. 5, 2005 / pp. 494-502 Fatti, Opinioni e Altro Lo studio DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study): risultati della coorte italiana G. Pontoriero
Workshop Clinici Interattivi
 Associazione Medici Endocrinologi AME 2003-3 Congresso Nazionale Palermo, 7-9 novembre 2003 Workshop Clinici Interattivi Evidenze scientifiche e pratica clinica Interventi efficaci Zona grigia Interventi
Associazione Medici Endocrinologi AME 2003-3 Congresso Nazionale Palermo, 7-9 novembre 2003 Workshop Clinici Interattivi Evidenze scientifiche e pratica clinica Interventi efficaci Zona grigia Interventi
AULA ROSSA STUDI CLINICI IN CORSO
 Terza Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche AULA ROSSA STUDI CLINICI IN CORSO Che cosa è uno studio clinico e a cosa serve? Si definisce sperimentazione clinica,
Terza Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche AULA ROSSA STUDI CLINICI IN CORSO Che cosa è uno studio clinico e a cosa serve? Si definisce sperimentazione clinica,
Sabato 21 Febbraio 2015 TITOLO DEL CORSO: Novità nella gestione e nella terapia di alcune patologie croniche
 AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO MEDICI DI MEDICINA GENERALE Sabato 21 Febbraio 2015 TITOLO DEL CORSO: Novità nella gestione e nella terapia di alcune patologie croniche Responsabile del corso Dr. : Tesei Fiorenzo
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO MEDICI DI MEDICINA GENERALE Sabato 21 Febbraio 2015 TITOLO DEL CORSO: Novità nella gestione e nella terapia di alcune patologie croniche Responsabile del corso Dr. : Tesei Fiorenzo
L Audit clinico come strumento di miglioramento continuo delle prestazioni assistenziali
 L Audit clinico come strumento di miglioramento continuo delle prestazioni assistenziali WE CANNOT CHANGE THE PAST, BUT YOU CAN CHANGE THE FUTURE (Pat Patfoort) Miglioramento della pratica clinica Cercare
L Audit clinico come strumento di miglioramento continuo delle prestazioni assistenziali WE CANNOT CHANGE THE PAST, BUT YOU CAN CHANGE THE FUTURE (Pat Patfoort) Miglioramento della pratica clinica Cercare
Per una Medicina Condivisa. Dott.ssa Elena Fachinat 2 aprile 2011
 Per una Medicina Condivisa Dott.ssa Elena Fachinat 2 aprile 2011 Per una Medicina Condivisa SULL EFFICACIA DI UNA TERAPIA SULLA SICUREZZA DI UNA TERAPIA SULL INUTILITA DI UNA TERAPIA CON LA DONNA IN GRAVIDANZA
Per una Medicina Condivisa Dott.ssa Elena Fachinat 2 aprile 2011 Per una Medicina Condivisa SULL EFFICACIA DI UNA TERAPIA SULLA SICUREZZA DI UNA TERAPIA SULL INUTILITA DI UNA TERAPIA CON LA DONNA IN GRAVIDANZA
TOTALE CLASSI D'ETA' SESSO uomini. donne ISTRUZIONE nessuna/elementare. media inferiore media superiore. laurea DIFF.
 Ipercolesterolemia L ipercolesterolemia, come l ipertensione, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le cardiopatie ischemiche e le malattie cerebrovascolari sul quale è possibile intervenire
Ipercolesterolemia L ipercolesterolemia, come l ipertensione, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le cardiopatie ischemiche e le malattie cerebrovascolari sul quale è possibile intervenire
I pazienti con diabete di tipo 1 sono in gran parte giovani, ma sono una piccola minoranza rispetto al totale. La maggior parte dei diabetici,
 DIABETE Per quali pazienti diabetici è indicato il trapianto di rene? I pazienti diabetici più comunemente inseriti in lista di trapianto renale sono quelli in cui il diabete è dovuto a un'insufficiente
DIABETE Per quali pazienti diabetici è indicato il trapianto di rene? I pazienti diabetici più comunemente inseriti in lista di trapianto renale sono quelli in cui il diabete è dovuto a un'insufficiente
RASSEGNA STAMPA SCENARIO DIABETOLOGIA
 RASSEGNA STAMPA SCENARIO DIABETOLOGIA Aggiornamento 26 aprile 2016 Sommario TESTATA TITOLO DATA ILFARMACISTAONLINE.IT Diabete tipo1. Rischio di epilessia triplicato 18/04/2016 QUOTIDIANOSANITA.IT Il diabete
RASSEGNA STAMPA SCENARIO DIABETOLOGIA Aggiornamento 26 aprile 2016 Sommario TESTATA TITOLO DATA ILFARMACISTAONLINE.IT Diabete tipo1. Rischio di epilessia triplicato 18/04/2016 QUOTIDIANOSANITA.IT Il diabete
Stato nutrizionale e abitudini alimentari
 Stato nutrizionale e abitudini alimentari La situazione nutrizionale di una popolazione è un determinante importante delle sue condizioni di salute. In particolare l eccesso di peso, favorendo l insorgenza
Stato nutrizionale e abitudini alimentari La situazione nutrizionale di una popolazione è un determinante importante delle sue condizioni di salute. In particolare l eccesso di peso, favorendo l insorgenza
EXPO 2015 IL FUTURO DELLA SALUTE MENTALE MILANO LUGLIO E la psicoterapia una scienza? E anche una scienza utile per la società?
 EXPO 2015 IL FUTURO DELLA SALUTE MENTALE MILANO 19-20 LUGLIO 2015 E la psicoterapia una scienza? E anche una scienza utile per la società? Aristide Saggino Scuola di Medicina e Scienze della Salute Laboratorio
EXPO 2015 IL FUTURO DELLA SALUTE MENTALE MILANO 19-20 LUGLIO 2015 E la psicoterapia una scienza? E anche una scienza utile per la società? Aristide Saggino Scuola di Medicina e Scienze della Salute Laboratorio
Dùtor, a mè gnù la prospera! Operetta (non proprio comica) in due atti
 Operetta (non proprio comica) in due atti ATTO PRIMO 1. il quesito ATTO SECONDO 5. il quesito ATTO PRIMO 4. la risposta Il caso clinico ATTO PRIMO 2. il PICO ATTO SECONDO 6. la risposta ATTO PRIMO 3. la
Operetta (non proprio comica) in due atti ATTO PRIMO 1. il quesito ATTO SECONDO 5. il quesito ATTO PRIMO 4. la risposta Il caso clinico ATTO PRIMO 2. il PICO ATTO SECONDO 6. la risposta ATTO PRIMO 3. la
Fedra Mori UOC Endocrinologia Ospedale Sant Andrea Roma. Bari, 7-10 novembre 2013
 Fedra Mori UOC Endocrinologia Ospedale Sant Andrea Roma Bari, Cancro della mammella Bari, Il cancro della mammella è una neoplasia ormono-sensibile Nel mondo è la seconda causa di morte dopo il tumore
Fedra Mori UOC Endocrinologia Ospedale Sant Andrea Roma Bari, Cancro della mammella Bari, Il cancro della mammella è una neoplasia ormono-sensibile Nel mondo è la seconda causa di morte dopo il tumore
PIANO FORMATIVO 2012 PROVIDER: FENIX ID 331
 I FATTORI DI RISCHIO IMA E ANGINA: DALLA PREVENZIONE ALLA GESTIONE DEL PAZIENTE INFARTUATO PIANO FORMATIVO PROVIDER: FENIX ID 331 METODOLOGIA SEDE Corso residenziale Valenza Poliambulatorio Valenza Medica
I FATTORI DI RISCHIO IMA E ANGINA: DALLA PREVENZIONE ALLA GESTIONE DEL PAZIENTE INFARTUATO PIANO FORMATIVO PROVIDER: FENIX ID 331 METODOLOGIA SEDE Corso residenziale Valenza Poliambulatorio Valenza Medica
Infortuni domestici. Quante persone si sono infortunate?
 Infortuni domestici Gli infortuni domestici rappresentano un problema di interesse rilevante per la sanità pubblica, sia dal punto di vista della mortalità e della morbosità che da tali eventi consegue,
Infortuni domestici Gli infortuni domestici rappresentano un problema di interesse rilevante per la sanità pubblica, sia dal punto di vista della mortalità e della morbosità che da tali eventi consegue,
Prevenire le complicanze del diabete: come? Donata Richini
 Prevenire le complicanze del diabete: come? Donata Richini Capo di Ponte, 17 marzo 2013 Nel MONDO: 2011 = 366 milioni 2030 = 552 milioni IDF. Diabetes Atlas 5 th Ed. 2011 *Health in european Union:
Prevenire le complicanze del diabete: come? Donata Richini Capo di Ponte, 17 marzo 2013 Nel MONDO: 2011 = 366 milioni 2030 = 552 milioni IDF. Diabetes Atlas 5 th Ed. 2011 *Health in european Union:
Il ruolo attivo del distretto per la prevenzione ed i buoni stili di vita
 Il ruolo attivo del distretto per la prevenzione ed i buoni stili di vita L importanza di un corretto stile di vita per il trattamento del paziente diabetico Giuseppina Floriddia Prevalenza di diabete
Il ruolo attivo del distretto per la prevenzione ed i buoni stili di vita L importanza di un corretto stile di vita per il trattamento del paziente diabetico Giuseppina Floriddia Prevalenza di diabete
Confronti e Commenti alle Linee Guida sull'anemia
 Confronti e Commenti alle Linee Guida sull'anemia 00064 Autori Francesco Locatelli Massimo Morosetti (redattore) Giovanni Cancarini (redattore) Mariano Feriani (redattore) Contenuti 1. Abstract 2. Introduzioe
Confronti e Commenti alle Linee Guida sull'anemia 00064 Autori Francesco Locatelli Massimo Morosetti (redattore) Giovanni Cancarini (redattore) Mariano Feriani (redattore) Contenuti 1. Abstract 2. Introduzioe
In questa diapositiva vengono riportate alcune informazioni circa il paziente oggetto del caso clinico. Si discuterà di un uomo di 77 anni, con
 1 In questa diapositiva vengono riportate alcune informazioni circa il paziente oggetto del caso clinico. Si discuterà di un uomo di 77 anni, con malattia renale cronica in stadio CKD 5 n-d, che inizia
1 In questa diapositiva vengono riportate alcune informazioni circa il paziente oggetto del caso clinico. Si discuterà di un uomo di 77 anni, con malattia renale cronica in stadio CKD 5 n-d, che inizia
Capitolo 4. Le nuove linee guida USA (ATP-IV)
 Capitolo 4 Le nuove linee guida USA (ATP-IV) Le nuove linee guida USA (ATP-IV) ATP-IV: gruppi di soggetti candidati al trattamento con statine (Stone NJ et al, ATP-IV panel, Circulation 2013) 3 Pazienti
Capitolo 4 Le nuove linee guida USA (ATP-IV) Le nuove linee guida USA (ATP-IV) ATP-IV: gruppi di soggetti candidati al trattamento con statine (Stone NJ et al, ATP-IV panel, Circulation 2013) 3 Pazienti
Capitolo 3.2. La valutazione economica dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NOACs) nella prevenzione di ictus in pazienti con fibrillazione atriale (SPAF)
 La valutazione economica dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NOACs) nella prevenzione di ictus in pazienti con fibrillazione atriale (SPAF) Analisi di Budget Impact a livello nazionale e regionale 159 Analisi
La valutazione economica dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NOACs) nella prevenzione di ictus in pazienti con fibrillazione atriale (SPAF) Analisi di Budget Impact a livello nazionale e regionale 159 Analisi
CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI
 CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Cognome e Nome Scalia Alfio Data di nascita 04.04.1953 Qualifica Medico Chirurgo Amministrazione ASST MELEGNANO E MARTESANA Incarico attuale Dirigente medico 1 livello
CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Cognome e Nome Scalia Alfio Data di nascita 04.04.1953 Qualifica Medico Chirurgo Amministrazione ASST MELEGNANO E MARTESANA Incarico attuale Dirigente medico 1 livello
Indicatori di performance per le cure primarie nel FVG
 Roma, 15 giugno 2004 Indicatori di performance per le cure primarie nel FVG Antonella Franzo ASS 6 Friuli Occidentale Scopo del progetto Sviluppare un set di indicatori di performance che valutino alcuni
Roma, 15 giugno 2004 Indicatori di performance per le cure primarie nel FVG Antonella Franzo ASS 6 Friuli Occidentale Scopo del progetto Sviluppare un set di indicatori di performance che valutino alcuni
OSSERVATORIO REGIONALE DEL CREDITO E BANCA D ITALIA: UN ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL RAPPORTO BANCHE IMPRESE
 OSSERVATORIO REGIONALE DEL CREDITO E BANCA D ITALIA: UN ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL RAPPORTO BANCHE IMPRESE Dai dati diffusi dalla Banca d Italia permangono sintomi di sofferenza nei finanziamenti
OSSERVATORIO REGIONALE DEL CREDITO E BANCA D ITALIA: UN ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL RAPPORTO BANCHE IMPRESE Dai dati diffusi dalla Banca d Italia permangono sintomi di sofferenza nei finanziamenti
Efficacia del farmaco, valutazione degli effetti collaterali: dalla ricerca alle buone pratiche cliniche
 Efficacia del farmaco, valutazione degli effetti collaterali: dalla ricerca alle buone pratiche cliniche Corrado Barbui WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health and Service Evaluation
Efficacia del farmaco, valutazione degli effetti collaterali: dalla ricerca alle buone pratiche cliniche Corrado Barbui WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health and Service Evaluation
Il Trattamento dell Iperglicemia. nel Paziente Ricoverato. Il Problema dell Iperglicemia. nel Paziente Ricoverato
 Il Trattamento dell Iperglicemia nel Paziente Ricoverato Conegliano, 19 novembre 201 Il Problema dell Iperglicemia nel Paziente Ricoverato Antonio Sacchetta Conegliano Inerzia Terapeutica L atteggiamento
Il Trattamento dell Iperglicemia nel Paziente Ricoverato Conegliano, 19 novembre 201 Il Problema dell Iperglicemia nel Paziente Ricoverato Antonio Sacchetta Conegliano Inerzia Terapeutica L atteggiamento
rischio cardiovascolare
 rischio cardiovascolare rischio cardiovascolare 30 ipertensione arteriosa 31 ipercolesterolemia 32 calcolo del rischio cardiovascolare 33 29 Rischio cardiovascolare Le malattie cardiovascolari rappresentano
rischio cardiovascolare rischio cardiovascolare 30 ipertensione arteriosa 31 ipercolesterolemia 32 calcolo del rischio cardiovascolare 33 29 Rischio cardiovascolare Le malattie cardiovascolari rappresentano
Effetti clinici di un promemoria medico computerizzato nei test di controllo preventivo
 Effetti clinici di un promemoria medico computerizzato nei test di controllo preventivo Eva Toth-Pal, Gunnar H. Nilsson, Anna-Karin Furhoff Clinical effect of computer generated physician reminders in
Effetti clinici di un promemoria medico computerizzato nei test di controllo preventivo Eva Toth-Pal, Gunnar H. Nilsson, Anna-Karin Furhoff Clinical effect of computer generated physician reminders in
Chronic Care Model in salsa tedesca 1. Gavino Maciocco
 Chronic Care Model in salsa tedesca 1 Gavino Maciocco L introduzione del Chronic Care Model (CCM) non ha prodotto solo effetti positivi sulla salute della popolazione tedesca e sul budget delle assicurazioni
Chronic Care Model in salsa tedesca 1 Gavino Maciocco L introduzione del Chronic Care Model (CCM) non ha prodotto solo effetti positivi sulla salute della popolazione tedesca e sul budget delle assicurazioni
Stato nutrizionale e abitudini alimentari della popolazione della città di Rieti e della sua Provincia
 Stato nutrizionale e abitudini alimentari della popolazione della città di Rieti e della sua Provincia Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione;
Stato nutrizionale e abitudini alimentari della popolazione della città di Rieti e della sua Provincia Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione;
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA CORSO DI LAUREA IN DIETISTICA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA CORSO DI LAUREA IN DIETISTICA TESI INTERVENTI SULLO STILE DI VITA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI RELATORE CANDIDATO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA CORSO DI LAUREA IN DIETISTICA TESI INTERVENTI SULLO STILE DI VITA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI RELATORE CANDIDATO
AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco
 NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON LE AUTORITÀ REGOLATORIE EUROPEE E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Luglio 2013 Restrizione della popolazione target e limitazione della durata del trattamento
NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON LE AUTORITÀ REGOLATORIE EUROPEE E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Luglio 2013 Restrizione della popolazione target e limitazione della durata del trattamento
Uso dei farmaci nel paziente diabetico
 PREVENIRE LE COMPLICANZE DEL DIABETE: DALLA RICERCA DI BASE ALL ASSISTENZA ASSISTENZA Uso dei farmaci nel paziente diabetico Giampiero Mazzaglia Agenzia Regionale di Sanità Toscana & Società Italiana di
PREVENIRE LE COMPLICANZE DEL DIABETE: DALLA RICERCA DI BASE ALL ASSISTENZA ASSISTENZA Uso dei farmaci nel paziente diabetico Giampiero Mazzaglia Agenzia Regionale di Sanità Toscana & Società Italiana di
Lombardia Statistiche Report
 Lombardia Statistiche Report N 9 / 2016 13 dicembre 2016 L incidentalità stradale nel 2015 in Lombardia e nei suoi territori Il trend a livello regionale Nel 2015 gli incidenti stradali che hanno provocato
Lombardia Statistiche Report N 9 / 2016 13 dicembre 2016 L incidentalità stradale nel 2015 in Lombardia e nei suoi territori Il trend a livello regionale Nel 2015 gli incidenti stradali che hanno provocato
IV CONGRESSO REGIONALE ADDIS (Napoli, 14 dicembre 2012)
 IV CONGRESSO REGIONALE ADDIS (Napoli, 14 dicembre 2012) Sostenibilità economica dell appropriatezza terapeutica: il caso delle statine e della terapia dell osteoporosi Luca Degli Esposti, Economista CliCon
IV CONGRESSO REGIONALE ADDIS (Napoli, 14 dicembre 2012) Sostenibilità economica dell appropriatezza terapeutica: il caso delle statine e della terapia dell osteoporosi Luca Degli Esposti, Economista CliCon
Allegato III. Modifiche ai paragrafi pertinenti del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo
 Allegato III Modifiche ai paragrafi pertinenti del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo Nota: Queste modifiche ai paragrafi pertinenti del Riassunto delle Caratteristiche
Allegato III Modifiche ai paragrafi pertinenti del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo Nota: Queste modifiche ai paragrafi pertinenti del Riassunto delle Caratteristiche
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI LECCO
 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI LECCO PRESIDI OSPEDALIERI: LECCO - MERATE BELLANO POLIAMBULATORI: CASATENOVO CALOLZIOCORTE MANDELLO OGGIONO Dipartimento di Area Medica Struttura Complessa di Nefrologia
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI LECCO PRESIDI OSPEDALIERI: LECCO - MERATE BELLANO POLIAMBULATORI: CASATENOVO CALOLZIOCORTE MANDELLO OGGIONO Dipartimento di Area Medica Struttura Complessa di Nefrologia
Negli ultimi anni il concetto di disturbo mentale grave è. diventato comune nei paesi sviluppati. Con tale definizione
 Introduzione Negli ultimi anni il concetto di disturbo mentale grave è diventato comune nei paesi sviluppati. Con tale definizione intendiamo persone che soffrono di disturbi psicotici come la schizofrenia
Introduzione Negli ultimi anni il concetto di disturbo mentale grave è diventato comune nei paesi sviluppati. Con tale definizione intendiamo persone che soffrono di disturbi psicotici come la schizofrenia
Training in Trombosi Società Italiana per lo Studio dell Emostasi e della Trombosi. Introduzione. Cremona settembre 2016
 Training in Trombosi Società Italiana per lo Studio dell Emostasi e della Trombosi Cremona 19-23 settembre 2016 Introduzione Anna Falanga Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo www.siset.org Chi Siamo S
Training in Trombosi Società Italiana per lo Studio dell Emostasi e della Trombosi Cremona 19-23 settembre 2016 Introduzione Anna Falanga Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo www.siset.org Chi Siamo S
Antipneumococcico 13v dopo 6 anni. Nicola Principi
 Antipneumococcico 13v dopo 6 anni Nicola Principi from CDC website, 2014 * * From CDC website 2014 *Serotypes 1,3,5,7F,19A from CDC website, 2014 Clinical and economic impact of routine infant vaccination
Antipneumococcico 13v dopo 6 anni Nicola Principi from CDC website, 2014 * * From CDC website 2014 *Serotypes 1,3,5,7F,19A from CDC website, 2014 Clinical and economic impact of routine infant vaccination
PREVENZIONE SECONDARIA
 PREVENZIONE SECONDARIA dell ictus ischemico N. Lovera, Neurologia, Ospedale G. Bosco Dalla malattia al..futuro Consapevolezza Pregiudizi Affollamento terapeutico Pericolosità dei farmaci Identificazione
PREVENZIONE SECONDARIA dell ictus ischemico N. Lovera, Neurologia, Ospedale G. Bosco Dalla malattia al..futuro Consapevolezza Pregiudizi Affollamento terapeutico Pericolosità dei farmaci Identificazione
Sistema di sorveglianza Passi
 Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia Sistema di sorveglianza Passi Screening per il tumore del collo dell utero periodo 2010-2013 Valle d Aosta Diagnosi precoce delle neoplasie del
Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia Sistema di sorveglianza Passi Screening per il tumore del collo dell utero periodo 2010-2013 Valle d Aosta Diagnosi precoce delle neoplasie del
SIEDP JOURNAL CLUB DIABETE. Maggio 2012
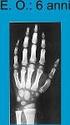 SIEDP JOURNAL CLUB DIABETE Maggio 2012 Commento su: Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basalbolus treatment with mealtime insulin aspart in type 1 diabetes
SIEDP JOURNAL CLUB DIABETE Maggio 2012 Commento su: Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basalbolus treatment with mealtime insulin aspart in type 1 diabetes
Ma si può morire di Crepacuore solamente per una forte emozione?
 Il maggiore errore commesso da molti medici è rappresentato dal tentare di curare il corpo senza occuparsi della mente. La mente ed il corpo sono un tutt unico. Così recitava nel 400 ac Ippocrate. E esperienza
Il maggiore errore commesso da molti medici è rappresentato dal tentare di curare il corpo senza occuparsi della mente. La mente ed il corpo sono un tutt unico. Così recitava nel 400 ac Ippocrate. E esperienza
Quali sono le novità nella terapia ormonale sostitutiva nell insufficienza delle ghiandole surrenaliche?
 ANDREA GIUSTINA Direttore Cattedra Endocrinologia Università degli Studi di Brescia Quali sono le novità nella terapia ormonale sostitutiva nell insufficienza delle ghiandole surrenaliche? Come da determinazione
ANDREA GIUSTINA Direttore Cattedra Endocrinologia Università degli Studi di Brescia Quali sono le novità nella terapia ormonale sostitutiva nell insufficienza delle ghiandole surrenaliche? Come da determinazione
DATI ISTAT SULLA FORZA LAVORO
 DATI ISTAT SULLA FORZA LAVORO Provincia di Piacenza: Forze di lavoro e tassi di disoccupazione, occupazione e attività, medie annue 2000/2002 2000 2001 2002 FORZE DI LAVORO OCCUPATI 107 110 111 maschi
DATI ISTAT SULLA FORZA LAVORO Provincia di Piacenza: Forze di lavoro e tassi di disoccupazione, occupazione e attività, medie annue 2000/2002 2000 2001 2002 FORZE DI LAVORO OCCUPATI 107 110 111 maschi
LO STATO PONDERALE DEI BAMBINI
 LO STATO PONDERALE DEI BAMBINI L obesità ed il sovrappeso in età evolutiva tendono a persistere in età adulta e a favorire lo sviluppo di gravi patologie quali le malattie cardio-cerebro-vascolari, diabete
LO STATO PONDERALE DEI BAMBINI L obesità ed il sovrappeso in età evolutiva tendono a persistere in età adulta e a favorire lo sviluppo di gravi patologie quali le malattie cardio-cerebro-vascolari, diabete
Le Linee Guida ALS ERC del 2015 non contengono sostanziali cambiamenti rispetto alle precedenti linee guida ERC pubblicate nel 2010
 I Farmaci Tommaso Pellis Anestesia, Terapia Intensiva e C.O. 118 AAS 5 Friuli Occidentale Ospedale Santa Maria degli Angeli Pordenone Direttore: F. Bassi thomas.pellis@gmail.com COI: Nessuno Le Linee Guida
I Farmaci Tommaso Pellis Anestesia, Terapia Intensiva e C.O. 118 AAS 5 Friuli Occidentale Ospedale Santa Maria degli Angeli Pordenone Direttore: F. Bassi thomas.pellis@gmail.com COI: Nessuno Le Linee Guida
Possibilità terapeutiche attuali nelle sindromi mielodisplastiche
 Possibilità terapeutiche attuali nelle sindromi mielodisplastiche Luca Malcovati, Professore Associato di Ematologia, Dipartimento di Ematologia e Oncologia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo & Dipartimento
Possibilità terapeutiche attuali nelle sindromi mielodisplastiche Luca Malcovati, Professore Associato di Ematologia, Dipartimento di Ematologia e Oncologia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo & Dipartimento
VALUTAZIONE E CURA DEL DELIRIUM IN UN GRUPPO DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN UNA UNITA DI CURE SUB ACUTE
 VALUTAZIONE E CURA DEL DELIRIUM IN UN GRUPPO DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN UNA UNITA DI CURE SUB ACUTE Angela Cassinadri, Stefano Boffelli, Sara Tironi, Fabrizio Mercurio, Renzo Rozzini, Marco Trabucchi
VALUTAZIONE E CURA DEL DELIRIUM IN UN GRUPPO DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN UNA UNITA DI CURE SUB ACUTE Angela Cassinadri, Stefano Boffelli, Sara Tironi, Fabrizio Mercurio, Renzo Rozzini, Marco Trabucchi
Prima dei 15 anni il dosaggio di paracetamolo dipende dal peso del bambino e deve essere compreso tra i 10 e i 15 mg/kg/dose; l intervallo tra una
 1 2 Prima dei 15 anni il dosaggio di paracetamolo dipende dal peso del bambino e deve essere compreso tra i 10 e i 15 mg/kg/dose; l intervallo tra una dose e l altra deve essere sempre almeno di 4 ore.
1 2 Prima dei 15 anni il dosaggio di paracetamolo dipende dal peso del bambino e deve essere compreso tra i 10 e i 15 mg/kg/dose; l intervallo tra una dose e l altra deve essere sempre almeno di 4 ore.
Riabilitazione dopo sindrome coronarica acuta
 Riabilitazione dopo sindrome coronarica acuta INTRODUZIONE Le malattie cardiovascolari sono la causa principale di morte e disabilità in tutti i paesi del mondo occidentale,inclusa l Italial Le malattie
Riabilitazione dopo sindrome coronarica acuta INTRODUZIONE Le malattie cardiovascolari sono la causa principale di morte e disabilità in tutti i paesi del mondo occidentale,inclusa l Italial Le malattie
