PRINCIPIO DI GERARCHIA
|
|
|
- Battistina Catalano
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PRINCIPIO DI GERARCHIA 4.1. PRINCIPIO DI GERARCHIA A - Transizioni dalla città al sistema di città: i vari tipi di città come parti di un sistema, vs dicotomie città-campagna (accessibilità) e città resto del mondo (base economica) dalla competitività aggregata alla competitività disaggregata: i vari tipi di funzioni urbane (vs. base) dall approccio micro parziale (primi tre principi) all approccio macro generale (come anche base) B - Interrogativi perché nella realtà coesistono città di diversa dimensione, in una situazione di apparente equilibrio? perché alle diverse dimensioni sembrano corrispondere funzioni economiche differenti? perché tra città di diverse dimensioni intercorrono distanze geografiche differenti?
2 4.2. MODELLI DI CHRISTALLER E DI LOESCH APPROCCIO GEOGRAFICO (Christaller, 1933) A - Obiettivo Esaminare come prodotti e funzioni diverse (di servizio) si articolino sul territorio dando origine a una gerarchia urbana (l analisi della localizzazione e delle aree di mercato rientra nell agglomerazione) B - Ipotesi - spazio isotropo: omogeneo in tutte le direzioni, sia per densità demografica (domanda) che per caratteri fisici (distanza) e infrastrutturali (costi di trasporto) - efficienza spaziale di siti produttivi equidistanti ed aree di mercato esagonali (principio agglomerazione)
3 C - Definizione della gerarchia dei beni - portata (range): distanza massima di vendibilità del bene - soglia (threshold): distanza/area corrispondente alla quantità minima da produrre in modo efficiente si producono tutti e soli i beni con portata > soglia (significa: agglomerazione se economie di scala > costi di trasporto), e la soglia definisce la loro gerarchia D - Definizione della struttura spaziale dei beni (Fig. 4.1 Camagni) - si parte dai beni di ordine superiore: un solo sito produttivo - poi beni di ordine via via inferiore, come segue - localizzazione dei primi siti produttivi ove già esistenti (economie di agglomerazione) - poi copertura delle aree scoperte interstiziali (nuovi siti ai vertici degli esagoni) E - Caratteri della struttura spaziale dei centri - ogni centro maggiore (rango > 1) produce i beni relativi al suo livello gerarchico e tutti i beni di ordine inferiore - per ciascun centro di ordine superiore esiste, a cascata, una pluralità di centri di ordine inferiore, fino al villaggio rurale (rango = 1)
4 F - Principi organizzatori (Fig. 4.1 Camagni) - mercato (k=3) n r+1 = 3 n r (1 r + 6/3 r+1 ): il nuovo sito è al baricentro fra 3 centri - trasporto (k=4) n r+1 = 4 n r (1 r + 6/2 r+1 ): il nuovo sito è al baricentro fra 2 centri (direttr.stradale) - amministrazione (k=7) n r+1 = 7 n r (1 r + 6/1 r+1 ): il nuovo sito è tutto interno all influenza di 1 centro G - Postulati (impliciti in Christaller, esplicitati da Loesch) - comportamento ottimizzante dei consumatori (aree di mercato separate e non sovrapposte) - spazio economico omogeneo ma origine economica delle agglomerazioni - costo di trasporto proporzionale alla distanza - presenza di economie di scala ( soglia minima di produzione ) - copertura completa del territorio: accesso a tutti i beni per tutti i consumatori (equità) H - Empirico (Fig. 4.2 Camagni) definiti esogenamente (con un indice di centralità telefonica) 7 livelli di centri => concordanza notevole con il principio di mercato (parzialmente influenzato da quello di trasporto)
5 APPROCCIO ECONOMICO (Loesch, 1938 e 1940) A - Sviluppi e progressi - fonda sulla (micro-)economia, formalizza (rigorizza), generalizza (flessibilizza) - ipotesi consuete, più una maglia triangolare di insediamenti agricoli pre-esistenti (esogena) - costruzione della struttura spaziale dei beni (siti produttivi equidistanti e aree di mercato esagonali) come esito del (in base al) modello di concorrenza monopolistica di Chamberlin, quindi - esplicite, ma esogene funzioni di costo e di domanda individuale, e - equilibrio stabile attraverso la libertà di entrata
6 B - Principi organizzatori (Fig. 4.3 Camagni) Modi di sovrapposizione fra le strutture spaziali di beni diversi => => non esistono solo 3 principi organizzatori ma almeno 10, corrispondenti a soglie crescenti: k = 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21, per k: n aree mercato inscritte in area superiore; a: distanza fra centri agricoli; R: numero max di ranghi Rango r r R Numero centri di r n r 1 k 0 (k-1) k 1 (k-1) k 2 (k-1) k 3 (k-1) k r-1 (k-1) k R-1 (k-1 Numero aree mercato N k 0 k 1 k 2 k 3 k 4 k r k R Distanza fra centri di r d r avk R avk R-1 avk R-2 avk R-3 avk R-4 avk R-r a
7 C - Struttura spaziale dei centri (Figura Camagni) - non è vero che k è costante: può variare lungo la gerarchia => Loesch è meno rigido di Christaller - non è vero che ogni centro svolga tutte le funzioni inferiori => Loesch è meno meccanicistico (ma meno elegante) di Christaller => quindi centri dello stesso rango hanno differente mix produttivo e addirittura differente numero di funzioni => solo per la metropoli (a priori) vale questa regola di Christaller: su di essa si imperniano tutte le reti di siti produttivi (il modello non spiega la centralità della metropoli) - Loesch fa ruotare le reti per ottenere massima coincidenza delle localizzazioni (massime economie agglomerazione) e massima densità dei centri in settori circolari (minimi costi di trasporto) D - Empirico Definiti 6 livelli di centri e k=4 => quasi perfetta concordanza => => ma in realtà sottopone a verifica Christaller con k=4!
8 4.3. CONSIDERAZIONI CRITICHE VALIDITA RELATIVA DEI DUE MODELLI A forza: da due soli elementi genetici (economie di scala e costi di trasporto) e nessuna eterogeneità spaziale esogena (fisica economica) a spazio eterogeneo e ordinato entrambi: ipotesi di ottimizzazione (min costi trasporto per consumatore, max n produttori, max economie agglomerazione = min n centri, max profitti per produttore) => modello di equilibrio spaziale generale => soluzioni razionali e normative, con riscontro empirico (centralità della produzione) B Christaller: sistema basato sulla produzione di servizi (costi di trasporto sopportati dai consumatori, economie di scala poco evidenti, chiare soglie gerarchiche) C Loesch: sistema basato su produzioni industriali (importanza economie di scala e ev. localizzazione per specializzazione) MA costi di trasporto oggi irrilevanti e varietà (differenziazione orizzontale) => aree di mercato sovrapposte (commercio orizzontale)
9 LIMITI Non è vero equilibrio generale, anzi logica interna contraddittoria: gerarchia di centri senza vere città a) sola produzione: domanda esogena => ipotesi D omogenea in spazio vs esito agglomerato in centri di O b) costi indipendenti da localizzazione => assenza economie di localizzazione => solo presenza/assenza c) no interdipendenza settoriale (vs ) => sottovalutazione economie di urbanizzazione d) condizione necessaria dimostrata (L.), ma non esistenza, unicità, stabilità => ingeneroso (complessità)
10 4.4. EVOLUZIONE DELLA GERARCHIA E RETI DI CITTA APPLICAZIONI DEL MODELLO DI GERARCHIA Non è astratto: numerose applicazioni empiriche (descrittive, falsificative, normative) MA la distribuzione della dimensione dei centri è continua (vedi 4.5): come articolare i centri in classi e definirne i confini? Analisi multivariate di coesistenza tra funzioni/settori e di loro presenza/assenza per predeterminare classi di servizi e di centri (p.es. doppia analisi fattoriale in Somea, 1973 (C.) e 1987 (L.) : Tab. 4.1 Camagni) aspetti gerarchia urbana: nazionale e regionale / intra-metropolitana / intra-funzionale per qualità
11 EVOLUZIONE DELLA GERARCHIA URBANA Il modello è statico, ma dall analisi della sua logica => riflessioni di statica comparata (quasi-dinamica) Fattori di cambiamento inducono mutamenti nell equilibrio tra econ. scala e costi tpt (Tab Camagni) - variazione reddito pro capite => densità domanda => extra-profitti => entrate => distanza fra centri - variazione densità demografica => densità domanda => extra-profitti => entrate => distanza fra centri - variazione costi trasporto (<0) => nel b.p. effetto reddito: v. sopra; nel l.p. effetto sostituzione: v. sotto - variazione economie di scala ossia soglia (>0) => uscite => concentrazione - variazione soglia (<0) => entrate => diffusione Analisi empirica (medio-lungo periodo, per effetti): compresenza di fattori di cambiamento => => spinte in direzioni differenti MA economie di scala, automobile => => gerarchizzazione metropoli e rurali
12 MODELLO DI STATICA COMPARATA (Parr, 1981) A - Esplorazione dei modi di mutamento della gerarchia in un sistema urbano a k variabile (Loesch), mantenendo l ipotesi di inclusività funzionale (Christaller) in quanto realistica: a) formazione di livelli successivi della gerarchia in sequenza temporale b) mutamento nella allocazione delle funzioni economiche all interno dei diversi livelli gerarchici c) modificazioni nella struttura gerarchica (numero di livelli funzionali associati alle diverse dimensioni) B - Formazione di livelli successivi crescente differenziazione funzionale e divisione spaziale del lavoro => dai più bassi ai più alti aumento della densità demografica (e/o economica) => dai più alti ai più bassi
13 C - Riallocazione delle funzioni economiche all interno di un livello muta la composizione funzionale da centro a centro, ma non muta la gerarchia dei centri D - Modificazioni nella struttura gerarchica (Fig. 4.6 Camagni) i) formazione di un nuovo livello della gerarchia (per aumento della domanda o delle economie di scala in alcune funzioni tipiche) intermedio fra l esistente e quello superiore ii) modificazione dell estensione dell area di mercato di un livello in tutte le funzioni tipiche (p.es. per aumento delle economie di scala in tutte le funzioni), con declino gerarchico di alcuni centri iii) scomparsa di un livello (tutte le funzioni tipiche sono producibili dal livello inferiore, oppure tutti i centri acquisiscono le funzioni del livello superiore) Conclusione: il progresso tecnico e i processi innovativi fanno mutare la struttura del sistema di città
14 DALLA GERARCHIA ALLE RETI DI CITTA A Perché dal 1970 crescono i centri di dimensione intermedia tra le capitali e i centri rurali? Ipotesi di mutamenti qualitativi nei rapporti gerarchici urbani: struttura intermedia di centri con accentuata specializzazione produttiva, interdipendenze orizzontali, assenza di gerarchia interna (Fig. 4.7 Camagni) B Elementi di spiegazione di tali mutamenti strutturali (in sequenza logica): i) propensione localizzativa non-metropolitana dell industria => specializzazione senza gerarchia ii) economie di localizzazione intra-industriali (distretti di pmi) => specializzazione vs. differenziazione iii) riduzione della soglia (dimensione minima efficiente) <= passaggio dal paradigma meccanico fordista al paradigma micro-elettronico flessibile => funzioni di alto rango in centri di basso rango iv) crisi (fiscale, organizzativa, economica) della grande città dal 1970 => disurbanizzazione v) omogeneizzazione delle condizioni di infrastrutturazione non-metropolitana (inclusa l istruzione) vi) negligibilità del costo di trasporto => abbandono del principio areale (gravitazionale) d organizzazione dei mercati => principio reticolare (topologico) fisico e relazionale ( più sinergia, meno gerarchia )
15 C Quindi declino di Christaller (agri-commercio-burocrazia) e ascesa di Loesch (pseudo-gerarchia): a) ancora gerarchia ai ranghi alti (mercati di terziario avanzato e controllo) del sistema di città, MA più piatta (k elevato) di quelle di Christaller b) ancora gerarchia areale, MA per aree di mercato di risorse immobili (risorse naturali) o ad alto costo di trasporto (lavoro) e non più per aree di mercato di prodotti c) centri di rango medio specializzati (vocazioni industriali o terziarie per mercati non locali: turismo), MA con rapporti orizzontali
16 D Oppure verso nuovo paradigma interpretativo dei mutamenti strutturali (paradigma reticolare): a) reti di città: rapporti/flussi orizzontali (tra città senza rapporti nel modello classico) b) reti di complementarità (specializzazioni differenti: Dematteis) o di sinergia (stesse specializzazioni) c) motivate da vantaggi specifici (diversi da economie di scala o di agglomerazione): => specializzazione o divisione del lavoro territoriale: integrazione orizz. (distretto) e vert. (filiera) => esternalità di rete (club esclusivi, p.es. integrazione telematica) d) reti di innovazione come caso particolare di reti di sinergia (condivisione costi fissi di investimento) e) permanenza della gerarchia, sia per ragioni di inerzia storica (e vantaggi consolidati) sia perché più appropriata per certe attività f) quindi gerarchia di reti: rete di primo livello (sinergica) delle città mondiali, rete di secondo livello (complementare) delle città specializzate nazionali, rete di terzo livello (complementare) delle città specializzate regionali
17 E Il paradigma mercantile (Vance, 1970) Fondato sul commercio a lunga distanza su reti specifiche (comunicazione, trasporto) tra soggetti tutti a monte del consumo finale Procede dall atto esogeno della costruzione di avamposti in nuovi territori (mercati potenziali) a stadi finalizzati (esplorazione, raccolta, insediamento, logistica) che creano allineamenti prima che si sviluppi l organizzazione a località centrali Empiricamente (Fig. 4.8 Camagni), spiega bene lo sviluppo urbano delle aree toccate dalla colonizzazione europea, islamica o cinese; manca però di solida logica teorica Presentato come alternativa al modello delle località centrali, è complementare più che sostitutiva: il merito sta nel mettere in rilievo la natura della città come nodo di relazioni anche a lunga distanza
18 4.5. DISTRIBUZIONE DELLE DIMENSIONI URBANE (RANK-SIZE RULE) A Dall analisi micro (comportamento dei singoli soggetti) all analisi macro del sistema urbano La regola rango - dimensione (rank - size) fu scoperta da Auerbach (1913) con b=1, perfezionata da Lotka (1924) e Gibrat con formulazione loglineare, applicata sistematicamente e popolarizzata da Zipf (1949) B Formulazione ed applicazione empirica Per ogni centro di rango r il prodotto di dimensione P e rango r è costante: P r. r = P 1. 1 = P* ove P* = P 1 o più in generale P r = P* / r b ove b può variare intorno all unità in forma logaritmica (stimabile) log P r = log P* - b. log r La regola è una uniformità empirica quasi perfettamente valida in tutti i sistemi economici urbani: empiricamente, esclusi i centri rurali, la correlazione tra legge è realtà è quasi perfetta
19 C Interpretazioni Zipf (1949): è il risultato stocastico di due forze, derivanti dal principio del minimo sforzo : i) forza di unificazione, o concentrazione, legata alle economie di scala ii) forze di diversificazione, o diffusione, legata alla minimizzazione dei costi di trasporto Simon (1955): è esempio (come la distribuzione dei redditi) della legge probabilistica dell effetto proporzionale : la crescita assoluta è proporzionale alla dimensione e il tasso di crescita ne è indipendente D La regola e i modelli teorici di gerarchia urbana sono compatibili (Beckmann, 1958) se: a) si consente una distribuzione casuale dei centri di ogni livello attorno al valore teorico b) si confrontano i prodotti di dimensione della città mediana e rango (costanti) oppure si interpretano gli scostamenti dalla distribuzione loglineare come reminiscenze di ranghi teorici
20 4.6. GERARCHIA, DIPENDENZA, DOMINAZIONE TERRITORIALE A - Gerarchia => rapporto non equilibrato fra partners => => potere: funzioni strategiche o attività direttive, non solo economico-funzionali (mercato scambi) ma di controllo (finanziario, organizzativo) e leadership B - Rinvio a sociologia e politologia, ma anche all economia classica (pre-marginalista) i) analisi dei prezzi relativi e dei fattori di appropriazione del surplus ii) teoria della distribuzione del reddito: remunerazioni differenti dei fattori produttivi (nello spazio) iii) modi di orientamento della distribuzione del reddito da parte dei decisori di localizzazioni, tecniche, investimenti, allocazioni (scelte tecnologia produttiva e contenuto prodotti e stili di vita: tutti pro-urbani)
21 C - Fondamenti di una teoria della dominazione o del potere i) dipendenza commerciale: scambio unidirezionale lungo la gerarchia (in Chr., meno in Loesch o Dem.) ii) sfruttamento imperfezioni mercato beni finali: relazione inversa rango elasticità D, e rarità O: p > cm iii) sfruttamento imperfezioni mercato risorse, anche intermedie (filiera del comando): la qualità (specie informazione e direzionalità) sposta il prezzo da costo di produzione (offerta) a valore d uso (domanda) iv) controllo: in acquisizione, allocazione, localizzazione risorse (inclusa info), lucrando su non trasparenza del mercato e vischiosità degli aggiustamenti (interessi, profitti, royalties, rendite) v) leadership: orientamento al futuro, contesto dinamico (analisi non strettamente economica) D Analizzabilità economica: la gerarchia non ha autonomia istituzionale: a) non può essere gestita con puri rapporti di forza b) si fonda e legittima in rapporti funzionali, di cui è la controfaccia distributiva, nello spazio (ottimizzazione dell uso dello spazio, divisione territoriale del lavoro)
ECONOMIA URBANA. Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre. Contatti:
 ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it ECONOMIA URBANA E REGIONALE Economia Urbana 2 TEORIA DELLA LOCALIZZAZIONE Economia Urbana
ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it ECONOMIA URBANA E REGIONALE Economia Urbana 2 TEORIA DELLA LOCALIZZAZIONE Economia Urbana
Le reti di città. IR8R Istituto Regionale di Rtcerca della Lombardia. FrancoAngeli. Teoria, politiche e analisi nell'area padana
 . Le reti di città Teoria, politiche e analisi nell'area padana FrancoAngeli IR8R Istituto Regionale di Rtcerca della Lombardia T I ' Istituto Universitario Architettura Venezia ASU 152 Servizio Bibliografico
. Le reti di città Teoria, politiche e analisi nell'area padana FrancoAngeli IR8R Istituto Regionale di Rtcerca della Lombardia T I ' Istituto Universitario Architettura Venezia ASU 152 Servizio Bibliografico
Geografia del made in Italy
 Geografia del made in Italy Geografia del made in Italy http://www.memotef.uniroma1.it/node/6785 Filippo Celata (filippo.celata@uniroma1.it) 3 ottobre 21 dicembre 2016 (lunedì, martedì, mercoledì, 16-18,
Geografia del made in Italy Geografia del made in Italy http://www.memotef.uniroma1.it/node/6785 Filippo Celata (filippo.celata@uniroma1.it) 3 ottobre 21 dicembre 2016 (lunedì, martedì, mercoledì, 16-18,
organizzazione sociale separazione tra luoghi di produzione e luoghi di consumo sistema economico con dimensione spaziale
 Economisti del XVI e XVIII secolo Cantillion, Quesnay, fisiocratici terra possesso e coltivazione della terra proprietario agricolo 2 tipi di relazioni: relazioni verticali relazioni orizzontali Costi
Economisti del XVI e XVIII secolo Cantillion, Quesnay, fisiocratici terra possesso e coltivazione della terra proprietario agricolo 2 tipi di relazioni: relazioni verticali relazioni orizzontali Costi
Economia Industriale Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale. Introduzione
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Economia Industriale Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale Introduzione Prof. Gianmaria Martini Oggetto di analisi Economia Industriale: Comportamento delle imprese
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Economia Industriale Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale Introduzione Prof. Gianmaria Martini Oggetto di analisi Economia Industriale: Comportamento delle imprese
L economia periferica
 L economia periferica Anni 60 e 70: tesi sul decentramento produttivo crescenti rigidità della grande impresa piccola impresa funzionale al meccanismo di accumulazione piccola impresa NON morfologicamente
L economia periferica Anni 60 e 70: tesi sul decentramento produttivo crescenti rigidità della grande impresa piccola impresa funzionale al meccanismo di accumulazione piccola impresa NON morfologicamente
Economia urbana: localizzazione e usi del suolo nelle città (non tutto ciò che accade in città )
 INTRODUZIONE ALL ECONOMIA URBANA (evans) Economia urbana: localizzazione e usi del suolo nelle città (non tutto ciò che accade in città ) Nasce in risposta alla congestione del traffico: l offerta varia
INTRODUZIONE ALL ECONOMIA URBANA (evans) Economia urbana: localizzazione e usi del suolo nelle città (non tutto ciò che accade in città ) Nasce in risposta alla congestione del traffico: l offerta varia
Il sistema produttivo italiano. I fatti e le loro rappresentazioni
 Il sistema produttivo italiano I fatti e le loro rappresentazioni Crisi petrolifera del 1973 crisi idea di modernità sviluppo inteso come percorso lineare Italia diversa da un paese proteso verso la modernità
Il sistema produttivo italiano I fatti e le loro rappresentazioni Crisi petrolifera del 1973 crisi idea di modernità sviluppo inteso come percorso lineare Italia diversa da un paese proteso verso la modernità
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
 1 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE A.A. 2008/09 PAROLE CHIAVE PARTE GENERALE ECONOMIA GESTIONE IMPRESE ORGANIZZAZIONE STABILE PERSONE E MEZZI PROCESSI DI PRODUZIONE BENI/SERVIZI SCAMBIO PRODUZIONE RICCHEZZA
1 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE A.A. 2008/09 PAROLE CHIAVE PARTE GENERALE ECONOMIA GESTIONE IMPRESE ORGANIZZAZIONE STABILE PERSONE E MEZZI PROCESSI DI PRODUZIONE BENI/SERVIZI SCAMBIO PRODUZIONE RICCHEZZA
Indice. Presentazione. Capitolo 1
 Presentazione XIII Capitolo 1 Capitolo 2 Il sistema economico: i soggetti e le interdipendenze 1 1. Il sistema economico 1 2. La teoria economica 3 3. Un modello economico disaggregato: i comportamenti
Presentazione XIII Capitolo 1 Capitolo 2 Il sistema economico: i soggetti e le interdipendenze 1 1. Il sistema economico 1 2. La teoria economica 3 3. Un modello economico disaggregato: i comportamenti
ECONOMIA URBANA. Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre. Contatti:
 ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it ECONOMIA URBANA E REGIONALE Economia Urbana 2 INTRODUZIONE L attività economica nasce, cresce
ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it ECONOMIA URBANA E REGIONALE Economia Urbana 2 INTRODUZIONE L attività economica nasce, cresce
Economia Industriale. Lezione 4
 Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro Facoltà di Economia A.A. 2005/2006 Economia Industriale Dott. Massimiliano Piacenza Lezione 4 Concorrenza perfetta Evidenza empirica Selezione competitiva
Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro Facoltà di Economia A.A. 2005/2006 Economia Industriale Dott. Massimiliano Piacenza Lezione 4 Concorrenza perfetta Evidenza empirica Selezione competitiva
Paolo Depaoli. Supporti alle lezioni basate sul capitolo 8 del testo «La progettazione organizzativa» (a cura di Franco Isotta)
 http://it.123rf.com/photo_23991404_cerchio-da-simbolimusicali.html?fromid=bkvnlzzerkhmou9ys3juwwm1yje0ut09 Paolo Depaoli Supporti alle lezioni basate sul capitolo 8 del testo «La progettazione organizzativa»
http://it.123rf.com/photo_23991404_cerchio-da-simbolimusicali.html?fromid=bkvnlzzerkhmou9ys3juwwm1yje0ut09 Paolo Depaoli Supporti alle lezioni basate sul capitolo 8 del testo «La progettazione organizzativa»
PRINCIPIO DI ACCESSIBILITA
 PRINCIPIO DI ACCESSIBILITA 2.1. PRINCIPIO DI ACCESSIBILITA A - Definizione Superamento della barriera imposta dallo spazio ai movimenti e agli scambi Assenza di costi di trasporto/transazione => disponibilità
PRINCIPIO DI ACCESSIBILITA 2.1. PRINCIPIO DI ACCESSIBILITA A - Definizione Superamento della barriera imposta dallo spazio ai movimenti e agli scambi Assenza di costi di trasporto/transazione => disponibilità
L affermazione dei modelli di sviluppo post-industriale
 L affermazione dei modelli di sviluppo post-industriale Il rapporto tra attività produttive e territorio negli ultimi due decenni è andato in contro a profonde modificazioni a causa di tre fenomeni interdipendenti:
L affermazione dei modelli di sviluppo post-industriale Il rapporto tra attività produttive e territorio negli ultimi due decenni è andato in contro a profonde modificazioni a causa di tre fenomeni interdipendenti:
Indice. Presentazione dell edizione italiana Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura
 Indice Presentazione dell edizione italiana Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura PARTE I Concetti di base XI XII XIII 1 Le basi dell economia 1 1.1 Introduzione 1 1.1.1 Scarsità ed efficienza:
Indice Presentazione dell edizione italiana Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura PARTE I Concetti di base XI XII XIII 1 Le basi dell economia 1 1.1 Introduzione 1 1.1.1 Scarsità ed efficienza:
13 Capitolo I La natura e lo scopo della microeconomia. 35 Capitolo II L utilità cardinale e la scelta del consumatore
 5 Indice 11 Prefazione 13 Capitolo I La natura e lo scopo della microeconomia 1.1. Come insegnare la microeconomia, 13-1.2. La dimensione spaziale della microeconomia, 15-1.3. L efficacia della teoria
5 Indice 11 Prefazione 13 Capitolo I La natura e lo scopo della microeconomia 1.1. Come insegnare la microeconomia, 13-1.2. La dimensione spaziale della microeconomia, 15-1.3. L efficacia della teoria
In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio.
 In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. Domande a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. Domande a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
le regole dell organizzazione
 le regole dell organizzazione Lo sviluppo organizzativo tra soggetti e ambienti Antonio D Antonio ad est dell equatore 395 Indice p.9 Ringraziamenti p.11 Premessa p.15 Prima sezione La definizione del
le regole dell organizzazione Lo sviluppo organizzativo tra soggetti e ambienti Antonio D Antonio ad est dell equatore 395 Indice p.9 Ringraziamenti p.11 Premessa p.15 Prima sezione La definizione del
Teoria e metodologia estimativa
 Teoria e metodologia estimativa Prof. Stefano Stanghellini Collaboratore: Arch. Alessandro Mascarello Una definizione di Estimo L Estimo è la parte della scienza economica definibile come l insieme dei
Teoria e metodologia estimativa Prof. Stefano Stanghellini Collaboratore: Arch. Alessandro Mascarello Una definizione di Estimo L Estimo è la parte della scienza economica definibile come l insieme dei
Le economie esterne marshalliane
 Le economie esterne marshalliane Marshall (1842-1924): fenomeni complessi economie esterne di localizzazione (o locali) distinzione fondamentale economie interne economie esterne nuova unità di analisi:
Le economie esterne marshalliane Marshall (1842-1924): fenomeni complessi economie esterne di localizzazione (o locali) distinzione fondamentale economie interne economie esterne nuova unità di analisi:
Geografia della città fordista
 Geografia della città fordista Geografia della città post-fordista Dal monocentrismo al policentrismo - Decentramento produttivo e territoriale; - Dematerializzazione della produzione; - Terziarizzazione
Geografia della città fordista Geografia della città post-fordista Dal monocentrismo al policentrismo - Decentramento produttivo e territoriale; - Dematerializzazione della produzione; - Terziarizzazione
ECONOMIA URBANA. Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre. Contatti:
 ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it LA MICROECONOMIA LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO DEI SINGOLI AGENTI IN UN SISTEMA ECONOMICO Economia
ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it LA MICROECONOMIA LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO DEI SINGOLI AGENTI IN UN SISTEMA ECONOMICO Economia
L organizzazione della banca. Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2013/2014
 L organizzazione della banca Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2013/2014 Premessa L organizzazione dell attività bancaria (attività di impresa svolta in un contesto
L organizzazione della banca Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2013/2014 Premessa L organizzazione dell attività bancaria (attività di impresa svolta in un contesto
L organizzazione urbana
 Fulvio Adobati Seeta Maggi, Andrea Azzini, Michela Lazzarini (cultori della materia) Facoltà di Scienze Umanistiche Corso di Geografia Antropica A.A. 2010/2011 Università degli Studi di Bergamo L organizzazione
Fulvio Adobati Seeta Maggi, Andrea Azzini, Michela Lazzarini (cultori della materia) Facoltà di Scienze Umanistiche Corso di Geografia Antropica A.A. 2010/2011 Università degli Studi di Bergamo L organizzazione
Funzioni della città. Mauro Giovanni Università di Trieste
 Funzioni della città Mauro Giovanni Università di Trieste Le funzioni della città Siccome nessuna città è isolata, un concetto chiave è quello di funzione, ossia del ruolo che la città svolge all interno
Funzioni della città Mauro Giovanni Università di Trieste Le funzioni della città Siccome nessuna città è isolata, un concetto chiave è quello di funzione, ossia del ruolo che la città svolge all interno
Lezione 6 12 marzo 2010
 Lezione 6 12 marzo 2010 Concetti visti Analisi SWOT Richiamo analisi macro-ambiente e attrattività Paese Teorie dipendenza settoriale Paradigma SCP Struttura del settore Forma di mercato Barriere all entrata
Lezione 6 12 marzo 2010 Concetti visti Analisi SWOT Richiamo analisi macro-ambiente e attrattività Paese Teorie dipendenza settoriale Paradigma SCP Struttura del settore Forma di mercato Barriere all entrata
IL VANTAGGIO COMPETITIVO NEI SETTORI MATURI
 IL VANTAGGIO COMPETITIVO NEI SETTORI MATURI 1 Maturità di un settore non significa mancanza di opportunità. I settori maturi costituiscono la spina dorsale delle economie dei paesi industrializzati. Anche
IL VANTAGGIO COMPETITIVO NEI SETTORI MATURI 1 Maturità di un settore non significa mancanza di opportunità. I settori maturi costituiscono la spina dorsale delle economie dei paesi industrializzati. Anche
Commercio internazionale con mercati non concorrenziali. Giuseppe De Arcangelis 2015 Economia Internazionale
 Commercio internazionale con mercati non concorrenziali Giuseppe De Arcangelis 2015 Economia Internazionale 1 Schema della lezione Ripasso di microeconomia: rendimenti di scala crescenti e differenziazione
Commercio internazionale con mercati non concorrenziali Giuseppe De Arcangelis 2015 Economia Internazionale 1 Schema della lezione Ripasso di microeconomia: rendimenti di scala crescenti e differenziazione
Prerequisiti: regole base di derivazione; funzioni a più variabili; derivate parziali; nozione di integrale
 Microeconomia Economia e Finanza Prerequisiti: regole base di derivazione; funzioni a più variabili; derivate parziali; nozione di integrale Introduzione. L oggetto dell economia politica; l oggetto della
Microeconomia Economia e Finanza Prerequisiti: regole base di derivazione; funzioni a più variabili; derivate parziali; nozione di integrale Introduzione. L oggetto dell economia politica; l oggetto della
Il sistema della subfornitura artigiana per il settore dei mezzi di trasporto terrestre in Toscana
 Laboratorio di Economia dell Innovazione Keith Pavitt Il sistema della subfornitura artigiana per il settore dei mezzi di trasporto terrestre in Toscana Regione Toscana Sala Pegaso P.zza del Duomo, 10
Laboratorio di Economia dell Innovazione Keith Pavitt Il sistema della subfornitura artigiana per il settore dei mezzi di trasporto terrestre in Toscana Regione Toscana Sala Pegaso P.zza del Duomo, 10
Lezione 16 Concorrenza perfetta
 Lezione 16 Concorrenza perfetta Le forme di mercato Le condizioni che portano l impresa a decidere prezzi e quantità sono diverse e seconda della forma di mercato Concorrenza perfetta Concorrenza imperfetta
Lezione 16 Concorrenza perfetta Le forme di mercato Le condizioni che portano l impresa a decidere prezzi e quantità sono diverse e seconda della forma di mercato Concorrenza perfetta Concorrenza imperfetta
PRIMA PARTE: POLITICHE MACROECONOMICHE
 PRIMA PARTE: POLITICHE MACROECONOMICHE 1 In questa parte del corso: Utilizzeremo i modelli del corso di Economia politica (macroeconomia) e ne analizzeremo in maggiore profondità le implicazioni di politica
PRIMA PARTE: POLITICHE MACROECONOMICHE 1 In questa parte del corso: Utilizzeremo i modelli del corso di Economia politica (macroeconomia) e ne analizzeremo in maggiore profondità le implicazioni di politica
Struttura di mercato: insieme di elementi che incidono sul comportamento e il rendimento delle imprese di mercato, quali numero di imprese e tipo di
 Struttura di mercato: insieme di elementi che incidono sul comportamento e il rendimento delle imprese di mercato, quali numero di imprese e tipo di bene venduto Concorrenzialità del mercato: dipende dalla
Struttura di mercato: insieme di elementi che incidono sul comportamento e il rendimento delle imprese di mercato, quali numero di imprese e tipo di bene venduto Concorrenzialità del mercato: dipende dalla
Economia delle Imprese Multinazionali
 Economia delle Imprese Multinazionali Geografia economica Davide Castellani Università di Perugia Facoltà di Economia Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica davide.castellani@unipg.it Il successo
Economia delle Imprese Multinazionali Geografia economica Davide Castellani Università di Perugia Facoltà di Economia Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica davide.castellani@unipg.it Il successo
Parte 1 Il modello della concorrenza allargata dott.ssa Francesca Rivetti
 CORSO DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO Parte 1 Il modello della concorrenza allargata dott.ssa Francesca Rivetti Applicazione No. 7 Rapporti tra impresa e ambiente al centro
CORSO DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO Parte 1 Il modello della concorrenza allargata dott.ssa Francesca Rivetti Applicazione No. 7 Rapporti tra impresa e ambiente al centro
Capitolo cinque. La teoria del commercio internazionale. Una visione d insieme sulle teorie del commercio internazionale
 Capitolo cinque La teoria del commercio internazionale Una visione d insieme sulle teorie del commercio internazionale 5-3 Si ha libero scambio quando un governo non cerca di influenzare, con contingentamenti
Capitolo cinque La teoria del commercio internazionale Una visione d insieme sulle teorie del commercio internazionale 5-3 Si ha libero scambio quando un governo non cerca di influenzare, con contingentamenti
3.a STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO SULLA CRESCITA E SULLO SVILUPPO
 3.a STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO SULLA CRESCITA E SULLO SVILUPPO A Mercantilisti e fisiocratici ( 600, 700) Mercantilisti ( 600): la ricchezza viene dalla valuta, ossia dall esportazione (predatoria)
3.a STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO SULLA CRESCITA E SULLO SVILUPPO A Mercantilisti e fisiocratici ( 600, 700) Mercantilisti ( 600): la ricchezza viene dalla valuta, ossia dall esportazione (predatoria)
INDICE CAPITOLO 1 IL SISTEMA ECONOMICO, LE REGOLE E GLI OPERATORI
 INDICE CAPITOLO 1 IL SISTEMA ECONOMICO, LE REGOLE E GLI OPERATORI 1. Introduzione... pag. 1 2. Il sistema economico e i modelli in economia...» 5 3. Il flusso circolare dei beni e del reddito...» 7 4.
INDICE CAPITOLO 1 IL SISTEMA ECONOMICO, LE REGOLE E GLI OPERATORI 1. Introduzione... pag. 1 2. Il sistema economico e i modelli in economia...» 5 3. Il flusso circolare dei beni e del reddito...» 7 4.
Indice Introduzione Il paradigma della globalizzazione Le realtà della globalizzazione
 01_136_08_DEAGO_Geografia sviluppo.qxp 14-10-2008 18:00 Pagina V XI XVII XVII XVIII XX Gli autori Introduzione di G. Dematteis Due visioni dello sviluppo: tra semplificazioni e complessità Salvare la complessità:
01_136_08_DEAGO_Geografia sviluppo.qxp 14-10-2008 18:00 Pagina V XI XVII XVII XVIII XX Gli autori Introduzione di G. Dematteis Due visioni dello sviluppo: tra semplificazioni e complessità Salvare la complessità:
i-x_1-179_imbriani_07.qxp :10 Pagina V Indice
 i-x_1-179_imbriani_07.qxp 20-04-2007 11:10 Pagina V 3 CAPITOLO 1 Introduzione alla macroeconomia 3 1.1 L oggetto della macroeconomia 5 1.2 Dalla microeconomia alla macroeconomia 6 1.3 La produzione e la
i-x_1-179_imbriani_07.qxp 20-04-2007 11:10 Pagina V 3 CAPITOLO 1 Introduzione alla macroeconomia 3 1.1 L oggetto della macroeconomia 5 1.2 Dalla microeconomia alla macroeconomia 6 1.3 La produzione e la
LE STRATEGIE CAPITOLO 3
 LE STRATEGIE CAPITOLO 3 Breve riassunto della lezione scorsa La CREAZIONE DI VALORE V > CT - BN La CATENA DEL VALORE Il processo aziendale (o business process) è un insieme di attività interrelate, svolte
LE STRATEGIE CAPITOLO 3 Breve riassunto della lezione scorsa La CREAZIONE DI VALORE V > CT - BN La CATENA DEL VALORE Il processo aziendale (o business process) è un insieme di attività interrelate, svolte
Indice Sommario. pag. Indice delle figure TEORIA DEL CONSUMATORE Domande a risposta aperta
 Indice Sommario pag. Indice delle figure... 5 1. TEORIA DEL CONSUMATORE... 9 Domande a risposta aperta... 11 Problemi... 38 Domande a risposta multipla... 55 2. PRODUZIONE E COSTI... 59 Domande a risposta
Indice Sommario pag. Indice delle figure... 5 1. TEORIA DEL CONSUMATORE... 9 Domande a risposta aperta... 11 Problemi... 38 Domande a risposta multipla... 55 2. PRODUZIONE E COSTI... 59 Domande a risposta
Indice. Prefazione alla nuova edizione... L editore ringrazia... Un approccio visuale. Com è organizzato un capitolo di Geografia Umana?...
 Indice V Indice Prefazione alla nuova edizione... L editore ringrazia... Un approccio visuale. Com è organizzato un capitolo di Geografia Umana?.... XII XV XVI CAPITOLO 1 CHE COS È LA GEOGRAFIA UMANA?...
Indice V Indice Prefazione alla nuova edizione... L editore ringrazia... Un approccio visuale. Com è organizzato un capitolo di Geografia Umana?.... XII XV XVI CAPITOLO 1 CHE COS È LA GEOGRAFIA UMANA?...
Indice. Parte 1 Concetti fondamentali 1. 1 Organizzazione industriale: cosa, come e perché 3. 2 Fondamenti di microeconomia 19
 Prefazione all edizione originale Prefazione all edizione italiana Autori Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura XVII XIX XXI XXIII XXV Parte 1 Concetti fondamentali 1 1 Organizzazione industriale:
Prefazione all edizione originale Prefazione all edizione italiana Autori Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura XVII XIX XXI XXIII XXV Parte 1 Concetti fondamentali 1 1 Organizzazione industriale:
I PROVA INTERMEDIA DOMANDE PER ESERCITAZIONE
 Nome Cognome Matr. 1) Se la domanda è ad elasticità unitaria rispetto al prezzo, quali sono le conseguenze di una diminuzione del prezzo del 5% sulla quantità domandata? La quantità domandata non varia
Nome Cognome Matr. 1) Se la domanda è ad elasticità unitaria rispetto al prezzo, quali sono le conseguenze di una diminuzione del prezzo del 5% sulla quantità domandata? La quantità domandata non varia
Capitolo 11 Concorrenza perfetta. Robert H. Frank Microeconomia - 5 a Edizione Copyright The McGraw-Hill Companies, srl
 Capitolo 11 Concorrenza perfetta MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto contabile è
Capitolo 11 Concorrenza perfetta MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto contabile è
Il commercio internazionale delle imprese. Giuseppe De Arcangelis 2016 Economia Internazionale
 Il commercio internazionale delle imprese Giuseppe De Arcangelis 16 Economia Internazionale 1 Schema della lezione Impresa rappresentativa e imprese eterogenee Dinamica di entrata e uscita Produttività
Il commercio internazionale delle imprese Giuseppe De Arcangelis 16 Economia Internazionale 1 Schema della lezione Impresa rappresentativa e imprese eterogenee Dinamica di entrata e uscita Produttività
INDICE CAPITOLO I LINEAMENTI DI STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
 V INDICE CAPITOLO I LINEAMENTI DI STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 1. Adam Smith e la nascita della scuola classica... 4 2. La scuola classica: Malthus, Ricardo, Mill... 8 3. La rivoluzione marginalista:
V INDICE CAPITOLO I LINEAMENTI DI STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 1. Adam Smith e la nascita della scuola classica... 4 2. La scuola classica: Malthus, Ricardo, Mill... 8 3. La rivoluzione marginalista:
Network Analysis of World Trade Using the BACI-CEPII dataset
 Network Analysis of World Trade Using the BACI-CEPII dataset L. De Benedictis (U. Macerata) S. Nenci (U. Roma III) G. Santoni (Banque de France) L. Tajoli (P. Milano) C. Vicarelli (ISTAT) Discussion by
Network Analysis of World Trade Using the BACI-CEPII dataset L. De Benedictis (U. Macerata) S. Nenci (U. Roma III) G. Santoni (Banque de France) L. Tajoli (P. Milano) C. Vicarelli (ISTAT) Discussion by
Lo scenario per nuove imprese e nuovi imprenditori
 Lo scenario per nuove imprese e nuovi imprenditori Gli imperativi dello scenario Globalizzazione Stato Societa Imprenditorialità Impresa Mercato del lavoro Lavoro autonomo Neoimpresa Gli imperativi dello
Lo scenario per nuove imprese e nuovi imprenditori Gli imperativi dello scenario Globalizzazione Stato Societa Imprenditorialità Impresa Mercato del lavoro Lavoro autonomo Neoimpresa Gli imperativi dello
Allearsi per competere Prof. Giovanni Fattore, Università Bocconi, Milano
 Allearsi per competere Prof. Giovanni Fattore, Università Bocconi, Milano Il contesto generale Crescita interesse generale per il tema dell alimentazione (non solo un problema del terzo mondo o di produttività)
Allearsi per competere Prof. Giovanni Fattore, Università Bocconi, Milano Il contesto generale Crescita interesse generale per il tema dell alimentazione (non solo un problema del terzo mondo o di produttività)
Il processo di industrializzazione in Italia e l intervento pubblico
 Il processo di industrializzazione in Italia e l intervento pubblico La legislazione antimonopolista Gli strumenti di politica economica: protezioni, sussidi, diritti esclusivi, salvataggi, svalutazioni
Il processo di industrializzazione in Italia e l intervento pubblico La legislazione antimonopolista Gli strumenti di politica economica: protezioni, sussidi, diritti esclusivi, salvataggi, svalutazioni
L innovazione tecnologica dal fordismo al post-fordismo
 L innovazione tecnologica dal fordismo al post-fordismo Obiettivi della lezione Definizione di tecnologia Il rapporto fra scienza e tecnologia nel paradigma della produzione di massa La crisi del fordismo
L innovazione tecnologica dal fordismo al post-fordismo Obiettivi della lezione Definizione di tecnologia Il rapporto fra scienza e tecnologia nel paradigma della produzione di massa La crisi del fordismo
Politica economica: Lezione 25
 Politica economica: Lezione 25 II canale: M - Z Crediti: 9 Corsi di laurea: Nuovo Ordinamento (DM. 270) Vecchio ordinamento (DM. 590) Politica Economica - Luca Salvatici 1 La soluzione del modello IS-LM
Politica economica: Lezione 25 II canale: M - Z Crediti: 9 Corsi di laurea: Nuovo Ordinamento (DM. 270) Vecchio ordinamento (DM. 590) Politica Economica - Luca Salvatici 1 La soluzione del modello IS-LM
Dalla microeconomia alla macroeconomia
 Dalla microeconomia alla macroeconomia MICROECONOMIA: studio dei comportamenti individuali Economia politica MACROECONOMIA: studio dei comportamenti collettivi Lo studio dei comportamenti collettivi deve
Dalla microeconomia alla macroeconomia MICROECONOMIA: studio dei comportamenti individuali Economia politica MACROECONOMIA: studio dei comportamenti collettivi Lo studio dei comportamenti collettivi deve
3.2 I fattori localizzativi micro
 3.2 I fattori localizzativi micro Più specificamente, i fattori che influenzano la scelta localizzativa per l insediamento di questo tipo di strutture commerciali specializzate possono essere suddivisi
3.2 I fattori localizzativi micro Più specificamente, i fattori che influenzano la scelta localizzativa per l insediamento di questo tipo di strutture commerciali specializzate possono essere suddivisi
STRATEGIA AZIENDALE MATERIALE DIDATTICO DOCENTE. Christian Corsi ARGOMENTO APPROCCI STRATEGICI. Insegnamento di: a.a. 2009/2010
 Corso di laurea in Economia Bancaria Finanziaria e Assicurativa Insegnamento di: STRATEGIA AZIENDALE a.a. 2009/2010 MATERIALE DIDATTICO DOCENTE Christian Corsi ARGOMENTO APPROCCI STRATEGICI info: ccorsi@unite.it
Corso di laurea in Economia Bancaria Finanziaria e Assicurativa Insegnamento di: STRATEGIA AZIENDALE a.a. 2009/2010 MATERIALE DIDATTICO DOCENTE Christian Corsi ARGOMENTO APPROCCI STRATEGICI info: ccorsi@unite.it
Internazionalizzazione delle imprese e del lavoro. Giuseppe De Arcangelis 2016 Economia Internazionale
 Internazionalizzazione delle imprese e del lavoro Giuseppe De Arcangelis 2016 Economia Internazionale 1 Movimento dei fattori produttivi e della produzione Capitale e imprese Investimenti diretti esteri
Internazionalizzazione delle imprese e del lavoro Giuseppe De Arcangelis 2016 Economia Internazionale 1 Movimento dei fattori produttivi e della produzione Capitale e imprese Investimenti diretti esteri
Università degli Studi di Pisa Corso di laurea in Ingegneria Gestionale Specifica dell insegnamento di ISTITUZIONI DI ECONOMIA
 Docenza Università degli Studi di Pisa Corso di laurea in Ingegneria Gestionale Specifica dell insegnamento di ISTITUZIONI DI ECONOMIA Docente: prof. Andrea Bonaccorsi Scuola Superiore Sant Anna Tel.:
Docenza Università degli Studi di Pisa Corso di laurea in Ingegneria Gestionale Specifica dell insegnamento di ISTITUZIONI DI ECONOMIA Docente: prof. Andrea Bonaccorsi Scuola Superiore Sant Anna Tel.:
I sistemi economici dei territori toscani: identificazione, struttura ed evoluzione
 XXII Edizione degli Incontri di Artimino Nuovo sviluppo industriale e politiche di sistema I sistemi economici dei territori toscani: identificazione, struttura ed evoluzione Simone Bertini e David Burgalassi
XXII Edizione degli Incontri di Artimino Nuovo sviluppo industriale e politiche di sistema I sistemi economici dei territori toscani: identificazione, struttura ed evoluzione Simone Bertini e David Burgalassi
Internazionalizzazione delle imprese e del lavoro. Giuseppe De Arcangelis 2015 Economia Internazionale
 Internazionalizzazione delle imprese e del lavoro Giuseppe De Arcangelis 2015 Economia Internazionale 1 Movimento dei fattori produttivi e della produzione Capitale e imprese Investimenti diretti esteri
Internazionalizzazione delle imprese e del lavoro Giuseppe De Arcangelis 2015 Economia Internazionale 1 Movimento dei fattori produttivi e della produzione Capitale e imprese Investimenti diretti esteri
ECONOMIA URBANA. Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre. Contatti:
 ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it ECONOMIA URBANA E REGIONALE Economia Urbana 2 TEORIA DELLA CRESCITA E DELLO SVILUPPO REGIONALE
ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it ECONOMIA URBANA E REGIONALE Economia Urbana 2 TEORIA DELLA CRESCITA E DELLO SVILUPPO REGIONALE
ISTITUZIONI DI ECONOMIA (a.a ) PROVE D ESAME
 Giuseppe Garofalo Dipartimento di Economia pubblica Facoltà di Economia Università degli studi di Roma La Sapienza ISTITUZIONI DI ECONOMIA (a.a. 1999-2000) PROVE D ESAME Prova intermedia di Macro (4-3-2000)
Giuseppe Garofalo Dipartimento di Economia pubblica Facoltà di Economia Università degli studi di Roma La Sapienza ISTITUZIONI DI ECONOMIA (a.a. 1999-2000) PROVE D ESAME Prova intermedia di Macro (4-3-2000)
ECONOMIA REGIONALE. IX. Competitività territoriale e. domanda/offerta
 ECONOMIA REGIONALE Teorie della crescita regionale: lo spazio diversificato stilizzato IX. Competitività territoriale e sviluppo cumulativo domanda/offerta 1 Rendimenti crescenti, competitività e sviluppo
ECONOMIA REGIONALE Teorie della crescita regionale: lo spazio diversificato stilizzato IX. Competitività territoriale e sviluppo cumulativo domanda/offerta 1 Rendimenti crescenti, competitività e sviluppo
Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11)
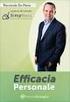 Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11) MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto economico
Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11) MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto economico
Considerazioni sulle strategie logistiche per il nodo logistico di Trento. Trento, 16 Settembre 2005
 Considerazioni sulle strategie logistiche per il nodo logistico di Trento Trento, 16 Settembre 2005 1 Il nodo di Trento e le sue peculiarità logistiche Opportunità e rischi dell intersezione fra due corridoi
Considerazioni sulle strategie logistiche per il nodo logistico di Trento Trento, 16 Settembre 2005 1 Il nodo di Trento e le sue peculiarità logistiche Opportunità e rischi dell intersezione fra due corridoi
L analisi strategica per le decisioni aziendali
 L analisi strategica per le decisioni aziendali Guida alla lettura del Grant (le prime quattro sezioni) 22 aprile 2009 EGI Prof. R. Faraci 1 Temi e articolazione Introduzione alla strategia Il concetto
L analisi strategica per le decisioni aziendali Guida alla lettura del Grant (le prime quattro sezioni) 22 aprile 2009 EGI Prof. R. Faraci 1 Temi e articolazione Introduzione alla strategia Il concetto
INDICE GENERALE. Prefazione... Pag. VII Indice generale...» XIII Indice delle tabelle...» XXI Indice delle figure...» XXIII
 INDICE GENERALE Prefazione.... Pag. VII Indice generale....» XIII Indice delle tabelle...» XXI Indice delle figure...» XXIII PARTE PRIMA ELEMENTI DI ECONOMIA DELL IMPRESA Capitolo Primo L IMPRESA E IL
INDICE GENERALE Prefazione.... Pag. VII Indice generale....» XIII Indice delle tabelle...» XXI Indice delle figure...» XXIII PARTE PRIMA ELEMENTI DI ECONOMIA DELL IMPRESA Capitolo Primo L IMPRESA E IL
Corrado Gatti, Antonio Renzi, Gianluca Vagnani, L impresa. I fondamenti. Copyright 2016 McGraw-Hill Education (Italy) srl
 Capitolo 4 Il contesto interno 4.1 Introduzione 4.2 L attività dell organizzazione 4.3 Le componenti del sistema organizzativo interno 4.3.1 Struttura 4.3.2 Persone 4.3.3 Incentivi 4.3.4 Cultura 4.3.5
Capitolo 4 Il contesto interno 4.1 Introduzione 4.2 L attività dell organizzazione 4.3 Le componenti del sistema organizzativo interno 4.3.1 Struttura 4.3.2 Persone 4.3.3 Incentivi 4.3.4 Cultura 4.3.5
La terza via dell agricoltura nella creazione di nuove identità del rurale: i casi della campagna italiana
 La terza via dell agricoltura nella creazione di nuove identità del rurale: i casi della campagna italiana Università di Perugia Italia Roma, 28 giugno 2009 Le nuove sfide La globalizzazione (trade, capitali,
La terza via dell agricoltura nella creazione di nuove identità del rurale: i casi della campagna italiana Università di Perugia Italia Roma, 28 giugno 2009 Le nuove sfide La globalizzazione (trade, capitali,
CORSO DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING A.A
 Prof.ssa Elena Cedrola elena.cedrola@unimc.it http://docenti.unimc.it/docenti/elena-cedrola Lezione 4 CORSO DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING A.A. 2014-2015 1 Contenuti lezione 4: le teorie
Prof.ssa Elena Cedrola elena.cedrola@unimc.it http://docenti.unimc.it/docenti/elena-cedrola Lezione 4 CORSO DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING A.A. 2014-2015 1 Contenuti lezione 4: le teorie
Il marketing territoriale
 Il marketing territoriale Matteo G.Caroli capitolo 1 Territorio Sistema costituito da un insieme di attori e di risorse, sede di attività e di relazioni, guidato dal sub-sistema di governo. Dimensione:
Il marketing territoriale Matteo G.Caroli capitolo 1 Territorio Sistema costituito da un insieme di attori e di risorse, sede di attività e di relazioni, guidato dal sub-sistema di governo. Dimensione:
Inoltre: Interscambio commerciale tra due paesi = import + export (contati una sola volta) Bilancia commerciale = (export import) di un paese
 LE STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 1 Una premessa: la differenza tra esportazioni e IDE Esportazione: trasferimento di beni / servizi attraverso i confini nazionali IDE (investimenti diretti esteri):
LE STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 1 Una premessa: la differenza tra esportazioni e IDE Esportazione: trasferimento di beni / servizi attraverso i confini nazionali IDE (investimenti diretti esteri):
Modigliani Esporre il contenuto della relazione di F. Modigliani: The Italian Economic Crisis: Causes, Cures and Some Political Implications
 Storia del Pensiero Economico 16 luglio 20134 Nome Cognome Crediti Matricola 1. I classici e la teoria del commercio internazionale 1) Il vantaggio assoluto 2) Il vantaggio comparato 3) La teoria del commercio
Storia del Pensiero Economico 16 luglio 20134 Nome Cognome Crediti Matricola 1. I classici e la teoria del commercio internazionale 1) Il vantaggio assoluto 2) Il vantaggio comparato 3) La teoria del commercio
PROGRAMMA SVOLTO IN DIRITTO-ECONOMIA. Anno scolastico L ordinamento della Repubblica.
 PROGRAMMA SVOLTO IN DIRITTO-ECONOMIA Classe 2C programmatori L ordinamento della Repubblica. - Il Parlamento: composizione e funzionamento. Le funzioni del Parlamento. - Lo scioglimento anticipato delle
PROGRAMMA SVOLTO IN DIRITTO-ECONOMIA Classe 2C programmatori L ordinamento della Repubblica. - Il Parlamento: composizione e funzionamento. Le funzioni del Parlamento. - Lo scioglimento anticipato delle
Economia regionale. Analisi dei processi localizzativi. Modelli economici regionali e analisi dell interazione spaziale
 Economia regionale Analisi dei rocessi localizzativi Modelli economici regionali e analisi dell interazione saziale Sviluo economico regionale e analisi delle olitiche regionali Il concetto di sazio Sazio
Economia regionale Analisi dei rocessi localizzativi Modelli economici regionali e analisi dell interazione saziale Sviluo economico regionale e analisi delle olitiche regionali Il concetto di sazio Sazio
SCENARI 2015 PER IL SETTORE AGROALIMENTARE ITALIANO. Liberalizzazione dei mercati e crescita economica: prospettive per il settore agroalimentare
 SCENARI 2015 PER IL SETTORE AGROALIMENTARE ITALIANO Liberalizzazione dei mercati e crescita economica: prospettive per il settore agroalimentare Federalimentare Ismea Centro Studi Confindustria Settembre
SCENARI 2015 PER IL SETTORE AGROALIMENTARE ITALIANO Liberalizzazione dei mercati e crescita economica: prospettive per il settore agroalimentare Federalimentare Ismea Centro Studi Confindustria Settembre
Le scelte del consumatore
 Istituzioni di Economia a.a. - Importante: - completare sempre i grafici indicando le variabili in ascissa e ordinata; - le definizioni si possono dare in termini discorsivi o in termini analitici Le scelte
Istituzioni di Economia a.a. - Importante: - completare sempre i grafici indicando le variabili in ascissa e ordinata; - le definizioni si possono dare in termini discorsivi o in termini analitici Le scelte
Capitolo 1. Introduzione
 Capitolo 1 Introduzione Economia politica: definizione L economia politica è la scienza che studia il modo in cui le società umane si sono organizzate o potrebbero organizzarsi per produrre e distribuire,
Capitolo 1 Introduzione Economia politica: definizione L economia politica è la scienza che studia il modo in cui le società umane si sono organizzate o potrebbero organizzarsi per produrre e distribuire,
Il contesto: gli inizi degli anni 90
 Il contesto: gli inizi degli anni 90 Agli inizi degli anni 90 ed in maniera più accentuata al passare degli anni, l evidenza empirica sembra non essere spiegata dalla teoria. La competizione di costo da
Il contesto: gli inizi degli anni 90 Agli inizi degli anni 90 ed in maniera più accentuata al passare degli anni, l evidenza empirica sembra non essere spiegata dalla teoria. La competizione di costo da
C.d) Equilibri multipli
 C.d) Equilibri multipli o L evidenza empirica sui processi di convergenza nei livelli di produttività tra le regioni europee suggerisce l esistenza di Club di convergenza, ovvero di gruppi di regioni che
C.d) Equilibri multipli o L evidenza empirica sui processi di convergenza nei livelli di produttività tra le regioni europee suggerisce l esistenza di Club di convergenza, ovvero di gruppi di regioni che
Il marketing nell economia e nella gestione d impresa
 Il marketing nell economia e nella gestione d impresa Obiettivi conoscitivi Definire il concetto di marketing nell insieme dei rapporti tra impresa e mercato Definire gli obiettivi di marketing partendo
Il marketing nell economia e nella gestione d impresa Obiettivi conoscitivi Definire il concetto di marketing nell insieme dei rapporti tra impresa e mercato Definire gli obiettivi di marketing partendo
CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA
 CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA VOLUME DI MERCATO LANCIO CRESCITA MATURITA OBSOLESCENZA CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA VOLUME DI MERCATO LANCIO CRESCITA MATURITA OBSOLESCENZA INNOVAZIONE TECNOLOGICA PROCESSO
CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA VOLUME DI MERCATO LANCIO CRESCITA MATURITA OBSOLESCENZA CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA VOLUME DI MERCATO LANCIO CRESCITA MATURITA OBSOLESCENZA INNOVAZIONE TECNOLOGICA PROCESSO
Indice. Parte 1 Le famiglie 21 XVII XXI XXIII XXV
 Prefazione alla seconda edizione europea Prefazione alla quinta edizione Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura XVII XXI XXIII XXV Capitolo 1 L economia di mercato 1 1.1 L economia e la scarsità
Prefazione alla seconda edizione europea Prefazione alla quinta edizione Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura XVII XXI XXIII XXV Capitolo 1 L economia di mercato 1 1.1 L economia e la scarsità
Possibile presenza di opportunismo da parte dell impresa con cui si interagisce, legato a:
 Perché esistono i costi di transazione? Possibile presenza di opportunismo da parte dell impresa con cui si interagisce, legato a: - investimenti specifici della transazione e opportunismo - limitatezza
Perché esistono i costi di transazione? Possibile presenza di opportunismo da parte dell impresa con cui si interagisce, legato a: - investimenti specifici della transazione e opportunismo - limitatezza
Le 5 configurazioni. 1. Una tassonomia delle organizzazioni 2. Una sintesi delle correlazioni tra i diversi parametri di progettazione
 Le 5 configurazioni 1. Una tassonomia delle organizzazioni 2. Una sintesi delle correlazioni tra i diversi parametri di progettazione La Struttura semplice Coordinamento Supervisione diretta Parte fondamentale
Le 5 configurazioni 1. Una tassonomia delle organizzazioni 2. Una sintesi delle correlazioni tra i diversi parametri di progettazione La Struttura semplice Coordinamento Supervisione diretta Parte fondamentale
Introduzione. L oggetto di studio dell Economia sanitaria. Quadro teorico di riferimento. Le peculiarità del mercato delle prestazioni sanitarie
 Introduzione NB: Questi lucidi presentano solo parzialmente gli argomenti trattati ttati in classe. In particolare non contengono i modelli economici per i quali si rinvia direttamente al libro di testo
Introduzione NB: Questi lucidi presentano solo parzialmente gli argomenti trattati ttati in classe. In particolare non contengono i modelli economici per i quali si rinvia direttamente al libro di testo
ECONOMIA URBANA. Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre. Contatti:
 ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it LA MICROECONOMIA LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO DEI SINGOLI AGENTI IN UN SISTEMA ECONOMICO Economia
ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it LA MICROECONOMIA LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO DEI SINGOLI AGENTI IN UN SISTEMA ECONOMICO Economia
Canali distributivi dei servizi bancari. Massimo Caratelli, maggio 2017
 Canali distributivi dei servizi bancari Massimo Caratelli, maggio 2017 1 Contenuti Ø Ø Ø Ø Servizio finanziario Sistema di erogazione e distribuzione dei servizi finanziari Canale distributivo Caratteristiche
Canali distributivi dei servizi bancari Massimo Caratelli, maggio 2017 1 Contenuti Ø Ø Ø Ø Servizio finanziario Sistema di erogazione e distribuzione dei servizi finanziari Canale distributivo Caratteristiche
Lo sviluppo economico regionale
 Lo sviluppo economico regionale Perché innovazione tecnologica? differenze nei livelli di sviluppo tecnologico innovazione tecnologica = pensiero economico moderno molto recente problema: attività di ricerca
Lo sviluppo economico regionale Perché innovazione tecnologica? differenze nei livelli di sviluppo tecnologico innovazione tecnologica = pensiero economico moderno molto recente problema: attività di ricerca
Teoria dell offerta. Offerta di beni ed equilibrio di mercato La produzione Minimizzazione dei costi Focus sulle curve di costo
 Teoria dell offerta Offerta di beni ed equilibrio di mercato La produzione Minimizzazione dei costi Focus sulle curve di costo 1 Teoria dell offerta Offerta di beni ed equilibrio di mercato La produzione
Teoria dell offerta Offerta di beni ed equilibrio di mercato La produzione Minimizzazione dei costi Focus sulle curve di costo 1 Teoria dell offerta Offerta di beni ed equilibrio di mercato La produzione
26. Le aree funzionali
 26. Le aree funzionali Le funzioni aziendali sono composte da gruppi di operazioni omogenee attraverso le quali il sistema-azienda attua il proprio oggetto e persegue specifici obiettivi. Le aree funzionali
26. Le aree funzionali Le funzioni aziendali sono composte da gruppi di operazioni omogenee attraverso le quali il sistema-azienda attua il proprio oggetto e persegue specifici obiettivi. Le aree funzionali
Concentrarsi o disperdersi: storia e geografia della popolazione in Italia negli ultimi 150 anni
 Concentrarsi o disperdersi: storia e geografia della popolazione in Italia negli ultimi 150 anni Marcello Pagnini Economista, Banca d Italia Sede di Bologna L Italia unita e suoi mille shock Il processo
Concentrarsi o disperdersi: storia e geografia della popolazione in Italia negli ultimi 150 anni Marcello Pagnini Economista, Banca d Italia Sede di Bologna L Italia unita e suoi mille shock Il processo
IL MERCATO: RUOLO E CONFIGURAZIONI (OVVERO LE FORME DI MERCATO)
 IL MERCATO: RUOLO E CONFIGURAZIONI (OVVERO LE FORME DI MERCATO) acarbone@unitus.it Nome docente. Prof. Anna Carbone la vita economica Stringendo al massimo si riassume in due azioni fondamentali: Produrre
IL MERCATO: RUOLO E CONFIGURAZIONI (OVVERO LE FORME DI MERCATO) acarbone@unitus.it Nome docente. Prof. Anna Carbone la vita economica Stringendo al massimo si riassume in due azioni fondamentali: Produrre
3.7. L autonomia e la comunanza degli obiettivi garantiscono l autoregolazione 53
 INDICE PREMESSA INTRODUZIONE CAPITOLO 1 - L economia capitalistica come sistema di organizzazioni 1.1. Che cosa è una impresa capitalistica 1 1.2. Le caratteristiche dell insieme degli agenti 5 1.3. Le
INDICE PREMESSA INTRODUZIONE CAPITOLO 1 - L economia capitalistica come sistema di organizzazioni 1.1. Che cosa è una impresa capitalistica 1 1.2. Le caratteristiche dell insieme degli agenti 5 1.3. Le
Giovanni Anania e Rosanna Nisticò EMAA 11/12 X / 1
 La dispersione i dei prezzi al consumo. I risultati di un indagine empirica sui prodotti alimentari. Giovanni Anania e Rosanna Nisticò EMAA 11/12 X / 1 Il problema Un ottimo uso del vostro tempo! questa
La dispersione i dei prezzi al consumo. I risultati di un indagine empirica sui prodotti alimentari. Giovanni Anania e Rosanna Nisticò EMAA 11/12 X / 1 Il problema Un ottimo uso del vostro tempo! questa
Valutazioni e raccomandazioni
 Valutazioni e raccomandazioni La sua popolazione è più ricca della media della popolazione italiana, con un PIL pro capite (pari a 32.941 USD) paragonabile a quello di Toronto o Barcellona In confronto
Valutazioni e raccomandazioni La sua popolazione è più ricca della media della popolazione italiana, con un PIL pro capite (pari a 32.941 USD) paragonabile a quello di Toronto o Barcellona In confronto
L economia politica si suddivide in due branche principali
 L economia politica si suddivide in due branche principali Microeconomia: si occupa del comportamento dei singoli mercati e dei singoli operatori/soggetti economici. Macroeconomia: studia il funzionamento
L economia politica si suddivide in due branche principali Microeconomia: si occupa del comportamento dei singoli mercati e dei singoli operatori/soggetti economici. Macroeconomia: studia il funzionamento
CAPITOLO 9. La concorrenza perfetta
 CAPITOLO 9 La concorrenza perfetta 1 Mercati di concorrenza perfetta Un mercato di concorrenza perfetta è composto da imprese che producono beni identici e che vendono allo stesso prezzo. Il volume di
CAPITOLO 9 La concorrenza perfetta 1 Mercati di concorrenza perfetta Un mercato di concorrenza perfetta è composto da imprese che producono beni identici e che vendono allo stesso prezzo. Il volume di
