Note per un interpretazione sintetica dell etica di Tommaso d Aquino
|
|
|
- Alessandro Moro
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CONGRESSO TOMISTA INTERNAZIONALE L UMANESIMO CRISTIANO NEL III MILLENNIO: PROSPETTIVA DI TOMMASO D AQUINO ROMA, settembre 2003 Pontificia Accademia di San Tommaso Società Internazionale Tommaso d Aquino Note per un interpretazione sintetica dell etica di Tommaso d Aquino Prof. Angelo Campodonico Università di Genova (Italia) The paper tries to compare in a concise way Aquinas ethics and the approach of contemporary moral philosophy. The first problem concerns the place of philosophy in theological ethics. Although there is no complete and ready made philosophical ethics (in contemporary sense) in Aquinas works, still there are milestones to construe it. The other main points are the task and the method of ethics. The ethics of Thomas is not an ethics of difficult cases (as many contemporary ethics); still it allows to solve difficult cases. Stressing the role of the phrase Bonum ex integra causa, the paper shows that there is a deep unity between some polarities that are not often connected: body and soul, speculative and practical reason, morality and happiness, reason and passion, reason and will, reason and motivation, matter and goal of the action, inclinations and precepts, intention and responsibility, law and virtue. In fact law and virtue are both rooted in practical reason. When he is acting, the good man must consider all together his wholeness and integrity (integritas) with his ontological order and the wholeness and integrity of the situation where he is acting with his ontological and hierarchical order. To be a moral man means to answer here and now with his wholeness to the wholeness of being, loving more what is more perfect. Furthermore we can find implicitly in the ethics of Aquinas an important connection between human nature and history. Scopo di questo contributo è quello di fornire alcuni spunti per un interpretazione sintetica della teoria dell azione e dell etica di Tommaso d Aquino che permetta di situarle storicamente e di confrontarle in modo non ingenuo e meccanico con le problematiche odierne della filosofia morale. 1) Occorre notare innanzitutto - che ciò che rientra nella teologia morale di Tommaso (in particolare tutta la Secunda pars della Summa theologiae) abbraccia un ambito assai più vasto di quello che oggi s intende per filosofia morale. Oltre alla teologia morale in senso proprio, esso copre, in particolare, quell ambito della filosofia che oggi rientrerebbe nell antropologia filosofica (per esempio: il tema del desiderio e delle passioni) e, in particolare, in quella filosofia dell azione verso cui si registra, dopo secoli di oblio, un rinnovato interesse 1. Inoltre sembra essere assodato dalla critica più recente che Tommaso abbia 1 Cfr., per esempio, G.E.M. ANSCOMBE, Intention, Blackwell, Oxford 1957; Cfr. A. Kenny, Action, Emotion and Will, Routledge & Kegan Paul, London 1979; P. Geach, The Virtues, CUA, Cambridge 1977; S. Brock, Azione e condotta. Tommaso d Aquino e la teoria dell azione, Edizioni Università della Santa Croce, Roma Copyright 2003 INSTITUTO UNIVERSITARIO VIRTUAL SANTO TOMÁS Fundación Balmesiana Universitat Abat Oliba CEU
2 A. CAMPODONICO, Note per un interpretazione sintetica dell etica di Tommaso intrapreso la stesura della Summa theologiae con l intenzione precisa di dare un nuovo e più ampio spazio alla riflessione sull agire umano nel movimento di ritorno del creato a Dio 2. 2) Il problema preliminare che occorre prendere in considerazione è il ruolo della filosofia morale all interno di una costruzione di carattere essenzialmente teologico. In genere l interpretazione dell etica di Tommaso si è imbattuta in due rischi: quello corso da una certa Neo-scolastica di estrarre un etica filosofica bell e fatta dalla sua teologia morale, ignorando il contesto e la finalità teologica dell insieme della sua riflessione, e inversamente, quello di lasciar supporre che non vi sia per nulla una dimensione filosofica nel suo pensiero che possa interessare la filosofia morale del nostro tempo (che è il rischio di molte letture contemporanee). Tommaso non sembra interessato in primo luogo alla costruzione di un etica filosofica completa, perché le problematiche del suo tempo non lo sollecitavano in tal senso. Per Tommaso, come per gli scolastici in genere, essere teologo è molto più comprensivo dell essere meramente filosofo. C è una filosofia morale in Tommaso nella misura in cui la teologia riconosce spazio e legittimità ad essa. Tuttavia il fatto che quella dell Aquinate sia principalmente e programmaticamente un etica teologica cristiana non significa che non si possano ritrovare in essa importanti elementi di un etica filosofica aperta ad un completamento religioso e, soprattutto, che da essa non si possano trarre significativi spunti per la costruzione di un etica filosofica ancor oggi valida. Significativamente il teologo Tommaso non appena possibile argomenta in modo filosofico in ambito teologico. Negare questo aspetto implicherebbe negare la struttura analogica del suo pensiero, secondo cui la grazia suppone e perfeziona la natura, ma non la sopprime mai. Come notato, per Tommaso, una teologia cristiana fatta bene dovrebbe essere in grado di affermare più e migliori tesi intorno a tematiche riguardanti la filosofia di quanto i filosofi stessi siano in grado di sostenere. Se una teologia cristiana non può fare questo, Tommaso non la giudicherebbe una teologia ben fatta 3. Si potrebbe osservare che nella sua prospettiva fa parte dell essere teologo il fatto di argomentare la verità delle sue tesi con tutti, su un piano condiviso, adattandosi anche al tipo di argomentazione che è propria di quelli che Tommaso considera filosofi tout court (in particolare Aristotele). Quindi, per quanto il subiectum e la finalità della Summa theologiae siano eminentemente teologici e per quanto la filosofia con la quale Tommaso dialettizza non sia la filosofia di oggi, tuttavia il suo discorso è ricchissimo di spunti per il filosofo morale contemporaneo. In altri termini: si può volgere 2 Cfr., per esempio, L. Boyle, The Setting of the Summa theologiae of Saint Thomas, Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto M. JORDAN, Theology and Philosophy in The Cambridge Companion to Aquinas, edited by N. Kretzmann and E. Stump, CUP, New York, 1993, p p. 2
3 Congresso Tomista Internazionale l attenzione soprattutto alla dinamica teologica complessiva del suo pensiero morale o, altrettanto legittimamente, si può focalizzarla su tematiche e argomentazioni filosofiche, ma essendo sempre consapevoli della decontestualizzazione operata. La struttura analogica che anima la riflessione dell Aquinate lo consente e talora lo incoraggia. L inquadramento dell etica all interno della teologia evidenzia piuttosto che è difficile, se non impossibile, concepire un autentico e fecondo rinnovamento della riflessione sulla morale senza radici e senza compimento nella dimensione religiosa (intesa almeno in senso lato). Del resto non è un caso che un problema fondamentale dell etica filosofica contemporanea è rappresentato dallo stacco difficile da colmare in una prospettiva meramente filosofica fra ragioni e motivazioni dell agire. In sintesi: non dobbiamo pretendere di assumere da Tommaso meccanicamente e in blocco un etica filosofica valida anche oggi, ma piuttosto dobbiamo cercare di assimilare talmente la finalità e le argomentazioni della sua teologia morale da riformularne continuamente una nel confronto con la contemporaneità. Cercherò di offrire qualche spunto in tal senso nel seguito del discorso. 3) Sintetizziamo, innanzitutto il metodo della filosofia morale che è implicito nella teologia morale di Tommaso: a) a partire dalla considerazione della vita dell uomo saggio che interpreta di fatto l esperienza morale che è almeno inizialmente presente in tutti (dimensione dell esperienza) grazie alle prime evidenze (primi principi pratici), b) si risale ai principi primi dell agire, c) la validità di questi si misura alla luce dell antropologia e della metafisica come pure della teologia (momento prettamente speculativo), d) si considerano le implicazioni pratiche in modo sempre più dettagliato (a partire dai primi precetti della legge naturale fino all applicazione della saggezza pratica o prudentia), verificando la loro coerenza con i principi (momento risolutivo). Infine, occorre notare che più le scienze pratiche si avvicinano al concreto e al contingente, più perdono in certezza e più cresce il bisogno delle virtù e dei consigli altrui. 4) Veniamo ora al confronto con l etica contemporanea. A differenza di essa l etica di Tommaso non è innanzitutto un etica dei casi difficili, anche se non esclude in linea di principio queste problematiche. Si potrebbe affermare, invece, che nella sua prospettiva, si è maggiormente in grado di affrontare i casi difficili quanto più si è in grado di agire bene nella vita normale. Il problema morale o del senso della vita non consiste per Tommaso innanzitutto nel rispondere alla domanda tipica della casistica: Che cosa devo fare?, e tanto meno Che cosa devo fare in quella data circostanza? ma piuttosto e in primo luogo all interrogativo: Quale è il vero bene per me?, Che cosa è veramente capace di compiermi?, A che cosa affezionarmi? L uomo, infatti, non è mai isolato in se stesso, ma è sempre intenzionalmente relazionato alla realtà e a dei p. 3
4 A. CAMPODONICO, Note per un interpretazione sintetica dell etica di Tommaso beni che lo attraggono 4. Non si tratta mai di rinnegarli totalmente, ma di approfondirne il senso, per cogliere, in essi e attraverso di essi, il vero bene di cui partecipano e che sazia il desiderio di felicità. In questa prospettiva la beatitudine o felicità compiuta (da non intendersi in un accezione empiristicopsicologistica, ma come riuscita integrale della vita ) nozione di derivazione religiosa ebraico-cristiana, assunta dalla filosofia medioevale e moderna e connessa alla scoperta dell infinità trascendentale del desiderio umano, è diventata una prospettiva di compimento che la filosofia non è più in grado d ignorare. Essa non rappresenta per Tommaso una meta estrinseca rispetto alla concreta vita morale, ma è proprio essa il fattore che l anima dall interno. 5) Il fondamentale presupposto antropologico dell etica di Tommaso, che emerge soprattutto qualora la si confronti con l etica moderna in genere (dall empirismo a Kant), è la stretta unità e sinergia, pur nella distinzione dei piani, di psiche e corporeità, ragione speculativa e ragione pratica, ragione e passioni, ragione e volontà, ragioni e motivazioni, materia e fine dell azione, moralità e felicità, legge e virtù ecc. In sintesi: s interpreta correttamente l etica di Tommaso d Aquino qualora si comprenda come essa superi di fatto ab origine determinate scissioni che contraddistinguono l antropologia, la teoria dell azione e l etica a lui precedenti e a lui successive. Le azioni (gli atti umani) possiedono un unità sotto il profilo morale, determinata dalla purezza e dall intensità dell intenzione del fine da parte della volontà (amor) e, insieme, dal rapporto di questa con la ragione pratica, la quale tiene conto di tutti i fattori in gioco (fine, materia o oggetto e circostanze) in base al principio secondo cui il bene deriva da una causa integra, il male da singoli difetti 5. L espressione però non è da intendersi alla luce di una prospettiva distaccata o esternalista che, calcolando, valuti dal di fuori ( in terza persona ) i diversi fattori in gioco (come avviene nel caso dell utilitarismo), ma dalla prospettiva di chi, agendo, entra in prima pesona, anima e corpo, nel merito dei diversi fattori che determinano la moralità dell azione. Essa significa in concreto che il bene morale di un comportamento è, in ultima analisi, una proprietà di una persona che agisce qui e ora 6. Non basta compiere azioni che siano conformi alla legge morale; occorre essere intimamente buoni, fare il bene in nome del bene qui e ora. Soltanto la bontà vera della persona si diffonde intorno a sé, producendo frutti buoni. 4 Cfr. P. J. WADELL The Primacy of Love. An Introduction to the Ethics of Thomas Aquinas, Paulist Press, New York Bonum ex integra causa, malum ex singularibus defectibus. L espressione di Dionigi è rafforzata da T. anche con considerazioni tratte da Aristotele. Cfr. In Eth. V, 1106 b 35 (pure 28-37). 6 Cfr. R. Spaemann, in Thomas von Aquin, Ueber sittliches Handeln, p. 16. p. 4
5 Congresso Tomista Internazionale Tommaso evidenzia che l etica non può fare a meno della dimensione della misura-integrità, ovvero di una qualche forma di gerarchizzazione, perché contempera insieme unità e molteplicità. L uomo, infatti, è limitato. L integrità dell agire, che attua il bene morale (bonum honestum), poi, è anche bella. L integritas, infatti, è, per Tommaso, un carattere della bellezza (insieme con la claritas e con la consonantia). Il bene morale è bello e in grado di affascinare, poiché è misurato dalla ragione pratica 7. Questa relazione di convenienza con la ragione, in base alla nozione d integrità-completezza, particolarmente evidente nel rapporto fra fine e materia dell azione, determina la bontà o la malizia sotto il profilo morale delle azioni umane. L agire esterno (che solo in parte coincide per Tommaso con quelle che oggi comunemente denominiamo azioni) possiede normalmente un suo proprio significato intersoggettivamente manifesto (v è un linguaggio del corpo eticamente rilevante). Tale significato per mezzo della ragione s impone alla scelta libera e, in quanto è assunto da questa ed indirizzato ad uno scopo buono, le conferisce un contenuto nettamente definito, dando, per così dire, corpo all intenzione. Come sul piano speculativo l interpretazione per essere fedele alla realtà deve tenere conto di certi significati e, in ultima analisi, di certe evidenze sensibili fenomenologicamente rilevanti, così sul piano etico-pratico la volontà buona non può ignorare certi significati dell agire umano determinanti sotto il profilo etico per le loro connotazioni antropologiche e culturali. Si evitano così gli opposti rischi rappresentati da una morale della pura intenzione, da un lato, e da una morale oggettivistica e legalistica dall altro, come pure dalla falsa alternativa fra una morale della convinzione e da una della responsabilità 8. Questi rischi sono connessi ad una concezione naturalistico-fisicistica dell azione, che ne 7 Cfr. ST. II-II, 145, 2: sicut accipi potest ex verbis Dionysii, 4 cap. De Div. nom. ad rationem pulchri sive decori, concurrit et claritas et debita proportio: dicit enim quod Deus dicitur pulcher sicut universorum consonantiae et claritatis causa. Unde pulchritudo corporis in hoc consistit quod homo habeat membra corporis bene proportionata, cum quadam debiti coloris claritate. Et similiter pulchritudo spiritualis in hoc consistit quod conversatio hominis, sive actio eius, sit bene proportionata secundum spiritualem rationis claritatem. Hoc autem pertinet ad rationem honesti, quod diximus (a. 1) idem esse virtuti, quae secundum rationem moderatur omnes res humanas. Et ideo honestum est idem spirituali decori. Unde Augustinus dicit in libro Octogintatrium Quaest. (q. 30): Honestatem voco intelligibilem pulchritudinem, quam spiritualem nos proprie dicimus. Cfr. anche ST. II-II, 145, 3: Dicitur enim aliquid honestum, sicut dictum est (a. 2), inquantum habet quendam decorem ex ordinatione rationis. Hoc autem quod est secundum rationem ordinatum, est naturaliter conveniens homini. Unumquodque autem naturaliter delectatur in suo convenienti. Et ideo honestum est naturaliter homini delectabile: sicut de operatione virtutis Philosophus probat, in I Eth. (c. 8, lect. 13). 8 L espressione, come noto, è di Max Weber. Così pure alcuni aspetti dell etica utilitaristica (che sottolinea il ruolo delle conseguenze delle nostre azioni) possono essere valorizzati nella prospettiva tommasiana. p. 5
6 A. CAMPODONICO, Note per un interpretazione sintetica dell etica di Tommaso ignora l intenzionalità e, quindi, il suo carattere propriamente umano. Il fine intenzionato dalla volontà comanda in ultima analisi l azione, ma l oggetto o materia (ciò che effettivamente si compie) non può essere ignorato dall intenzione buona. Da un lato la moralità, che appartiene in prima istanza all atto interno, si comunica all atto esterno, in modo tale che anche per esso, bene e male diventano delle differenze essenziali 9. D altro lato la dimensione esterna e corporea dell azione possiede già dei propri significati, che non possono essere ignorati e devono essere assunti dalla libera scelta della volontà 10. I rischi di dissociazione (morale della mera intenzione, da un lato, e casistica dall altro) sono, in questo caso, sempre connessi ad una concezione naturalistico-fisicistica dell azione, che ne ignora l intenzionalità e, quindi, il suo carattere propriamente umano. 6) Non si sottolineerà mai abbastanza che alla radice dell azione si trova, in Tommaso, una concezione di ragione unitaria e insieme articolata. La ragione è una e sempre conosce, almeno in certa misura, la realtà. Benché la dimensione pratica sia dominante nell esperienza quotidiana di ogni uomo, la ragione finalizzata alla prassi possiede sempre una dimensione speculativa, la quale cioè riconosce un ordine gerarchico fra enti e nature e almeno implicitamente l esistenza di un principio d ordine (Dio). Tuttavia, quando è finalizzata all agire, la ragione istituisce (facit) il suo ordine (autonomia della dimensione pratico-morale), ma sempre a partire da un ordine riconosciuto nella realtà (considerando facit). Si tratta d istituire un ordine (specificità e autonomia relativa della dimensione pratica della ragione) sulla base di un ordine naturale immediatamente riconosciuto. L esperienza del dialogo interpersonale, seppur non esplicitamente tematizzata da Tommaso, è sotto questo profilo paradigmatica: nel rapportarmi ad una persona per cercare di convincerla della bontà di qualcosa (dimensione pratica della ragione), terrò contemporaneamente conto della sua peculiare natura e dignità in quanto essere umano, come pure delle reazioni che trapelano continuamente dal suo volto (dimensione speculativa della ragione). Si potrebbe affermare sinteticamente che nella concezione realistica dell Aquinate la dimensione dell etico consiste nell appello che la realtà (l essere) considerata nel suo complesso e nella prospettiva del bene da compiersi, rivolge alla persona umana, considerata essa pure nel suo complesso e nella gerarchia delle sue facoltà. Si comprende perché il valore di un uomo, per quanto sta a lui, sia definito innanzitutto dalla sua moralità. 9 Cfr. ST. I-II, 71, 6 ad 2: ipsi exteriores actus pertinent ad substantiam peccati cum sint secundum se mali. Cfr. S. Pinkaers, Les actes humaines II, p Questo aspetto è stato sottolineato opportunamente in T. G. Belmans, La spécification de l agir humain par son objet chez S. Thomas d Aquin in Divinitas, 1978, pp e 1979, 1, pp p. 6
7 Congresso Tomista Internazionale 7) L ordine etico si fonda sull incontro fra la ragione, che è natura in senso analogico, e la natura umana (unità di anima e corpo) con le sue fondamentali inclinazioni che dalla ragione pratica vengono riconosciute, valorizzate, interpretate e rese normative. Il rischio è qui rappresentato da un interpretazione della razionalità pratica formalistica, che trascuri la natura umana e le inclinazioni naturali da interpretare, da un lato, e, inversamente, quello di una natura che sarebbe normativa a prescindere dall interpretazione della ragione pratica dall altro. Sono i rischi rappresentati da una lettura kantiana di Tommaso, da un lato, o da un interpretazione oggettivistica della sua etica, secondo cui la morale verrebbe meccanicamente dedotta dalla metafisica. In particolare si deve scorgere un nesso stretto fra il terzo precetto della legge naturale che impone di coltivare la ragione e la regola aurea che prescrive di trattare l altro come se stessi, rispettandone la dignità, il suo carattere di fine. L uomo, infatti, è per Tommaso, l unica creatura che non è finalizzata ad altro, essendo l oggetto immediato della provvidenza divina 11. In questo l Aquinate prepara storicamente la seconda formulazione dell imperativo kantiano 12. La struttura dell etica di Tommaso è dinamica e finalistica. A differenza di molte interpretazioni successive che hanno avuto luogo anche in ambito scolastico, la stessa legge va, quindi, interpretata innanzitutto in senso dinamico e finalistico, come via al bene e al compimento dell uomo. Il finalismo non è, perciò, antitetico rispetto al carattere normativo dell etica. Anzi è quello a fondare quest ultimo. In questa prospettiva dinamica appare erroneo partire dalle norme morali e dalla formulazione riflessa della legge naturale per contrapporre alle norme astratte la situazione concreta 13. 7) Virtù e legge, che sono spesso dissociate nell etica moderna, nell etica di Tommaso sono fra loro armonizzate grazie alla comune radice nella ragione pratica che informa entrambe. Se non si radicasse nei primi principi della ragione pratica e della legge naturale, la morale (e con essa la virtù) sarebbe una sovrastruttura estrinseca e non il compimento dell uomo. Sotto il profilo assiologico (o del valore della persona) e genetico-esistenziale (della comunicazione dell esperienza morale) la virtù precede la legge, ma sotto altro 11 Cfr. CG. III, Cfr. A. Donagan, Human Ends and Human Actions. An Exploration in St. Thomas s Treatment, Marquette University Press, Milwaukee Cfr. M. Rhonheimer, Natur als Grundlage der Moral. Die personale Struktur des Naturgesetzes bei Thomas von Aquin. Eine Auseinandersetzung mit autonomer u. Theologischer Ethik, Tyrolia Verlag, Innsbruck 1987, tr. it di E. Babbini Legge naturale e ragione pratica. Una visione tomista dell autonomia morale, Armando, Roma 2001, p p. 7
8 A. CAMPODONICO, Note per un interpretazione sintetica dell etica di Tommaso punto di vista (concettuale e costitutivo), i primi principi della ragione pratica, che sono il fondamento della legge naturale, costituiscono la scaturigine delle virtù 14. Queste richiedono un educazione delle passioni e permettono di immedesimarsi con spontaneità nei particolari della vita concreta. 9) Data la concezione tommasiana di natura e di natura umana, appare forzato opporre gli uni agli altri la natura e il caso, la natura e la storia. Ciò può accadere quando si assuma una nozione troppo statica ed essenzialistica della natura e di Dio. Ma nell Aquinate constatiamo invece la presenza di una nozione disposizionale e dinamica di natura. Così, nel suo pensiero possiamo ritrovare un senso profondo della storia e del ruolo delle cause seconde nella natura e nella storia, benché egli non tratti per lo più questo tema in modo esplicito e per esteso 15. Ma la logica interna della sua metafisica della creazione appare profondamente aperta nei riguardi della novità (novitas) degli avvenimenti storici e, quindi, del gioco del caso. Ciò potrebbe anche significare che gli avvenimenti della storia permettono di esplicitare progressivamente virtualità presenti nella natura umana e la legge naturale nelle sue articolazioni (anche per via di negazione, secondo una modalità di tipo dialettico) nella misura in cui la libertà dell uomo si rende disponibile. Così si potrebbe spiegare, per esempio, il fatto che i diritti umani, ovvero i diritti soggettivi impliciti nella legge naturale, si rendono manifesti, come la storia insegna, soprattutto dopo che sono stati violentemente negati. In questa prospettiva natura e storia, natura e temporalità non possono considerarsi come dimensioni contraddittorie l una rispetto all altra, ma costituiscono piuttosto delle polarità viventi e complementari, che si arricchiscono a vicenda Cfr. R. Audi, Moral Knowledge and Ethical Character, OUP, Oxford 1997, cap. VIII. 15 Sul senso della storia nell Aquinate si veda la sua attenzione all etimologia di certe parole. Cfr., per esempio, In I Sent., d. 23, q.1, a Gli avvenimenti storici, il caso e la fortuna, in ultima analisi la stessa Grazia divina, in quanto apportatori di novità, sono, quindi, importanti nella nostra vita. Ma questa novità suppone sempre la natura e la necessità a suo fondamento. Tommaso, infatti, afferma che possiamo sapere che c è del caso, perché sappiamo almeno in modo implicito che v è della natura, dell ordine, della necessità in noi stessi e nel mondo in genere. Se è vero che si deve parlare di caso nella prospettiva delle cause seconde e, quindi, anche dell agire umano l autonomo ruolo delle cause seconde è da lui assai sottolineato dal punto di vista di Dio, invece, non v è affatto del caso. Cfr. ST. I, 22, 4, ad 1: "Effectus divinae providentiae non solum est aliquid evenire quocumque modo; sed aliquid evenire vel contingenter vel necessario. Et ideo evenit infallibiliter et necessario, quod divina providentia disponit evenire infallibiliter et necessario; et evenit contingenter, quod divinae providentiae ratio habet ut contingenter eveniat. p. 8
9 Congresso Tomista Internazionale In sintesi: l etica di Tommaso deve moltissimo alla tradizione classica, patristica e scolastica. Egli riprende non solo molti dei suoi problemi, ma assai spesso anche le soluzioni che trova nel contesto delle discussioni teologiche del suo tempo. Né poteva essere altrimenti per un teologo medievale sensibile alla funzione delle auctoritates. Tuttavia a motivo della sua completezza e sistematicità, dell equilibrio e della finezza di certe soluzioni di problemi antichi, l etica di Tommaso presenta un indubbia originalità e ha esercitato un notevole influsso sulla storia del pensiero morale. Per il fatto di contemperare armoniosamente diversi elementi che spesso nel pensiero contemporaneo sono fra di loro dissociati essa riveste oggi un particolare interesse per la filosofia morale e per la filosofia dell uomo. p. 9
ETICA GENERALE ETICA
 ETICA GENERALE Master di Bioetica 2016/17 ETICA La prassi umana: l uomo che agisce è il primo soggetto etico. La libertà come premessa al discorso morale: non si offre agire etico senza la libertà. Atti
ETICA GENERALE Master di Bioetica 2016/17 ETICA La prassi umana: l uomo che agisce è il primo soggetto etico. La libertà come premessa al discorso morale: non si offre agire etico senza la libertà. Atti
Hegel. Il sistema hegeliano in sintesi
 Hegel I capisaldi del pensiero hegeliano 2 Il pensiero di Hegel rappresenta una delle più poderose sintesi filosofiche di tutti i tempi e grande è l influsso che ha esercitato sulla cultura europea dell
Hegel I capisaldi del pensiero hegeliano 2 Il pensiero di Hegel rappresenta una delle più poderose sintesi filosofiche di tutti i tempi e grande è l influsso che ha esercitato sulla cultura europea dell
Orizzonti della bioetica, diverse prospettive a confronto
 Orizzonti della bioetica, diverse prospettive a confronto 1 PROF. ANDREA PORCARELLI D o c e n t e d i P e d a g o g i a g e n e r a l e e s o c i a l e a l l U n i v e r s i t à d i P a d o v a D o c e
Orizzonti della bioetica, diverse prospettive a confronto 1 PROF. ANDREA PORCARELLI D o c e n t e d i P e d a g o g i a g e n e r a l e e s o c i a l e a l l U n i v e r s i t à d i P a d o v a D o c e
Percorso su LIM da Kant all idealismo
 Percorso su LIM da Kant all idealismo CRITICA DELLA RAGION (PURA) PRATICA NON EMPIRICA VOLONTA Massime «SE.. Devi> Imperativi Imperativi ipotetici Imperativo categorico «Tu devi» Formulazioni dell imperativo
Percorso su LIM da Kant all idealismo CRITICA DELLA RAGION (PURA) PRATICA NON EMPIRICA VOLONTA Massime «SE.. Devi> Imperativi Imperativi ipotetici Imperativo categorico «Tu devi» Formulazioni dell imperativo
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno)
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) 1) Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2) Saper riconoscere
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) 1) Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2) Saper riconoscere
L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi
 Filosofia U. D. IV L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi Nell Enciclopedia (1817) è descritto il sistema filosofico di Hegel in possesso del sapere assoluto ovvero di essere già consapevole
Filosofia U. D. IV L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi Nell Enciclopedia (1817) è descritto il sistema filosofico di Hegel in possesso del sapere assoluto ovvero di essere già consapevole
Introduzione alla Teologia
 Introduzione alla Teologia Settima lezione: La nascita della teologia scolastica Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 11 dicembre
Introduzione alla Teologia Settima lezione: La nascita della teologia scolastica Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 11 dicembre
Pasquale Porro. Tommaso d Aquino. Un profilo storico-filosofico. Carocci editore
 Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
IMMANUEL KANT CRITICA DELLA RAGION PURA LOGICA TRASCENDENTALE
 IMMANUEL KANT CRITICA DELLA RAGION PURA LOGICA TRASCENDENTALE Senza sensibilità nessun oggetto ci sarebbe dato, e senza intelletto nessun oggetto verrebbe pensato. I pensieri senza contenuto sono vuoti,
IMMANUEL KANT CRITICA DELLA RAGION PURA LOGICA TRASCENDENTALE Senza sensibilità nessun oggetto ci sarebbe dato, e senza intelletto nessun oggetto verrebbe pensato. I pensieri senza contenuto sono vuoti,
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO 1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO 1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico
La filosofia come istanza critica. Prof. Marco Lombardi Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè
 Immanuel Kant La filosofia Prof. Marco Lombardi Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè Da dove derivano i giudizi sintetici a priori? 2 La rivoluzione copernicana Kant, per rispondere a questo interrogativo,
Immanuel Kant La filosofia Prof. Marco Lombardi Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè Da dove derivano i giudizi sintetici a priori? 2 La rivoluzione copernicana Kant, per rispondere a questo interrogativo,
SOMMARIO PRESENTAZIONE INTRODUZIONE AL PROBLEMA DELLA SOCIALITÀ NEL PENSIERO DI GIOVANNI AMBROSETTI CAPITOLO I
 SOMMARIO PRESENTAZIONE.1. Oggetto della trattazione 1.2. Le questioni di fondo 2.3. Le tesi sottostanti al presente lavoro 3.4. La struttura argomentativa 5.5. Indicazioni sullo stile espositivo 7 CAPITOLO
SOMMARIO PRESENTAZIONE.1. Oggetto della trattazione 1.2. Le questioni di fondo 2.3. Le tesi sottostanti al presente lavoro 3.4. La struttura argomentativa 5.5. Indicazioni sullo stile espositivo 7 CAPITOLO
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA
 LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
G.W.F. Hegel. Filosofia dello Spirito. Spirito Assoluto: Arte. Religione. Filosofia
 G.W.F. Hegel Filosofia dello Spirito. Spirito Assoluto: Arte. Religione. Filosofia Spirito Assoluto Spirito Assoluto Negli stati e nella storia lo Spirito trova un incarnazione che resta sempre determinata
G.W.F. Hegel Filosofia dello Spirito. Spirito Assoluto: Arte. Religione. Filosofia Spirito Assoluto Spirito Assoluto Negli stati e nella storia lo Spirito trova un incarnazione che resta sempre determinata
La filosofia. Storia della filosofia contemporanea
 La filosofia Storia della filosofia contemporanea Che cos è la filosofia? Concezione tradizionale della filosofia La filosofia è una disciplina scolastica o accademica, che ha per oggetto la storia del
La filosofia Storia della filosofia contemporanea Che cos è la filosofia? Concezione tradizionale della filosofia La filosofia è una disciplina scolastica o accademica, che ha per oggetto la storia del
Polisemia della Coscienza. A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia
 Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
BENEDETTO SPINOZA a cura di Pietro Gavagnin con il contributo degli alunni di 4AOL as
 BENEDETTO SPINOZA 1632-1677 a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net con il contributo degli alunni di 4AOL as 2014-2015 OPERE: TRATTATO TEOLOGICO - POLITICO (1670) Scopo fondamentale del trattato è la
BENEDETTO SPINOZA 1632-1677 a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net con il contributo degli alunni di 4AOL as 2014-2015 OPERE: TRATTATO TEOLOGICO - POLITICO (1670) Scopo fondamentale del trattato è la
IMMANUEL KANT Critica del giudizio (1790)
 IL SENTIMENTO Nella Critica del Giudizio, Kant studia quello che chiama sentimento, così come nelle altre due critiche aveva analizzato la conoscenza e la morale. Anche il sentimento di cui egli parla
IL SENTIMENTO Nella Critica del Giudizio, Kant studia quello che chiama sentimento, così come nelle altre due critiche aveva analizzato la conoscenza e la morale. Anche il sentimento di cui egli parla
Anno scolastico PROGRAMMA SVOLTO E CONTENUTI MINIMI. Docente: Enzo Citarella. Materia: Filosofia
 Anno scolastico 2015-16 PROGRAMMA SVOLTO E CONTENUTI MINIMI Docente: Enzo Citarella Materia: Filosofia Classe : 4 F Indirizzo Linguistico ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI SECONDO UNITA FORMATIVE
Anno scolastico 2015-16 PROGRAMMA SVOLTO E CONTENUTI MINIMI Docente: Enzo Citarella Materia: Filosofia Classe : 4 F Indirizzo Linguistico ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI SECONDO UNITA FORMATIVE
LE COMPETENZE ESSENZIALI DI FILOSOFIA
 LE ESSENZIALI DI FILOSOFIA classe terza Liceo scientifico Liceo linguistico essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che,
LE ESSENZIALI DI FILOSOFIA classe terza Liceo scientifico Liceo linguistico essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che,
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla
 Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Thomas Hobbes
 588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
LIBRO DI TESTO: Il nuovo protagonisti e testi della filosofia volumi 2A e 2B
 PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA 2015-2016 CLASSE:4G DOCENTE: Maria Ausilia Lupo LIBRO DI TESTO: Il nuovo protagonisti e testi della filosofia volumi 2A e 2B UNITA 1 VOLUME 2A 1 LE COORDINATE STORICO-SOCIALI
PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA 2015-2016 CLASSE:4G DOCENTE: Maria Ausilia Lupo LIBRO DI TESTO: Il nuovo protagonisti e testi della filosofia volumi 2A e 2B UNITA 1 VOLUME 2A 1 LE COORDINATE STORICO-SOCIALI
Cataldo Zuccaro. Teologia morale fondamentale
 Cataldo Zuccaro Teologia morale fondamentale QUERINIANA Indice Introduzione.... 5 I. Questioni epistemologiche iniziali. Scoprire le carte... 9 1. Epistemologie, scienze, teologia 10 1.1 Frantumazione
Cataldo Zuccaro Teologia morale fondamentale QUERINIANA Indice Introduzione.... 5 I. Questioni epistemologiche iniziali. Scoprire le carte... 9 1. Epistemologie, scienze, teologia 10 1.1 Frantumazione
LETTURA DI UN CLASSICO LA SUMMA THEOLOGIAE DI TOMMASO D AQUINO
 marcianum 2-12_layout 1 23/10/12 11.42 pagina 513 MARCIANUM VIII (2012) 513-517 LETTURA DI UN CLASSICO LA SUMMA THEOLOGIAE DI TOMMASO D AQUINO La Summa theologiae rappresenta l opera che meglio riflette
marcianum 2-12_layout 1 23/10/12 11.42 pagina 513 MARCIANUM VIII (2012) 513-517 LETTURA DI UN CLASSICO LA SUMMA THEOLOGIAE DI TOMMASO D AQUINO La Summa theologiae rappresenta l opera che meglio riflette
Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità
 Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità Tommaso d Aquino 1225-1274 diritto naturale classico vs. antico vs. moderno Summa Theologiae I a -II ae, qq. 90
Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità Tommaso d Aquino 1225-1274 diritto naturale classico vs. antico vs. moderno Summa Theologiae I a -II ae, qq. 90
PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA. ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B
 PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B La ricerca del pensiero Storia, testi e problemi della filosofia Volume 1B UNITA 5 SOCIETA E CULTURA NELL ETA ELLENISTICA CAPITOLO
PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B La ricerca del pensiero Storia, testi e problemi della filosofia Volume 1B UNITA 5 SOCIETA E CULTURA NELL ETA ELLENISTICA CAPITOLO
Filosofia e acquisizione di competenze
 Filosofia e acquisizione di competenze Pensiero filosofico per le competenze educative A.A. 2014/15 lezione 20.10.14 2 È possibile individuare un ontologia dell umano? Quali conseguenze determina la rinuncia
Filosofia e acquisizione di competenze Pensiero filosofico per le competenze educative A.A. 2014/15 lezione 20.10.14 2 È possibile individuare un ontologia dell umano? Quali conseguenze determina la rinuncia
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814)
 Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015
 Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca
Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca
IMMANUEL KANT Critica della ragione pratica (1787)
 1 La seconda grande opera di Kant concerne non il conoscere scientifico dell uomo, ma il suo agire pratico. Nella Critica della ragion pratica Kant parte da questa convinzione: esiste una legge etica assoluta.
1 La seconda grande opera di Kant concerne non il conoscere scientifico dell uomo, ma il suo agire pratico. Nella Critica della ragion pratica Kant parte da questa convinzione: esiste una legge etica assoluta.
Aspetti Epistemologici dell Informatica
 Aspetti Epistemologici dell Informatica Prof.ssa Stefania Bandini Dott. Gianluca Colombo Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione Università di Milano-Bicocca bandini@disco.unimib.it tel.
Aspetti Epistemologici dell Informatica Prof.ssa Stefania Bandini Dott. Gianluca Colombo Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione Università di Milano-Bicocca bandini@disco.unimib.it tel.
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE
 FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
Guido Alliney Trento, 4 dicembre Libera volontà. Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto
 Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
L indagine sulla natura: il pensiero presocratico
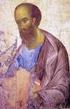 PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE TERZA SEZ. D DOCENTE: ADELE FRARACCI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 L indagine sulla natura: il pensiero presocratico La Grecia e la nascita della filosofia Le condizioni storico-politiche
PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE TERZA SEZ. D DOCENTE: ADELE FRARACCI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 L indagine sulla natura: il pensiero presocratico La Grecia e la nascita della filosofia Le condizioni storico-politiche
VIII. Insegnamento religioso
 VIII. Insegnamento religioso VIII. Insegnamento religioso 281 1. Insegnamento religioso cattolico L insegnamento religioso cattolico fa proprie le finalità e le modalità degli studi liceali così come sono
VIII. Insegnamento religioso VIII. Insegnamento religioso 281 1. Insegnamento religioso cattolico L insegnamento religioso cattolico fa proprie le finalità e le modalità degli studi liceali così come sono
L Enciclopedia delle scienze filosofiche
 L Enciclopedia delle scienze filosofiche La logica È la scienza dell Idea pura, cioè dell Idea nell elemento astratto del pensiero. Tesi di fondo: essere = pensiero (identità a partire dall Io puro) Hegel
L Enciclopedia delle scienze filosofiche La logica È la scienza dell Idea pura, cioè dell Idea nell elemento astratto del pensiero. Tesi di fondo: essere = pensiero (identità a partire dall Io puro) Hegel
Ruggero Morresi. Neotopica: un linguaggio, una filosofia. eum > scienze della comunicazione
 Ruggero Morresi Neotopica: un linguaggio, una filosofia eum > scienze della comunicazione eum > scienze della comunicazione Ruggero Morresi Neotopica: un linguaggio, una filosofia eum isbn 978-88-6056-161-9
Ruggero Morresi Neotopica: un linguaggio, una filosofia eum > scienze della comunicazione eum > scienze della comunicazione Ruggero Morresi Neotopica: un linguaggio, una filosofia eum isbn 978-88-6056-161-9
Sacra Scrittura e Simbolo
 Sacra Scrittura e Simbolo La pagina biblica è un «grande codice» La Bibbia è costituita da tre lingue: 1. ebraico; 2. Aramaico; 3. Greco. Due mondi: 1. Semitico; 2. Greco. La Bibbia è CONTEMPORANEAMENTE
Sacra Scrittura e Simbolo La pagina biblica è un «grande codice» La Bibbia è costituita da tre lingue: 1. ebraico; 2. Aramaico; 3. Greco. Due mondi: 1. Semitico; 2. Greco. La Bibbia è CONTEMPORANEAMENTE
La filosofia della medicina Lezione n. 1
 Storia e Filosofia della Medicina La filosofia della medicina Lezione n. 1 Contenuti del corso Che cos è la filosofia della medicina Dalla medicina magica alla medicina scientifica La medicina scientifica
Storia e Filosofia della Medicina La filosofia della medicina Lezione n. 1 Contenuti del corso Che cos è la filosofia della medicina Dalla medicina magica alla medicina scientifica La medicina scientifica
FACOLTÀ DI FILOSOFIA IN FILOSOFIA
 FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea IN FILOSOFIA PRESENTAZIONE La Facoltà di Filosofia dell Università Vita-Salute San Raffaele si trova in uno dei maggiori centri di ricerca europei, che pone la persona,
FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea IN FILOSOFIA PRESENTAZIONE La Facoltà di Filosofia dell Università Vita-Salute San Raffaele si trova in uno dei maggiori centri di ricerca europei, che pone la persona,
Il verbo latino adsistere, stare presso indica un venire da per andare verso (ad) qualcosa; curare e adsistere dicono, dunque, la stessa cosa:
 Il verbo latino adsistere, stare presso indica un venire da per andare verso (ad) qualcosa; curare e adsistere dicono, dunque, la stessa cosa: indicano un mio stare accanto a qualcuno perché costui mi
Il verbo latino adsistere, stare presso indica un venire da per andare verso (ad) qualcosa; curare e adsistere dicono, dunque, la stessa cosa: indicano un mio stare accanto a qualcuno perché costui mi
LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI A.S. 2015/2016 CLASSE IV D PROGRAMMA DI FILOSOFIA PROF.SSA ANTONIETTA PISTONE
 LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI A.S. 2015/2016 CLASSE IV D PROGRAMMA DI FILOSOFIA PROF.SSA ANTONIETTA PISTONE Filosofia cultura cittadinanza 2 Dall Umanesimo a Hegel, A. La Vergata, F. Trabattoni Unità 1:
LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI A.S. 2015/2016 CLASSE IV D PROGRAMMA DI FILOSOFIA PROF.SSA ANTONIETTA PISTONE Filosofia cultura cittadinanza 2 Dall Umanesimo a Hegel, A. La Vergata, F. Trabattoni Unità 1:
GIOVANNI GENTILE ( ) Gentile: lo spirito come atto. Vita ed opere
 GIOVANNI GENTILE (1875-1944) Ritratto di Giovanni Gentile http://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2016/04/giovanni-gentile.jpg Gentile: lo spirito come atto Vita ed opere Settantacinque in
GIOVANNI GENTILE (1875-1944) Ritratto di Giovanni Gentile http://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2016/04/giovanni-gentile.jpg Gentile: lo spirito come atto Vita ed opere Settantacinque in
Arianna Fermani VITA FELICE UMANA In dialogo con Platone e Aristotele
 Arianna Fermani VITA FELICE UMANA In dialogo con Platone e Aristotele eum x filosofia eum x 2006 eum edizioni università di macerata vicolo Tornabuoni, 58-62100 Macerata info.ceum@unimc.it http://ceum.unimc.it
Arianna Fermani VITA FELICE UMANA In dialogo con Platone e Aristotele eum x filosofia eum x 2006 eum edizioni università di macerata vicolo Tornabuoni, 58-62100 Macerata info.ceum@unimc.it http://ceum.unimc.it
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara)
 APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A
 HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,
HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,
TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI
 TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI LA SCOLASTICA E LA FILOSOFIA CRISTIANA DEL MEDIOEVO SVILUPPATASI FRA L XI e IL XIV SECOLO ESSA VENNE ELABORATA NELLE SCHOLAE ISTITUITE NEI MONASTERI, DOPO
TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI LA SCOLASTICA E LA FILOSOFIA CRISTIANA DEL MEDIOEVO SVILUPPATASI FRA L XI e IL XIV SECOLO ESSA VENNE ELABORATA NELLE SCHOLAE ISTITUITE NEI MONASTERI, DOPO
Bisogno di cura, desiderio di educazione A. Potestio e F. Togni. Corso di Pedagogia generale prof. G. Bertagna
 Bisogno di cura, desiderio di educazione A. Potestio e F. Togni Corso di Pedagogia generale prof. G. Bertagna 2011-2012 1 La categoria di cura La cura si è imposta nel Novecento come snodo centrale di
Bisogno di cura, desiderio di educazione A. Potestio e F. Togni Corso di Pedagogia generale prof. G. Bertagna 2011-2012 1 La categoria di cura La cura si è imposta nel Novecento come snodo centrale di
LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN ANNO SCOLASTICO Classe 3D. LIBRO DI TESTO: Abbagnano- Fornero CON-FILOSOFARE Dalle origine ad Aristotele
 LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Classe 3D LIBRO DI TESTO: Abbagnano- Fornero CON-FILOSOFARE Dalle origine ad Aristotele PROGRAMA FILOSOFIA LA GRECIA E LA NASCITA DELLA FILOSIA
LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Classe 3D LIBRO DI TESTO: Abbagnano- Fornero CON-FILOSOFARE Dalle origine ad Aristotele PROGRAMA FILOSOFIA LA GRECIA E LA NASCITA DELLA FILOSIA
Testo adottato: N.Abbagnano, G.Fornero La ricerca del pensiero vol. 2 A, 2B, Paravia
 PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA Classe: 4 G Anno Scolastico: 2015-2016 Docente: Bianca Maria Poggiali Testo adottato: N.Abbagnano, G.Fornero La ricerca del pensiero vol. 2 A, 2B, Paravia - Umanesimo e Rinascimento.
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA Classe: 4 G Anno Scolastico: 2015-2016 Docente: Bianca Maria Poggiali Testo adottato: N.Abbagnano, G.Fornero La ricerca del pensiero vol. 2 A, 2B, Paravia - Umanesimo e Rinascimento.
Classe III C Liceo Scientifico A.S. 2009/2010. Indicazioni per il lavoro estivo
 Classe III C Liceo Scientifico A.S. 2009/2010 Indicazioni per il lavoro estivo FILOSOFIA Per tutti gli studenti Lettura del testo: Ermanno Bencivenga, Platone,amico mio, Ed. Oscar Mondadori, Introduzione
Classe III C Liceo Scientifico A.S. 2009/2010 Indicazioni per il lavoro estivo FILOSOFIA Per tutti gli studenti Lettura del testo: Ermanno Bencivenga, Platone,amico mio, Ed. Oscar Mondadori, Introduzione
A cura di Alessandra Durando, Martina Ferrari, Serena Marsella, Ylenia Venturi. Liceo Classico G. Chiabrera 3^ F
 A cura di Alessandra Durando, Martina Ferrari, Serena Marsella, Ylenia Venturi. Liceo Classico G. Chiabrera 3^ F DUALISMO Ma che cos è il dualismo? Il termine dualismo definisce, in generale, ogni dottrina
A cura di Alessandra Durando, Martina Ferrari, Serena Marsella, Ylenia Venturi. Liceo Classico G. Chiabrera 3^ F DUALISMO Ma che cos è il dualismo? Il termine dualismo definisce, in generale, ogni dottrina
Esame scritto dell Opzione specifica. Filosofia + Pedagogia/Psicologia
 Nome e Cognome:. Gruppo:..Numero:.. Esame scritto dell Opzione specifica Filosofia + Pedagogia/Psicologia Parte interdisciplinare (Tempo a disposizione: 1 ora) Legga attentamente il seguente brano di David
Nome e Cognome:. Gruppo:..Numero:.. Esame scritto dell Opzione specifica Filosofia + Pedagogia/Psicologia Parte interdisciplinare (Tempo a disposizione: 1 ora) Legga attentamente il seguente brano di David
RELIGIONE CATTOLICA NEL PROFESSIONALE GRAFICO AMMINISTRATIVO
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE a.s.2014/2015 RELIGIONE CATTOLICA NEL PROFESSIONALE GRAFICO AMMINISTRATIVO PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI A CURA DEL RESPONSABILE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE a.s.2014/2015 RELIGIONE CATTOLICA NEL PROFESSIONALE GRAFICO AMMINISTRATIVO PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI A CURA DEL RESPONSABILE
Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva
 Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,
Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli
 FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
Johann Gottlieb Fichte
 ADESIONE A KANT Il primo Fichte riteneva che la prospettiva emersa con Kant fosse, in ambito filosofico, insuperabile. -1- Oggetto proprio della Filosofia non è l Essere (quindi l ontologia) ma il sapere
ADESIONE A KANT Il primo Fichte riteneva che la prospettiva emersa con Kant fosse, in ambito filosofico, insuperabile. -1- Oggetto proprio della Filosofia non è l Essere (quindi l ontologia) ma il sapere
MARIA GRAZIA BERGAMO Dall'Umanesimo all'idealismo, Porro Esposito, Editori Laterza
 DISCIPLINA CLASSE DOCENTE TESTO IN ADOZIONE FILOSOFIA IV C MARIA GRAZIA BERGAMO Dall'Umanesimo all'idealismo, Porro Esposito, Editori Laterza Facendo riferimento a quanto stabilito e condiviso nelle riunioni
DISCIPLINA CLASSE DOCENTE TESTO IN ADOZIONE FILOSOFIA IV C MARIA GRAZIA BERGAMO Dall'Umanesimo all'idealismo, Porro Esposito, Editori Laterza Facendo riferimento a quanto stabilito e condiviso nelle riunioni
Docente: Alessandra Fralleoni
 Università Roma Tre Facoltà di Scienze della formazione Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia L.39 A.A. 2016-2017 13 marzo 2017 Documentazione e scrittura di servizio sociale Strumento fondamentale
Università Roma Tre Facoltà di Scienze della formazione Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia L.39 A.A. 2016-2017 13 marzo 2017 Documentazione e scrittura di servizio sociale Strumento fondamentale
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Regione Siciliana
 I-AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE CLASSE III SEZ. A DOCENTE: Vincenzo Fusto MATERIA: Filosofia ANALISI DELLA CLASSE CONOSCENZE POSSESSO DEI PREREQUISITI COMPORTAMENTO SOCIALE
I-AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE CLASSE III SEZ. A DOCENTE: Vincenzo Fusto MATERIA: Filosofia ANALISI DELLA CLASSE CONOSCENZE POSSESSO DEI PREREQUISITI COMPORTAMENTO SOCIALE
CONOSCENZA ED ESPERIENZA
 CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza
CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza
Testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Vol. 2 A, 2B, Paravia
 PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA Classe: 4 G Anno Scolastico: 2016-2017 Docente: Bianca Maria Poggiali Testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Vol. 2 A, 2B, Paravia - Umanesimo
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA Classe: 4 G Anno Scolastico: 2016-2017 Docente: Bianca Maria Poggiali Testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Vol. 2 A, 2B, Paravia - Umanesimo
HEGEL (Stoccarda 1770-Berlino 1831) INTRODUZIONE
 HEGEL (Stoccarda 1770-Berlino 1831) INTRODUZIONE D aria Dispensa ad uso degli studenti del Liceo Sociale Besta Testi di riferimento: Abbagnano Fornero Itinerari di filosofia Massaro Il pensiero che conta
HEGEL (Stoccarda 1770-Berlino 1831) INTRODUZIONE D aria Dispensa ad uso degli studenti del Liceo Sociale Besta Testi di riferimento: Abbagnano Fornero Itinerari di filosofia Massaro Il pensiero che conta
L evoluzione del concetto di Responsabilità Sociale d Impresa
 Progetto "Per la tua maturità" L evoluzione del concetto di Responsabilità Sociale d Impresa Prof.ssa Giada Mainolfi Docente UNINT 15 marzo 2016 Cosa è la CSR (Responsabilità Sociale delle Imprese) L integrazione
Progetto "Per la tua maturità" L evoluzione del concetto di Responsabilità Sociale d Impresa Prof.ssa Giada Mainolfi Docente UNINT 15 marzo 2016 Cosa è la CSR (Responsabilità Sociale delle Imprese) L integrazione
Indice. Nota all edizione italiana di Salvatore Veca Prefazione del curatore Note introduttive Testi citati
 Indice Nota all edizione italiana di Salvatore Veca Prefazione del curatore Note introduttive Testi citati Introduzione: osservazioni sulla filosofia politica 1.Quattro domande sulla filosofia politica
Indice Nota all edizione italiana di Salvatore Veca Prefazione del curatore Note introduttive Testi citati Introduzione: osservazioni sulla filosofia politica 1.Quattro domande sulla filosofia politica
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI. Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima
 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Prof. Andrea Guarise. PROGETTO DIDATTICO CLASSE 3 a E scientifico
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Lezioni XII-XIII. Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele
 Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
AGOSTINO. Vita. Opere. La lotta alle eresie. - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene.
 AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
L IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE NELLA SICUREZZA
 L IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE NELLA SICUREZZA ------------------------------------------------- Dott.ssa Tullia Grossi Responsabile Area Formazione GEM BB S.r.l. «Conoscere non è affatto scomporre, né
L IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE NELLA SICUREZZA ------------------------------------------------- Dott.ssa Tullia Grossi Responsabile Area Formazione GEM BB S.r.l. «Conoscere non è affatto scomporre, né
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia
 APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
Trascendentale e temporalità
 SANDRO PALAZZO Trascendentale e temporalità Gilles Deleuze e l eredità kantiana a cura di Carla De Pascale Edizioni ETS www.edizioniets.com Il volume è stato stampato con il contributo di Dipartimento
SANDRO PALAZZO Trascendentale e temporalità Gilles Deleuze e l eredità kantiana a cura di Carla De Pascale Edizioni ETS www.edizioniets.com Il volume è stato stampato con il contributo di Dipartimento
Temi d Esame Logica II
 PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE Facoltà di Filosofia Temi d Esame Logica II Corso50609 Anno Accademico 2007/8 ELENCO TEMI D ESAME L ESAME SARÀ SCRITTO, DURERÀ DUE ORE E SARÀ COMPOSTO DI TRE PARTI. CHI
PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE Facoltà di Filosofia Temi d Esame Logica II Corso50609 Anno Accademico 2007/8 ELENCO TEMI D ESAME L ESAME SARÀ SCRITTO, DURERÀ DUE ORE E SARÀ COMPOSTO DI TRE PARTI. CHI
Etica e politica. Diritti, valori, cultura ed educazione in terra di Gomorra 8 febbraio 2013
 Etica e politica Diritti, valori, cultura ed educazione in terra di Gomorra 8 febbraio 2013 I. Moralità, socialità, politica: i termini in prospettiva etica Tre domande: - Come essere presenti all interno
Etica e politica Diritti, valori, cultura ed educazione in terra di Gomorra 8 febbraio 2013 I. Moralità, socialità, politica: i termini in prospettiva etica Tre domande: - Come essere presenti all interno
scienza dell essenza e della costruzione essenziale dell uomo nel suo tempo l essenza e l origine dell uomo sono state più incerte e l uomo è divenuto
 l uomo, la cui natura non è ascrivibile né ad una condizione di necessità assoluta né di libertà - - scienza dell essenza e della costruzione essenziale dell uomo nel suo tempo l essenza e l origine dell
l uomo, la cui natura non è ascrivibile né ad una condizione di necessità assoluta né di libertà - - scienza dell essenza e della costruzione essenziale dell uomo nel suo tempo l essenza e l origine dell
Kant, Hegel e noi. Introduzione
 Kant, Hegel e noi Introduzione 1. Il livello esistenziale del discorso speculativo filosofico: la filosofia è scienza, sapere oggettivo, ma anche molto di più, è testimonianza personale, è la vita stessa
Kant, Hegel e noi Introduzione 1. Il livello esistenziale del discorso speculativo filosofico: la filosofia è scienza, sapere oggettivo, ma anche molto di più, è testimonianza personale, è la vita stessa
LICEO SCIENTIFICO F. Lussana, BERGAMO. Classe 4C. Programma effettivamente svolto di FILOSOFIA. Anno scolastico CONTENUTI
 LICEO SCIENTIFICO F. Lussana, BERGAMO Classe 4C Programma effettivamente svolto di FILOSOFIA Anno scolastico 2015-2016 CONTENUTI 1. Dalla Patristica alla Scolastica a) Cristianesimo e filosofia: nucleo
LICEO SCIENTIFICO F. Lussana, BERGAMO Classe 4C Programma effettivamente svolto di FILOSOFIA Anno scolastico 2015-2016 CONTENUTI 1. Dalla Patristica alla Scolastica a) Cristianesimo e filosofia: nucleo
1. L esistenza del magistero della Chiesa Le radici del ministero apostolico La Scrittura...131
 Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
Immanuel Kant. Corso di Riallineamento di Filosofia A.A. 2015/2016 Prof.ssa Laura Stochino
 Immanuel Kant Corso di Riallineamento di Filosofia A.A. 2015/2016 Prof.ssa Laura Stochino Come e cosa conosciamo? https://www.youtube.com/watch?v=oux2mylkiby Le opere precritiche Dal razionalismo tedesco
Immanuel Kant Corso di Riallineamento di Filosofia A.A. 2015/2016 Prof.ssa Laura Stochino Come e cosa conosciamo? https://www.youtube.com/watch?v=oux2mylkiby Le opere precritiche Dal razionalismo tedesco
Laurea triennale in Scienze Religiose
 Laurea triennale in Scienze Religiose Il titolo accademico di laurea triennale in Scienze Religiose è propedeutico a successivi titoli di laurea magistrale (per il titolo magistrale è attivo l' indirizzo
Laurea triennale in Scienze Religiose Il titolo accademico di laurea triennale in Scienze Religiose è propedeutico a successivi titoli di laurea magistrale (per il titolo magistrale è attivo l' indirizzo
IMMANUEL KANT. (1724 Germania-1804) INTRODUZIONE
 IMMANUEL KANT (1724 Germania-1804) INTRODUZIONE ILLUMINISMO ROMANTICISMO SAPERE AUDE (Ultimo periodo della sua vita) USCIRE DALLO STATO DI MINORITA Nella CRITICA DEL GIUDIZIO CONDIZIONE DELL UOMO CHE NON
IMMANUEL KANT (1724 Germania-1804) INTRODUZIONE ILLUMINISMO ROMANTICISMO SAPERE AUDE (Ultimo periodo della sua vita) USCIRE DALLO STATO DI MINORITA Nella CRITICA DEL GIUDIZIO CONDIZIONE DELL UOMO CHE NON
IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L alunno: è aperto alla sincera ricerca della verità; sa interrogarsi
IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L alunno: è aperto alla sincera ricerca della verità; sa interrogarsi
D ARIA Dispensa ad uso degli studenti del Liceo Sociale Besta di Milano E del Liceo linguistico Natta di Milano
 D ARIA Dispensa ad uso degli studenti del Liceo Sociale Besta di Milano E del Liceo linguistico Natta di Milano RESTAURAZIONE 1814-1830 INSURREZIONI E MOTI RIVOLUZIONARI 1830-1848 EUROPA AMERICA SETTENTRIONALE
D ARIA Dispensa ad uso degli studenti del Liceo Sociale Besta di Milano E del Liceo linguistico Natta di Milano RESTAURAZIONE 1814-1830 INSURREZIONI E MOTI RIVOLUZIONARI 1830-1848 EUROPA AMERICA SETTENTRIONALE
MISTERO DELLA TRASFORMAZIONE
 Josef Wohlmuth MISTERO DELLA TRASFORMAZIONE Tentativo di una escatologia tridimensionale, in dialogo con il pensiero ebraico e la filosofia contemporanea QUERINIANA Indice Prefazione..............................................
Josef Wohlmuth MISTERO DELLA TRASFORMAZIONE Tentativo di una escatologia tridimensionale, in dialogo con il pensiero ebraico e la filosofia contemporanea QUERINIANA Indice Prefazione..............................................
(dal greco φιλοσοφία, composto di φιλειν (filèin), amare e σοφία (sofìa), sapienza, ossia amore per la sapienza)
 la filosofia 1 La filosofia (dal greco φιλοσοφία, composto di φιλειν (filèin), amare e σοφία (sofìa), sapienza, ossia amore per la sapienza) è la disciplina che si pone domande e cerca di dare risposte
la filosofia 1 La filosofia (dal greco φιλοσοφία, composto di φιλειν (filèin), amare e σοφία (sofìa), sapienza, ossia amore per la sapienza) è la disciplina che si pone domande e cerca di dare risposte
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO LO STUDIO DI CASO Una prospettiva didattica UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO ORIGINE SCIENTIFICA DELLA METODOLOGIA Studio di caso -
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO LO STUDIO DI CASO Una prospettiva didattica UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO ORIGINE SCIENTIFICA DELLA METODOLOGIA Studio di caso -
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
Umanesimo e Rinascimento
 Umanesimo e Rinascimento Caratteri generali di Pietro Gavagnin Scuola di Atene, Raffaello Humanitas = educazione e formazione dell uomo a) Non c è più un Dio ordinatore e perciò ci sarà una cosmologia
Umanesimo e Rinascimento Caratteri generali di Pietro Gavagnin Scuola di Atene, Raffaello Humanitas = educazione e formazione dell uomo a) Non c è più un Dio ordinatore e perciò ci sarà una cosmologia
CLASSE PRIMA MACRO ARGOMENTO CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI COMPETENZE 1 2 3
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL BIENNIO 1. Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2. Potenziare il dialogo interdisciplinare,
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL BIENNIO 1. Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2. Potenziare il dialogo interdisciplinare,
FACOLTÀ DI FILOSOFIA IN FILOSOFIA
 FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea IN FILOSOFIA PRESENTAZIONE La Facoltà di Filosofia dell Università Vita-Salute San Raffaele si trova in uno dei maggiori centri di ricerca europei, che pone la persona,
FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea IN FILOSOFIA PRESENTAZIONE La Facoltà di Filosofia dell Università Vita-Salute San Raffaele si trova in uno dei maggiori centri di ricerca europei, che pone la persona,
RELIGIONE Classe I sez. B Programma effettivamente svolto dal docente Maurizio Ormas
 RELIGIONE Classe I sez. B OBIETTIVI DEL BIENNIO 1. Saper individuare lo specifico della religione e dell esperienza religiosa, distinguendo tra domanda di senso, risposta religiosa e fede. 2. Saper individuare
RELIGIONE Classe I sez. B OBIETTIVI DEL BIENNIO 1. Saper individuare lo specifico della religione e dell esperienza religiosa, distinguendo tra domanda di senso, risposta religiosa e fede. 2. Saper individuare
INDlCE. Introduzione 13. PARTE PRIMA La formazione dell'etica di Kant 21
 INDlCE Introduzione 13 PARTE PRIMA La formazione dell'etica di Kant 21 1. L'etica di Kant e la tradizione della "Schulphilosophie" 23 2. Due interpretazioni dell'etica di Kant 27 3. Illuogo natio dell'etica
INDlCE Introduzione 13 PARTE PRIMA La formazione dell'etica di Kant 21 1. L'etica di Kant e la tradizione della "Schulphilosophie" 23 2. Due interpretazioni dell'etica di Kant 27 3. Illuogo natio dell'etica
IL CURRICOLO DI SCUOLA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
 IL CURRICOLO DI SCUOLA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA DELL INFANZIA - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) SCUOLA PRIMARIA - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) SCUOLA SECONDARIA I
IL CURRICOLO DI SCUOLA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA DELL INFANZIA - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) SCUOLA PRIMARIA - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) SCUOLA SECONDARIA I
Capire i media. UNDICESimA lezione. prof. Peppino Ortoleva.
 UNDICESimA lezione prof. Peppino Ortoleva peppino.ortoleva@gmail.com LE PAROLE SONO IMPORTANTI è essenziale imparare a usarle criticamente: cioè da un lato distinguendo bene i diversi significati, dall
UNDICESimA lezione prof. Peppino Ortoleva peppino.ortoleva@gmail.com LE PAROLE SONO IMPORTANTI è essenziale imparare a usarle criticamente: cioè da un lato distinguendo bene i diversi significati, dall
1- risoluzione del finito nell infinito; 2- identità di ragione e realtà; 3- funzione giustificatrice della filosofia.
 Schemi per Lilly 1- risoluzione del finito nell infinito; 2- identità di ragione e realtà; 3- funzione giustificatrice della filosofia. La realtà non è un insieme di sostanze, ma un organismo unitario,
Schemi per Lilly 1- risoluzione del finito nell infinito; 2- identità di ragione e realtà; 3- funzione giustificatrice della filosofia. La realtà non è un insieme di sostanze, ma un organismo unitario,
IL RACCONTO DELLA FILOSOFIA
 UGO PERONE IL RACCONTO DELLA FILOSOFIA Breve storia della filosofia Queriniana Indice generale Racconto e storia.... 5 La filosofia si definisce.... 9 1. I primordi 9 2. La filosofia nello spazio della
UGO PERONE IL RACCONTO DELLA FILOSOFIA Breve storia della filosofia Queriniana Indice generale Racconto e storia.... 5 La filosofia si definisce.... 9 1. I primordi 9 2. La filosofia nello spazio della
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO PROFESSIONALE IRC COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE TEMPI*
 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO PROFESSIONALE IRC CLASSE TERZA COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE TEMPI* Sviluppare un maturo Impostare domande di senso Questioni di
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO PROFESSIONALE IRC CLASSE TERZA COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE TEMPI* Sviluppare un maturo Impostare domande di senso Questioni di
Leonardo Messinese. L apparire di Dio. Per una metafisica teologica. Edizioni ETS
 Leonardo Messinese L apparire di Dio Per una metafisica teologica Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2015 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com
Leonardo Messinese L apparire di Dio Per una metafisica teologica Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2015 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com
ALLEGATO: TRACCE CONVITTO NAZIONALE 23 GENNAIO 2017
 ALLEGATO: TRACCE CONVITTO NAZIONALE 23 GENNAIO 2017 1) In ogni corpo l'intelletto coglie gli elementi strutturali, che per Galilei sono matematicamente determinabili (figura, relazione,collocazione spaziale,
ALLEGATO: TRACCE CONVITTO NAZIONALE 23 GENNAIO 2017 1) In ogni corpo l'intelletto coglie gli elementi strutturali, che per Galilei sono matematicamente determinabili (figura, relazione,collocazione spaziale,
