I trasferimenti intergovernativi (Bosi, Cap. 4) A.A Prof. Stefano Capri (a cura)
|
|
|
- Gregorio Fede
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 I trasferimenti intergovernativi (Bosi, Cap. 4) A.A Prof. Stefano Capri (a cura)
2 Le domande In tutti i modelli di decentramento/federalismo sono presenti trasferimenti di risorse dal centro alla periferia. In misura diversa, tanto minori, quanto maggiore è l autonomia dei livelli inferiori A quali motivazioni rispondono i trasferimenti? Di quali tipologie possono essere? Quali sono i loro effetti economici e distributivi?
3 Motivazioni dei trasferimenti intergovernativi 1) Integrazione di carenze di risorse per consentire consumi minimi di servizi (tendenza naturale) Concorrenza fiscale Effetto Baumol 2) Redistribuzione per ragioni di efficienza Effetti di traboccamento 3) Redistribuzione per ragioni di equità Trasferimenti perequativi 4) Finanziamento di spese di investimento in presenza di vincoli all indebitamento
4 Motivazioni dei trasferimenti intergovernativi (Carenze di risorse per consentire consumi minimi di servizi) Concorrenza fiscale Un tema di crescente importanza, soprattutto a livello transnazionale Le motivazioni della concorrenza sono l attrazione di persone, ma più spesso imprese, nel territorio locale a cui si associano effetti economici o politici positivi La presenza di effetti positivi non èperò scontata e va verificata e argomentata caso per caso (migrazioni, investimenti diretti in regioni sottosviluppate)
5 Motivazioni dei trasferimenti intergovernativi (Carenze di risorse per consentire consumi minimi di servizi) Effetto Baumol La produttività del lavoro cresce a ritmi diversi tipicamente industria (elevata) e molti servizi (bassa) Nel medio periodo questo comporta una modificazione dei prezzi relativi La produttività del lavoro è più lenta nei servizi che hanno un forte contenuto di lavoro che richiede adattamento a situazioni particolari (lavoro di cura, asili nido, ecc.)
6 3) Redistribuzione per ragioni di equità Trasferimenti perequativi A livello degli enti o degli individui? bisognosi; standard assistenziali; diverso reddito delle popolazioni servite 4) Finanziamento di spese di investimento in presenza di vincoli all indebitamento Meglio centralizzare l indebitamento pubblico
7 MOTIVAZIONI DEI TRASFERIMENTI INTERGOVERNATIVI (correzione degli spillover attraverso sussidi) Distribuzione territoriale dei benefici Comune A Spillover Comune B Redistribuzione per ragioni di efficienza Effetti di traboccamento (Spillover)
8 I trasferimenti intergovernativi possono essere disegnati in modo diverso in relazione a: Ammontare Discrezionali/Automatici Limitati(closed end)/illimitati(open end) Utilizzo Non condizionati/condizionati Modalità di distribuzione Cofinanziamento (matching)/in somma fissa (nonmatching)
9 I trasferimenti intergovernativi possono essere disegnati in modo diverso in relazione a: Ammontare Discrezionali/Automatici Limitati(closed end) a programmi specifici e con un ammontare massimo (e.g. sostegno alla povertà) Illimitati(open end): il centro finanzia tutti gli aventi diritto
10 Tipologia dei trasferimenti intergovernativi Modalità di distribuzione Somma fissa (non matching o lump sum) Cofinanziamento (matching) solitamente espressi in % della spesa autonomamente decisa dall ente locale, hanno la funzione di responsabilizzazione del livello inferiore di governo
11 Tipologia dei trasferimenti intergovernativi Utilizzo Non condizionati Utilizzabili senza vicoli di funzione Condizionati Utilizzabili solo per la funzione destinata (funzioni delegate servizi con rilevanti effetti esterni standard minimi imposti dall autorità centrale
12 Effetti economici dei trasferimenti L analisi che segue èrilevante soprattutto per i trasferimenti ad integrazione delle risorse o per quelli con finalità incentivanti Il problema è valutare l efficacia dei trasferimenti nello stimolare l offerta dei servizi locali
13 Gli effetti dei trasferimenti Gli strumenti di analisi utilizzati Si massimizza: 1. il benessere del governo centrale, nell ipotesi che esso sia in grado di rappresentare correttamente il benessere dei governi decentrati (visione paternalistica) 2. Il benessere dei membri dell ente locale (di difficile rappresentazione Teorema di Arrow) (visione individualistica) 3. Si massimizza il benessere dell elettore mediano
14 Gli effetti dei trasferimenti Consideriamo il terzo approccio L elettore mediano In tale approccio, il massimo benessere dell elettore mediano coincide con il benessere della comunità locale, o comunque è coerente con i meccanismi di decisione politica democratica a livello locale.
15 Gli effetti dei trasferimenti L approccio seguito è soggetto ad ipotesi: le stesse già viste per il teorema del decentramento di Oates (comunità di cittadini con preferenze largamente omogenee) e inoltre: l elettore mediano sia sempre lo stesso soggetto, prima e dopo il trasferimento; le decisioni di spesa dell autorità locale siano effettivamente prese in accordo con le preferenze espresse dall elettore mediano: l autorità massimizza l utilità dell elettore mediano.
16 Gli effetti dei trasferimenti L apparato tecnico utilizzato è quello delle curve di indifferenze Gli aspetti fondamentali, come nella teoria del consumo, sono costituiti da: Effetto reddito: i trasferimenti dal centro aumentano il reddito dei cittadini (dell elettore mediano) Effetto sostituzione: i trasferimenti possono essere disegnati in modo da modificare il prezzo (costo) relativo del servizio pubblico rispetto agli altri beni a cui è diretta la spesa dei cittadini (dell elettore mediano)
17 Gli effetti dei trasferimenti I trasferimenti possono quindi avere, in definitiva, tre diversi effetti: a) addizionalità diretta netta: che sia generale o specifico il trasferimento risulta efficace nel finanziare servizi pubblici locali che non sarebbero stati altrimenti prodotti (e questa èla sua finalità propria); b) addizionalità indiretta netta. Si tratta di un effetto che può esser conseguito da un trasferimento specifico che stimoli anche, pur senza volerlo, il consumo di altri servizi pubblici diversi da quello al cui finanziamento è diretto. c) spiazzamento. Si verifica quando il trasferimento centrale è usato impropriamente dall ente locale non già per ampliare la propria offerta di servizi pubblici ma per sostituire le imposte locali come fonte di finanziamento del medesimo ammontare di servizi.
18 Gli effetti dei trasferimenti Esaminiamo alcuni casi trasferimento non condizionato lump sum trasferimento condizionato non matching closed end trasferimento matching open end trasferimento matching closed end
19 Gli effetti dei trasferimenti Per le ipotesi fatte (teoria dell elettore mediano) i trasferimenti si traducono in aumenti delle risorse disponibile dell elettore mediano stesso, che èvincolato ad un vincolo di bilancio e le cui preferenze tra servizio pubblico e altri beni (privati) sono rappresentato da un sistema di curve di indifferenza.
20 X I 2 2 B Trasferimento non condizionato in somma fissa (lump-sum) (x 1 il servizio, x 2 tutti gli altri beni) I 1 E I P L Q - P 1 /P 2 O Addizionalità indiretta netta U H Addizionalità diretta netta D A X 1
21 Trasferimento lump sum Addizionalità diretta netta: si verifica in quanto aumenta il consumo del servizio X 1 a cui èdiretto il trasferimento Addizionalità indiretta netta e spiazzamento. Può essere rappresentata dall aumento del consumo di X 2,se X 2 rappresentasse altri servizi pubblici. Se X 2 èsolo beni privati si ha lo spiazzamento
22 Trasferimento condizionato non matching Si trasferisce una quantità di servizio pubblico (condizionato) a cui non corrisponde alcun costo per l elettore mediano (non matching) Ha l effetto di imporre all elettore mediano un consumo del servizio almeno pari al trasferimento (se il trasferimento fosse non condizionato l elettore raggiungerebbe un livello di benessere superiore potrebbe scegliere altri servizi)
23 Trasferimento matching open end Il trasferimento consiste in un sussidio pari a T euro per ogni unità di servizio pubblico consumata (openend perché non c è un vincolo alla somma che il livello superiore di governo intende spendere) Il vincolo di bilancio prima era: R = p 1 X 1 + p 2 X 2 Ora è R =(p 1 T) X 1 + p 2 X 2
24 X 2 B TRASFERIMENTO MATCHING OPEN-END END I 2 J I 1. G I. F. N P. -(P 1 -T)/P 2 O -P 1 /P 2 C H Z A X 1 FP= sussidio ricevuto
25 CONFRONTO TRA TRASFERIMENTO CONDIZIONATO LUMP-SUM E MATCHING OPEN-END END X 2 B H. G F.. N P. O C Z A X 1
26 Trasferimento matching closed end Il trasferimento consiste in un sussidio pari a T euro per ogni unità di servizio pubblico consumata (openend perché esiste un vincolo alla somma che il livello superiore di governo intende spendere) Il vincolo di bilancio prima era: R = p 1 X 1 + p 2 X 2 Ora è R =(p 1 T) X 1 + p 2 X 2
27 X 2 B TRASFERIMENTO MATCHING CLOSED-END END I 2 J I 1 (vincolo stringente il consumo ottimale OP > OL). G..R N P. O L C Z A X 1 Il trasferimento non può superare CZ (closed end): fino a OL il consumo è matching, poi èin somma fissa
28 X 2 B TRASFERIMENTO MATCHING CLOSED-END END I 2 J I 1 (vincolo non stringente il consumo ottimale OP< OL).. N P.G O C L Z A X 1
29 Gli effetti dei trasferimenti L analisi svolta mostra che fissare la forma del trasferimento significa fissare il vincolo di bilancio Le forme di trasferimento che inducono maggiore consumo di servizio pubblico sono i sussidi condizionati lump sum e i sussidi matching Questi ultimi vedono all opera anche effetti di sostituzione e quindi sono potenzialmente più distorsivi Se la finalità del trasferimento fosse solo perequativa sarebbe meglio usare trasferimenti lump sum
30 Critiche all approccio dell elettore mediano 1) le decisioni dell ente locale non necessariamente riflettono quelle degli elettori: ragioni ideologiche, esistenza di vincoli imposti centralmente, fattori socioeconomici, applicazione di regole incrementali nella determinazione del bilancio, ecc.. 2) La regola della maggioranza non èin grado di garantire che l aggregazione delle preferenze individuali dia luogo a un ordinamento di scelte collettive transitivo.
31 Critiche all approccio dell elettore mediano Il teorema dell elettore mediano vale infatti in ipotesi molto restrittive: il voto deve riguardare la semplice scelta fra due alternative (non ci devono essere scelte multivariate); la distribuzione delle preferenze individuali ènormale (preferenze single peaked); la votazione avviene a maggioranza; tutti gli aventi diritti votano (se non si sa quali cittadini votano non èinfatti possibile individuare l elettore mediano); si conoscono i costi delle alternative di spesa fra cui si è chiamati a scegliere; non ci sono comportamenti strategici: i cittadini votano secondo le loro preferenze senza cercare alleanze con gli altri votanti.
32 Critiche all approccio dell elettore mediano Due ulteriori problemi dell'approccio che fa riferimento alle preferenze dell elettore mediano: ignora i problemi redistributivi (come sempre avviene quando si ricorre alla logica di un agente rappresentativo della collettività, che èanalogo ad ipotizzare agenti identici); l identità stessa dell elettore mediano può cambiare per gli effetti che l insieme delle imposte locali e centrali e dei trasferimenti intergovernativi esercitano sul reddito disponibile degli elettori.
33 Il Fly paper effect Nell analisi fatta un sussidio lump sum è equivalente ad un aumento del reddito disponibile dell elettore mediano. Questa equivalenza non si verifica nella realtà e i soldi che vengono trasferiti sotto forma di sussidi dal centro alla periferia sono invece preferenzialmente utilizzati nei servizi pubblici I soldi restano attaccati là ove si posano (effetto carta moschicida) Ciò mette in crisi l approccio fin qui esposto. Tra le varia scuole critiche vi è quella della Public Choice (le inefficienze derivano dalla presenza di obiettivi dei politici e burocrati in conflitto con quelle dei cittadini)
34 Public Choice E una teoria molto famosa nell ambito della scuola della Public Choice La Public Choice èun campo dell economia pubblica che analizza i problemi introducendo nella teoria anche il comportamento dei burocrati o dei governi, a cui sono attribuiti obiettivi diversi da quelli dei cittadini. Gli obiettivi dei politici sono il mantenimento del potere, essere rieletti Per i burocrati di amministrare budget sempre più grandi perché da ciò dipende il loro prestigio e reddito
35 Public Choice Le teorie della Public Choice raggiungono per lo più conclusioni molto ostili all intervento pubblico. Uno dei suoi massimi esponenti èil premio Nobel James Buchanan Politici a burocrati hanno obiettivi diversi da quelli dei cittadini: ciò ècausa di inefficienze
36 Il modello di Niskanen Niskanen èuno dei primi a esaminare il comportamento dei burocrati. Si suppone che essi abbiano informazioni private sui costi marginali e sui vantaggi marginali dei servizi pubblici e usino questo privilegio informativo per allargare il budget da essi amministrato.
37 Il modello di Niskanen e il Flypaper effect Nell ambito del modello di Niskanen è possibile fornire una spiegazione del Flypaper effect. Se c è un trasferimento dal centro a un ente locale, questo si traduce in una riduzione del costo medio del servizio. Di ciò approfitteranno i manager pubblici per allargare il bilancio Se il trasferimento fosse dato direttamente ai cittadini, la domanda del servizio pubblico sarebbe aumentata (se il servizio pubblico ha un elasticità positiva rispetto al reddito), ma l incremento sarebbe stato probabilmente minore. In tal modo il Flypaper effect risulta spiegato dalla volontà dei manager di approfittare del trasferimento per allargare il bilancio, spendendo più del livello efficiente.
38 MODELLI DI TRASFERIMENTI PEREQUATIVI
39 Modelli di trasferimenti perequativi Domande Quanta perequazione deve essere fatta? Come evitare comportamenti strategici/opportunistici da parte degli enti locali?
40 Modelli di trasferimenti perequativi Spesa storica (si pretende dal Centro il finanziamento non finanziabile con risorse proprie, e nella difficoltà dei costi standard, si garantisce la spesa consolidata nel tempo Performance (risorse pari alla differenza fra fabbisogno standard e gettito effettivo dell ente) Capacità (risorse pari alla differenza fra fabbisogno standard e gettito potenziale tiene costo dell evasione dell ente) Potenziale fiscale (risorse pari alla differenza tra l aliquota introdotta nell ente locale e quella media nazionale)
41 Modelli di trasferimenti perequativi Ipotesi Responsabilità dell ente locale nell impiego efficiente delle risorse e nell uso della propria autonomia fiscale
42 Modelli di trasferimenti perequativi Ipotesi Diversi enti locali Con popolazione omogenea Una sola imposta proporzionale Con diversa base imponibile Libertà dell ente locale di determinare: l aliquota dell imposta il livello della spesa pubblica
43 Modelli di trasferimenti perequativi Ipotesi Si fa riferimento sempre a grandezze (base imponibile, imposte e spesa pubblica) in termini pro capite
44 Modelli di trasferimenti perequativi Definizione di alcune variabili t i B i T i = t i B i G i TR i A i =T i +TR i aliquota dell imposta locale base imponibile gettito dell imposta locale spesa effettiva locale trasferimento dal governo centrale risorse complessive del governo locale
45 La spesa storica Non èun modello, ma la rappresentazione di una prassi molto comune Poco raccomandabile
46 La spesa storica S i =G i T i fabbisogno dell ente locale TR i = S i trasferimento dello Stato A i = T i +TR i = G i dotazione di ciascun ente
47 Dati di base EL 1 EL 2 EL3 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,05 0,05 t*i,aliq. standard 0,05 0,05 0,05 Ti=ti Bi T*=t* B*=A* Gi Si=Gi-Ti Spesa storica TRi= Si Ai=Ti + TRi Fondo centrale= Sum Tri 0
48 Dati di base EL 1 EL 2 EL3 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,02 0,05 t*i,aliq. standard 0,04 0,04 0,04 Ti=ti Bi T*=t* B*=A* Gi Si=Gi-Ti Spesa storica TRi= Si Ai=Ti + TRi Fondo centrale= Sum Si 60
49 Dati di base EL 1 EL 2 EL3 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,05 0,05 t*i,aliq. standard 0,05 0,05 0,05 Ti=ti Bi T*=t* B*=A* Gi Si=Gi-Ti Spesa storica TRi= Si Ai=Ti + TRi Fondo centrale= Sum Tri 30
50 Il modello della performance L idea èdi commisurare i trasferimenti al fabbisogno degli enti e non alla spesa effettiva. Implica la definizione di un fabbisogno standard
51 Il modello della performance Fabbisogno standard: A* TR i =A* T i dove A* = t* B* base imponibile standard x aliquota standard T i = t i B i base imponibile x aliquota A i = T i +TR i = A*
52 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,05 0,05 t*i,aliq. standard 0,05 0,05 0,05 Ti=ti Bi T*=t* B*=A* Gi Si=Gi-Ti Performance A*i TRi= A*i- Ti Ai=Ti + TRi = A*i Fondo centrale= Sum Tri 0
53 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,05 0,05 t*i,aliq. standard 0,05 0,05 0,05 Ti=ti Bi T*=t* B*=A* Gi Si=Gi-Ti Performance A*i=T*i TRi= A*i- Ti Ai=Ti + TRi = A*i Fondo centrale= Sum Tri 0
54 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,03 0,05 t*i,aliq. standard 0,04 0,04 0,04 Ti=ti Bi T*=t* B*=A* Gi Si=Gi-Ti Performance A*i TRi= A*i- Ti Ai=Ti + TRi = A*i Fondo centrale= Sum Tri 40
55 Il modello della performance Il Fabbisogno standard non è necessariamente uguale per tutti gli enti locali. Possono esservi ragioni che spiegano differenze di fabbisogno standard Si identificano pesi o coefficienti in grado di tenere conto di queste differenza di fabbisogno standard.
56 Il modello della performance Fabbisogno standard ponderato A i * = m i (x 1, x 2,..,x n ) A* Dove m i =indici di fabbisogno relativo (=1 per l ente medio) A i = T i +TR i = A i *
57 Dati di base EL 1 EL 2 EL3 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,05 0,05 t*i,aliq. standard 0,05 0,05 0,05 Ti=ti Bi T*=t* B*=A* Gi Si=Gi-Ti Performance ponderata mi 1,5 1,0 0,8 A*ip=A*i*mi TRi= A*i- Ti Ai=Ti + TRi = A*i Fondo centrale= Sum Tri 30
58 Il modello della capacita Affronta la causa di irresponsabilità lasciata aperta dal modello della performance. Il trasferimento èpari alla differenza tra spesa standard e gettito standard
59 Il modello della capacita Il gettito standard èdato dal prodotto tra aliquota standard e base imponibile effettiva L aliquota standard è determinata dal governo centrale. Spesso èvicina al valore dell aliquota media
60 Il modello della capacita Aliquota standard: t* èuna media ponderata delle aliquote effettive, pesata con le basi imponibili dei vari enti TR i =A* t*b i A i = T i + TR i = t i B i + A* t*b i = A*+ (t i t*)b i
61 Dati di base EL 1 EL 2 EL3 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,05 0,05 t*i,aliq. standard 0,05 0,05 0,05 Ti=ti Bi A* Gi Si=Gi-Ti Capacità TRi = A*-t* Bi Ai=Tì+TRi=Bi(t-t*)+A* Fondo centrale= Sum Tri 0
62 Dati di base EL 1 EL 2 EL3 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,02 0,05 t*i,aliq. standard 0,05 0,05 0,05 Ti=ti Bi A* Gi Si=Gi-Ti Capacità TRi = A*-t* Bi Ai=Tì+TRi=Bi(t-t*)+A* Fondo centrale= Sum Tri 0
63 B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,05 0,05 t*i,aliq. standard 0,05 0,05 0,05 Ti=ti Bi T*=t* B*=A* Gi Si=Gi-Ti Performance ponderata mi 1,5 1,0 0,8 A*ip=A*i*mi TRi= A*i- Ti Ai=Ti + TRi = A*i Fondo centrale= Sum Tri 30
64 Il modello della capacita (versione canadese) In questo modello la perequazione viene operata non sul versante della spesa, ma su quello delle entrate Il concetto rilevante èla capacità fiscale
65 Dati di base EL 1 EL 2 EL3 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,05 0,05 t*i,aliq. standard 0,05 0,05 0,05 Ti=ti Bi A* Gi Si=Gi-Ti Capacità TRi = A*-t* Bi Ai=Tì+TRi=Bi(t-t*)+A* Fondo centrale= Sum Tri 0
66 Il modello della capacita (versione canadese) Poiché A*=t*B* I risultati non sono diversi dal modello già esaminato Sono diverse le informazioni necessarie al governo centrale per implementarlo
67 Il modello della capacita (versione canadese) Il trasferimento èpari alla differenza tra t*b* e la capacità fiscale t*b
68 Il modello della capacità (versione canadese) A*=t*B* TR i =A* t*b i = t*(b* B i ) A i = T i + TR i = t*b* + (t i t*)b i
69 Il modello del potenziale Si pone l obiettivo di premiare e incentivare lo sforzo fiscale Nel modello capacità canadese TR= t*(b* B) Qui si sostituisce a t* l aliquota t Se t aumenta aumenta il trasferimento
70 Il modello del potenziale TR i = t (B* B i ) A i = T i + TR i = tb i + tb* tb i = tb*
71 Dati di base EL 1 EL 2 EL3 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,05 0,05 t*i,aliq. standard 0,05 0,05 0,05 Ti=ti Bi T*=t* B*=A* Gi Si=Gi-Ti Potenziale TRi = ti(b* - Bi) Ai = tib* Fondo centrale= Sum Tri 0 SFi = ti/t* 1,0 1,0 1,0 Ai/SFi
72 Dati di base EL 1 EL 2 EL3 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,06 0,05 t*i,aliq. standard 0,05 0,05 0,05 Ti=ti Bi T*=t* B*=A* Gi Si=Gi-Ti Potenziale TRi = ti(b* - Bi) Ai = tib* Fondo centrale= Sum Tri 0 SFi = ti/t* 1,0 1,2 1,0 Ai/SFi
73 Dati di base EL 1 EL 2 EL3 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,05 0,06 t*i,aliq. standard 0,05 0,05 0,05 Ti=ti Bi T*=t* B*=A* Gi Si=Gi-Ti Potenziale TRi = ti(b* - Bi) Ai = tib* Fondo centrale= Sum Tri -10 SFi = ti/t* 1,0 1,0 1,2 Ai/SFi
74 Dati di base EL 1 EL 2 EL3 Bi,base imponibile B*i, b.i.standard ti, aliquota 0,05 0,05 0,05 t*i,aliq. standard 0,05 0,05 0,05 Ti=ti Bi T*=t* B*=A* Gi Si=Gi-Ti Capacità TRi = A*-t* Bi Ai=Tì+TRi=Bi(t-t*)+A* Fondo centrale= Sum Tri 0 Dati di base EL 1 EL 2 EL3
75 Conclusioni L orientamento prevalente in Italia èdi realizzare modelli della capacità fiscale. C è una certa oscillazione tra la scelta del modello spesa rispetto al modello canadese.
76 Conclusioni La scelta è fortemente condizionata dal fabbisogno informativo necessario per implementare ciascun modello Sono forti le resistenze dei politici ad abbandonare modelli legati alla spesa storica
IL DECENTRAMENTO FISCALE. Scienza delle finanze lezione 13
 IL DECENTRAMENTO FISCALE Scienza delle finanze lezione 13 ALCUNE DOMANDE Perché esistono diversi livelli di governo: stato, regioni, comuni? Quali sono i compiti più appropriati per il centro e la periferia?
IL DECENTRAMENTO FISCALE Scienza delle finanze lezione 13 ALCUNE DOMANDE Perché esistono diversi livelli di governo: stato, regioni, comuni? Quali sono i compiti più appropriati per il centro e la periferia?
MODELLI DI TRASFERIMENTI PEREQUATIVI
 Lezione 5 MODELLI DI TRASFERIMENTI MODELLI DI TRASFERIMENTI domande Quanta perequazione deve essere fatta? Come evitare comportamenti strategici da parte degli entu locali? MODELLI DI TRASFERIMENTI Spesa
Lezione 5 MODELLI DI TRASFERIMENTI MODELLI DI TRASFERIMENTI domande Quanta perequazione deve essere fatta? Come evitare comportamenti strategici da parte degli entu locali? MODELLI DI TRASFERIMENTI Spesa
Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, il Mulino, 2012 Capitolo I, lezione 1 Il problema e alcune premesse
 Il problema e alcune premesse La costruzione della grande frontiera delle utilità e l ottimo l paretiano La scienza delle finanze studia le entrate e le uscite pubbliche con un approccio normativo e positivo
Il problema e alcune premesse La costruzione della grande frontiera delle utilità e l ottimo l paretiano La scienza delle finanze studia le entrate e le uscite pubbliche con un approccio normativo e positivo
Effetti distorsivi delle imposte
 Capitolo III. Effetti distorsivi delle imposte Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, il Mulino, 2006 1 Effetti sul benessere dei contribuenti Tutte le imposte sottraggono risorse ai contribuenti,
Capitolo III. Effetti distorsivi delle imposte Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, il Mulino, 2006 1 Effetti sul benessere dei contribuenti Tutte le imposte sottraggono risorse ai contribuenti,
Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11)
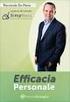 Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11) MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto economico
Concorrenza perfetta (Frank - Capitolo 11) MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto economico
STATO E RIDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE
 STATO E RIDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE, FACOLTÁ DI SOCIOLOGIA A.A. 2008-2009 ANNA TEMPIA 4 LEZIONE CENNI DI TEORIA DELL IMPOSTA (PARTE SECONDA) BIBLIOGRAFIA: P. Bosi
STATO E RIDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE, FACOLTÁ DI SOCIOLOGIA A.A. 2008-2009 ANNA TEMPIA 4 LEZIONE CENNI DI TEORIA DELL IMPOSTA (PARTE SECONDA) BIBLIOGRAFIA: P. Bosi
PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI
 PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI Già da qualche anno sono stati cambiati i parametri con i quali i pensionati possono ottenere le prestazioni pensionistiche legate al reddito.
PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI Già da qualche anno sono stati cambiati i parametri con i quali i pensionati possono ottenere le prestazioni pensionistiche legate al reddito.
STABILIZZATORI AUTOMATICI E TEORIA DEL DEBITO PUBBLICO
 DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELL ATTIVITA ECONOMICA STABILIZZATORI AUTOMATICI E TEORIA DEL DEBITO PUBBLICO Principio della domanda effettiva Offerta elastica Prezzi fissi Non pieno utilizzo della capacità
DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELL ATTIVITA ECONOMICA STABILIZZATORI AUTOMATICI E TEORIA DEL DEBITO PUBBLICO Principio della domanda effettiva Offerta elastica Prezzi fissi Non pieno utilizzo della capacità
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
 FONDO PENSIONE PREVIBANK iscritto all Albo dei Fondi Pensione al n. 1059 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 Luglio 2014) Pagina 1 di 6 Versione Luglio 2014 PREMESSA Le informazioni fornite nel
FONDO PENSIONE PREVIBANK iscritto all Albo dei Fondi Pensione al n. 1059 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 Luglio 2014) Pagina 1 di 6 Versione Luglio 2014 PREMESSA Le informazioni fornite nel
ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI
 FACOLTA DI INGEGNERIA ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI ESERCIZI SVOLTI IN AULA A.A. 2010-2011 DOCENTE: Francesca Iacobone ASSISTENTE ALLA DIDATTICA: Andrea Maresca RICHIAMI DI TEORIA I richiami di teoria
FACOLTA DI INGEGNERIA ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI ESERCIZI SVOLTI IN AULA A.A. 2010-2011 DOCENTE: Francesca Iacobone ASSISTENTE ALLA DIDATTICA: Andrea Maresca RICHIAMI DI TEORIA I richiami di teoria
L IRPEF. L imposta sul reddito in Italia
 L IRPEF L imposta sul reddito in Italia 1 1 L IRPEF Imposta personale e progressiva Assicura un gettito elevato Permette di realizzare obiettivi di redistribuzione del reddito E uno strumento di stabilizzazione
L IRPEF L imposta sul reddito in Italia 1 1 L IRPEF Imposta personale e progressiva Assicura un gettito elevato Permette di realizzare obiettivi di redistribuzione del reddito E uno strumento di stabilizzazione
Domanda individuale e domanda di mercato (Frank, Capitolo 4)
 Domanda individuale e domanda di mercato (Frank, Capitolo 4) GLI EFFETTI DELLE VARIAZIONI DI PREZZO: CURVE PREZZO CONSUMO La curva prezzo-consumo per l abitazione rappresenta i panieri ottimali corrispondenti
Domanda individuale e domanda di mercato (Frank, Capitolo 4) GLI EFFETTI DELLE VARIAZIONI DI PREZZO: CURVE PREZZO CONSUMO La curva prezzo-consumo per l abitazione rappresenta i panieri ottimali corrispondenti
Economia, Corso di Laurea Magistrale in Ing. Elettrotecnica, A.A Prof. R. Sestini SCHEMA DELLE LEZIONI DELLA PRIMA SETTIMANA
 Economia, Corso di Laurea Magistrale in Ing. Elettrotecnica, A.A. 2013-2014. Prof. R. Sestini SCHEMA DELLE LEZIONI DELLA PRIMA SETTIMANA ALCUNE PREMESSE Cosa e la microeconomia? E la disciplina che studia
Economia, Corso di Laurea Magistrale in Ing. Elettrotecnica, A.A. 2013-2014. Prof. R. Sestini SCHEMA DELLE LEZIONI DELLA PRIMA SETTIMANA ALCUNE PREMESSE Cosa e la microeconomia? E la disciplina che studia
IL MODELLO ECONOMICO DI BASE: RIPASSO
 IL MODELLO ECONOMICO DI BASE: RIPASSO 1 Argomenti studiati nel corso di Economia Politica Introduzione e funzionamento dell economia nel lungo periodo o Il modello macroeconomico (capp. 1-3) o Moneta e
IL MODELLO ECONOMICO DI BASE: RIPASSO 1 Argomenti studiati nel corso di Economia Politica Introduzione e funzionamento dell economia nel lungo periodo o Il modello macroeconomico (capp. 1-3) o Moneta e
Esempi di attribuzione dei seggi
 Esempi di attribuzione dei seggi Al fine di chiarire il funzionamento dei meccanismi previsti per l attribuzione dei seggi e l ordine delle relative operazioni, vengono presentati due esempi di attribuzione
Esempi di attribuzione dei seggi Al fine di chiarire il funzionamento dei meccanismi previsti per l attribuzione dei seggi e l ordine delle relative operazioni, vengono presentati due esempi di attribuzione
La teoria normativa della politica economica
 La teoria normativa della politica economica Teoria normativa della politica economica Dai fallimenti del mercato scaturisce l esigenza dell intervento di un operatore avente motivazioni e obiettivi collettivi
La teoria normativa della politica economica Teoria normativa della politica economica Dai fallimenti del mercato scaturisce l esigenza dell intervento di un operatore avente motivazioni e obiettivi collettivi
Federalismo e comuni, un confronto
 Federalismo e comuni, un confronto Domenico Suppa 25 gennaio 2009 In Italia il federalismo fiscale è un argomento largamente dibattuto. Il dualismo territoriale che caratterizza il nostro Paese è lo sfondo
Federalismo e comuni, un confronto Domenico Suppa 25 gennaio 2009 In Italia il federalismo fiscale è un argomento largamente dibattuto. Il dualismo territoriale che caratterizza il nostro Paese è lo sfondo
32 L influenza della politica monetaria e fiscale sulla domanda aggregata
 32 L influenza della politica monetaria e fiscale sulla domanda aggregata 1 La domanda aggregata è influenzata da molti fattori, inclusi i desideri di spesa delle famiglie e delle imprese Quando i desideri
32 L influenza della politica monetaria e fiscale sulla domanda aggregata 1 La domanda aggregata è influenzata da molti fattori, inclusi i desideri di spesa delle famiglie e delle imprese Quando i desideri
Esercizi svolti per l esame di Microeconomia
 Esercizi svolti per l esame di Microeconomia Università di Bari aa. 015-16 Es. 3.1 Concorrenza perfetta In un mercato in concorrenza perfetta in equilibrio di lungo periodo il prezzo è P = 00, la quantità
Esercizi svolti per l esame di Microeconomia Università di Bari aa. 015-16 Es. 3.1 Concorrenza perfetta In un mercato in concorrenza perfetta in equilibrio di lungo periodo il prezzo è P = 00, la quantità
Effetti dell imposizione societaria: analisi delle aliquote effettive. Economia dei tributi_polin 1
 Effetti dell imposizione societaria: analisi delle aliquote effettive Economia dei tributi_polin 1 Aliquote effettive Per valutare l incidenza del sistema fiscale sulle decisioni di investimento e di localizzazione,
Effetti dell imposizione societaria: analisi delle aliquote effettive Economia dei tributi_polin 1 Aliquote effettive Per valutare l incidenza del sistema fiscale sulle decisioni di investimento e di localizzazione,
Economia Internazionale e Politiche Commerciali (a.a. 14/15)
 Economia Internazionale e Politiche Commerciali (a.a. 14/15) Soluzione Prova intermedia (15 novembre 2014) 1. (11 p.) Ipotizzate che in un mondo a due paesi, India e Stati Uniti, due fattori, capitale
Economia Internazionale e Politiche Commerciali (a.a. 14/15) Soluzione Prova intermedia (15 novembre 2014) 1. (11 p.) Ipotizzate che in un mondo a due paesi, India e Stati Uniti, due fattori, capitale
DOMANDE a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non sono previste penalizzazioni in caso di risposte non corrette)
 In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. DOMANDE a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. DOMANDE a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
Temi speciali di bilancio
 Università degli Studi di Parma Temi speciali di bilancio Le imposte Riferimenti PRINCIPIO CONTABILE n. 25 (da fare tutto) DOCUMENTO INTERPRETATIVO AL P.C. 25 (N.2) (da fare: 1-15, 18-42) 2 Le imposte
Università degli Studi di Parma Temi speciali di bilancio Le imposte Riferimenti PRINCIPIO CONTABILE n. 25 (da fare tutto) DOCUMENTO INTERPRETATIVO AL P.C. 25 (N.2) (da fare: 1-15, 18-42) 2 Le imposte
Pagina 2 di 6 - Pagina Stima sulla bianca pensione complementare. Edizione 03.2016. GeneraFuturo
 GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico Fondo Pensione (iscrizione all Albo COVIP n. 5095) Stima della pensione Progetto esemplificativo standardizzato Pagina 2 di 6 - Pagina Stima sulla bianca pensione
GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico Fondo Pensione (iscrizione all Albo COVIP n. 5095) Stima della pensione Progetto esemplificativo standardizzato Pagina 2 di 6 - Pagina Stima sulla bianca pensione
PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E
 PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013 - ASSE E Progetto Performance PA Ambito B - Linea 2 Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del personale Seminario Il sistema di
PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013 - ASSE E Progetto Performance PA Ambito B - Linea 2 Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del personale Seminario Il sistema di
SCIENZA DELLE FINANZE A.A Esercitazione IVA e IRAP TESTO e SOLUZIONI
 SCIENZA DELLE FINANZE A.A. 2013-2014 Esercitazione IVA e IRAP TESTO e SOLUZIONI Esercizio 1 Si consideri la seguente situazione: - l impresa A vende all'impresa B un bene intermedio, che ha prodotto utilizzando
SCIENZA DELLE FINANZE A.A. 2013-2014 Esercitazione IVA e IRAP TESTO e SOLUZIONI Esercizio 1 Si consideri la seguente situazione: - l impresa A vende all'impresa B un bene intermedio, che ha prodotto utilizzando
ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL CICLO ECONOMICO
 Università degli studi di MACERATA Facoltà di SCIENZE POLITICHE ECONOMIA POLITICA: MICROECONOMIA A.A. 2009/2010 ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL CICLO ECONOMICO Fabio CLEMENTI E-mail: fabio.clementi@univpm.it
Università degli studi di MACERATA Facoltà di SCIENZE POLITICHE ECONOMIA POLITICA: MICROECONOMIA A.A. 2009/2010 ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL CICLO ECONOMICO Fabio CLEMENTI E-mail: fabio.clementi@univpm.it
Biblioteca di Pronti... via 2 o biennio TOMO h
 UNITÀ C Tecniche di gestione degli acquisti e delle scorte Biblioteca di Pronti... via 2 o biennio TOMO h La funzione del magazzino e la politica delle scorte Documento Esercizi Logistica Q1 Spiega che
UNITÀ C Tecniche di gestione degli acquisti e delle scorte Biblioteca di Pronti... via 2 o biennio TOMO h La funzione del magazzino e la politica delle scorte Documento Esercizi Logistica Q1 Spiega che
Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi
 Articolo 2, commi 51-56 Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi di Silvia Spattini La volontà di prevedere una misura di sostegno al reddito rivolta ai collaboratori coordinati
Articolo 2, commi 51-56 Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi di Silvia Spattini La volontà di prevedere una misura di sostegno al reddito rivolta ai collaboratori coordinati
I DIECI PRINCIPI DELL ECONOMIA
 Università degli studi di MACERATA Facoltà di SCIENZE POLITICHE ECONOMIA POLITICA: MICROECONOMIA A.A. 2011/2012 I DIECI PRINCIPI Fabio CLEMENTI E-mail: fabio.clementi@unimc.it Web: http://docenti.unimc.it/docenti/fabio-clementi
Università degli studi di MACERATA Facoltà di SCIENZE POLITICHE ECONOMIA POLITICA: MICROECONOMIA A.A. 2011/2012 I DIECI PRINCIPI Fabio CLEMENTI E-mail: fabio.clementi@unimc.it Web: http://docenti.unimc.it/docenti/fabio-clementi
La riduzione dell aliquota IRES
 La riduzione dell aliquota IRES di Lelio Violetti Le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) prevedono all articolo 5 la riduzione dell aliquota
La riduzione dell aliquota IRES di Lelio Violetti Le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) prevedono all articolo 5 la riduzione dell aliquota
Le imprese nei mercati concorrenziali
 Le imprese nei mercati concorrenziali Le decisioni di prezzo e di produzione delle imprese sono influenzate dalla forma di mercato. Un caso estremo di mercato è quello della concorrenza perfetta. Tre condizioni:
Le imprese nei mercati concorrenziali Le decisioni di prezzo e di produzione delle imprese sono influenzate dalla forma di mercato. Un caso estremo di mercato è quello della concorrenza perfetta. Tre condizioni:
Corso di. Economia Politica
 Prof.ssa Blanchard, Maria Laura Macroeconomia Parisi, PhD; Una parisi@eco.unibs.it; prospettiva europea, DEM Università Il Mulino di 20 Brescia Capitolo I. Un Viaggio intorno al mondo Corso di Economia
Prof.ssa Blanchard, Maria Laura Macroeconomia Parisi, PhD; Una parisi@eco.unibs.it; prospettiva europea, DEM Università Il Mulino di 20 Brescia Capitolo I. Un Viaggio intorno al mondo Corso di Economia
la distribuzione di uomini e donne fra i diversi settori produttivi; la ripartizione dei due sessi fra le diverse qualifiche professionali 1.
 Differenziali retributivi fra uomini e donne nel lavoro interinale. Alcune evidenze ricavate dalla banca dati EBITEMP sui prestiti ai lavoratori per l anno 2004. 1. Premessa Attualmente non risulta disponibile
Differenziali retributivi fra uomini e donne nel lavoro interinale. Alcune evidenze ricavate dalla banca dati EBITEMP sui prestiti ai lavoratori per l anno 2004. 1. Premessa Attualmente non risulta disponibile
Allegato 3 - Sistema di misurazione e valutazione IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
 Allegato 3 - Sistema di misurazione e valutazione IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE Titolo 1 - LA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI
Allegato 3 - Sistema di misurazione e valutazione IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE Titolo 1 - LA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI
a) Usando i seguenti livelli di significatività, procedere alla verifica di ipotesi, usando come ipotesi alternativa un'ipotesi unidirezionale:
 ESERCIZIO 1 Da studi precedenti, il responsabile del rischio di una grande banca sa che l'ammontare medio di denaro che deve essere corrisposto dai correntisti che hanno il conto scoperto è pari a 240.
ESERCIZIO 1 Da studi precedenti, il responsabile del rischio di una grande banca sa che l'ammontare medio di denaro che deve essere corrisposto dai correntisti che hanno il conto scoperto è pari a 240.
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE I PROTAGONISTI NELLA VITA DELL IMPRESA PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO
 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE I PROTAGONISTI NELLA VITA DELL IMPRESA PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO Struttura della lezione - I protagonisti dell impresa e le scelte di governo - Gli organi di governo
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE I PROTAGONISTI NELLA VITA DELL IMPRESA PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO Struttura della lezione - I protagonisti dell impresa e le scelte di governo - Gli organi di governo
OFFERTA DI LAVORO. p * C = M + w * L
 1 OFFERTA DI LAVORO Supponiamo che il consumatore abbia inizialmente un reddito monetario M, sia che lavori o no: potrebbe trattarsi di un reddito da investimenti, di donazioni familiari, o altro. Definiamo
1 OFFERTA DI LAVORO Supponiamo che il consumatore abbia inizialmente un reddito monetario M, sia che lavori o no: potrebbe trattarsi di un reddito da investimenti, di donazioni familiari, o altro. Definiamo
Il Veneto a confronto con le Regioni a statuto speciale
 Il Veneto a confronto con le Regioni a statuto speciale 1. Sulla base dei dati dei bilanci regionali e di quelli consolidati utilizzati nei precedenti capitoli, focalizziamo ora l analisi sul confronto
Il Veneto a confronto con le Regioni a statuto speciale 1. Sulla base dei dati dei bilanci regionali e di quelli consolidati utilizzati nei precedenti capitoli, focalizziamo ora l analisi sul confronto
FACTS & FIGURES #12/2015
 FACTS & FIGURES #12/2015 Nel mese di marzo 2015 il saldo è positivo per 30.603 assunzioni rispetto al marzo 2014 (avviamenti vs. cessazioni); Inoltre sono 17.918 le trasformazioni a tempo indeterminato
FACTS & FIGURES #12/2015 Nel mese di marzo 2015 il saldo è positivo per 30.603 assunzioni rispetto al marzo 2014 (avviamenti vs. cessazioni); Inoltre sono 17.918 le trasformazioni a tempo indeterminato
il costo in contabilità generale
 il costo in contabilità generale costi di acquisto di fattori produttivi e valori di diversa natura (tributi, permute, apporti, ammortamenti, ecc.) C.E. (-) valori classificati per origine costo calcolato
il costo in contabilità generale costi di acquisto di fattori produttivi e valori di diversa natura (tributi, permute, apporti, ammortamenti, ecc.) C.E. (-) valori classificati per origine costo calcolato
Il Mercato del Lavoro. determiniamo l equilibrio nel mercato del lavoro e il tasso naturale di disoccupazione
 Il Mercato del Lavoro In questa lezione: definiamo i concetti di disoccupazione, occupazione, forza lavoro determiniamo il funzionamento del mercato del lavoro determiniamo l equilibrio nel mercato del
Il Mercato del Lavoro In questa lezione: definiamo i concetti di disoccupazione, occupazione, forza lavoro determiniamo il funzionamento del mercato del lavoro determiniamo l equilibrio nel mercato del
12 Il mercato del lavoro dei politici
 INTroDUzIoNE La figura del politico e quella dell elettore sono alla base del concetto di democrazia rappresentativa. Ma chi è il politico? Ed è giusto considerare quella del politico una professione come
INTroDUzIoNE La figura del politico e quella dell elettore sono alla base del concetto di democrazia rappresentativa. Ma chi è il politico? Ed è giusto considerare quella del politico una professione come
APPROPRIATEZZA EFFICACIA EFFICIENZA in Sanità
 Corso di Alta Formazione Modulo 2 APPROPRIATEZZA EFFICACIA EFFICIENZA in Sanità Dott.ssa F.Camilli Il Paradigma della gestione della qualità ECONOMICITA EFFICIENZA EFFICACIA Economicità Per ogni tipologia
Corso di Alta Formazione Modulo 2 APPROPRIATEZZA EFFICACIA EFFICIENZA in Sanità Dott.ssa F.Camilli Il Paradigma della gestione della qualità ECONOMICITA EFFICIENZA EFFICACIA Economicità Per ogni tipologia
PARTE SECONDA: LA MACROECONOMIA MD 06 I DATI MACROECONOMICI
 PARTE SECONDA: LA MACROECONOMIA MD 06 I DATI MACROECONOMICI Con questa Unità didattica iniziamo la parte dedicata alla macroeconomia, ossia all analisi del funzionamento del sistema economico nel suo insieme.
PARTE SECONDA: LA MACROECONOMIA MD 06 I DATI MACROECONOMICI Con questa Unità didattica iniziamo la parte dedicata alla macroeconomia, ossia all analisi del funzionamento del sistema economico nel suo insieme.
Il disegno dell imposta personale sul reddito
 Capitolo III. Il disegno dell imposta personale sul reddito Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, il Mulino, 2006 1 Problemi principali a) Scelta della base imponibile b) Scelta dell unità
Capitolo III. Il disegno dell imposta personale sul reddito Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, il Mulino, 2006 1 Problemi principali a) Scelta della base imponibile b) Scelta dell unità
Sistema per la valutazione delle posizioni per le Posizioni Organizzative
 Sistema per la valutazione delle posizioni per le Posizioni Organizzative 1 La posizione organizzativa è intesa come rappresentazione della funzione e del ruolo del posto di lavoro all interno della struttura
Sistema per la valutazione delle posizioni per le Posizioni Organizzative 1 La posizione organizzativa è intesa come rappresentazione della funzione e del ruolo del posto di lavoro all interno della struttura
OSSERVATORIO ECONOMICO INDICOD-ECR XIII EDIZIONE - SETTEMBRE 2011
 1.1 I principali risultati OSSERVATORIO ECONOMICO INDICOD-ECR XIII EDIZIONE - SETTEMBRE 2011 Congiuntura e clima di fiducia. Il clima di fiducia crolla decisamente nella rilevazione di settembre 2011.
1.1 I principali risultati OSSERVATORIO ECONOMICO INDICOD-ECR XIII EDIZIONE - SETTEMBRE 2011 Congiuntura e clima di fiducia. Il clima di fiducia crolla decisamente nella rilevazione di settembre 2011.
Elezioni comunali 2014. Esempi di attribuzione dei seggi
 Elezioni comunali 2014 4 Esempi di attribuzione dei seggi Esempi di attribuzione dei seggi Al fine di chiarire il funzionamento dei meccanismi previsti per l attribuzione dei seggi e l ordine delle relative
Elezioni comunali 2014 4 Esempi di attribuzione dei seggi Esempi di attribuzione dei seggi Al fine di chiarire il funzionamento dei meccanismi previsti per l attribuzione dei seggi e l ordine delle relative
Campo di Variazione Costituisce la misura di
 Statistica2 22/09/2015 I Parametri di dispersione Campo di Variazione Costituisce la misura di PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI matricola PESO SESSO 7 38,00 F 8 38,00 F 1 40,00 F 2 40,00 F 5 40,00 F 10 42,00
Statistica2 22/09/2015 I Parametri di dispersione Campo di Variazione Costituisce la misura di PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI matricola PESO SESSO 7 38,00 F 8 38,00 F 1 40,00 F 2 40,00 F 5 40,00 F 10 42,00
METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE In sede di adeguamento del Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi al D.lgs. n. 150/2009, avvenuto con deliberazione G.C. n. 86/2010,
METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE In sede di adeguamento del Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi al D.lgs. n. 150/2009, avvenuto con deliberazione G.C. n. 86/2010,
Corso di REVISIONE AZIENDALE
 Corso di REVISIONE AZIENDALE a.a. 2004-1 Corso di REVISIONE AZIENDALE - Modulo VI - Prof. Fabio Fortuna ffortuna@unich.it Anno accademico 2004- Corso di REVISIONE AZIENDALE a.a. 2004-2 La revisione gestionale
Corso di REVISIONE AZIENDALE a.a. 2004-1 Corso di REVISIONE AZIENDALE - Modulo VI - Prof. Fabio Fortuna ffortuna@unich.it Anno accademico 2004- Corso di REVISIONE AZIENDALE a.a. 2004-2 La revisione gestionale
IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE
 Caso 5 IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE Oggetto ed obiettivi: oggetto del caso sono le imposte differite. Calcolarle è necessario per la corretta imputazione a Conto Economico delle imposte di competenza.
Caso 5 IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE Oggetto ed obiettivi: oggetto del caso sono le imposte differite. Calcolarle è necessario per la corretta imputazione a Conto Economico delle imposte di competenza.
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Antonella Ubaldi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Annalisa Grussu
 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 7 ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 7 STRADA LACUGNANO, S.N. 06132 PERUGIA (PG)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 7 ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 7 STRADA LACUGNANO, S.N. 06132 PERUGIA (PG)
Sommario. Estrapolare la curva di domanda. Domanda individuale e di mercato. Domanda Individuale. Effetto Reddito e Effetto di Sostituzione
 Sommario Domanda individuale e di mercato Domanda Individuale Effetto Reddito e Effetto di Sostituzione Domanda di mercato Surplus o rendita del consumatore Estrapolare la curva di domanda Estrapolare
Sommario Domanda individuale e di mercato Domanda Individuale Effetto Reddito e Effetto di Sostituzione Domanda di mercato Surplus o rendita del consumatore Estrapolare la curva di domanda Estrapolare
(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti;
 Fiscalità differita ed anticipata: casi e soluzioni L iscrizione delle imposte differite attive e passive ad integrazione delle imposte correnti è necessaria al fine di rappresentare correttamente nel
Fiscalità differita ed anticipata: casi e soluzioni L iscrizione delle imposte differite attive e passive ad integrazione delle imposte correnti è necessaria al fine di rappresentare correttamente nel
ESERCIZI - ECONOMIA PUBBLICA LZ 2016
 ESERCIZI - ECONOMIA PUBBLICA LZ 2016 Esercizio 1 (IVA) Si consideri la seguente situazione: - l'impresa A vende all'impresa B un bene intermedio, che ha prodotto utilizzando solo il fattore lavoro, al
ESERCIZI - ECONOMIA PUBBLICA LZ 2016 Esercizio 1 (IVA) Si consideri la seguente situazione: - l'impresa A vende all'impresa B un bene intermedio, che ha prodotto utilizzando solo il fattore lavoro, al
Teorema del limite centrale TCL
 Teorema del limite centrale TCL Questo importante teorema della statistica inferenziale si applica a qualsiasi variabile aleatoria che sia combinazione lineare di N variabili aleatorie le cui funzioni
Teorema del limite centrale TCL Questo importante teorema della statistica inferenziale si applica a qualsiasi variabile aleatoria che sia combinazione lineare di N variabili aleatorie le cui funzioni
PROPOSTA REGOLATIVA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE
 PROPOSTA REGOLATIVA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE REGOLE DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI Il processo di razionalizzazione e di riqualificazione
PROPOSTA REGOLATIVA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE REGOLE DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI Il processo di razionalizzazione e di riqualificazione
Il sistema tributario italiano
 SCIENZA DELLE FINANZE Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche Corso di Economia aziendale Prof. MICHELE SABATINO Il sistema tributario italiano Imposta: prelievo coattivo di denaro senza vincoli di
SCIENZA DELLE FINANZE Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche Corso di Economia aziendale Prof. MICHELE SABATINO Il sistema tributario italiano Imposta: prelievo coattivo di denaro senza vincoli di
La tariffa è aggiornata ogni trimestre ed è composta da:
 Guida alla lettura delle voci di spesa per i clienti serviti nel mercato libero Voce di spesa Descrizione del prezzo Componenti incluse Spesa per la materia gas naturale Il prezzo è aggiornato ogni trimestre
Guida alla lettura delle voci di spesa per i clienti serviti nel mercato libero Voce di spesa Descrizione del prezzo Componenti incluse Spesa per la materia gas naturale Il prezzo è aggiornato ogni trimestre
Esercitazioni di statistica
 Esercitazioni di statistica Misure di associazione: Indipendenza assoluta e in media Stefania Spina Universitá di Napoli Federico II stefania.spina@unina.it 22 ottobre 2014 Stefania Spina Esercitazioni
Esercitazioni di statistica Misure di associazione: Indipendenza assoluta e in media Stefania Spina Universitá di Napoli Federico II stefania.spina@unina.it 22 ottobre 2014 Stefania Spina Esercitazioni
Unità di Direzione Istruzione-Sicurezza degli ambienti di lavoro e scolastici- Edilizia Scolastica Ricostruzione
 CITTÀ DI POTENZA Unità di Direzione Istruzione-Sicurezza degli ambienti di lavoro e scolastici- Edilizia Scolastica Ricostruzione Ufficio Istruzione OGGETTO: Riconferma del quadro tariffario del Servizio
CITTÀ DI POTENZA Unità di Direzione Istruzione-Sicurezza degli ambienti di lavoro e scolastici- Edilizia Scolastica Ricostruzione Ufficio Istruzione OGGETTO: Riconferma del quadro tariffario del Servizio
CORSO DI STATISTICA (parte 1) - ESERCITAZIONE 5
 CORSO DI STATISTICA (parte 1) - ESERCITAZIONE 5 Dott.ssa Antonella Costanzo a.costanzo@unicas.it Esercizio 1. Misura dell associazione tra due caratteri Uno store manager è interessato a studiare la relazione
CORSO DI STATISTICA (parte 1) - ESERCITAZIONE 5 Dott.ssa Antonella Costanzo a.costanzo@unicas.it Esercizio 1. Misura dell associazione tra due caratteri Uno store manager è interessato a studiare la relazione
2. Le assunzioni non stagionali
 53 2. Le assunzioni non stagionali Si riportano nella tabella che segue i dati delle assunzioni non stagionali previste per il 2011 sui quali è svolta l analisi delle caratteristiche (per genere, età,
53 2. Le assunzioni non stagionali Si riportano nella tabella che segue i dati delle assunzioni non stagionali previste per il 2011 sui quali è svolta l analisi delle caratteristiche (per genere, età,
Capitolo 6. Politica monetaria e politica fiscale
 Capitolo 6 Politica monetaria e politica fiscale Dornbusch, Fischer, Startz, Canullo, Pettenati, Macroeconomia 11e Politiche economiche I Governi e le Banche Centrali utilizzano le politiche fiscale e
Capitolo 6 Politica monetaria e politica fiscale Dornbusch, Fischer, Startz, Canullo, Pettenati, Macroeconomia 11e Politiche economiche I Governi e le Banche Centrali utilizzano le politiche fiscale e
CRITERI PER VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
 CRITERI PER VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE Le risorse destinate dalla contrattazione decentrata integrativa, nell ambito del fondo per le risorse decentrate, alla incentivazione delle performance
CRITERI PER VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE Le risorse destinate dalla contrattazione decentrata integrativa, nell ambito del fondo per le risorse decentrate, alla incentivazione delle performance
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEI COMUNI E NELLE PROVINCE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
 SUPPORTI DI ANALISI di FINANZA LOCALE IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEI COMUNI E NELLE PROVINCE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Analisi per l anno 2008 (Dicembre 2010) A cura del Servizio Finanza locale Direzione
SUPPORTI DI ANALISI di FINANZA LOCALE IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEI COMUNI E NELLE PROVINCE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Analisi per l anno 2008 (Dicembre 2010) A cura del Servizio Finanza locale Direzione
Imposte ed efficienza. La perdita di efficienza associata alla tassazione
 Imposte ed efficienza La perdita di efficienza associata alla tassazione Confronto tra imposte ed effetti economici Imposta proporzionale sul salario Imposta proporzionale sul salario Supponiamo che venga
Imposte ed efficienza La perdita di efficienza associata alla tassazione Confronto tra imposte ed effetti economici Imposta proporzionale sul salario Imposta proporzionale sul salario Supponiamo che venga
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 343 24.11.2014 Il nuovo ISEE corrente Quando si presenta e composizione del modello Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie Con la pubblicazione
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 343 24.11.2014 Il nuovo ISEE corrente Quando si presenta e composizione del modello Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie Con la pubblicazione
Lezione 12. Flessibilità automatica di bilancio Stabilizzatori automatici Saldo strutturale
 Lezione 12 Flessibilità automatica di bilancio Stabilizzatori automatici Saldo strutturale 1 Obiettivo Richiamare elementi di macroeconomia relativi alle nozioni di Stabilizzatori automatici Flessibilità
Lezione 12 Flessibilità automatica di bilancio Stabilizzatori automatici Saldo strutturale 1 Obiettivo Richiamare elementi di macroeconomia relativi alle nozioni di Stabilizzatori automatici Flessibilità
VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)
 VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014
VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014
Facoltà di Economia - Parma 1
 L analisi dei costi 3 IL ONETTO DI OSTO on il termine OSTO si vuole indicare il valore degli investimenti effettuati per l acquisto dei fattori produttivi impiegati per l ottenimento di un determinato
L analisi dei costi 3 IL ONETTO DI OSTO on il termine OSTO si vuole indicare il valore degli investimenti effettuati per l acquisto dei fattori produttivi impiegati per l ottenimento di un determinato
Il calcolo economico. Le relazioni tra costi e prezzi.
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA FACOLTÀ DI ECONOMIA Il calcolo economico. Le relazioni tra costi e prezzi. Capitolo 6 Chiara Demartini cdemartini@eco.unipv.it 1 RELAZIONI TRA COSTI E PREZZI Nel cap. 5
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA FACOLTÀ DI ECONOMIA Il calcolo economico. Le relazioni tra costi e prezzi. Capitolo 6 Chiara Demartini cdemartini@eco.unipv.it 1 RELAZIONI TRA COSTI E PREZZI Nel cap. 5
GRUPPO DI LAVORO DATINI 3
 GRUPPO DI LAVORO DATINI 3 Prof.ssa Caruso Luisa (lisa66winthrop@gmail.com) Prof.ssa Citro Brunella (brunella.citro@istruzione.it) Prof. Marino Pasquale (marinopasqual@tiscali.it) Prof.ssa Pede Giuliana
GRUPPO DI LAVORO DATINI 3 Prof.ssa Caruso Luisa (lisa66winthrop@gmail.com) Prof.ssa Citro Brunella (brunella.citro@istruzione.it) Prof. Marino Pasquale (marinopasqual@tiscali.it) Prof.ssa Pede Giuliana
2. Le assunzioni non stagionali
 81 2. Le assunzioni non stagionali L analisi delle caratteristiche delle assunzioni previste (cioè per genere, età, tipo di contratto, titolo di studio, ecc ) è svolta solo sulle assunzioni non stagionali,
81 2. Le assunzioni non stagionali L analisi delle caratteristiche delle assunzioni previste (cioè per genere, età, tipo di contratto, titolo di studio, ecc ) è svolta solo sulle assunzioni non stagionali,
La Politica Economica in Economia Aperta
 La Politica Economica in Economia Aperta In questa lezione: Studiamo l equilibrio in economia aperta. Studiamo gli effetti di shock esterni sulla produzione e sulla bilancia commerciale. Studiamo gli effetti
La Politica Economica in Economia Aperta In questa lezione: Studiamo l equilibrio in economia aperta. Studiamo gli effetti di shock esterni sulla produzione e sulla bilancia commerciale. Studiamo gli effetti
ESTERNALITÀ. Fallimento del MKT e inefficenza: l attività di consumo o produzione trascura effetto diretto sul benessere degli altri agenti.
 Negativa ESTERNALITÀ Effetto diretto (ovvero non ottenuto attraverso variazione dei prezzi di mercato) di una attività di produzione o consumo ) sull utilità o i profitti di altri agenti. Fallimento del
Negativa ESTERNALITÀ Effetto diretto (ovvero non ottenuto attraverso variazione dei prezzi di mercato) di una attività di produzione o consumo ) sull utilità o i profitti di altri agenti. Fallimento del
Applicazione della Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio (DURP) nell ambito dell edilizia agevolata
 EEVE - DURP Applicazione della Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio (DURP) nell ambito dell edilizia agevolata Ripartizione edilizia abitativa 1 Premessa Articolo 2, comma 1/bis della legge
EEVE - DURP Applicazione della Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio (DURP) nell ambito dell edilizia agevolata Ripartizione edilizia abitativa 1 Premessa Articolo 2, comma 1/bis della legge
IL QUADRO DELLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA
 IL QUADRO DELLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA Parma, 15 giugno 2013 Le entrate dei Comuni della provincia di Parma La finanza locale sta vivendo un periodo di profonda trasformazione e incertezza,
IL QUADRO DELLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA Parma, 15 giugno 2013 Le entrate dei Comuni della provincia di Parma La finanza locale sta vivendo un periodo di profonda trasformazione e incertezza,
A) LA LETTURA DEL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO B) GLI EQUILIBRI DI BILANCIO C) LE VARIAZIONI DI BILANCIO
 A) LA LETTURA DEL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO B) GLI EQUILIBRI DI BILANCIO C) LE VARIAZIONI DI BILANCIO A) LA LETTURA DEL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO Caso 1: il Comune di Minola (da Rota S., Sicilia
A) LA LETTURA DEL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO B) GLI EQUILIBRI DI BILANCIO C) LE VARIAZIONI DI BILANCIO A) LA LETTURA DEL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO Caso 1: il Comune di Minola (da Rota S., Sicilia
Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato)
 (Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma
(Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma
Il tasso di disoccupazione: confronti internazionali
 Il tasso di disoccupazione: confronti internazionali Andamento della disoccupazione - Il caso statunitense - Euro area Italy United States Japan United Kingdom 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 1997
Il tasso di disoccupazione: confronti internazionali Andamento della disoccupazione - Il caso statunitense - Euro area Italy United States Japan United Kingdom 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 1997
DOMANDE a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non sono previste penalizzazioni in caso di risposte non corrette)
 In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. DOMANDE a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
In un ora rispondere alle dieci domande a risposta multipla, alla domanda a risposta aperta, e risolvere l esercizio. DOMANDE a risposta multipla (ogni risposta esatta riceve una valutazione di due; non
Rischio Chimico. Definizioni
 Rischio Chimico Definizioni a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come
Rischio Chimico Definizioni a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come
Tecniche di Vendita. Facoltà di Scienze della Comunicazione Università degli Studi di Teramo. Prof. Marco Galdenzi Anno accademico 2015/16
 Tecniche di Vendita Facoltà di Scienze della Comunicazione Università degli Studi di Teramo Prof. Marco Galdenzi Anno accademico 2015/16 CANALI DI DISTRIBUZIONE Un canale di distribuzione è costituito
Tecniche di Vendita Facoltà di Scienze della Comunicazione Università degli Studi di Teramo Prof. Marco Galdenzi Anno accademico 2015/16 CANALI DI DISTRIBUZIONE Un canale di distribuzione è costituito
Occupazione e disoccupazione
 Lezione 20 1 Occupazione e disoccupazione L occupazione ha una fortissima importanza sociale, e pone molti problemi di rilevazione. In questa lezione vediamo come la definizione di occupazione fa emergere
Lezione 20 1 Occupazione e disoccupazione L occupazione ha una fortissima importanza sociale, e pone molti problemi di rilevazione. In questa lezione vediamo come la definizione di occupazione fa emergere
LE RISORSE E LE COMPETENZE COME BASE DELLA STRATEGIA
 LE RISORSE E LE COMPETENZE COME BASE DELLA STRATEGIA CAPITOLO QUINTO Grant R. L analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna, 1999 1 DAL SETTORE ALL IMPRESA Fino agli anni Novanta:
LE RISORSE E LE COMPETENZE COME BASE DELLA STRATEGIA CAPITOLO QUINTO Grant R. L analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna, 1999 1 DAL SETTORE ALL IMPRESA Fino agli anni Novanta:
ALLEGATOB alla Dgr n. 827 del 31 maggio 2016 pag. 1/5
 giunta regionale 10^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 827 del 31 maggio 2016 pag. 1/5 POR, parte FESR, 2014-2020 ASSE 1 RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO AUMENTO DELL INCIDENZA
giunta regionale 10^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 827 del 31 maggio 2016 pag. 1/5 POR, parte FESR, 2014-2020 ASSE 1 RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO AUMENTO DELL INCIDENZA
ANALISI DELLA SOLIDITA
 ANALISI DELLA SOLIDITA ANALISI DELLA SOLIDITA Solidità: capacità di resistere agli eventi sfavorevoli E l analisi dell equilibrio finanziario nel M/L periodo dipende da Finanziamento delle immobilizzazioni
ANALISI DELLA SOLIDITA ANALISI DELLA SOLIDITA Solidità: capacità di resistere agli eventi sfavorevoli E l analisi dell equilibrio finanziario nel M/L periodo dipende da Finanziamento delle immobilizzazioni
Programma Operativo Nazionale Settore Trasporti Periodo di programmazione 2000-2006
 4 PIANO FINANZIARIO 4.1 ORGANIZZAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO Il Costo Totale del Programma Trasporti per il periodo 2000 2006, sulla base della Decisione C(2001) 2162 del 14.09.01, è pari a 4.280,548
4 PIANO FINANZIARIO 4.1 ORGANIZZAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO Il Costo Totale del Programma Trasporti per il periodo 2000 2006, sulla base della Decisione C(2001) 2162 del 14.09.01, è pari a 4.280,548
Macroeconomia. Equilibrio di breve e medio periodo: Modello As - Ad. Esercitazione del 13.04.2016 (+ soluzioni) (a cura della dott.
 Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza Corso di Laurea in ECONOMIA Macroeconomia Equilibrio di breve e medio periodo: Modello As - Ad Esercitazione del 13.04.2016 (+ soluzioni) (a cura della dott.ssa
Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza Corso di Laurea in ECONOMIA Macroeconomia Equilibrio di breve e medio periodo: Modello As - Ad Esercitazione del 13.04.2016 (+ soluzioni) (a cura della dott.ssa
Epidemiologia della tubercolosi in Italia (anni )
 Epidemiologia della tubercolosi in Italia (anni 1995 2005) Prefazione Il sistema di notifica della tubercolosi, elemento indispensabile al programma di controllo della malattia stessa, ha tra gli obiettivi
Epidemiologia della tubercolosi in Italia (anni 1995 2005) Prefazione Il sistema di notifica della tubercolosi, elemento indispensabile al programma di controllo della malattia stessa, ha tra gli obiettivi
CORSO DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING A.A
 Prof.ssa Elena Cedrola elena.cedrola@unimc.it http://docenti.unimc.it/docenti/elena-cedrola Lezione 4 CORSO DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING A.A. 2014-2015 1 Contenuti lezione 4: le teorie
Prof.ssa Elena Cedrola elena.cedrola@unimc.it http://docenti.unimc.it/docenti/elena-cedrola Lezione 4 CORSO DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING A.A. 2014-2015 1 Contenuti lezione 4: le teorie
Informazioni e ipotesi utilizzate per la stima PREVALENTEMENTE OBBLIGAZIONARIO/PROTEZIONE 3,40% BILANCIATO/EQUILIBRIO 2,80%
 Fondaereo - Fondo Pensione Fondo pensione negoziale iscritto all Albo COVIP al n. 2167 Stima della Pensione Complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo
Fondaereo - Fondo Pensione Fondo pensione negoziale iscritto all Albo COVIP al n. 2167 Stima della Pensione Complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato) Il presente progetto esemplificativo
ANALISI E GESTIONE DEI COSTI
 ANALISI E GESTIONE DEI COSTI Dott.ssa Francesca Mandanici IL REPORTING: L analisi degli scostamenti 17-20 DICEMBRE 2010 Gli scopi conoscitivi dell analisi degli scostamenti SCOPI TRADIZIONALI SCOPI EMERGENTI
ANALISI E GESTIONE DEI COSTI Dott.ssa Francesca Mandanici IL REPORTING: L analisi degli scostamenti 17-20 DICEMBRE 2010 Gli scopi conoscitivi dell analisi degli scostamenti SCOPI TRADIZIONALI SCOPI EMERGENTI
Lezione 4 a - Misure di dispersione o di variabilità
 Lezione 4 a - Misure di dispersione o di variabilità Abbiamo visto che la media è una misura della localizzazione centrale della distribuzione (il centro di gravità). Popolazioni con la stessa media possono
Lezione 4 a - Misure di dispersione o di variabilità Abbiamo visto che la media è una misura della localizzazione centrale della distribuzione (il centro di gravità). Popolazioni con la stessa media possono
CREDITO AGRICOLO Fondo a favore delle PMI
 CREDITO Fondo a favore delle PMI IL CONTESTO DI RIFERIMENTO Il comparto agricolo regionale Superficie agricola totale (SAT): 1.470.698 ettari; Superficie agricola utilizzata (SAU): 1.153.690 ettari; Il
CREDITO Fondo a favore delle PMI IL CONTESTO DI RIFERIMENTO Il comparto agricolo regionale Superficie agricola totale (SAT): 1.470.698 ettari; Superficie agricola utilizzata (SAU): 1.153.690 ettari; Il
Principi di Economia - Macroeconomia Esercitazione 4 Moneta, Modello IS-LM e Stabilizzazione Soluzioni
 Principi di Economia - Macroeconomia Esercitazione 4 Moneta, Modello IS-LM e Stabilizzazione Soluzioni Daria Vigani Maggio 205. In un economia senza banche un individuo con un reddito di 75000eè caratterizzato
Principi di Economia - Macroeconomia Esercitazione 4 Moneta, Modello IS-LM e Stabilizzazione Soluzioni Daria Vigani Maggio 205. In un economia senza banche un individuo con un reddito di 75000eè caratterizzato
UNITA DI MISURA LOGARITMICHE
 UNITA DI MISURA LOGARITMICHE MOTIVAZIONI Attenuazione del segnale trasmesso esponenziale con la lunghezza mentre si propaga sulle linee di trasmissione (conduttori metallici) Utilizzando le unità logaritmiche
UNITA DI MISURA LOGARITMICHE MOTIVAZIONI Attenuazione del segnale trasmesso esponenziale con la lunghezza mentre si propaga sulle linee di trasmissione (conduttori metallici) Utilizzando le unità logaritmiche
