IL SIGNIFICATO LINGUISTICO E FILOSOFICO DELLA LINGUISTICA GENERALE DI FERDINAND DE SAUSSURE
|
|
|
- Fortunato Carlucci
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL SIGNIFICATO LINGUISTICO E FILOSOFICO DELLA LINGUISTICA GENERALE DI FERDINAND DE SAUSSURE di Renzo Raggiunti La distinzione fondamentale, che ci viene fornita dal Cours de Linguistique générale, è quella di langue e parole. Saussure considera i sintagmi e le frasi costruiti su forme o moduli regolari come entità che sono da attribuire alla langue, anziché alla parole. La langue è la parte sociale del linguaggio, esterna all individuo, che da solo non può né crearla né modificarla, essa esiste solo in virtù di una specie di contratto stipulato fra i membri della comunità 1. La langue, distinta dalla parole, è un oggetto che si può studiare separatamente. Potenzialmente, tutte le frasi sono già date nella lingua in quanto nella lingua sono già date tutte le regole per la combinazione delle parole. Saussure, a questo punto, si domanda in quale maniera la parole sia presente nel modello collettivo della langue. Egli afferma che, a rigore, non vi è niente di collettivo nella parole, le sue manifestazioni sono individuali e momentanee 2. Il Nostro afferma ancora che si può parlare di una linguistica della parole. Ma bisognerà non confonderla con la linguistica propriamente detta, quella della quale la langue è l unico oggetto. Bisogna non cancellare i limiti che separano i due domini. Ma la lingua, qualsiasi lingua, non stabilisce e non prescrive che alcune parole, aventi un particolare significato, debbano o anche soltanto possano essere combinate in una certa maniera con altre. De Mauro, nella sua Introduzione al Corso, da lui tradotto 3, cerca di porre in evidenza gli aspetti più significativi e originali della linguistica generale di Saussure, con la seguente osservazione: Il punto di partenza delle riflessioni di Saussure è l acuta consapevolezza della individualità assoluta, irripetibile del singolo atto espressivo, quell atto che egli chiama naturalmente in francese parole, e parole chiamano ormai i linguisti nelle più diverse lingue del mondo 4. Il carattere di individualità e libertà della parole veniva spiegato proprio in riferimento a quella libertà di combinazione che costituisce l aspetto più interessante della parole. Come osserva De Mauro, Saussure, affermando il carattere di individualità assoluta, irripetibile, del singolo atto linguistico aveva in mente più il lato semantico di esso che quello astrattamente sintattico. Le differenze semantiche di una stessa parola, qualunque essa sia, risultano chiaramente dai diversi contesti significazionali in cui la parola viene a trovarsi. Mi pare si debba affermare che nel Saussure sono contenute tutte le premesse valide per giungere a quelle conclusioni. André Burger, in un articolo del , ha contribuito in maniera notevole a chiarire la distinzione saussuriana di signifié e signification. Per Burger, giustamente, la nozione di signifié è da attribuire alla langue e quella di significa- 5SAGGI
2 6 tion o sense alla parole. Che cosa fa sí che il significato, entità potenziale, nella parole si attualizzi e si trasformi nella significazione? Malgrado le differenze foniche e significazionali in cui quella parola si attualizza successivamente, noi dobbiamo dire che si tratta sempre della stessa parola. La lingua, in questo senso, è un tesoro depositato nel nostro cervello. Questo tesoro afferma Saussure si è potuto formare in virtù di una facoltà ricettiva e coordinativa. La spiegazione di Saussure non va più in là. Tale facoltà coordinativa non potrebbe operare, a livello di lingua, se non vi fosse, prima di tutto, una facoltà astrattiva, capace di cogliere il generale dal particolare, l astratto dal concreto. Ma la lingua rinvia necessariamente alla parole: historiquement, le fait de parole précède toujours. Comment s aviserait-on d associer une idée à une image verbale, si l on ne surprenait pas d abord cette association dans un acte de parole? D autre part, c est en entendant les autres que nous apprenons notre langue naturelle: elle n arrive à se déposer dans notre cerveau qu à la suite d innombrables expériences 6. Saussure associa alla facoltà ricettiva una facoltà coordinativa, ma quest ultima non è in grado di funzionare senza una facoltà astrattiva. La distinzione di langue e parole, rigorosamente formulata da Saussure, contiene implicitamente la tesi di una attività astrattiva, che sia fondamento di quel tesoro depositato nel nostro cervello, che è la lingua. Tuttavia non troviamo nel Cours e neppure nelle fonti una affermazione o una serie di affermazioni che si riferiscano esplicitamente a tale attività astrattiva. Come si può spiegare questa lacuna? De Mauro, giustamente osserva che Saussure evita deliberatamente di usare il termine astratto, poiché, nell ambiente culturale del suo tempo, dominato dalla epistemologia kantiana, idealistica, positivistica 7 quel termine ha subito una svalutazione. Tuttavia la tesi di una facoltà astrattiva, e della conseguente attività astrattiva, è una conseguenza inevitabile della tesi saussuriana sulla lingua e la relazione-distinzione di langue e parole. Bisogna spiegare come il significato (signifié) si trasformi nella significazione (signification o sens). La signification è un elemento semantico che si integra con gli altri, nella combinazione della parole. La significazione può essere considerata come il contenuto semantico globale di un intera frase anche molto complessa, e può essere considerata come il singolo contenuto semantico portato dal singolo vocabolo all interno di una frase composta di molti vocaboli. Dobbiamo, però, osservare che il termine significazione e il termine significato si presentano talvolta nei testi saussuriani, con un significato generico e impreciso: si dà il caso che si adoperi il termine significazione per designare il significato. A questo proposito, possiamo osservare che il termine significazione, come il suo equivalente senso si presentano talvolta nei testi saussuriani con un significato generico e impreciso, comprensivo tanto della nozione di significazione quanto di quella di significato. Un esempio di questa imprecisione lo troviamo alle pagine 158, 159 del Cours nelle quali la signification è rappresentata semplicemente come la contre-partie de l image auditive. Ma la via giusta, indicata dallo stesso Saussure, è quella che ci conduce al
3 fattore contestuale. È il contesto linguistico il fattore linguistico determinante il carattere specifico e particolare della significazione. Il criterio denotazionistico, vale a dire del concreto riferimento che un individuo fa con un segno ad un certo oggetto può essere un fattore determinante di natura extra-linguistica delle particolarità di una significazione entro un atto linguistico, ma non esaurisce il contenuto di essa. Per cogliere il significato autentico del termine saussuriano significazione la via giusta è quella che conduce al fattore contestuale, più propriamente contestuale-linguistico. Ritornando al Cours, la pagina presa in esame, in cui si parla di parole di significato diverso le quali possono avere una stessa significazione, che corrisponde alla pagina 160 dell edizione originale, è da attribuire esclusivamente agli editori. Infatti, come si può constatare, osservando l edizione critica dello Engler, le proposizioni che abbiamo citato dal Cours non trovano un puntuale riscontro nelle fonti. Quanto è affermato in esse, sul rapporto fra il significato e la significazione, dipende da una errata interpretazione degli editori, che hanno, in questo caso, a mio parere frainteso, il pensiero del Maestro. Nell ultimo capitolo del terzo corso 8 Saussure sostiene che ciò che permette alla concezione delle lingua di evitare la soluzione nominalistica è il fatto che la significazione (senso), pur essendo dipendente dal valore (significato), ne è tuttavia distinta. Significato e significazione non si identificano, rimangono distinti, e ciò consente di attribuire al significato una flessibilità e mutevolezza, che lo rende diverso da lingua a lingua e, all interno di una stessa lingua, suscettibile di trasformazioni diacroniche. Anche se Saussure non lo afferma esplicitamente, le significazioni, che hanno il loro piano di realizzazione nella parole, nella loro possibilità di attuazione infinita, costituiscono il fattore principale di trasformazione del significato. Come le significazioni dipendono dai significati, i significati dipendono dalle significazioni. Libertà e originalità dei rapporti sintattici o contesti linguistici, indeterminatezza del numero delle significazioni: è quanto basta per rendere illusorio e contraddittorio il tentativo di produrre una qualsiasi classificazione delle significazioni. Langue e parole sono due termini che, nel pensiero di Saussure, si oppongono, ma, nello stesso tempo, si completano e si condizionano reciprocamente. Sappiamo che non sono pochi i linguisti che mettono in dubbio la validità di questa distinzione saussuriana 9. Ma vi è un altro argomento, di particolare interesse, quello dell idioletto (una lingua individuale), che avrebbe in comune con la parole un carattere di individualità. Vi è da chiedersi quale sia il rapporto fra tale idioletto e la langue. L idioletto è in una relazione necessaria e ineliminabile con la lingua sociale? Se l idioletto è in una relazione necessaria con la lingua sociale, è fuori discussione che l idioletto non può essere individuale come la parole propriamente detta. È certo che la nozione di lingua individuale non mette radicalmente in crisi la nozione di langue, poiché la prima assorbe in sé senza annullarla la nozione di langue, e neppure la distinzione saussuriana di langue e parole. L aspetto individuale dell idioletto non ha niente in comune con l aspetto individuale della parole anche se prefigura e si integra con quell aspetto. Può 7SAGGI
4 8 essere di aiuto, nella discussione di questo argomento, l esame di alcune tesi contenute nell articolo dello Spence, A Hardy Perennial: the Problem of la Langue and la Parole 10. Lo Spence fa notare, e io credo giustamente, che nella definizione di langue come sistema vi è qualche incertezza o incoerenza, e che la nozione di lingua come sistema non corrisponde esattamente ad una realtà, che sarebbe la maniera in cui parla, ad un dato momento, un certo gruppo linguistico, poiché, all interno di esso, vi sono gruppi distinti che, parlando in maniera diversa, impiegano, in certo modo, sistemi diversi. Ma questa considerazione non può indurci a pensare che si possa fare a meno della nozione di langue come sistema: si tratterà della coesistenza di più sistemi somiglianti che si influenzano reciprocamente. Lo Spence è convinto, in contrasto con le osservazioni che gli vengono rivolte da alcuni studiosi, che la stessa lingua individuale è già, in certa misura, collettiva. Un altro studioso, il Malmberg, in un suo saggio Système et méthode 11 colpisce nel segno, quando afferma che la presunta lingua individuale è sempre una lingua collettiva, e non può non essere collettiva se è una lingua. E su questo punto non può non trovarsi d accordo con lo stesso Spence. Vi debbono essere dei caratteri comuni a più lingue individuali che costituiscono il sistema linguistico di gruppo o collettivo. Un individuo, di una determinata lingua, riesce a comunicare con gli altri in virtù di quei caratteri che sono comuni alla lingua che egli ha nella sua mente, e alle lingue che sono nelle menti degli altri. È ben vero quello che afferma il Malmberg 12 quando sostiene che la presunta lingua individuale è sempre una lingua collettiva, e non può non essere collettiva se è una lingua. Su questo punto dovrebbe essere d accordo lo stesso Spence il quale considera come errata una considerazione puramente atomistica della lingua individuale, poiché ogni lingua individuale è in un rapporto di interdipendenza con le altre lingue individuali. Ogni lingua individuale incorpora necessariamente in sé il sistema linguistico di gruppo o collettivo. Altrimenti l individuo non riuscirebbe a comunicare con gli altri. La lingua come fatto mentale è insieme un fatto sociale, uno strumento di scambio interindividuale. Tuttavia, secondo lo Spence, la lingua non può essere contrapposta alla parole, poiché essa contiene già in sé degli elementi soggettivi, individuali. L errore di Saussure consisterebbe nel non aver messo in evidenza che la lingua si forma nella mente degli individui, e, perciò, ha già dei caratteri di individualità che preludono alla parole. Ma, come bisogna osservare, quello che conta, perché si possa opporre la langue alla parole, è il fatto che questa lingua, detta individuale, ha prima di tutto un carattere collettivo. Perciò si può dire che l opposizione langue-parole non è solo giustificata, ma si verifica già all interno della lingua cosiddetta individuale, in quanto, essa ha insieme un carattere individuale e un carattere collettivo. Non vi sono dubbi sul fatto che anche la proposizione formulata mentalmente sia già un atto di parole. E atto di parole è anche ogni espressione che un autore fissa graficamente sulla carta senza pronunciarla materialmente. Quello che conta al di là delle differenze che possono esservi fra le lingue cosiddette individuali, è il sostanziale nucleo comune, il sistema che ognuna
5 di esse incorpora. All interno di uno stesso gruppo linguistico si verifica, come osserva Jespersen nell opera citata, l esistenza di diversi gruppi, a causa di diversi distinti fattori. Ognuno di questi gruppi usa il sistema linguistico in maniera un po diversa, e, perciò, ha un sistema linguistico diverso, senza contare che all interno di uno stesso gruppo si riscontrano altre differenze, che fanno capo alle lingue individuali. Perciò un gruppo linguistico non ha una sola langue. Tuttavia le convergenze e le somiglianze dei distinti sistemi linguistici sono preponderanti rispetto alle divergenze e alle differenze. Su queste convergenze e somiglianze può essere fondato il concetto saussuriano di langue senza il quale risulta inconcepibile ogni atto di comunicazione linguistica. Lo Spence avanza su queste tesi di Jespersen alcune riserve e termina con un giudizio piuttosto negativo sulla distinzione saussuriana: Questa distinzione fra langue e parole originariamente agì come un considerevole stimolo per il pensiero linguistico; ma si è tentati di concludere che ora essa produce confusioni nello stesso 13. Non si può essere d accordo con il giudizio alquanto negativo sulla distinzione saussuriana di langue e parole. Ha le sue buone ragioni Saussure nell affermare risolutamente che il compito del linguista è quello di scoprire il sistema al di là delle differenze che possono verificarsi nelle maniere di parlare dei distinti gruppi che costituiscono una comunità. Il problema filosofico della comunicazione non è estraneo alla mentalità prevalentemente scientifica di Saussure. La langue che è il codice a mezzo del quale soltanto i singoli atti linguistici possono risultare comunicativi, espleterà la sua funzione in maniera sempre migliore quanto più saranno eliminate le differenze con cui i diversi gruppi e singoli individui utilizzeranno il codice-lingua. In relazione al concetto di signification o sense e della definizione che di esso viene data da Saussure, risulta opportuno il riferimento alla posizione assunta dal semiologo Luis Prieto, che, a mio avviso, dà del suddetto concetto una versione non conforme alla tesi saussuriana, e, per alcuni aspetti unilaterale. Nella sua prospettiva, Prieto manifesta una tendenza ad una interpretazione, che potrei definire di tipo neopositivistico, e che risulta, in special modo nella sua opera Principes de Neologie (l Aja, 1964). Egli vuol ridurre i concetti di significato e senso entro i limiti di un comportamento linguistico controllabile attraverso la situazione, collegata direttamente all atto linguistico. Il senso di un atto di parole è il rapporto sociale che si stabilisce in virtù di quell atto. Per Prieto il rapporto sociale, ed esso soltanto, costituisce il senso dell atto semico. Possiamo osservare legittimamente che, anche per Saussure, il senso di un atto linguistico può stabilire un determinato rapporto sociale, ma, per Saussure, giustamente, il senso di un atto linguistico non costituisce sempre e unicamente l atto linguistico mediante il quale si stabilisce, fra parlante e ascoltatore, un determinato rapporto sociale. L atto di parole con il quale si esprime un verso poetico non ha certamente come conseguenza lo stabilirsi, fra parlante e ascoltatore, di un determinato rapporto sociale. 9SAGGI
6 1 F. DE SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Payot, Paris 1960, p Ivi, p T. DE MAURO, Introduzione, in F. DE SAUSSURE, Corso di linguistica generale, Laterza, Bari Ivi, p. IX. 5 A. BURGER, Signification et valeur du suffixe verbal français, in Cahiers F. De Saussure, 18, F. DE SAUSSURE, Cours, cit., p ID., Corso, n.70, pp. 388, R. GODEL, Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. De Saussure, Genève 1957, p V. O. JESPERSEN, Mankind, Nation and Individual from a Linguistic Point of View, Oslo 1925, Cap I; N. C. W. SPENCE, A Hardy Perennial: the Problem of la Langue and la Parole, Archivium Linguisticuum IX, 1957 pp Archivium linguisticuum, 9, 1957, pp Lund, Ibidem. 13 Ivi, p
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Macerata
 Facoltà di Scienze della Comunicazione, Macerata Lo studio del segno in una prospettiva storicometodologica Il modello saussuriano langue/parole significante/significato sintagma/paradigm,a Segno: aliquid
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Macerata Lo studio del segno in una prospettiva storicometodologica Il modello saussuriano langue/parole significante/significato sintagma/paradigm,a Segno: aliquid
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Macerata
 Facoltà di Scienze della Comunicazione, Macerata Le due anime della semiotica: come si giustificano Il modello peirciano Il concetto di inferenza Deduzione/Induzione/Abduzione Icona/Indice/Simbolo Il modello
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Macerata Le due anime della semiotica: come si giustificano Il modello peirciano Il concetto di inferenza Deduzione/Induzione/Abduzione Icona/Indice/Simbolo Il modello
PROBLEMI DI SIGNIFICATO. L ATTO LINGUISTICO COME ESPRESSIONE E COME COMUNICAZIONE
 PROBLEMI DI SIGNIFICATO. L ATTO LINGUISTICO COME ESPRESSIONE E COME COMUNICAZIONE di Renzo Raggiunti 102 Uno degli aspetti più interessanti della definizione della parole, dell atto linguistico concreto
PROBLEMI DI SIGNIFICATO. L ATTO LINGUISTICO COME ESPRESSIONE E COME COMUNICAZIONE di Renzo Raggiunti 102 Uno degli aspetti più interessanti della definizione della parole, dell atto linguistico concreto
Psicologia della comunicazione Fondamenti. Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1
 Psicologia della comunicazione Fondamenti Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1 Psicologia della comunicazione Settore scientifico-disciplinare: Psicologia generale Campo di ricerca interdisciplinare
Psicologia della comunicazione Fondamenti Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1 Psicologia della comunicazione Settore scientifico-disciplinare: Psicologia generale Campo di ricerca interdisciplinare
la formazione delle classi e della categorie
 la formazione delle classi e della categorie Tradizionalmente si assume che per formare una classe sia necessario indicare proprietà necessarie e congiuntamente sufficienti. Indicate le proprietà si possono
la formazione delle classi e della categorie Tradizionalmente si assume che per formare una classe sia necessario indicare proprietà necessarie e congiuntamente sufficienti. Indicate le proprietà si possono
Pragmatica e atti linguistici
 Pragmatica e atti linguistici Giovanni Manetti, Scienze della comunicazione, Siena c. Giovanni Manetti 1 Charles Morris 1. Sintattica 2. Semantica 3. Pragmatica c. Giovanni Manetti 2 Astratto/Concreto
Pragmatica e atti linguistici Giovanni Manetti, Scienze della comunicazione, Siena c. Giovanni Manetti 1 Charles Morris 1. Sintattica 2. Semantica 3. Pragmatica c. Giovanni Manetti 2 Astratto/Concreto
Paul Grice teoria dell implicatura conversazionale
 Paul Grice teoria dell implicatura conversazionale significato naturale e significato non naturale Grice attira l attenzione su due differenti modi in cui il verbo significare è usato. quelle macchie significano
Paul Grice teoria dell implicatura conversazionale significato naturale e significato non naturale Grice attira l attenzione su due differenti modi in cui il verbo significare è usato. quelle macchie significano
CAPITOLO V. DATABASE: Il modello relazionale
 CAPITOLO V DATABASE: Il modello relazionale Il modello relazionale offre una rappresentazione matematica dei dati basata sul concetto di relazione normalizzata. I principi del modello relazionale furono
CAPITOLO V DATABASE: Il modello relazionale Il modello relazionale offre una rappresentazione matematica dei dati basata sul concetto di relazione normalizzata. I principi del modello relazionale furono
de Saussure Note di lettura dal Corso di Linguistica Generale per il corso di Filosofia del linguaggio e semiotica 2010-11
 de Saussure Note di lettura dal Corso di Linguistica Generale per il corso di Filosofia del linguaggio e semiotica 2010-11 Il Corso di Linguistica Generale Si tratta di lezioni tenute a Ginevra fra il
de Saussure Note di lettura dal Corso di Linguistica Generale per il corso di Filosofia del linguaggio e semiotica 2010-11 Il Corso di Linguistica Generale Si tratta di lezioni tenute a Ginevra fra il
Analisi del linguaggio
 Analisi del linguaggio 3 livelli: SINTASSI: si occupa della relazione dei segni linguistici tra loro; SEMANTICA: si occupa della relazione dei segni linguistici con qualcosa di esterno al linguaggio; PRAGMATICA:
Analisi del linguaggio 3 livelli: SINTASSI: si occupa della relazione dei segni linguistici tra loro; SEMANTICA: si occupa della relazione dei segni linguistici con qualcosa di esterno al linguaggio; PRAGMATICA:
Filosofia del linguaggio (i) (3 cr.)
 Filosofia del linguaggio (i) (3 cr.) Docente: Giuseppe Spolaore Orario: Martedì ore 17.20 aula T4, mercoledì ore 17.20 aula 1.4, giovedì ore 14.00 aula 1.4 (per un totale di circa 10 lezioni). Ricevimento:
Filosofia del linguaggio (i) (3 cr.) Docente: Giuseppe Spolaore Orario: Martedì ore 17.20 aula T4, mercoledì ore 17.20 aula 1.4, giovedì ore 14.00 aula 1.4 (per un totale di circa 10 lezioni). Ricevimento:
Appunti di geometria euclidea
 Appunti di geometria euclidea Il metodo assiomatico Appunti di geometria Euclidea Lezione 1 Prima di esaminare nel dettaglio la Geometria dal punto di vista dei Greci è opportuno fare unrichiamo di Logica.
Appunti di geometria euclidea Il metodo assiomatico Appunti di geometria Euclidea Lezione 1 Prima di esaminare nel dettaglio la Geometria dal punto di vista dei Greci è opportuno fare unrichiamo di Logica.
Cerchiamo di capire che cosa questo significa
 http://filosofia.dipafilo.unimi.it/~paganini/index.html A tutti appare chiaro che Quando leggiamo una frase ambigua facciamo molto fatica a cogliere l ambiguità, noi leggiamo la frase in base a una certa
http://filosofia.dipafilo.unimi.it/~paganini/index.html A tutti appare chiaro che Quando leggiamo una frase ambigua facciamo molto fatica a cogliere l ambiguità, noi leggiamo la frase in base a una certa
Che cos è la filosofia analitica?
 Che cos è la filosofia analitica? Sascia Pavan sascia.pavan@gmail.com 31 marzo 2011 Sommario 1 Introduzione I padri fondatori Logica matematica 2 La filosofia analitica prima maniera: dalle origini agli
Che cos è la filosofia analitica? Sascia Pavan sascia.pavan@gmail.com 31 marzo 2011 Sommario 1 Introduzione I padri fondatori Logica matematica 2 La filosofia analitica prima maniera: dalle origini agli
3. Logica. Obiettivi di apprendimento: Relazioni, dati e previsioni 6T, 7T, 8T, 10Q. La logica nel linguaggio comune...
 Capitolo 3. Logica 3. Logica Obiettivi di apprendimento: Relazioni, dati e previsioni 6T, 7T, 8T, 10Q. La logica nel linguaggio comune... sei una persona priva di logica è logico comportarsi cosí fai l
Capitolo 3. Logica 3. Logica Obiettivi di apprendimento: Relazioni, dati e previsioni 6T, 7T, 8T, 10Q. La logica nel linguaggio comune... sei una persona priva di logica è logico comportarsi cosí fai l
LOCKE. Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza:
 LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
Limiti di successioni
 Capitolo 5 Limiti di successioni 5.1 Successioni Quando l insieme di definizione di una funzione coincide con l insieme N costituito dagli infiniti numeri naturali 1, 2, 3,... talvolta si considera anche
Capitolo 5 Limiti di successioni 5.1 Successioni Quando l insieme di definizione di una funzione coincide con l insieme N costituito dagli infiniti numeri naturali 1, 2, 3,... talvolta si considera anche
parte I teoria generale lezione 1 introduzione alla semiotica
 Corso di Semiotica per la comunicazione Università di Teramo a.a. 2007/2008 prof. Piero Polidoro parte I teoria generale lezione 1 introduzione alla semiotica Sommario Quadro storico 3. 4. 5. Quadro storico
Corso di Semiotica per la comunicazione Università di Teramo a.a. 2007/2008 prof. Piero Polidoro parte I teoria generale lezione 1 introduzione alla semiotica Sommario Quadro storico 3. 4. 5. Quadro storico
IL QUIZ DELLE REGIONI
 IL QUIZ DELLE REGIONI Attività metacognitiva e valutazione dinamica Insegnante Marisa Squillace CARTE GIOCO per scoprire le regioni d Italia. UN GIOCO PER VALUTARE IN MODO DINAMICO E GIOCOSO E METTERE
IL QUIZ DELLE REGIONI Attività metacognitiva e valutazione dinamica Insegnante Marisa Squillace CARTE GIOCO per scoprire le regioni d Italia. UN GIOCO PER VALUTARE IN MODO DINAMICO E GIOCOSO E METTERE
Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva
 Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,
Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,
7. INSIEMI APERTI, INSIEMI CHIUSI, INSIEMI NE APERTI NE CHIUSI
 7. INSIEMI APERTI, INSIEMI CHIUSI, INSIEMI NE APERTI NE CHIUSI Sia E un insieme numerico, sia cioè. Esempi Si dice che E è un insieme APERTO se tutti i suoi punti sono interni. Ogni intervallo aperto (dove
7. INSIEMI APERTI, INSIEMI CHIUSI, INSIEMI NE APERTI NE CHIUSI Sia E un insieme numerico, sia cioè. Esempi Si dice che E è un insieme APERTO se tutti i suoi punti sono interni. Ogni intervallo aperto (dove
CORSO ZERO DI MATEMATICA
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTÀ DI ARCHITETTURA CORSO ZERO DI MATEMATICA RADICALI Dr. Erasmo Modica erasmo@galois.it LE RADICI Abbiamo visto che l insieme dei numeri reali è costituito da tutti
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTÀ DI ARCHITETTURA CORSO ZERO DI MATEMATICA RADICALI Dr. Erasmo Modica erasmo@galois.it LE RADICI Abbiamo visto che l insieme dei numeri reali è costituito da tutti
Ragionamento LOGICA E PENSIERO COMUNE. Fondamenti di Psicologia Generale Cap. 20. Dott.ssa Stefania Pighin -
 Ragionamento LOGICA E PENSIERO COMUNE Fondamenti di Psicologia Generale Cap. 20 Dott.ssa Stefania Pighin - stefania.pighin@unitn.it Due fratelli, Paolo e Francesco, vanno a fare la spesa al mercato. La
Ragionamento LOGICA E PENSIERO COMUNE Fondamenti di Psicologia Generale Cap. 20 Dott.ssa Stefania Pighin - stefania.pighin@unitn.it Due fratelli, Paolo e Francesco, vanno a fare la spesa al mercato. La
La matematica come forma di comunicazione PRIN
 La matematica come forma di comunicazione PRIN 2009-2011 Introduzione Quanto è chiara l idea di comunicazione matematica? Possiamo distinguere il discorso matematico da tutti gli altri concentrandoci soltanto
La matematica come forma di comunicazione PRIN 2009-2011 Introduzione Quanto è chiara l idea di comunicazione matematica? Possiamo distinguere il discorso matematico da tutti gli altri concentrandoci soltanto
EQUAZIONI CON VALORE ASSOLUTO DISEQUAZIONI CON VALORE ASSOLUTO
 EQUAZIONI CON VALORE AOLUTO DIEQUAZIONI CON VALORE AOLUTO Prima di tutto: che cosa è il valore assoluto di un numero? Il valore assoluto è quella legge che ad un numero (positivo o negativo) associa sempre
EQUAZIONI CON VALORE AOLUTO DIEQUAZIONI CON VALORE AOLUTO Prima di tutto: che cosa è il valore assoluto di un numero? Il valore assoluto è quella legge che ad un numero (positivo o negativo) associa sempre
Dai risultati delle prove INVALSI alle prospettive didattiche
 Dai risultati delle prove INVALSI alle prospettive didattiche 1 Struttura della prova di 2 primaria La prova è costituita di 17 quesiti di comprensione della lettura di un breve testo narrativo, tutti
Dai risultati delle prove INVALSI alle prospettive didattiche 1 Struttura della prova di 2 primaria La prova è costituita di 17 quesiti di comprensione della lettura di un breve testo narrativo, tutti
Il tubo del tempo. Dalla descrizione grammaticale alla cognizione della grammatica
 Il tubo del tempo Dalla descrizione grammaticale alla cognizione della grammatica Parte prima: La situazione attuale Il posto della grammatica cognitiva A che cosa serve la grammatica? Tante risposte:
Il tubo del tempo Dalla descrizione grammaticale alla cognizione della grammatica Parte prima: La situazione attuale Il posto della grammatica cognitiva A che cosa serve la grammatica? Tante risposte:
Lezione 20: Atomi e molecole
 Lezione 20 - pag.1 Lezione 20: Atomi e molecole 20.1. Il punto della situazione Abbiamo visto, nella lezione precedente, come il modello atomico sia in grado di spiegare la grande varietà di sostanze che
Lezione 20 - pag.1 Lezione 20: Atomi e molecole 20.1. Il punto della situazione Abbiamo visto, nella lezione precedente, come il modello atomico sia in grado di spiegare la grande varietà di sostanze che
3. Successioni di insiemi.
 3. Successioni di insiemi. Per evitare incongruenze supponiamo, in questo capitolo, che tutti gli insiemi considerati siano sottoinsiemi di un dato insieme S (l insieme ambiente ). Quando occorrerà considerare
3. Successioni di insiemi. Per evitare incongruenze supponiamo, in questo capitolo, che tutti gli insiemi considerati siano sottoinsiemi di un dato insieme S (l insieme ambiente ). Quando occorrerà considerare
G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio A L C U N E I D E E B A S I L A R I 1
 G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio A L C U N E I D E E B A S I L A R I 1 La linguistica, il «linguaggio» e i «linguaggi» 2 Linguistica: Scienza cognitiva (cfr. lezioni introduttive) Lo studio
G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio A L C U N E I D E E B A S I L A R I 1 La linguistica, il «linguaggio» e i «linguaggi» 2 Linguistica: Scienza cognitiva (cfr. lezioni introduttive) Lo studio
Continua la serie di minitesti di avvio al pensiero scientifico.
 info@didatticaperprogetti.it PROGETTO 3.1.4 TITOLO Cerco di capire (2) AREA Scientifica (Pensiero scientifico) SCUOLA Elementare: classi 3-4 - 5 Media: 1-2 - 3 OBIETTIVO Riflettere sul concetto di comprensione
info@didatticaperprogetti.it PROGETTO 3.1.4 TITOLO Cerco di capire (2) AREA Scientifica (Pensiero scientifico) SCUOLA Elementare: classi 3-4 - 5 Media: 1-2 - 3 OBIETTIVO Riflettere sul concetto di comprensione
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 13.8.2008 COM(2008) 514 definitivo VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 13.8.2008 COM(2008) 514 definitivo VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004
Riappropriarsi del tempo per riappropriarsi di sé. Guida per l insegnante
 Obiettivi educativi generali Compito di esplorazione - dà risposte originali - è capace di produrre molte idee - comprende la molteplicità dei punti di vista Guida per l insegnante Compito di cristallizzazione
Obiettivi educativi generali Compito di esplorazione - dà risposte originali - è capace di produrre molte idee - comprende la molteplicità dei punti di vista Guida per l insegnante Compito di cristallizzazione
Indice. 1 Introduzione alla Ricerca Empirica L osservazione partecipata e non partecipata...5
 INSEGNAMENTO DI PEDAGOGIA SPERIMENTALE LEZIONE III LA RICERCA EMPIRICA PARTE I PROF. LUCIANO GALLIANI Indice 1 Introduzione alla Ricerca Empirica...3 2 L osservazione partecipata e non partecipata...5
INSEGNAMENTO DI PEDAGOGIA SPERIMENTALE LEZIONE III LA RICERCA EMPIRICA PARTE I PROF. LUCIANO GALLIANI Indice 1 Introduzione alla Ricerca Empirica...3 2 L osservazione partecipata e non partecipata...5
Indice. 1 Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto ------------------------------------------------------3
 INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE V FATTO ED EFFETTO GIURIDICO PROF. DOMENICO RUGGIERO Indice 1 Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto ------------------------------------------------------3
INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE V FATTO ED EFFETTO GIURIDICO PROF. DOMENICO RUGGIERO Indice 1 Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto ------------------------------------------------------3
1. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO.
 1. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO. L art. 42 della Carta Costituzionale afferma che i beni economici, intendendosi per essi quelli suscettibili di appropriazione e dunque di commercio, appartengono allo
1. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO. L art. 42 della Carta Costituzionale afferma che i beni economici, intendendosi per essi quelli suscettibili di appropriazione e dunque di commercio, appartengono allo
Modulo di Psicologia Sociale e dei Gruppi
 Modulo di Psicologia Sociale e dei Gruppi Insegnamento di Psicologia Sociale e di Comunità Antonio Nocera Corso di Laurea in Scienze dell educazione A.A. 2011/2012 Date degli esami 24 gennaio 2012 ore
Modulo di Psicologia Sociale e dei Gruppi Insegnamento di Psicologia Sociale e di Comunità Antonio Nocera Corso di Laurea in Scienze dell educazione A.A. 2011/2012 Date degli esami 24 gennaio 2012 ore
Riconoscere e formalizzare le dipendenze funzionali
 Riconoscere e formalizzare le dipendenze funzionali Giorgio Ghelli 25 ottobre 2007 1 Riconoscere e formalizzare le dipendenze funzionali Non sempre è facile indiduare le dipendenze funzionali espresse
Riconoscere e formalizzare le dipendenze funzionali Giorgio Ghelli 25 ottobre 2007 1 Riconoscere e formalizzare le dipendenze funzionali Non sempre è facile indiduare le dipendenze funzionali espresse
I Disturbi Specifici di Linguaggio. Percorsi Evolutivi Dei DSL
 I Disturbi Specifici di Linguaggio Percorsi Evolutivi Dei DSL Il motore dell apprendimento linguistico, come acquisizione di un sistema basato su molte competenze, è il seguente: utilizzare come risolutive
I Disturbi Specifici di Linguaggio Percorsi Evolutivi Dei DSL Il motore dell apprendimento linguistico, come acquisizione di un sistema basato su molte competenze, è il seguente: utilizzare come risolutive
Es. quadrilatero: specie di poligono, genere di quadrato. La specie ha più caratteristiche, il genere è riferito a più elementi.
 La logica di Aristotele La logica non si trova tra le scienze dell enciclopedia aristotelica, poiché essa ha per oggetto la forma comune a tutte le scienze, cioè il procedimento dimostrativo, o le varie
La logica di Aristotele La logica non si trova tra le scienze dell enciclopedia aristotelica, poiché essa ha per oggetto la forma comune a tutte le scienze, cioè il procedimento dimostrativo, o le varie
COME COMUNICARE IN MODO EFFICIENTE? Comunicazione e dinamiche relazionali
 COME COMUNICARE IN MODO EFFICIENTE? Comunicazione e dinamiche relazionali Cosa significa comunicare? Informazione A -----------> B Mittente Messaggio Destinatario Cosa significa comunicare? Comunicazione
COME COMUNICARE IN MODO EFFICIENTE? Comunicazione e dinamiche relazionali Cosa significa comunicare? Informazione A -----------> B Mittente Messaggio Destinatario Cosa significa comunicare? Comunicazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Anno accademico 2015-2016 Corso di Pedagogia Lezione 05/4/2016 Loredana La Vecchia Dalla prospettiva del soggetto* malattia ü Evento traumatico (che perturba) ü Minaccia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Anno accademico 2015-2016 Corso di Pedagogia Lezione 05/4/2016 Loredana La Vecchia Dalla prospettiva del soggetto* malattia ü Evento traumatico (che perturba) ü Minaccia
Rappresentazione dei numeri reali in un calcolatore
 Corso di Calcolatori Elettronici I A.A. 2010-2011 Rappresentazione dei numeri reali in un calcolatore Lezione 3 Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Rappresentazione di numeri
Corso di Calcolatori Elettronici I A.A. 2010-2011 Rappresentazione dei numeri reali in un calcolatore Lezione 3 Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Rappresentazione di numeri
Teoria intuitiva degli insiemi
 Teoria intuitiva degli insiemi Il concetto di insieme. lcuni esempi Tutta la matematica moderna è fondata sul concetto di insieme. Un insieme è da considerarsi nella sua nozione intuitiva di collezione,
Teoria intuitiva degli insiemi Il concetto di insieme. lcuni esempi Tutta la matematica moderna è fondata sul concetto di insieme. Un insieme è da considerarsi nella sua nozione intuitiva di collezione,
Scongiurare un pericolo
 http://italianosemplicemente.com/ Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente Scongiurare un pericolo Buongiorno amici. Buona giornata a tutti gli amici di Italiano Semplicemente. Oggi per la sezione
http://italianosemplicemente.com/ Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente Scongiurare un pericolo Buongiorno amici. Buona giornata a tutti gli amici di Italiano Semplicemente. Oggi per la sezione
Lo psicologo può fare divulgazione scientifica?
 Lo psicologo può fare divulgazione scientifica? Lo psicologo è un esperto di comunicazione. Perché non valorizziamo queste competenze nella divulgazione scientifica? Chimici, fisici, biologi, matematici
Lo psicologo può fare divulgazione scientifica? Lo psicologo è un esperto di comunicazione. Perché non valorizziamo queste competenze nella divulgazione scientifica? Chimici, fisici, biologi, matematici
Semiotica Lumsa a.a. 2015/2016 Piero Polidoro. 7 ottobre lezione 1 saussure, concetti fondamentali
 Semiotica Lumsa a.a. 2015/2016 Piero Polidoro 7 ottobre 2015 lezione 1 saussure, concetti fondamentali Sommario 1. Introduzione al corso e informazioni pratiche 2. Concetti fondamentali 3. Testi da studiare
Semiotica Lumsa a.a. 2015/2016 Piero Polidoro 7 ottobre 2015 lezione 1 saussure, concetti fondamentali Sommario 1. Introduzione al corso e informazioni pratiche 2. Concetti fondamentali 3. Testi da studiare
Guido Alliney Trento, 4 dicembre Libera volontà. Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto
 Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Applicazioni:la traduzione automatica
 Applicazioni:la traduzione automatica Il problema di tradurre automaticamente un testo da una lingua all altra è stato affrontato ancora prima della nascita dell IA. Negli anni Cinquanta diversi ricercatori,
Applicazioni:la traduzione automatica Il problema di tradurre automaticamente un testo da una lingua all altra è stato affrontato ancora prima della nascita dell IA. Negli anni Cinquanta diversi ricercatori,
La prova scritta di italiano nell esame conclusivo del primo ciclo
 La prova scritta di italiano nell esame conclusivo del primo ciclo La prova d esame come esito di una didattica efficace Un ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo delle competenze di scrittura
La prova scritta di italiano nell esame conclusivo del primo ciclo La prova d esame come esito di una didattica efficace Un ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo delle competenze di scrittura
Intervista con la professoressa Elisabetta Santoro, docente di Lingua Italiana presso la Facoltà di Lettere dell Università di São Paulo (FFLCH USP).
 Lezione 15 Intervista con la professoressa Elisabetta Santoro, docente di Lingua Italiana presso la Facoltà di Lettere dell Università di São Paulo (FFLCH USP). Tema: Il passato prossimo e l imperfetto
Lezione 15 Intervista con la professoressa Elisabetta Santoro, docente di Lingua Italiana presso la Facoltà di Lettere dell Università di São Paulo (FFLCH USP). Tema: Il passato prossimo e l imperfetto
Luca Costabile Esercizi di Logica Matematica Dispensa Calcolo Proposizionale 1
 Luca Costabile Esercizi di Logica Matematica Dispensa Calcolo Proposizionale 1 Esercizio 1.12 Per dimostrare che per ogni funzione esiste una formula in cui compaiono le variabili tale che la corrispondente
Luca Costabile Esercizi di Logica Matematica Dispensa Calcolo Proposizionale 1 Esercizio 1.12 Per dimostrare che per ogni funzione esiste una formula in cui compaiono le variabili tale che la corrispondente
LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA
 JEAN DANIÉLOU LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA Postfazione all edizione italiana di Piero Coda terza edizione Queriniana Premessa alla seconda edizione L accoglienza riservata a questo libriccino
JEAN DANIÉLOU LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA Postfazione all edizione italiana di Piero Coda terza edizione Queriniana Premessa alla seconda edizione L accoglienza riservata a questo libriccino
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARBERINO DI MUGELLO Scuola Secondaria di primo grado classi prime Insegnante: Enrico Masi. Solidi, liquidi e gas
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARBERINO DI MUGELLO Scuola Secondaria di primo grado classi prime Insegnante: Enrico Masi Solidi, liquidi e gas 1 PREFAZIONE Alcune note sul metodo usato Non si deve dare definizioni
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARBERINO DI MUGELLO Scuola Secondaria di primo grado classi prime Insegnante: Enrico Masi Solidi, liquidi e gas 1 PREFAZIONE Alcune note sul metodo usato Non si deve dare definizioni
La Statistica: introduzione e approfondimenti
 La Statistica: introduzione e approfondimenti Definizione di statistica Che cosa è la statistica? La statistica è una disciplina scientifica che trae i suoi risultati dalla raccolta, dall elaborazione
La Statistica: introduzione e approfondimenti Definizione di statistica Che cosa è la statistica? La statistica è una disciplina scientifica che trae i suoi risultati dalla raccolta, dall elaborazione
Pedagogia sperimentale Prof. Giovanni Arduini
 Pedagogia sperimentale Lezione n. 3 A.A. 2015/16 U.D. n.2: Tipi e metodi della ricerca pedagogica dall'età moderna ad oggi 1. Definizione di ricerca pedagogica Con il termine "ricerca" generalmente si
Pedagogia sperimentale Lezione n. 3 A.A. 2015/16 U.D. n.2: Tipi e metodi della ricerca pedagogica dall'età moderna ad oggi 1. Definizione di ricerca pedagogica Con il termine "ricerca" generalmente si
Come trasformare la competizione in collaborazione;
 OBIETTIVI Come trasformare la competizione in collaborazione; PRESUPPOSTI La competizione è un opportunità per i dipendenti e per l azienda quando è gestita correttamente; La competizione, quando gestita
OBIETTIVI Come trasformare la competizione in collaborazione; PRESUPPOSTI La competizione è un opportunità per i dipendenti e per l azienda quando è gestita correttamente; La competizione, quando gestita
NOTE SULLE FUNZIONI CONVESSE DI UNA VARIABILE REALE
 NOTE SULLE FUNZIONI CONVESSE DI UNA VARIABILE REALE ROBERTO GIAMBÒ 1. DEFINIZIONI E PRIME PROPRIETÀ In queste note saranno presentate alcune proprietà principali delle funzioni convesse di una variabile
NOTE SULLE FUNZIONI CONVESSE DI UNA VARIABILE REALE ROBERTO GIAMBÒ 1. DEFINIZIONI E PRIME PROPRIETÀ In queste note saranno presentate alcune proprietà principali delle funzioni convesse di una variabile
LE REGOLE DEL METODO SOCIOLOGICO (1895) è il testo col quale Durkheim mette a punto una propria idea della metodologia. Qui si possono rintracciare
 LE REGOLE DEL METODO SOCIOLOGICO (1895) è il testo col quale Durkheim mette a punto una propria idea della metodologia. Qui si possono rintracciare alcuni elementi-chiave del suo pensiero: Il concetto
LE REGOLE DEL METODO SOCIOLOGICO (1895) è il testo col quale Durkheim mette a punto una propria idea della metodologia. Qui si possono rintracciare alcuni elementi-chiave del suo pensiero: Il concetto
Edoardo Boncinelli. L infinito in breve. Inciampi e contrattempi della scienza
 Edoardo Boncinelli L infinito in breve Inciampi e contrattempi della scienza Proprietà letteraria riservata 2016 Rizzoli Libri S.p.A./Rizzoli, Milano ISBN 978-88-17-09123-7 Prima edizione: novembre 2016
Edoardo Boncinelli L infinito in breve Inciampi e contrattempi della scienza Proprietà letteraria riservata 2016 Rizzoli Libri S.p.A./Rizzoli, Milano ISBN 978-88-17-09123-7 Prima edizione: novembre 2016
UNITÀ DIDATTICA 5 LA RETTA
 UNITÀ DIDATTICA 5 LA RETTA 5.1 - La retta Equazione generica della retta Dalle considerazioni emerse nel precedente capitolo abbiamo compreso come una funzione possa essere rappresentata da un insieme
UNITÀ DIDATTICA 5 LA RETTA 5.1 - La retta Equazione generica della retta Dalle considerazioni emerse nel precedente capitolo abbiamo compreso come una funzione possa essere rappresentata da un insieme
Italiano Tecnico 2007-2008. La relazione di lavoro
 Italiano Tecnico 2007-2008 La relazione di lavoro La relazione Si tratta di un testo che deve tracciare il bilancio di un esperienza o il resoconto di una ricerca. Nella relazione prevale la componente
Italiano Tecnico 2007-2008 La relazione di lavoro La relazione Si tratta di un testo che deve tracciare il bilancio di un esperienza o il resoconto di una ricerca. Nella relazione prevale la componente
Proposta didattica per la classe terza - quarta della scuola primaria. I. C. Visconti
 Proposta didattica per la classe terza - quarta della scuola primaria I. C. Visconti FASI DELL ESPERIENZA Cosa pensano i bambini di metà, un terzo e un quarto Raccolta delle loro idee e visualizzazione
Proposta didattica per la classe terza - quarta della scuola primaria I. C. Visconti FASI DELL ESPERIENZA Cosa pensano i bambini di metà, un terzo e un quarto Raccolta delle loro idee e visualizzazione
Cosa dobbiamo già conoscere?
 Cosa dobbiamo già conoscere? Come opera la matematica: dagli ai teoremi. Che cosa è una funzione, il suo dominio e il suo codominio. Che cosa significa n j=1 A j dove A j sono insiemi. Che cosa significa
Cosa dobbiamo già conoscere? Come opera la matematica: dagli ai teoremi. Che cosa è una funzione, il suo dominio e il suo codominio. Che cosa significa n j=1 A j dove A j sono insiemi. Che cosa significa
ITALIANO GRIGLIE DI VALUTAZIONE. Indicatore di competenza chiave europea CLASSE PRIMA
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO CLASSE PRIMA Indicatore di competenza chiave europea La comunicazione della madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO CLASSE PRIMA Indicatore di competenza chiave europea La comunicazione della madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e
LA RETTA. La retta è un insieme illimitato di punti che non ha inizio, né fine.
 LA RETTA La retta è un insieme illimitato di punti che non ha inizio, né fine. Proprietà: Per due punti del piano passa una ed una sola retta. Nel precedente modulo abbiamo visto che ad ogni punto del
LA RETTA La retta è un insieme illimitato di punti che non ha inizio, né fine. Proprietà: Per due punti del piano passa una ed una sola retta. Nel precedente modulo abbiamo visto che ad ogni punto del
Ore di lezione presso il CIAL
 Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Centro Interfacoltà per l Apprendimento Linguistico Viene illustrata di seguito l offerta formativa del CIAL in preparazione ai livelli linguistici stabiliti
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Centro Interfacoltà per l Apprendimento Linguistico Viene illustrata di seguito l offerta formativa del CIAL in preparazione ai livelli linguistici stabiliti
Lavoro individuale: leggi attentamente il testo e completa il testo che trovi al termine del stesso. (10 )
 Testo 1: Lavoro individuale: leggi attentamente il testo e completa il testo che trovi al termine del stesso. (10 ) Lavoro di gruppo T1: discuti assieme ai tuoi compagni il significato di quanto hai letto
Testo 1: Lavoro individuale: leggi attentamente il testo e completa il testo che trovi al termine del stesso. (10 ) Lavoro di gruppo T1: discuti assieme ai tuoi compagni il significato di quanto hai letto
Corso di Informatica Generale (C. L. Economia e Commercio) Ing. Valerio Lacagnina Rappresentazione dei numeri relativi
 Codice BCD Prima di passare alla rappresentazione dei numeri relativi in binario vediamo un tipo di codifica che ha una certa rilevanza in alcune applicazioni: il codice BCD (Binary Coded Decimal). È un
Codice BCD Prima di passare alla rappresentazione dei numeri relativi in binario vediamo un tipo di codifica che ha una certa rilevanza in alcune applicazioni: il codice BCD (Binary Coded Decimal). È un
Cap. 6 del manuale La natura e i suoi modelli
 Cap. 6 del manuale La natura e i suoi modelli 1. In questa stanza c è una lavagna 2. Gli atomi di sodio hanno 11 protoni e 11 elettroni Consideriamo vere queste due affermazioni? Perché? Aff. 1: Perché
Cap. 6 del manuale La natura e i suoi modelli 1. In questa stanza c è una lavagna 2. Gli atomi di sodio hanno 11 protoni e 11 elettroni Consideriamo vere queste due affermazioni? Perché? Aff. 1: Perché
Hegel. Il sistema hegeliano in sintesi
 Hegel I capisaldi del pensiero hegeliano 2 Il pensiero di Hegel rappresenta una delle più poderose sintesi filosofiche di tutti i tempi e grande è l influsso che ha esercitato sulla cultura europea dell
Hegel I capisaldi del pensiero hegeliano 2 Il pensiero di Hegel rappresenta una delle più poderose sintesi filosofiche di tutti i tempi e grande è l influsso che ha esercitato sulla cultura europea dell
OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO
 OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO TERZA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE VERIFICHE ASCOLTARE Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni, regole. Seguire una conversazione e comprendere ciò di
OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO TERZA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE VERIFICHE ASCOLTARE Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni, regole. Seguire una conversazione e comprendere ciò di
Indice. Università Telematica Pegaso. 2 di 6. 1 L adultità... 3
 L ADULTITÀ PROF. NICOLA PAPARELLA Indice 1... 3 2 di 6 1 In questa lezione riprenderemo un tema già annunciato: il tema dell adultità. Nella prima lezione abbiamo detto che sotto la nozione di adulto c
L ADULTITÀ PROF. NICOLA PAPARELLA Indice 1... 3 2 di 6 1 In questa lezione riprenderemo un tema già annunciato: il tema dell adultità. Nella prima lezione abbiamo detto che sotto la nozione di adulto c
Servizio INFORMATIVA 730
 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 MAGGIO 2009 Informativa n. 38 Ticket sui medicinali
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 MAGGIO 2009 Informativa n. 38 Ticket sui medicinali
Filosofia del linguaggio (i) (3 cr.)
 Filosofia del linguaggio (i) (3 cr.) Docente: Giuseppe Spolaore Orario: Martedì ore 17.20 aula T4, mercoledì ore 17.20 aula 1.4, giovedì ore 14.00 aula 1.4 (per un totale di circa 10 lezioni). Ricevimento:
Filosofia del linguaggio (i) (3 cr.) Docente: Giuseppe Spolaore Orario: Martedì ore 17.20 aula T4, mercoledì ore 17.20 aula 1.4, giovedì ore 14.00 aula 1.4 (per un totale di circa 10 lezioni). Ricevimento:
Estratto da: Yona Friedman, L'ordine complicato. Come costruire un'immagine, traduzione di Paolo Tramannoni, con una nota di Manuel Orazi,
 Estratto da: Yona Friedman, L'ordine complicato. Come costruire un'immagine, traduzione di Paolo Tramannoni, con una nota di Manuel Orazi, Quodlibet-Abitare, Macerata 2011. Ulteriori informazioni: http://www.quodlibet.it/schedap.php?id=1963
Estratto da: Yona Friedman, L'ordine complicato. Come costruire un'immagine, traduzione di Paolo Tramannoni, con una nota di Manuel Orazi, Quodlibet-Abitare, Macerata 2011. Ulteriori informazioni: http://www.quodlibet.it/schedap.php?id=1963
CRESCERE LAVORANDO IN GRUPPI AUTENTICI
 Progetto in rete I CARE CRESCERE LAVORANDO IN GRUPPI AUTENTICI ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURNO SCUOLA PRIMARIA DI CURNO GIOCHI LOGICI MATEMATICI REFERENTE: Ins. EPIFANI VINCENZA OBIETTIVO DIDATTICO: - Usare
Progetto in rete I CARE CRESCERE LAVORANDO IN GRUPPI AUTENTICI ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURNO SCUOLA PRIMARIA DI CURNO GIOCHI LOGICI MATEMATICI REFERENTE: Ins. EPIFANI VINCENZA OBIETTIVO DIDATTICO: - Usare
Ore di lezione presso il CIAL
 Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Centro Interfacoltà per l Apprendimento Linguistico LIVELLI LINGUA Ore di lezione presso il CIAL SYLLABUS (rif. Common European Framework ) INGLESE Il livello
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Centro Interfacoltà per l Apprendimento Linguistico LIVELLI LINGUA Ore di lezione presso il CIAL SYLLABUS (rif. Common European Framework ) INGLESE Il livello
LINGUA ITALIANA. Sapere Nuclei fondanti TESTO. Saper fare. Memorizzare. Comprendere. Produrre CODICE OGGETTO CULTURALE LESSICO.
 LINGUA ITALIANA è è Sapere Nuclei fondanti OGGETTO CULTURALE che registra i CAMBIAMENTI. CODICE Utilizzato per la COMUNICAZIONE Ha come unità fondamentale il TESTO Utilizza un LESSICO Saper fare che determinano
LINGUA ITALIANA è è Sapere Nuclei fondanti OGGETTO CULTURALE che registra i CAMBIAMENTI. CODICE Utilizzato per la COMUNICAZIONE Ha come unità fondamentale il TESTO Utilizza un LESSICO Saper fare che determinano
Il messaggio: tra linguaggio digitale e linguaggio analogico. Loredana La Vecchia Lezione 1 aprile 2009 Corso di Laurea Scienze dell educazione
 Il messaggio: tra linguaggio digitale e linguaggio analogico Loredana La Vecchia Lezione 1 aprile 2009 Corso di Laurea Scienze dell educazione definizione Linguaggio = capacità, facoltà mentale di cui
Il messaggio: tra linguaggio digitale e linguaggio analogico Loredana La Vecchia Lezione 1 aprile 2009 Corso di Laurea Scienze dell educazione definizione Linguaggio = capacità, facoltà mentale di cui
ISIS 'Il Pontormo' Empoli Liceo scientifico
 ISIS 'Il Pontormo' Empoli Liceo scientifico Documento degli obiettivi minimi di Filosofia e Storia. LE CONOSCENZE, LE ABILITÀ E LE COMPETENZE ESSENZIALI OFFERTE E RICHIESTE ALLO STUDENTE DEL LICEO Storia
ISIS 'Il Pontormo' Empoli Liceo scientifico Documento degli obiettivi minimi di Filosofia e Storia. LE CONOSCENZE, LE ABILITÀ E LE COMPETENZE ESSENZIALI OFFERTE E RICHIESTE ALLO STUDENTE DEL LICEO Storia
Mario Albertini. Tutti gli scritti VI a cura di Nicoletta Mosconi. Società editrice il Mulino
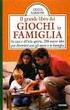 Mario Albertini Tutti gli scritti VI. 1971-1975 a cura di Nicoletta Mosconi Società editrice il Mulino Nota per la Giunta esecutiva del Mfe (20 dicembre 1975) Nella situazione politica c è un elemento
Mario Albertini Tutti gli scritti VI. 1971-1975 a cura di Nicoletta Mosconi Società editrice il Mulino Nota per la Giunta esecutiva del Mfe (20 dicembre 1975) Nella situazione politica c è un elemento
ITALIANO INDICATORE DISCIPLINARE
 ITALIANO INDICATORE DISCIPLINARE Sviluppare le abilità di base come l ascoltare, il parlare, il leggere e lo scrivere per maturare padronanza linguistica e consapevolezza comunicativa in ogni situazione,
ITALIANO INDICATORE DISCIPLINARE Sviluppare le abilità di base come l ascoltare, il parlare, il leggere e lo scrivere per maturare padronanza linguistica e consapevolezza comunicativa in ogni situazione,
Davidson. Verità e significato
 Davidson Verità e significato Teoria del significato Una teoria del significato soddisfacente deve spiegare come i significati degli enunciati dipendono dai significati delle parole Ma come si può costruire
Davidson Verità e significato Teoria del significato Una teoria del significato soddisfacente deve spiegare come i significati degli enunciati dipendono dai significati delle parole Ma come si può costruire
Informatica, Algoritmi, Linguaggi
 Elementi di Informatica e Applicazioni Numeriche T Informatica, Algoritmi, Linguaggi Cos'è l'informatica? Che cos'è l'informatica? Cos'è l'informatica? Che cos'è l'informatica? Dell'informatica possiamo
Elementi di Informatica e Applicazioni Numeriche T Informatica, Algoritmi, Linguaggi Cos'è l'informatica? Che cos'è l'informatica? Cos'è l'informatica? Che cos'è l'informatica? Dell'informatica possiamo
PERCORSO 2 Poligoni e triangoli
 PERCORSO 2 Poligoni e triangoli di Elena Ballarin Riferimento al testo base: A. Acquati, Mate.com, volume 1B, capitolo 4, pp. 132-177 Destinatari: scuola secondaria di primo grado, classe 1 a In classe
PERCORSO 2 Poligoni e triangoli di Elena Ballarin Riferimento al testo base: A. Acquati, Mate.com, volume 1B, capitolo 4, pp. 132-177 Destinatari: scuola secondaria di primo grado, classe 1 a In classe
5. Massimi, minimi e flessi
 1 5. Massimi, minimi e flessi Funzioni crescenti e decrescenti A questo punto dovremmo avere imparato come si calcolano le derivate di una funzione razionale fratta, ma dobbiamo capire in che modo queste
1 5. Massimi, minimi e flessi Funzioni crescenti e decrescenti A questo punto dovremmo avere imparato come si calcolano le derivate di una funzione razionale fratta, ma dobbiamo capire in che modo queste
ISTITUTO COMPRENSIVO ANAGNI 2 A.S. 2015/2016
 ISTITUTO COMPRENSIVO ANAGNI 2 A.S. 2015/2016 METODO ANALOGICO di CAMILLO BORTOLATO Teoria dell apprendimento intuitivo della matematica INTRODUZIONE COSA E IL METODO ANALOGICO? Il Metodo Analogico è basato
ISTITUTO COMPRENSIVO ANAGNI 2 A.S. 2015/2016 METODO ANALOGICO di CAMILLO BORTOLATO Teoria dell apprendimento intuitivo della matematica INTRODUZIONE COSA E IL METODO ANALOGICO? Il Metodo Analogico è basato
Schopenhauer Tra razionale e irrazionale
 Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?
Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?
LA MISURA DELLE SUPERFICI PIANE
 LA MISURA DELLE SUPERFICI PIANE Approccio al concetto di area Percorso didattico per la classe quarta della scuola elementare A cura del gruppo di ricerca sul curricolo verticale di matematica del CIDI
LA MISURA DELLE SUPERFICI PIANE Approccio al concetto di area Percorso didattico per la classe quarta della scuola elementare A cura del gruppo di ricerca sul curricolo verticale di matematica del CIDI
Il COMPORTAMENTO nell OTTICA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE COMPORTAMENTALE. Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Psicologia. Università di Parma
 Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Psicologia Università di Parma Il COMPORTAMENTO nell OTTICA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE COMPORTAMENTALE Dott.ssa Margherita Bonfatti Sabbioni Il caso di Lisa Lisa non
Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Psicologia Università di Parma Il COMPORTAMENTO nell OTTICA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE COMPORTAMENTALE Dott.ssa Margherita Bonfatti Sabbioni Il caso di Lisa Lisa non
Note sul Sudoku. Marco Liverani. Dicembre 2005
 Note sul Sudoku Marco Liverani Dicembre 2005 1 Introduzione Il gioco del Sudoku è un rompicapo giapponese che sta riscuotendo un successo notevole nel cosiddetto grande pubblico : pur essendo un gioco
Note sul Sudoku Marco Liverani Dicembre 2005 1 Introduzione Il gioco del Sudoku è un rompicapo giapponese che sta riscuotendo un successo notevole nel cosiddetto grande pubblico : pur essendo un gioco
STUDIO DELLE RADICI DI UNA EQUAZIONE ALGEBRICA DI TERZO GRADO A COEFFICIENTI REALI
 M. G. BUSATO STUDIO DELLE RADICI DI UNA EQUAZIONE ALGEBRICA DI TERZO GRADO A COEFFICIENTI REALI mgbstudio.net PAGINA INTENZIONALMENTE VUOTA SOMMARIO In questo scritto viene compiuto lo studio dettagliato
M. G. BUSATO STUDIO DELLE RADICI DI UNA EQUAZIONE ALGEBRICA DI TERZO GRADO A COEFFICIENTI REALI mgbstudio.net PAGINA INTENZIONALMENTE VUOTA SOMMARIO In questo scritto viene compiuto lo studio dettagliato
ALCUNI CENNI SUGLI INSIEMI
 ALCUNI CENNI SUGLI INSIEMI In Matematica il concetto di insieme è assunto come primitivo, cioè non si definisce. Considereremo quindi la nozione di insieme dal punto di vista intuitivo. Un insieme è quindi
ALCUNI CENNI SUGLI INSIEMI In Matematica il concetto di insieme è assunto come primitivo, cioè non si definisce. Considereremo quindi la nozione di insieme dal punto di vista intuitivo. Un insieme è quindi
Antropologia culturale - Prof.ssa Sabrina Tosi Cambini
 Antropologia culturale - Prof.ssa Sabrina Tosi Cambini Cultura, alcune definizioni * disposizione ad affrontare la realtà che si costituisce negli individui in quanto membri di una società storicamente
Antropologia culturale - Prof.ssa Sabrina Tosi Cambini Cultura, alcune definizioni * disposizione ad affrontare la realtà che si costituisce negli individui in quanto membri di una società storicamente
QUESTO MATERIALE VI AIUTA A CAPIRE COME COSTRUIRE IL VOSTRO RIASSUNTO.
 QUESTO MATERIALE VI AIUTA A CAPIRE COME COSTRUIRE IL VOSTRO RIASSUNTO. Il giorno dell esame: TEST DI LETTURA 1. guardate e cercate di capire il titolo del brano. 2. guardate la fonte (riportata in fondo):
QUESTO MATERIALE VI AIUTA A CAPIRE COME COSTRUIRE IL VOSTRO RIASSUNTO. Il giorno dell esame: TEST DI LETTURA 1. guardate e cercate di capire il titolo del brano. 2. guardate la fonte (riportata in fondo):
Il lascito di Massimo Severo Giannini. Giampaolo Rossi
 Il lascito di Massimo Severo Giannini Giampaolo Rossi La Newsletter dell Irpa (V, 2) contiene due contributi di Sabino Cassese su Massimo Severo Giannini. Sono l Introduzione e la Conclusione (alla quale
Il lascito di Massimo Severo Giannini Giampaolo Rossi La Newsletter dell Irpa (V, 2) contiene due contributi di Sabino Cassese su Massimo Severo Giannini. Sono l Introduzione e la Conclusione (alla quale
Filosofia o. Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia
 Filosofia o Storia della Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia della Filosofia! Utilità! È un po come per l interesse: della nostra materia non ha molto senso chiedere
Filosofia o Storia della Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia della Filosofia! Utilità! È un po come per l interesse: della nostra materia non ha molto senso chiedere
Un paio di esempi su serie e successioni di funzioni
 Un paio di esempi su serie e successioni di funzioni 29 novembre 2010 1 Successione di funzioni Ricordiamo innanzitutto un po di definizioni. Definizione 1. Una successione di funzioni è una corrispondenza
Un paio di esempi su serie e successioni di funzioni 29 novembre 2010 1 Successione di funzioni Ricordiamo innanzitutto un po di definizioni. Definizione 1. Una successione di funzioni è una corrispondenza
