Politica Sociale
|
|
|
- Gustavo Bianchini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Politica Sociale Step 2 - Storie di vita, sussistenza, benessere Matteo Villa matteo.villa@sp.unipi.it
2 1. Una giornata qualunque Come risolviamo il problema quotidiano della sussistenza? Chi / Cosa rende possibile, e in quale modo, la sussistenza e il benessere dell'uomo?
3 2. Forme dello scambio e di integrazione Karl Polanyi: tre forme di scambio e integrazione sociale ed economica reciprocità redistribuzione mercato
4 2. Forme dello scambio e di integrazione La reciprocità La reciprocità è intesa come movimento (o disponibilità) di beni e servizi fra attori disposti simmetricamente, senza un centro definito. la relazione è vincolata da norme e istituzioni (parentela, comunità, tradizioni religiose, altre forme di appartenenza), a carattere eventualmente mutualistico o clientelaristico.
5 2. Forme dello scambio e di integrazione La reciprocità (continua) La relazione ha un valore in sé, mentre il valore dell oggetto scambiato non è dato in sé, ma dipende dalle norme che definiscono il valore e le modalità del rapporto tra interazione e oggetto dell interazione. Rapporti di reciprocità si attualizzano in movimenti di dare e avere su sequenze di tempo differenziate, connesse alle norme condivise e alla presenza o assenza di mutualità. L appartenenza ad un più ampio sistema di aspettative e obbligazioni oltre la durata e il senso del singolo atto di scambio, è il criterio basilare di accesso a questa forma.
6 2. Forme dello scambio e di integrazione La redistribuzione la redistribuzione «designa un movimento verso un centro e poi di allontanamento da esso, indipendentemente dal fatto che gli oggetti siano spostati fisicamente o soltanto la loro disponibilità sia oggetto di mutamento» (Polanyi 1977 : 62). Si rende necessaria la presenza di un centro politico, consolidato e riconosciuto, che costituisca il luogo di raccolta e redistribuzione delle risorse (es. istituzioni di welfare).
7 2. Forme dello scambio e di integrazione La redistribuzione (continua) La struttura è definita da norme e leggi proclamate ai diversi livelli di centricità Il valore della relazione in sé, differisce in base alla natura del contesto sociale e ai significati dell appartenenza (dalla cittadinanza, alla appartenenza tribale). In tutti i casi, i legami attualizzano uno status di diritti e doveri che coniuga dimensione sociale, politica ed economica, secondo l ottica culturale prevalente nel sistema considerato.
8 2. Forme dello scambio e di integrazione Il mercato Lo scambio di mercato costituisce un movimento fra una qualsiasi coppia di punti dispersi o casuali del sistema. Gli scambi puri di mercato non producono legami: si attualizzano sulla base dell interesse razionale rispetto allo scopo esaurendo i significati dello scambio nella contingenza del medesimo e nell esito della transazione, (valore monetario). Il contesto (norme e strutture) non è ritenuto influente La norma regolatrice è data dal rapporto tra domanda e offerta Il tempo tende a zero (contingenza dello scambio), e il suo scorrere è una punteggiatura di eventi casuali senza sequenze
9 3. Storie di vita di disoccupati di lungo periodo Urbex. Spatial Dimension of Urban Social Exclusion and Integration Fonti: A. Andreotti, Y. Kazepov Y. (eds.), Spatial Dimension of Urban Social Exclusion and Integration. A European Comparison: The Case of Milan, EU - Fourth RTD Framework Programme Targeted Socio-Economic Research (TSER), AME Amsterdam Study Centre for the Metropolitan Environment, 2001, downloadable at: M. Villa, Rappresentazioni del locale. Comunità, esclusione, welfare, Volume per i corsisti del Master in Promozione della Partecipazione Sociale Università di Urbino - Facoltà di Sociologia, l Asterisco Copisteria, Urbino, giugno
10 Mercato Redistribuzione Reciprocità Spazio Lavoro Servizi pubblici Familiari Quartiere Consumi Servizi del privato sociale Vicini e amici Città Source: Andreotti & Kazepov 2001
11 Private No-Profit Services Public Services and Provisions Case 24 Labour Consumption Household Private No-Profit Services Public Services and Provisions Case 34 Labour Consumption Household Forme di attivazione del network (esempi) Source: Andreotti & Kazepov 2001 Villa 2003 City Neighbours and Friends City Neighbours and Friends Neighbourhood Neighbourhood Case 26 Case 33 Labour 10 Labour 10 Private No-Profit Services 8 6 Consumption Private No-Profit Services 8 6 Consumption Public Services and Provisions 0 Household Public Services and Provisions 0 Household City Neighbourhood Private No-Profit Services Public Services and Provisions Neighbours and Friends Case 28 Labour Consumption Household City Neighbourhood Public Services and Provisions Neighbours and Friends Private No-Profit Services valori medi Totali Labour Valori medi Consumption Household City Neighbours and Friends City 11 Neighbours and Friends Neighbourhood Neighbourhood
12 Valori medi nelle strategie dei disoccupati di lungo periodo (fonte: elaborazione da dati Urbex (Andreotti & Kazepov, 2001)
13 Forme di attivazione del network (confronti fra target group) Source: Villa 2003 LT Unemployed Lone Mother Immigrants Labour 3,44 6,73 4,95 Consumption 3,78 6,82 3,32 Household 4,61 6,68 2,89 Neighbours and Friends 4,22 5,18 3,26 Neighbourhood 3,61 6,18 2,74 City 4,17 5,18 3,74 Public Services and 7,17 6,00 4,16 Provisions Private No-Profit Services 4,78 4,55 4,68
14 Source: Villa 2003 Mutazioni nelle forme di attivazione del network
15 4. Esercizio: le storie di vita File per realizzare l'esercizio scaricabili da o_-_storie_di_vita_ zip (cartella compressa.zip) Restituzione esercizi
16 Alcune considerazioni dall'esercizio Domande e considerazioni. Aspetti da discutere e da riprendere da: Storie di vita vostre Storie di vita Ricerca Urbex Storie di vita Ricerca Giovani Storie di vita / Contesti / Forme di integrazione
17 5. Alcuni concetti e temi essenziali 5.1 Economia e società, economia formale e sostanziale, forme di integrazione (Polanyi) 5.2 Inclusione /Esclusione; Benessere e sussistenza (Simmel, Polanyi) 5.3 Appartenenza, Interdipendenza, Autonomia (Bateson, Simmel, Polanyi) 5.4 Welfare, welfare state, welfare system (Polanyi, Manuale)
18 5.1 Economia e società Definizione di economia formale (Robbins 1947): «L economia è la scienza che studia la condotta umana come una relazione tra scopi e mezzi scarsi, applicabili a usi alternativi» Polanyi (1977): nessuna società può esistere senza possedere un qualche tipo di economia sostanziale implicata dal fatto che l uomo dipende per la sua sopravvivenza dai processi di interazione con i suoi simili e con la natura. stabilire un uguaglianza fra l economia umana in generale e la sua forma di mercato costituisce un errore logico, una palese fallacia. L identificazione con il mercato implica un significato del termine economico derivante dalla natura logica della relazione mezzi-fini. Questa veicola una nozione estranea al processo complessivo di cui essa stessa fa parte, che rinuncia a osservare l'interdipendenza tra fenomeni e leggi della natura e fenomeni storici.
19 5.1 Economia e società 2 definizioni di economico (Polanyi, 1977) SOSTANZIALE FORMALE Si riferisce all interscambio tra il soggetto e il suo ambiente naturale e sociale. Si riferisce alla scelta tra diversi impieghi cui destinare i mezzi (scarsi). Deriva dal fatto che l uomo dipende per la sua sopravvivenza dalla natura e dai suoi simili. Deriva dal carattere logico del rapporto mezzi fini (economizzare).
20 5.1 Economia e società La fallacia economicista (Polanyi, 1977) «stabilire un uguaglianza fra l economia umana in generale e la sua forma di mercato» (Polanyi, 1977 : 28) Per cui appare necessario concepire «una teoria generale dell economia nella società, libera dalle preponderanti influenze della mentalità di mercato della nostra epoca» (Pearson, 1977 : XXXIII)
21 6. La prospettiva ecologica
22 Storie di vita, cioè? C'è un a priori che andrebbe per lo meno considerato quando trattiamo qualcosa di vitale: la storicità, la dinamicità, l'evoluzione e il cambiamento di ciò che Bateson (1972) chiamava la creatura, ovvero il mondo delle cose che in natura vivono, e cioè crescono, apprendono, si evolvono [...] il mondo creaturale dei processi mentali (Conserva 1996). Ogni forma di vita costituisce storie e intrecci di storie attraverso le relazioni e i loro cambiamenti nel corso del tempo a vari livelli, con tanto maggiore complessità quanto più la forma di vita in questione è dotata di capacità riflessive e, quindi, di percezione, descrizione, attribuzione e costruzione di senso. Cosicché ogni attore o sistema osservato è anche sistema osservante. Fonte: Villa 2012
23 Il gioco del croquet Alice pensava che in vita sua non aveva mai veduto un terreno più curioso per giocare il croquet; era tutto a solchi e zolle; le palle erano ricci, i mazzapicchi erano fenicotteri vivi, e gli archi erano soldati vivi, che si dovevano curvare e reggere sulle mani e sui piedi. Alice s Adventures In Wonderland Lewis Carroll
24 Estratto da: Gregory Bateson, Verso un'ecologia della mente, Adelphi, Milano, Prima parte I metaloghi, metalogo Perché le cose hanno contorni? P. Tanto per cambiare, pensiamo a un vero e proprio pasticcio concreto, per vedere se serve. Ti ricordi la partita di croquet in Alice nel paese delle meraviglie? F. Sì... coi fenicotteri? P. SI, quella. F. E cogli istrici al posto delle palle? P. No, porcospini. Erano porcospini. Non ci sono istrici in Inghilterra. F. Ah, era in Inghilterra, papà? Non lo sapevo. P. Certo che era in Inghilterra. In America non ci sono neppure duchesse. F. Ma c'è la duchessa di Windsor, papà. P. Sì, ma non ha aculei, non come un vero istrice. F. Continua con Alice, papà, e non dire sciocchezze. P. Sì, stavamo parlando dei fenicotteri. Il fatto è che l'uomo che scrisse Alice pensava alle stesse cose cui pensiamo noi. E si divertì con la piccola Alice immaginando una partita a croquet che fosse tutto un pasticcio, un assoluto pasticcio. Così stabilì che si dovessero usare fenicotteri invece di mazze, perché i fenicotteri potevano piegare il collo e così il giocatore non avrebbe saputo se la sua mazza avrebbe colpito la palla né come. F. D'altra parte la palla poteva andarsene per conto suo, perché era un porcospino. P. Certo. Così ogni cosa è talmente ingarbugliata che nessuno ha la minima idea di ciò che può accadere.
25 (continua) F. E poi anche gli archi se ne andavano in giro, perché erano soldati. P. Certo.., ogni cosa poteva muoversi e nessuno poteva dire come si sarebbe mossa. F. Per far questo pasticcio assoluto era necessario che ogni cosa fosse viva? P. No... avrebbe potuto fare un pasticcio... no, forse hai ragione. Ecco, questo è interessante. Sì, sì, doveva essere proprio così. Aspetta un momento. È curioso, ma hai ragione. Perché se avesse creato il pasticcio in un altro modo qualunque, i giocatori avrebbero potuto imparare a cavarsela. Cioè, se il campo di croquet fosse stato accidentato, o se le palle avessero avuto una forma bizzarra, o se le teste delle mazze fossero state semplicemente oscillanti, allora i giocatori avrebbero potuto lo stesso imparare e il gioco sarebbe stato solo più difficile, ma non impossibile. Ma una volta che ci si fanno entrare esseri viventi, diventa impossibile. Questo non me l'aspettavo. F. Davvero, papà? Io si. A me sembra naturale. P. Naturale? Certo.., abbastanza naturale. Ma non mi sarei aspettato che le cose andassero a quel modo. F. Perché no? Invece è proprio quello che io mi sarei aspettata. P. Sì. Ma la cosa che non mi sarei aspettato è questa. Che gli animali, che sono essi stessi in grado di prevedere un poco le cose, e di agire sulla base di ciò che pensano che stia per accadere - un gatto può acchiappare un topo saltando proprio sul punto dove il topo probabilmente sarà quando il gatto avrà completato il salto - ma è proprio il fatto che gli animali sono capaci di prevedere e imparare che li rende le uniche cose veramente imprevedibili del mondo. E pensare che noi facciamo leggi come se le persone fossero del tutto regolari e prevedibili! F. O forse si fanno le leggi proprio perché le persone non sono prevedibili e quelli che fanno le leggi vorrebbero che gli altri fossero prevedibili? P. Sì, forse è così.
26 Il gioco del croquet Rappresenta una metafora di una concezione del welfare come sistema vivente (che cambia, si evolve e apprende, ha caratteristiche di irreversibilità) cognitivo (dotato di riflessività e autoreferenza) ecologico (le cui parti, i processi e gli attori sono interdipendenti tra loro e con l'ambiente) "i sistemi puniscono ogni specie che sia tanto stolta da non andare d'accordo con la propria ecologia" (Bateson 1972).
27 Prospettiva ecologia Storie di vita / contesti / economia Sistemi di interdipendenza Sistemi vitali, cognitivi, ecologici Social Investment State, Ecological State
28 Grazie per l'attenzione Arrivederci alla prossima lezione
Sistemi di welfare comparati
 Corso di Laurea L-39 Sistemi di welfare comparati La sussistenza dell'uomo, la questione sociale e le origini del welfare state L2 - Storie di vita 24 febbraio 3, 10 marzo 2017 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it
Corso di Laurea L-39 Sistemi di welfare comparati La sussistenza dell'uomo, la questione sociale e le origini del welfare state L2 - Storie di vita 24 febbraio 3, 10 marzo 2017 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it
Sistemi di welfare comparati
 Corsi di Laurea L-16 L-40 Sistemi di welfare comparati L2 Storie di vita 17 e 25 febbraio 2016 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche Research LAB - LaRISS
Corsi di Laurea L-16 L-40 Sistemi di welfare comparati L2 Storie di vita 17 e 25 febbraio 2016 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche Research LAB - LaRISS
Sociologia del Lavoro e dell'organizzazione
 Corsi di Laurea LM-63 LM-87/88 Sociologia del Lavoro e dell'organizzazione L2 Alcuni presupposti di sociologia economica 26 febbraio 2016 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento
Corsi di Laurea LM-63 LM-87/88 Sociologia del Lavoro e dell'organizzazione L2 Alcuni presupposti di sociologia economica 26 febbraio 2016 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento
Sociologia del Lavoro
 Corsi di Laurea L-16 L-40 Sociologia del Lavoro L2 Lavoro e industrializzazione: spunti di sociologia economica 29 febbraio 2016 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento di Scienze
Corsi di Laurea L-16 L-40 Sociologia del Lavoro L2 Lavoro e industrializzazione: spunti di sociologia economica 29 febbraio 2016 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento di Scienze
Sociologia del Lavoro
 Corso di Laurea L-40 Sociologia del Lavoro L2 Lavoro e industrializzazione: spunti di sociologia economica II parte: la critica al paradigma di mercato 27-29 febbraio 2017 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it
Corso di Laurea L-40 Sociologia del Lavoro L2 Lavoro e industrializzazione: spunti di sociologia economica II parte: la critica al paradigma di mercato 27-29 febbraio 2017 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it
Sociologia del Lavoro
 Corso di Laurea L-40 Sociologia del Lavoro L1 Introduzione al corso 20 febbraio 2017 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche Research LAB - LaRISS - http://lariss.sp.unipi.it/index.php/en/
Corso di Laurea L-40 Sociologia del Lavoro L1 Introduzione al corso 20 febbraio 2017 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche Research LAB - LaRISS - http://lariss.sp.unipi.it/index.php/en/
Sociologia del Lavoro e dell'organizzazione
 Corsi di Laurea LM-63 LM-87/88 Sociologia del Lavoro e dell'organizzazione L1 Introduzione al corso 16 febbraio 2016 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche
Corsi di Laurea LM-63 LM-87/88 Sociologia del Lavoro e dell'organizzazione L1 Introduzione al corso 16 febbraio 2016 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche
Sistemi di welfare comparati
 Corso di Laurea L-39 Sistemi di welfare comparati L1 Introduzione al corso 24 febbraio 2017 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche Research LAB - LaRISS
Corso di Laurea L-39 Sistemi di welfare comparati L1 Introduzione al corso 24 febbraio 2017 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche Research LAB - LaRISS
Università degli Studi di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
 Università degli Studi di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Matteo Villa matteo.villa@sp.unipi.it Rachele Benedetti rachele.benedetti@sp.unipi.it 3 domande 1. Generalmente si promuovono
Università degli Studi di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Matteo Villa matteo.villa@sp.unipi.it Rachele Benedetti rachele.benedetti@sp.unipi.it 3 domande 1. Generalmente si promuovono
Sociologia del Lavoro e dell'organizzazione
 Corsi di Laurea LM-63 LM-87/88 Sociologia del Lavoro e dell'organizzazione Opzione 3/1 Ecologia e processi organizzativi 22 aprile 2016 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento
Corsi di Laurea LM-63 LM-87/88 Sociologia del Lavoro e dell'organizzazione Opzione 3/1 Ecologia e processi organizzativi 22 aprile 2016 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Università di Pisa Dipartimento
Povertà. 24 settembre. Approcci teorici ed empirici. Concetti e teorie. Diffusione e distribuzione territoriale della povertà: approcci e indicatori
 Guido Cavalca, Università di Milano Bicocca Povertà 24 settembre Approcci teorici ed empirici Concetti e teorie Diffusione e distribuzione territoriale della povertà: approcci e indicatori Domande di partenza
Guido Cavalca, Università di Milano Bicocca Povertà 24 settembre Approcci teorici ed empirici Concetti e teorie Diffusione e distribuzione territoriale della povertà: approcci e indicatori Domande di partenza
Politica Sociale
 Politica Sociale 2013-14 L4 / Caratteristiche fondamentali dei sistemi di Welfare attori, logiche, allocazione delle risorse, politiche Rachele Benedetti rachele.benedetti@sp.unipi.it Giulia Cordella giulia.cordella@gmail.com
Politica Sociale 2013-14 L4 / Caratteristiche fondamentali dei sistemi di Welfare attori, logiche, allocazione delle risorse, politiche Rachele Benedetti rachele.benedetti@sp.unipi.it Giulia Cordella giulia.cordella@gmail.com
Pianificazione e contesto per la sopravvivenza d impresa
 Lezioni 4-5 Pianificazione e contesto per la sopravvivenza d impresa d prof. ssa Clara Bassano Corso di Economia e Gestione delle Imprese A.A. 2005-2006 L approccio alla pianificazione Pianificare implica
Lezioni 4-5 Pianificazione e contesto per la sopravvivenza d impresa d prof. ssa Clara Bassano Corso di Economia e Gestione delle Imprese A.A. 2005-2006 L approccio alla pianificazione Pianificare implica
Dispensa n. 2 Argomenti trattati nelle Lezioni del 10 e 12 Marzo Il sistema dei servizi alla persona e le grandi riforme dagli anni 80 a oggi a
 1 Dispensa n. 2 Argomenti trattati nelle Lezioni del 10 e 12 Marzo 2009 Il sistema dei servizi alla persona e le grandi riforme dagli anni 80 a oggi a cura di Paolo Ferrario Questa dispensa si struttura
1 Dispensa n. 2 Argomenti trattati nelle Lezioni del 10 e 12 Marzo 2009 Il sistema dei servizi alla persona e le grandi riforme dagli anni 80 a oggi a cura di Paolo Ferrario Questa dispensa si struttura
La comunità territoriale
 La comunità territoriale Se mai può esistere una comunità nel mondo degli individui, può essere soltanto una comunità intessuta di comune e reciproco interesse ( Bauman (Z. CRITICITA disuguaglianze di
La comunità territoriale Se mai può esistere una comunità nel mondo degli individui, può essere soltanto una comunità intessuta di comune e reciproco interesse ( Bauman (Z. CRITICITA disuguaglianze di
L impresa non è solo quella che conosciamo ma quella di Cristoforo Colombo (Canzone Guccini) che ha in sé:
 Riflessioni sull essere impresa L impresa non è solo quella che conosciamo ma quella di Cristoforo Colombo (Canzone Guccini) che ha in sé: sogno,idea, progetto, azione, difficoltà, tenacia, cambiamento,
Riflessioni sull essere impresa L impresa non è solo quella che conosciamo ma quella di Cristoforo Colombo (Canzone Guccini) che ha in sé: sogno,idea, progetto, azione, difficoltà, tenacia, cambiamento,
Sociologia del Lavoro e dell'organizzazione
 Corsi di Laurea LM 59, 63 87-88 Sociologia del Lavoro e dell'organizzazione L1 Introduzione al corso 20-23 febbraio 2017 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Giulia Colombini giulia.colombini@for.unipi.it
Corsi di Laurea LM 59, 63 87-88 Sociologia del Lavoro e dell'organizzazione L1 Introduzione al corso 20-23 febbraio 2017 Matteo Villa matteo.villa@unipi.it Giulia Colombini giulia.colombini@for.unipi.it
Io ho trovato il progetto molto interessante specialmente le simmetrie e i numeri in natura perché non avevo mai pensato né osservato che un animale
 Rinnova mente è un attività che associa due materie, matematica e scienze, con un approccio matematico-ambientale. Abbiamo parlato di simmetria nel mondo della natura, di strisce, tassellazioni, spirali,
Rinnova mente è un attività che associa due materie, matematica e scienze, con un approccio matematico-ambientale. Abbiamo parlato di simmetria nel mondo della natura, di strisce, tassellazioni, spirali,
autismo e disturbi generalizzati di sviluppo Istituto Skinner Napoli Docente Mario D Ambrosio
 autismo e disturbi generalizzati di sviluppo Istituto Skinner Napoli Docente Mario D Ambrosio Criteri diagnostici per il disturbo autistico (DSM IV) Compromissione qualitativa dell interazione sociale
autismo e disturbi generalizzati di sviluppo Istituto Skinner Napoli Docente Mario D Ambrosio Criteri diagnostici per il disturbo autistico (DSM IV) Compromissione qualitativa dell interazione sociale
Definizione, Finalità e Metodo della disciplina
 Definizione, Finalità e Metodo della disciplina Parte Prima: Problemi e Intuizioni (30 ) Parte Seconda: Approfondimenti tecnici (60 ) Parte Terza: Applicazioni e verifica (30 ) Lezione 1: Parte Prima Problemi
Definizione, Finalità e Metodo della disciplina Parte Prima: Problemi e Intuizioni (30 ) Parte Seconda: Approfondimenti tecnici (60 ) Parte Terza: Applicazioni e verifica (30 ) Lezione 1: Parte Prima Problemi
Due definizioni di economia
 ELEMENTI DI SOCIOLOGIA II Reciprocità e redistribuzione Due definizioni di economia in senso sostanziale: l insieme delle attività orientate alla produzione, alla distribuzione e al consumo di beni e servizi
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA II Reciprocità e redistribuzione Due definizioni di economia in senso sostanziale: l insieme delle attività orientate alla produzione, alla distribuzione e al consumo di beni e servizi
Tre significati di politica
 Tre significati di politica Politica come agire politico: Politics Parlare di politica Fare una battaglia politica Buttarla in politica Politica come sfera/sistema politico: Polity Scendere in politica
Tre significati di politica Politica come agire politico: Politics Parlare di politica Fare una battaglia politica Buttarla in politica Politica come sfera/sistema politico: Polity Scendere in politica
La conoscenza per relazioni
 CORSO DI SOCIOLOGIA GENERALE La conoscenza per relazioni Marco Ingrosso Conoscenza: cosa si intende? La conoscenza è un processo di esplorazione e osservazione del mondo volto a comprenderlo al fine di
CORSO DI SOCIOLOGIA GENERALE La conoscenza per relazioni Marco Ingrosso Conoscenza: cosa si intende? La conoscenza è un processo di esplorazione e osservazione del mondo volto a comprenderlo al fine di
Modelli comunicativi e micro-macro link
 Modelli comunicativi e micro-macro link Le nuove tecnologie modificano i profili attuali della comunicazione e del sociale È necessario integrarle nelle teorie comunicative Nell analisi dei rapporti fra
Modelli comunicativi e micro-macro link Le nuove tecnologie modificano i profili attuali della comunicazione e del sociale È necessario integrarle nelle teorie comunicative Nell analisi dei rapporti fra
IL LAVORO SOCIALE NEL SETTORE DELL INFANZIA E DELLA FAMIGLIA: VERSO NUOVI SAPERI FAMIGLIE : QUALI INTERVENTI
 IL LAVORO SOCIALE NEL SETTORE DELL INFANZIA E DELLA FAMIGLIA: VERSO NUOVI SAPERI FAMIGLIE : QUALI INTERVENTI LE EMOZIONI IN GIOCO La relazione professionale LA RELAZIONE PROFESSIONALE Non vediamo le relazioni
IL LAVORO SOCIALE NEL SETTORE DELL INFANZIA E DELLA FAMIGLIA: VERSO NUOVI SAPERI FAMIGLIE : QUALI INTERVENTI LE EMOZIONI IN GIOCO La relazione professionale LA RELAZIONE PROFESSIONALE Non vediamo le relazioni
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA II
 ELEMENTI DI SOCIOLOGIA II Funzioni della sociologia in generale e per gli AS COSA VUOL DIRE PENSARE SOCIOLOGICO a) Non ci sono solo individui, c è la società b) Esistono le istituzioni, le norme c) Apparteniamo
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA II Funzioni della sociologia in generale e per gli AS COSA VUOL DIRE PENSARE SOCIOLOGICO a) Non ci sono solo individui, c è la società b) Esistono le istituzioni, le norme c) Apparteniamo
PERCORSI DI PARTECIPAZIONE SOCIALE NEL PIANO REGOLATORE SOCIALE DEL COMUNE DI ROMA. Claudia Chiarolanza Sapienza- Università di Roma
 PERCORSI DI PARTECIPAZIONE SOCIALE NEL PIANO REGOLATORE SOCIALE DEL COMUNE DI ROMA Claudia Chiarolanza Sapienza- Università di Roma PARTECIPAZIONE SOCIALE L interesse per la partecipazione sociale deriva
PERCORSI DI PARTECIPAZIONE SOCIALE NEL PIANO REGOLATORE SOCIALE DEL COMUNE DI ROMA Claudia Chiarolanza Sapienza- Università di Roma PARTECIPAZIONE SOCIALE L interesse per la partecipazione sociale deriva
IL COSTRUTTO DI APPRENDIMENTO SITUATO
 APPRENDIMENTO SITUATO SITUATED LEARNING PROF. EZIO DEL GOTTARDO Indice 1 IL COSTRUTTO DI APPRENDIMENTO SITUATO ----------------------------------------------------------------- 3 2 LA PARTECIPAZIONE PERIFERICA
APPRENDIMENTO SITUATO SITUATED LEARNING PROF. EZIO DEL GOTTARDO Indice 1 IL COSTRUTTO DI APPRENDIMENTO SITUATO ----------------------------------------------------------------- 3 2 LA PARTECIPAZIONE PERIFERICA
La comunità territoriale
 La comunità territoriale Se mai può esistere una comunità nel mondo degli individui, può essere soltanto una comunità intessuta di comune e reciproco interesse (Z. Bauman) COMUNITA Il più piccolo gruppo
La comunità territoriale Se mai può esistere una comunità nel mondo degli individui, può essere soltanto una comunità intessuta di comune e reciproco interesse (Z. Bauman) COMUNITA Il più piccolo gruppo
La matematica come forma di comunicazione PRIN
 La matematica come forma di comunicazione PRIN 2009-2011 Introduzione Quanto è chiara l idea di comunicazione matematica? Possiamo distinguere il discorso matematico da tutti gli altri concentrandoci soltanto
La matematica come forma di comunicazione PRIN 2009-2011 Introduzione Quanto è chiara l idea di comunicazione matematica? Possiamo distinguere il discorso matematico da tutti gli altri concentrandoci soltanto
azione di Maria Chiara Michelini
 Apprendimenti e competenze: dalla condivisione alla certificazione RIFLESSIVITA E STRUMENTI nella ricerca-azione azione di Maria Chiara Michelini mariachiara.michelini@uniurb.it Ufficio Scolastico Provinciale
Apprendimenti e competenze: dalla condivisione alla certificazione RIFLESSIVITA E STRUMENTI nella ricerca-azione azione di Maria Chiara Michelini mariachiara.michelini@uniurb.it Ufficio Scolastico Provinciale
Le economie esterne marshalliane
 Le economie esterne marshalliane Marshall (1842-1924): fenomeni complessi economie esterne di localizzazione (o locali) distinzione fondamentale economie interne economie esterne nuova unità di analisi:
Le economie esterne marshalliane Marshall (1842-1924): fenomeni complessi economie esterne di localizzazione (o locali) distinzione fondamentale economie interne economie esterne nuova unità di analisi:
Istruzione e formazione per la cittadinanza attiva, contro le disuguaglianze SEMINARIO DEL GRUPPO DI LAVORO DEI DOCENTI DI SCIENZE UMANE
 Istruzione e formazione per la cittadinanza attiva, contro le disuguaglianze SEMINARIO DEL GRUPPO DI LAVORO DEI DOCENTI DI SCIENZE UMANE ROMA 16-17 Marzo Trattazione di temi - problemi disciplinari nella
Istruzione e formazione per la cittadinanza attiva, contro le disuguaglianze SEMINARIO DEL GRUPPO DI LAVORO DEI DOCENTI DI SCIENZE UMANE ROMA 16-17 Marzo Trattazione di temi - problemi disciplinari nella
Teorie organizzative, relazioni inter-organizzative e ambiente
 Teorie organizzative, relazioni inter-organizzative e ambiente Lo studio delle organizzazioni come disciplina Negli anni 60 si assiste ad un primo tentativo di raggruppamento di riflessioni organizzative
Teorie organizzative, relazioni inter-organizzative e ambiente Lo studio delle organizzazioni come disciplina Negli anni 60 si assiste ad un primo tentativo di raggruppamento di riflessioni organizzative
Primi esiti della ricerca sul benessere e sugli stili di vita di preadolescenti e adolescenti Donata Bianchi Responsabile Servizio ricerca e
 Primi esiti della ricerca sul benessere e sugli stili di vita di preadolescenti e adolescenti Donata Bianchi Responsabile Servizio ricerca e monitoraggio Istituto degli Innocenti Contenuti Premessa e contesto
Primi esiti della ricerca sul benessere e sugli stili di vita di preadolescenti e adolescenti Donata Bianchi Responsabile Servizio ricerca e monitoraggio Istituto degli Innocenti Contenuti Premessa e contesto
HEGEL Fenomenologia dello spirito. Stoccarda Berlino 1831
 HEGEL Fenomenologia dello spirito Stoccarda 1770- Berlino 1831 L assoluto e le parti Le singole cose sono parti o manifestazioni dell assoluto che è inteso come un organismo unitario. Queste parti non
HEGEL Fenomenologia dello spirito Stoccarda 1770- Berlino 1831 L assoluto e le parti Le singole cose sono parti o manifestazioni dell assoluto che è inteso come un organismo unitario. Queste parti non
CIBERNETICA E SISTEMA
 CIBERNETICA E SISTEMA Dott. Antonio Caruso, psicologo psicoterapeuta direttore del Centro Panta Rei 1 Teoria di Campo (K. Lewin) Realtà psichica come sistema dinamico che comprende la persona e il suo
CIBERNETICA E SISTEMA Dott. Antonio Caruso, psicologo psicoterapeuta direttore del Centro Panta Rei 1 Teoria di Campo (K. Lewin) Realtà psichica come sistema dinamico che comprende la persona e il suo
LUCIANO GALLINO L'ATTORE SOCIALE BIOLOGIA, CULTURA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE SCIENTIFICA,J!INAUDI
 LUCIANO GALLINO L'ATTORE SOCIALE BIOLOGIA, CULTURA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE " SCIENTIFICA,J!INAUDI Ciascuno di noi è un attore sociale in quanto agisce il piu delle volte in risposta a norme e attese,
LUCIANO GALLINO L'ATTORE SOCIALE BIOLOGIA, CULTURA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE " SCIENTIFICA,J!INAUDI Ciascuno di noi è un attore sociale in quanto agisce il piu delle volte in risposta a norme e attese,
I LIVELLI DELLA CONOSCENZA. Francesco Maria Olivieri
 I LIVELLI DELLA CONOSCENZA Francesco Maria Olivieri Indice 1. APPROCCIO SISTEMICO ----------------------------------------------------------------------- 3 2. SISTEMI CHIUSI VS SISTEMI APERTI -----------------------------------------------------
I LIVELLI DELLA CONOSCENZA Francesco Maria Olivieri Indice 1. APPROCCIO SISTEMICO ----------------------------------------------------------------------- 3 2. SISTEMI CHIUSI VS SISTEMI APERTI -----------------------------------------------------
Attori sociali. Individuali. Collettivi. Agire sociale interazione aggregazione. Comportamenti collettivi Agire strutturato
 La sociologia si interessa dell individuo ma non dell individualità Attori sociali Psicologia: Dinamiche interne Comportamenti esterni degli individui nei rapporti sociali Rilevanza statistica Si può guardare
La sociologia si interessa dell individuo ma non dell individualità Attori sociali Psicologia: Dinamiche interne Comportamenti esterni degli individui nei rapporti sociali Rilevanza statistica Si può guardare
Mediare nei contesti complessi è costruire CULTURA DI COMUNITA!
 SAF SCUOLA ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Mediare nei contesti complessi è costruire CULTURA DI COMUNITA dr.ssa Lalla Facco mediatrice di comunità Milano, 20 ottobre 2014 Immagini relative a immagini comunità
SAF SCUOLA ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Mediare nei contesti complessi è costruire CULTURA DI COMUNITA dr.ssa Lalla Facco mediatrice di comunità Milano, 20 ottobre 2014 Immagini relative a immagini comunità
Altro generalizzato. Le prescrizioni diventeranno norme interiorizzate. Sanzioni positive di tipo affettivo. Tanto +
 Altro generalizzato + Sanzioni positive di tipo affettivo Tanto + Le prescrizioni diventeranno norme interiorizzate ALTRO GENERALIZZATO Processo di decentramento, posto alla base dello sviluppo intellettuale
Altro generalizzato + Sanzioni positive di tipo affettivo Tanto + Le prescrizioni diventeranno norme interiorizzate ALTRO GENERALIZZATO Processo di decentramento, posto alla base dello sviluppo intellettuale
L idea di cultura nella tradizione sociologica
 L idea di cultura nella tradizione sociologica Scemo e più Scemo, 1994 L idea di cultura in due tradizioni sociologiche di ricerca Émile Durkheim (1858 1917) Max Weber (1864 1920) La scuola Francese La
L idea di cultura nella tradizione sociologica Scemo e più Scemo, 1994 L idea di cultura in due tradizioni sociologiche di ricerca Émile Durkheim (1858 1917) Max Weber (1864 1920) La scuola Francese La
LABORATORIO DI TIROCINIO 3 CONTESTI ORGANIZZATIVI DEL LAVORO SOCIALE
 LABORATORIO DI TIROCINIO 3 CONTESTI ORGANIZZATIVI DEL LAVORO SOCIALE Organizzazione e contesti organizzativi Unical 15 Ottobre 2015 Programma della giornata - Presentazione laboratorio (5 minuti) - Interazione
LABORATORIO DI TIROCINIO 3 CONTESTI ORGANIZZATIVI DEL LAVORO SOCIALE Organizzazione e contesti organizzativi Unical 15 Ottobre 2015 Programma della giornata - Presentazione laboratorio (5 minuti) - Interazione
Cosa sono le organizzazioni?
 Cosa sono le organizzazioni? è Pensare alle organizzazioni come entità a se stanti, è concettualmente improprio! è Fa dimenticare che ad agire sono gli individui e i gruppi L ORGANIZZAZIONE Concetto Risultato
Cosa sono le organizzazioni? è Pensare alle organizzazioni come entità a se stanti, è concettualmente improprio! è Fa dimenticare che ad agire sono gli individui e i gruppi L ORGANIZZAZIONE Concetto Risultato
Approcci alla valutazione delle politiche sociali. Giuseppe Moro Università degli studi di Bari A. Moro
 Approcci alla valutazione delle politiche sociali Giuseppe Moro Università degli studi di Bari A. Moro Oggetti Il progetto può essere considerato l elemento base e non divisibile dell azione pubblica la
Approcci alla valutazione delle politiche sociali Giuseppe Moro Università degli studi di Bari A. Moro Oggetti Il progetto può essere considerato l elemento base e non divisibile dell azione pubblica la
TRATTO DA: DARIO I., CAMEROTTI S. (2005), IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PROGETTO DI VITA, TRENTO, ERICKSON
 TRATTO DA: DARIO I., CAMEROTTI S. (2005), IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PROGETTO DI VITA, TRENTO, ERICKSON SINTESI ED ADATTAMENTO DEL SECONDO CAPITOLO: IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E IL PROGETTO
TRATTO DA: DARIO I., CAMEROTTI S. (2005), IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PROGETTO DI VITA, TRENTO, ERICKSON SINTESI ED ADATTAMENTO DEL SECONDO CAPITOLO: IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E IL PROGETTO
Cosa sono le scienze umane. Il sapere antropologico
 Parte Prima Cosa sono le scienze umane Il sapere antropologico PRIMA tappa / Che cos è l antropologia culturale............................................. 4 SECONDA tappa / I metodi dell antropologia
Parte Prima Cosa sono le scienze umane Il sapere antropologico PRIMA tappa / Che cos è l antropologia culturale............................................. 4 SECONDA tappa / I metodi dell antropologia
Migrazioni e mutamenti sul piano delle dinamiche familiari
 Migrazioni e mutamenti sul piano delle dinamiche familiari 1. Processo di incorporazione dei migranti nella società di arrivo 2. Fattori che spingono gli individui ad espatriare a.paradigma economico individualista
Migrazioni e mutamenti sul piano delle dinamiche familiari 1. Processo di incorporazione dei migranti nella società di arrivo 2. Fattori che spingono gli individui ad espatriare a.paradigma economico individualista
Il progetto emergente. Il project management in contesti di complessità
 Il progetto emergente Il project management in contesti di complessità CIAgroup_20101115_Progetto Emergente-PM_BOZZA_Tarantino 2 Abbiamo bisogno di un modo nuovo di pensare per risolvere i problemi causati
Il progetto emergente Il project management in contesti di complessità CIAgroup_20101115_Progetto Emergente-PM_BOZZA_Tarantino 2 Abbiamo bisogno di un modo nuovo di pensare per risolvere i problemi causati
COME VEDIAMO GLI OGGETTI?
 Percezione visiva COME VEDIAMO GLI OGGETTI? CAPITOLO 5 «IL COLORE DELLA LUNA» Paola BRESSAN Ed. Laterza Dott.ssa Stefania Pighin - stefania.pighin@unitn.it Guardare significa vedere? - Secondo l accezione
Percezione visiva COME VEDIAMO GLI OGGETTI? CAPITOLO 5 «IL COLORE DELLA LUNA» Paola BRESSAN Ed. Laterza Dott.ssa Stefania Pighin - stefania.pighin@unitn.it Guardare significa vedere? - Secondo l accezione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Anno accademico 2015-2016 Corso di Pedagogia Lezione 05/4/2016 Loredana La Vecchia Dalla prospettiva del soggetto* malattia ü Evento traumatico (che perturba) ü Minaccia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Anno accademico 2015-2016 Corso di Pedagogia Lezione 05/4/2016 Loredana La Vecchia Dalla prospettiva del soggetto* malattia ü Evento traumatico (che perturba) ü Minaccia
Piergiorgio Reggio Università Cattolica, Milano Metodi, Milano
 Imparare dalle reti e dalle comunità di pratica professionale nelle organizzazioni Cremona, 27 Novembre 2009 Piergiorgio Reggio Università Cattolica, Milano Metodi, Milano 1 La prospettiva Dimensione sociale
Imparare dalle reti e dalle comunità di pratica professionale nelle organizzazioni Cremona, 27 Novembre 2009 Piergiorgio Reggio Università Cattolica, Milano Metodi, Milano 1 La prospettiva Dimensione sociale
Progettare e valutare l intervento sociale
 Progettare e valutare l intervento sociale Una precisazione semantica Piano - Programma Progetto I tre termini, spesso utilizzati come sinonimi, hanno in realtà una precisa connotazione che ne indica :
Progettare e valutare l intervento sociale Una precisazione semantica Piano - Programma Progetto I tre termini, spesso utilizzati come sinonimi, hanno in realtà una precisa connotazione che ne indica :
I. Studi sociologici dell integrazione europea. Sesta giornata 5 Maggio 2017, ore
 I. Studi sociologici dell integrazione europea Sesta giornata 5 Maggio 2017, ore 14.00-18.00 PROCESSI DI EUROPEIZZAZIONE (2) 31 Marzo 9 Maggio 2017 1 Obiettivo: il concetto di rito e lo studio dell Europa
I. Studi sociologici dell integrazione europea Sesta giornata 5 Maggio 2017, ore 14.00-18.00 PROCESSI DI EUROPEIZZAZIONE (2) 31 Marzo 9 Maggio 2017 1 Obiettivo: il concetto di rito e lo studio dell Europa
Approccio delle capacità
 Approccio delle capacità La prospettiva di Martha c. Nussbaum Approccio 'della capacità' o 'delle capacità' sono i termini chiave del programma politico che A. Sen propone in opere come La diseguaglianza
Approccio delle capacità La prospettiva di Martha c. Nussbaum Approccio 'della capacità' o 'delle capacità' sono i termini chiave del programma politico che A. Sen propone in opere come La diseguaglianza
Strumenti di lavoro in èquipe multiprofessionali
 Strumenti di lavoro in èquipe multiprofessionali FRANCESCO REITANO Direttore U.O. Psicologia 2 - Distretto Centro Sud Azienda Provinciale Servizi Sanitari della Provincia di Trento Strumenti di lavoro
Strumenti di lavoro in èquipe multiprofessionali FRANCESCO REITANO Direttore U.O. Psicologia 2 - Distretto Centro Sud Azienda Provinciale Servizi Sanitari della Provincia di Trento Strumenti di lavoro
- Introduzione ai Modelli e ai metodi di rete
 - Introduzione ai Modelli e ai metodi di rete Corso di Introduzione ai METODI e alle TECNICHE del SERVIZIO SOCIALE Anno accademico 2016/2017 (prof. MARCO GIORDANO) Concetti preliminari del lavoro di rete
- Introduzione ai Modelli e ai metodi di rete Corso di Introduzione ai METODI e alle TECNICHE del SERVIZIO SOCIALE Anno accademico 2016/2017 (prof. MARCO GIORDANO) Concetti preliminari del lavoro di rete
L innovazione tecnologica dal fordismo al post-fordismo
 L innovazione tecnologica dal fordismo al post-fordismo Obiettivi della lezione Definizione di tecnologia Il rapporto fra scienza e tecnologia nel paradigma della produzione di massa La crisi del fordismo
L innovazione tecnologica dal fordismo al post-fordismo Obiettivi della lezione Definizione di tecnologia Il rapporto fra scienza e tecnologia nel paradigma della produzione di massa La crisi del fordismo
Università di Macerata, Dipartimento di Economia e Diritto, a.a
 Obiettivo Comprendere l importanza dell agire in sinergia e sintonia con altre organizzazioni per la risoluzione di problemi, per lo sviluppo e l innovazione, per incrementare la performance Topics Relazioni
Obiettivo Comprendere l importanza dell agire in sinergia e sintonia con altre organizzazioni per la risoluzione di problemi, per lo sviluppo e l innovazione, per incrementare la performance Topics Relazioni
Formare alla sicurezza. Metodologie per partecipare e costruire la cultura della sicurezza
 Formare alla sicurezza. Metodologie per partecipare e costruire la cultura della sicurezza La cultura modelli culturali e credenze (a) I modelli culturali vivono delle credenze che individui e comunità
Formare alla sicurezza. Metodologie per partecipare e costruire la cultura della sicurezza La cultura modelli culturali e credenze (a) I modelli culturali vivono delle credenze che individui e comunità
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Macerata
 Facoltà di Scienze della Comunicazione, Macerata Le due anime della semiotica: come si giustificano Il modello peirciano Il concetto di inferenza Deduzione/Induzione/Abduzione Icona/Indice/Simbolo Il modello
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Macerata Le due anime della semiotica: come si giustificano Il modello peirciano Il concetto di inferenza Deduzione/Induzione/Abduzione Icona/Indice/Simbolo Il modello
A.A. 2008/2009. Modulo di Valutazione economica dei piani SSD ICAR 22. Docente: dott. Francesco Calabrò
 UNIVERSITA Mediterranea DI REGGIO CALABRIA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA A.A. 2008/2009 Modulo di Valutazione economica dei piani SSD ICAR 22 Docente: dott. Francesco Calabrò IL GIUDIZIO DI CONVENIENZA L economia
UNIVERSITA Mediterranea DI REGGIO CALABRIA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA A.A. 2008/2009 Modulo di Valutazione economica dei piani SSD ICAR 22 Docente: dott. Francesco Calabrò IL GIUDIZIO DI CONVENIENZA L economia
POLITICHE SOCIALI: il sistema dei SERVIZI SOCIALI e il sistema dei SERVIZI SANITARI. Paolo Ferrario:
 1 Paolo Ferrario: POLITICHE SOCIALI: il sistema dei SERVIZI SOCIALI e il sistema dei SERVIZI SANITARI Alla Università di Milano Bicocca, Corso Elementi di Politica sociale I - Prof.sa Tognetti Mara paolo.ferrario@email.it
1 Paolo Ferrario: POLITICHE SOCIALI: il sistema dei SERVIZI SOCIALI e il sistema dei SERVIZI SANITARI Alla Università di Milano Bicocca, Corso Elementi di Politica sociale I - Prof.sa Tognetti Mara paolo.ferrario@email.it
Metàloghi e Minotauri
 Metàloghi e Minotauri Metalogo di Giuseppe O. Longo Padre - Ah, stai disegnando... Figlia - Sì... ma non è finito, non dovresti guardare ancora. P - Ormai ho guardato... Un Minotauro!... Be, sei proprio
Metàloghi e Minotauri Metalogo di Giuseppe O. Longo Padre - Ah, stai disegnando... Figlia - Sì... ma non è finito, non dovresti guardare ancora. P - Ormai ho guardato... Un Minotauro!... Be, sei proprio
Bruner Il viaggio verso la mente
 Bruner 1915-2016 Il viaggio verso la mente Laureatosi in Psicologia nel 1941, si dedicò allo studio dell intelligenza cercando di scoprire i meccanismi della mente che seleziona ed ordina l esperienza
Bruner 1915-2016 Il viaggio verso la mente Laureatosi in Psicologia nel 1941, si dedicò allo studio dell intelligenza cercando di scoprire i meccanismi della mente che seleziona ed ordina l esperienza
NEL PAESE DEI NUMERETTI
 Istituto Comprensivo F. P. Michetti Francavilla al Mare (CH) Scuola dell Infanzia PIANE Formazione I livello MATEMATICA Ins. Di Domenica Donata Maria Ins. Firmani Gabriella NEL PAESE DEI NUMERETTI Nel
Istituto Comprensivo F. P. Michetti Francavilla al Mare (CH) Scuola dell Infanzia PIANE Formazione I livello MATEMATICA Ins. Di Domenica Donata Maria Ins. Firmani Gabriella NEL PAESE DEI NUMERETTI Nel
La semiotica del progetto
 Salvatore Zingale La semiotica del progetto: il senso delle cose e il senso del progettare D&H Milano 19 maggio 2010 1 / 34 Salvatore Zingale La semiotica del progetto Il senso delle cose e il senso del
Salvatore Zingale La semiotica del progetto: il senso delle cose e il senso del progettare D&H Milano 19 maggio 2010 1 / 34 Salvatore Zingale La semiotica del progetto Il senso delle cose e il senso del
Lezione 1 Introduzione al corso di economia politica
 Corso di Scienza Economica (Economia Politica) prof. G. Di Bartolomeo Lezione 1 Introduzione al corso di economia politica Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di Teramo Il corso: Economia
Corso di Scienza Economica (Economia Politica) prof. G. Di Bartolomeo Lezione 1 Introduzione al corso di economia politica Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di Teramo Il corso: Economia
FISM VENEZIA Formazione insegnanti scuola dell'infanzia INSIEME PER EDUCARE. La corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia
 FISM VENEZIA Formazione insegnanti scuola dell'infanzia INSIEME PER EDUCARE La corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia 16 febbraio 2016 Manuela Vanin Per far crescere un bambino ci vuole un villaggio
FISM VENEZIA Formazione insegnanti scuola dell'infanzia INSIEME PER EDUCARE La corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia 16 febbraio 2016 Manuela Vanin Per far crescere un bambino ci vuole un villaggio
Per l'approccio funzionalista, 3 fattori necessari affinchè il processo di socializzazione possa riuscire:
 La socializzazione 2 funzioni: - È il processo attraverso cui le persone apprendono le competenze e gli atteggiamenti connessi ai nostri ruoli sociali - assicura l'ordine e la continuità sociale Per l'approccio
La socializzazione 2 funzioni: - È il processo attraverso cui le persone apprendono le competenze e gli atteggiamenti connessi ai nostri ruoli sociali - assicura l'ordine e la continuità sociale Per l'approccio
Società della conoscenza - learning society dell apprendimento
 Società della conoscenza - learning society dell apprendimento a Nuove prospettive: per - istruzione/ formazione - dimensione educativa nella vita - individuale - sociale le definizioni: - società conoscitiva-
Società della conoscenza - learning society dell apprendimento a Nuove prospettive: per - istruzione/ formazione - dimensione educativa nella vita - individuale - sociale le definizioni: - società conoscitiva-
Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience. Par. I Il pubblico dei media
 Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience Par. I Il pubblico dei media Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience Il pubblico dei media 25/10/2004 Il pubblico dei media
Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience Par. I Il pubblico dei media Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience Il pubblico dei media 25/10/2004 Il pubblico dei media
Corso di Sociologia Politica e Relazioni Internazionali. La struttura sociale. Stefania Fragapane A.A
 Corso di Sociologia Politica e Relazioni Internazionali La struttura sociale Stefania Fragapane A.A. 2012-2013 La struttura sociale è l ambiente in cui i soggetti interagiscono Livelli di una struttura
Corso di Sociologia Politica e Relazioni Internazionali La struttura sociale Stefania Fragapane A.A. 2012-2013 La struttura sociale è l ambiente in cui i soggetti interagiscono Livelli di una struttura
Sociologia II Enzo Mingione: lezioni del 15 e 16 febbraio 1. Economia e società: la critica di Polanyi al paradigma del mercato 2.
 Sociologia II 2009-10 Enzo Mingione: lezioni del 15 e 16 febbraio 1. Economia e società: la critica di Polanyi al paradigma del mercato 2. Varietà e organizzazione dei mercati, economia informale Le difficoltà
Sociologia II 2009-10 Enzo Mingione: lezioni del 15 e 16 febbraio 1. Economia e società: la critica di Polanyi al paradigma del mercato 2. Varietà e organizzazione dei mercati, economia informale Le difficoltà
Appunti per una riflessione critica sull'integrazione dei rifugiati
 Percorsi plurimi l inserimento economico, che concerne in primo luogo il conseguimento di un autonomia economica, attraverso l accesso ad un occupazione dignitosa; l inserimento sociale, attraverso la
Percorsi plurimi l inserimento economico, che concerne in primo luogo il conseguimento di un autonomia economica, attraverso l accesso ad un occupazione dignitosa; l inserimento sociale, attraverso la
A PIEDI O IN BICI, CON LE AMICHE E CON GLI AMICI
 A PIEDI O IN BICI, CON LE AMICHE E CON GLI AMICI Come progettare e realizzare mobilità sostenibile dei bambini e delle bambine nei percorsi casa scuola, promuovendo comportamenti salutari PER CITTA AMICHE
A PIEDI O IN BICI, CON LE AMICHE E CON GLI AMICI Come progettare e realizzare mobilità sostenibile dei bambini e delle bambine nei percorsi casa scuola, promuovendo comportamenti salutari PER CITTA AMICHE
INTRODUZIONE ALLA STRUTTURA SOCIALE
 INTRODUZIONE ALLA STRUTTURA SOCIALE Chiamiamo struttura sociale l ambiente sociale, articolato a livelli diversi, entro il quale i soggetti vivono e interagiscono. I soggetti vedono la struttura sociale
INTRODUZIONE ALLA STRUTTURA SOCIALE Chiamiamo struttura sociale l ambiente sociale, articolato a livelli diversi, entro il quale i soggetti vivono e interagiscono. I soggetti vedono la struttura sociale
Dai settori ai territori: la qualità dei servizi alla persona come fattore di sviluppo regionale
 Dai settori ai territori: la qualità dei servizi alla persona come fattore di sviluppo regionale di Patrizia Messina Marzo 2017 Crisi del paradigma fordista del «welfare state» - crisi di sostenibilità
Dai settori ai territori: la qualità dei servizi alla persona come fattore di sviluppo regionale di Patrizia Messina Marzo 2017 Crisi del paradigma fordista del «welfare state» - crisi di sostenibilità
Ufficio Stampa Miur Roma, 29 gennaio 2015 Le Scienze Umane (Antropologia,
 Istruzione e formazione per la cittadinanza attiva, contro le disuguaglianze SEMINARIO DEL GRUPPO DI LAVORO DEI DOCENTI DI SCIENZE UMANE ROMA 16-17 Marzo Trattazione di temi - problemi disciplinari nella
Istruzione e formazione per la cittadinanza attiva, contro le disuguaglianze SEMINARIO DEL GRUPPO DI LAVORO DEI DOCENTI DI SCIENZE UMANE ROMA 16-17 Marzo Trattazione di temi - problemi disciplinari nella
GESTIONE ATTIVITA AUTISMO. Prof.ssa Antonella Gedda
 GESTIONE ATTIVITA AUTISMO PRIMA SUGGESTIONE Ma io, chi sono io, ora che suppongo che vi è qualcuno, che è estremamente potente e, se oso dirlo, malizioso e astuto, che impiega tutte le sue forze e tutta
GESTIONE ATTIVITA AUTISMO PRIMA SUGGESTIONE Ma io, chi sono io, ora che suppongo che vi è qualcuno, che è estremamente potente e, se oso dirlo, malizioso e astuto, che impiega tutte le sue forze e tutta
Alla base della conoscenza di sé e degli altri la teoria della mente. a cura di laura Aleni Sestito
 Alla base della conoscenza di sé e degli altri la teoria della mente a cura di laura Aleni Sestito LA CONOSCENZA DI SE E DEGLI ALTRI Premack e Woodruff, 1978 TEORIA DELLA MENTE T O M, Theory of Mind ovvero
Alla base della conoscenza di sé e degli altri la teoria della mente a cura di laura Aleni Sestito LA CONOSCENZA DI SE E DEGLI ALTRI Premack e Woodruff, 1978 TEORIA DELLA MENTE T O M, Theory of Mind ovvero
ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO SANTA MARIA DI LICODIA. Anno Scolastico 2009/2010
 ISTITUTO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE METODOLOGICA IN EDUCAZIONE E FORMAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO SANTA MARIA DI LICODIA Corso di aggiornamento Anno Scolastico 2009/2010 1 LA DIDATTICA
ISTITUTO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE METODOLOGICA IN EDUCAZIONE E FORMAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO SANTA MARIA DI LICODIA Corso di aggiornamento Anno Scolastico 2009/2010 1 LA DIDATTICA
Biblioteca Uni\lersale Laterza. . ~~rar-~ = !!!: = E2!i. ~~ u ::::: ==- == Manuale di sociologia
 1 Biblioteca Uni\lersale Laterza. ~~rar-~ = F!!!: = E2!i ~~ u ::::: ==- == Manuale di sociologia J Istituto Universitario Architettura Veni so 504 B Servizio Bibliografico Aud1ov1! e di Documentazione
1 Biblioteca Uni\lersale Laterza. ~~rar-~ = F!!!: = E2!i ~~ u ::::: ==- == Manuale di sociologia J Istituto Universitario Architettura Veni so 504 B Servizio Bibliografico Aud1ov1! e di Documentazione
CAMBIARE I COMPORTAMENTI LA SFIDA DELLE COMPETENZE Presa in carico della Educazione alla Cittadinanza Globale ECG INNOVAZIONE CVM - G.
 CAMBIARE I COMPORTAMENTI LA SFIDA DELLE COMPETENZE Presa in carico della Educazione alla Cittadinanza Globale ECG INNOVAZIONE CVM - G. CIPOLLARI MAPPA DEL MONDO DI IERI E DI OGGI CITTADINANZA MULTIPLA
CAMBIARE I COMPORTAMENTI LA SFIDA DELLE COMPETENZE Presa in carico della Educazione alla Cittadinanza Globale ECG INNOVAZIONE CVM - G. CIPOLLARI MAPPA DEL MONDO DI IERI E DI OGGI CITTADINANZA MULTIPLA
Sociologia generale. Corso di laurea in Igiene Dentale A.a Docente: Pierpaola Pierucci
 Sociologia generale Corso di laurea in Igiene Dentale A.a. 2015-2016 Docente: Pierpaola Pierucci Sociologia generale Viaggio all esplorazione di una disciplina Dalle teorie sociologiche allo studio delle
Sociologia generale Corso di laurea in Igiene Dentale A.a. 2015-2016 Docente: Pierpaola Pierucci Sociologia generale Viaggio all esplorazione di una disciplina Dalle teorie sociologiche allo studio delle
Parleremo di organizzazione, e in particolare di organizzazione d impresa
 Giovanni Masino Parleremo di organizzazione, e in particolare di organizzazione d impresa Attraverso concetti e strumenti teorici Attraverso alcuni esempi e casi aziendali Tratti da imprese tra le più
Giovanni Masino Parleremo di organizzazione, e in particolare di organizzazione d impresa Attraverso concetti e strumenti teorici Attraverso alcuni esempi e casi aziendali Tratti da imprese tra le più
La Mappa normativa di Feigenbaum La normativa quale informazione
 La Mappa normativa di Feigenbaum La normativa quale informazione Autore: Sabetta Sergio In: Sociologia e Psicologia del diritto Ogni decisione umana che comporti un evento si pone in una scelta minima
La Mappa normativa di Feigenbaum La normativa quale informazione Autore: Sabetta Sergio In: Sociologia e Psicologia del diritto Ogni decisione umana che comporti un evento si pone in una scelta minima
Promozione della salute. Professoressa Julita Sansoni
 Promozione della salute Professoressa Julita Sansoni Promozione della salute Nascita Vs Codificazione Dibattito Promozione della salute Alma Ata - 1978 Ottawa Charter of Health Promotion 1986; Adelaide
Promozione della salute Professoressa Julita Sansoni Promozione della salute Nascita Vs Codificazione Dibattito Promozione della salute Alma Ata - 1978 Ottawa Charter of Health Promotion 1986; Adelaide
UNA PROPOSTA DI LETTURA ANTROPOLOGICO-CULTURALE DELLE NUOVE INDICAZIONI. a cura di MARTINELLO ELENA, IdR
 UNA PROPOSTA DI LETTURA ANTROPOLOGICO-CULTURALE DELLE NUOVE INDICAZIONI a cura di MARTINELLO ELENA, IdR UNA PROPOSTA DI LETTURA ANTROPOLOGICO- CULTURALE DELLE NUOVE INDICAZIONI L idea che ognuno si forma
UNA PROPOSTA DI LETTURA ANTROPOLOGICO-CULTURALE DELLE NUOVE INDICAZIONI a cura di MARTINELLO ELENA, IdR UNA PROPOSTA DI LETTURA ANTROPOLOGICO- CULTURALE DELLE NUOVE INDICAZIONI L idea che ognuno si forma
Sociologia (A-K) Roberto Pedersini
 Sociologia (A-K) Roberto Pedersini Aspetti organizzativi Orario: 10.30-12.00, senza pausa Lezioni frontali, con momenti di partecipazione e discussione Nessuna iscrizione al corso Nessuna verifica delle
Sociologia (A-K) Roberto Pedersini Aspetti organizzativi Orario: 10.30-12.00, senza pausa Lezioni frontali, con momenti di partecipazione e discussione Nessuna iscrizione al corso Nessuna verifica delle
THOMAS HOBBES. Di: Francesco Coccorese. Claudia D'Ambrosio. Francesco Aldieri
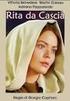 THOMAS HOBBES Di: Francesco Coccorese Claudia D'Ambrosio Francesco Aldieri Nacque a Westport, Inghilterra, il 5 Aprile 1588; Ebbe rapporti con l'ambiente culturale europeo grazie ai suo viaggi; La sua
THOMAS HOBBES Di: Francesco Coccorese Claudia D'Ambrosio Francesco Aldieri Nacque a Westport, Inghilterra, il 5 Aprile 1588; Ebbe rapporti con l'ambiente culturale europeo grazie ai suo viaggi; La sua
Milano, 18 novembre 2009
 Milano, 18 novembre 2009 Una soluzione partecipata per gli obiettivi del 20-20-20 e della Direttiva europea Clima-Energia. Nuove opportunità di coesione sociale e di sviluppo della sussidiarietà a cura
Milano, 18 novembre 2009 Una soluzione partecipata per gli obiettivi del 20-20-20 e della Direttiva europea Clima-Energia. Nuove opportunità di coesione sociale e di sviluppo della sussidiarietà a cura
PSICOLOGIA DI GRUPPO (a cura della Dr.ssa Catia Terra)
 C E F O PSICOLOGIA DI GRUPPO (a cura della Dr.ssa Catia Terra) Una Comunità è un insieme di individui che condividono lo stesso ambiente fisico formando un GRUPPO riconoscibile, unito da vincoli organizzativi,
C E F O PSICOLOGIA DI GRUPPO (a cura della Dr.ssa Catia Terra) Una Comunità è un insieme di individui che condividono lo stesso ambiente fisico formando un GRUPPO riconoscibile, unito da vincoli organizzativi,
METODI E STRUMENTI DELLA SCIENZA POLITICA
 METODI E STRUMENTI DELLA SCIENZA POLITICA 1 Scientificità della ricerca politica La ricerca politica è scientifica nella misura in cui raccolta delle osservazioni, elaborazione dei concetti e costruzione
METODI E STRUMENTI DELLA SCIENZA POLITICA 1 Scientificità della ricerca politica La ricerca politica è scientifica nella misura in cui raccolta delle osservazioni, elaborazione dei concetti e costruzione
Campo d azione, potere e dipendenza
 Campo d azione, potere e dipendenza Organizzazione Aziendale prof. Giovanni Masino Università di Ferrara_Corso di Laurea in Economia_AA 2014/2015 Qualunque cosa produca, l impresa non sarà mai totalmente
Campo d azione, potere e dipendenza Organizzazione Aziendale prof. Giovanni Masino Università di Ferrara_Corso di Laurea in Economia_AA 2014/2015 Qualunque cosa produca, l impresa non sarà mai totalmente
Il funzionamento efficace
 Il funzionamento efficace La ricerca della Felicità Aristotele credeva che ogni azione umana mirasse al conseguimento della Felicità. Nietzsche riteneva che ogni azione umana fosse finalizzata al Potere.
Il funzionamento efficace La ricerca della Felicità Aristotele credeva che ogni azione umana mirasse al conseguimento della Felicità. Nietzsche riteneva che ogni azione umana fosse finalizzata al Potere.
Stili di vita sostenibili nelle pratiche di consumo alimentare urbano. Il caso di Milano
 Stili di vita sostenibili nelle pratiche di consumo alimentare urbano. Il caso di Milano Chiara Demaldè Dottorato in Qualità della vita nella Società dell Informazione Dipartimento di Sociologia, Università
Stili di vita sostenibili nelle pratiche di consumo alimentare urbano. Il caso di Milano Chiara Demaldè Dottorato in Qualità della vita nella Società dell Informazione Dipartimento di Sociologia, Università
Nuove Tecnologie e Didattica l evoluzione dei modelli di insegnamento/apprendimento nella formazione continua e a distanza
 Nuove Tecnologie e Didattica l evoluzione dei modelli di insegnamento/apprendimento nella formazione continua e a distanza trentin @ itd.cnr cnr.it Istituto Tecnologie Didattiche Consiglio Nazionale delle
Nuove Tecnologie e Didattica l evoluzione dei modelli di insegnamento/apprendimento nella formazione continua e a distanza trentin @ itd.cnr cnr.it Istituto Tecnologie Didattiche Consiglio Nazionale delle
Ugo Carlone. Alle origini della paura: insicurezza urbana e legami sociali a Perugia
 Ugo Carlone Alle origini della paura: insicurezza urbana e legami sociali a Perugia Perché insicurezza urbana - Significa parlare della città nel suo complesso (sviluppo, contraddizioni, bisogni, mutamento)
Ugo Carlone Alle origini della paura: insicurezza urbana e legami sociali a Perugia Perché insicurezza urbana - Significa parlare della città nel suo complesso (sviluppo, contraddizioni, bisogni, mutamento)
