Filosofia del linguaggio La questione animale nel pensiero Cinque-Seicentesco
|
|
|
- Susanna Raimondi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Filosofia del linguaggio Unità didattica n. 11 (prof. Stefano Gensini) La questione animale nel pensiero Cinque-Seicentesco (schema per la lezione) Grandi fonti antiche Aristotele Historia animalium IV 9 Politica A a De anima B 420b Difatti, come s'è detto, non ogni suono [psóphos] dell'animale è voce [phoné] (giacché si può emettere un suono anche con la lingua o tossendo), ma il percuziente dev'essere animato ed accompagnarsi ad un'immagine [metà phantiasías tinòs]. In effetti la voce è un suono che significa qualcosa [semantikós], e non 'semplicemente, come la tosse, il suono dell'aria inspirata. Con quest'aria il percuziente urta l'aria che si trova nella trachea contro la trachea stessa. Una riprova di ciò è che non si può parlare quando si inspira o si espira, ma quando si trattiene il respiro: chi infatti trattiene il respiro, con esso produce questo movimento. Ed è anche manifesto perché i pesci sono privi di voce: perché non hanno laringe. E mancano di questa parte corporea perché non assumono l'aria e non respirano. Per quale causa ciò avvenga è un altro discorso. (Epicuro Lucrezio Lettera a Erodoto: origine naturale del linguaggio umano) De rerum natura, V libro, vv (sezione sull origine del linguaggio in cui riprende le tesi di Epicuro e si sofferma sulle analogia fra linguaggio umano e comunicazione animale) Stoici (presso Sesto Empirico Adv. log., II, 275 = SVF II, 135) Dicono che l'uomo non differisce dagli animali irragionevoli (áloga) per il discorso in quanto emissione della voce [lógos prophorikós] (emettono voci articolate anche i corvi, i pappagalli, le gazze), ma per il discorso interiore [endiathétos] ; e non per la rappresentazione pura e semplice (anche gli animali possono avere rappresentazioni), ma per la rappresentazione capace di passare da un oggetto all' altro e di forma complessa. Perciò l'uomo, che ha nozione della conseguenza, può immediatamente passare, in virtù di questa, alla nozione del segno: 'se è questo, è quest'altro'. Che il segno esista, dipende direttamente dalla natura e dalla struttura dell'uomo.
2 Filone Alessandrino (~20 a.c.- 50 d.c.) De animalibus (pervenuto in una versione armena del VI sec.) (Dal De animalibus, 45): "Un cane mentre inseguiva una preda giunse dinnanzi una fossa profonda, vicino alla quale c'erano due sentieri, uno a destra, l'altro a sinistra; stette seduto per un pò, meditando dove convenisse andare. Ma correndo a destra, e non trovando nessuna traccia (nullum inveniens vestigium ), tornò indietro verso l'altro sentiero. Poiché neppure in questo compariva apertamente qualche segno (neque in ista aperte appareret aliquod signum ), oltrepassò la fossa, indagando curiosamente, accelerando il passo sotto il suo fiuto; è sufficiente affermare che non lo fece accidentalmente, ma piuttosto per una vera deliberazione della mente (satis declarans non obiter haec facere, sed potius vera inquisitione consilii)." Plutarco ( d.c.) De sollertia animalium 973 a-e Gryllus 991f-992d Plinio il Vecchio (23-79 d.c.) Historia naturalis VIII 227 sgg. Sesto Empirico (~ ) Contro gli stoici e l antropocentrismo (Schizzi pirroniani I, 73-76) "Noi vediamo, cosa notevole, anche gli animali dei quali discorriamo, proferire, anche voci umane, come le piche e alcuni altri. Anche se non comprendiamo le voci degli animali, così detti, irragionevoli (alogoi), non sarebbe del tutto assurdo pensare che essi discorrano tra loro senza che noi li comprendiamo. Anche quando udiamo la voce dei barbari, non la comprendiamo, anzi ci fa l'impressione di essere un suono uniforme. Per tornare ai cani, noi li udiamo emettere una data voce, quando vogliono allontanare qualcuno, un'altra, quando urlano, un'altra, quando sono battuti, un'altra differente, quando scodinzolano di gioia. Insomma, se uno fissasse la sua attenzione a questo fatto, riscontrerebbe una grande differenza di voci e in questo e negli altri animali secondo le differenti circostanze, talché ne concluderebbe, verisimilmente, che gli animali, così detti, irragionevoli, partecipano, anche, del ragionamento esternato (logos prophorikos). Ora, se essi non rimangono dietro agli uomini né per acutezza di sensazioni, né per ragionamento interiore (logos endiathetos), né, abbondiamo pure, per ragionamento eternato, essi non dovrebbero essere meno degni di fede di noi, per quanto riguarda le rappresentazioni sensibili.così chi negherebbe che gli uccelli si distinguono per vivacità d'intelligenza, e sono dotati di ragionamento esternato, essi che sanno, non solo le cose presenti, ma, anche, le future, e le predicono a chi è in grado d'intendere, o segnalandole in altre maniere o preannunciandole con la voce?"
3 Porfirio (233/4-305 d.c.) De abstinentia ab esu carnium III, 3, 5 Ad esempio allo stesso modo che noi non percepiamo che un rumore e un suono, a causa del fatto che non conosciamo le usanze degli Sciiti, e ci sembra che essi schiamazzino, che non articolino niente, ma che emettano sempre uno stesso tipo di rumore, ora lungo, ora breve, senza che la sua modulazione giunga alle nostre orecchie formando un qualche senso, quale che sia, mentre per essi (s.c. gli Sciiti), il loro parlare è comprensibile e molto distinto, così come è per noi una lingua che ci è familiare; lo stesso avviene con gli animali: il senso (synesis) è afferrato in modo particolare secondo ogni specie, mentre noi non riusciamo ad intendere che un suono il cui senso ci sfugge, poiché ancora non si è trovato nessuno che abbia appreso la nostra lingua per insegnarci a tradurre nella nostra lingua ciò che è detto presso gli animali. Lattanzio (III-IV sec. d.c.) De ira dei VII 7
4 .. Dante Alighieri ( ) De vulgari eloquentia (I ii 5) Inferioribus quoque animalibus, cum solo nature instinctu ducantur, de locutione non oportuit provideri: nam omnibus eiusdem speciei sunt iidem actus et passiones, et sic possunt per proprios alienos cognoscere; inter ea vero que diversarum sunt specierum non solum non necessaria fuit locutio, sed prorsus dampnosa fuisset, cum nullum amicabile commertium fuisset in illis. Principali testi fra Cinque e Seicento Girolamo Rorario (Hieronymus Rorarius) ( ) Quod animalia bruta [saepe] ratione utantur melius homine mss, composto intorno al 1539; fu edito nel 1648 da Gabriel Naudé (Tétrade - libertinismo) eliminando il saepe dal titolo in modo da estremizzare la tesi dell operetta Conrad Gesner ( ) Historiae animalium ( ) Quadrupedes vivipares Quadrupedes ovipares Avium natura Piscium & aquatilium animantium natura Michel Eyquem de Montaigne ( ) (vedi oltre, citazioni) Essais spec. Vol II, 12, prima ed Recupera le fonti del naturalismo e dello scetticismo antichi (Lucrezio, Sesto Empirico) oltre al materiale aneddotico e moralistico offerto da Plutarco (De sollertia ecc.)
5 Pierre Charron ( ), avvocato, sacerdote, predicatore Traité de la sagesse, prima ed ; vedi libro I, cap. XXXIV attinge largam. a Montaigne; sua funzione nell attivazione del paradigma libertino; gli risponde polemicam. Il medico Chanet, Considerations sur Charron (1643), De l instinct et de la connoissance des animaux (1646). René Descartes ( ) Discours de la méthode (1637), V parte (vedi oltre per il testo) Marin Cureau de Chambre ( ), medico e consigliere di Luigi XIV Traité de la connoissance des animaux (1648), la razionalità degli animali è fondata sull uso della immaginazione ; l istinto come nocciolo della autonomia delle specie animali dal creatore, che ha dato loro una causa interna di autorealizzazione; difende Charron contro Chanet A destra, il frontespizio di La Chambre, Traité des animaux (1648); a sinistra lo schema che si trova in antiporta di un ms del Theophrastus redivivus: si noti, in ogni cerchio l indicazione di una delle fonti ideali dell opera.
6 Theophrastus redivivus (1659?) capolavoro della letteratura clandestina di orientamento laico e materialista. L autore, anonimo, è radicalmente anticartesiano. Trattato VI, cap. II, In quo hominem a ceteris animalibus non differre nisi specie declaratur etc. [v. l ed. crit. Canzani-Paganini, 2 voll. Firenze : La Nuova Italia] Pierre Bayle ( ), erudito, professore di filosofia e storia a Sedan e Rotterdam, calvinista Dal 1684 promotore delle Nouvelles de la république des lettres Dictionaire historique et critique prima ed. Amsterdam 1697, Rotterdam , fondamentale la voce «Rorario» dedicata alla querelle sull anima delle bestie
7 Il punto di vista tradizionale (Roccha, Bibliotheca Apostolica Vaticana 1591, pp , usa come base Gesner, Mithridates)
8 Supra, pp
9
10 Montaigne Essais, II, 12 (dalla Apologie de Raymond Sebond), si cita dalla ed. Adelphi a c. di F. Garavini. Bisogna che osserviamo la parità che c'è fra noi. Noi comprendiamo approssimativamente il loro sentimento, così le bestie il nostro, pressappoco nella stessa misura. Esse ci lusingano, ci minacciano e ci cercano; e noi loro. Del resto, vediamo in modo evidente che c'è fra loro una piena e totale comunicazione, e che esse si capiscono fra loro, non solo quelle della stessa specie, ma anche quelle di specie diverse
11
12 Mi sembra che il solo luogo dove si possa leggere Montaigne sia una biblioteca: possibilmente una di quelle grandi biblioteche cinquecentesche o secentesche, che ornano i palazzi aristocratici e le abbazie di tutta Europa. ( ) Montaigne aveva la sua biblioteca al terzo piano di una torre. Seduto al tavolo, vedeva con un solo sguardo i libri, schierati in cinque file, pronti a essere sfogliati se l' assaliva un capriccio o un' inquietudine. (Da P. Citati) Nella foto, la famosa torre di M., dove lo scrittore aveva la biblioteca e si dedicava allo studio. Siamo in Francia, a Saint-Michel-de-Montaigne, suo paese natale, tra Bordeaux e Bergerac.
13
14 Girolamo Fabrici d Acquapendente (m. 1619), De brutorum loquela (1603), capitolo 2 (trad. Gensini) Che cosa il linguaggio umano abbia in comune e in cosa sia diverso da quello degli altri animali, e in che cosa quello degli animali fra di loro Da quanto detto si ricava senza difficoltà che cosa abbiano in comune e in che cosa si differenzino il linguaggio umano e quello degli animali, e in che cosa quello degli animali fra di loro. In primo luogo, gli uomini e gli altri animali hanno in comune il fatto che entrambi hanno un linguaggio e formano articolazioni (come si è detto). Ma differiscono in ciò, che le articolazioni umane sono lettere, quelle degli animali sono molte e di natura diversa. Hanno anche in comune il fatto che sia gli uomini sia gli animali producono il linguaggio mediante la combinazione delle articolazioni; ma differiscono, perché il linguaggio degli animali è più semplice, e quello degli uomini invece è più composito: esso infatti consta di lettere, sillabe, locuzioni e discorso. Sicché nella prima età l infante produce quasi soltanto voce, al tempo in cui diciamo ch egli vagisce; poi forma qualche lettera, dapprima le più facili, che non richiedono accostamento [degli organi fonatori], come le vocali, e fra queste anzitutto quelle più semplici come A, E, O; successivamente forma le consonanti, di nuovo quelle più facili come T, P, B, e imparando un po alla volta a congiungerle alle vocali, forma le sillabe, come MA, PA, BA, TA. E la fase in cui diciamo che l infante borbotta. In seguito, piano piano produce anche altre consonanti, forma delle locuzioni, però non in modo completo: dapprima forma solo le ultime sillabe delle locuzioni, poi, componendole un po per volta, prima forma quelle bisillabe, poi le trisillabe e le quadrisillabe e infine, intorno al primo anno di età, le forma tutte. Dipoi, andando sempre più avanti, mette assieme le locuzioni e forma il discorso, dapprima quello semplice composto di nome e verbo, in seguito con gli elementi sincategorematici, cioè con le altre parti del discorso, quelle che i grammatici chiamano invariabili, quali sono l avverbio, la congiunzione, la preposizione e l interiezione (i filosofi, infatti, comprendono il pronome nel nome e il participio nel verbo). Il tipo di combinazione che si osserva negli animali è molto meno ricco e più imperfetto. Movendo da ciò, fra il linguaggio dell uomo e degli altri animali vediamo un analogia e una differenza solo particolare, nel senso che se entrambi hanno un linguaggio e formano articolazioni, nondimeno, le articolazioni umane sono più libere e inoltre sono molteplici e diverse. Di nuovo, hanno in comune il fatto che sia l uomo che gli altri [animali] formano la voce mediante articolazioni, ma differiscono in quanto gli altri [animali] non formano le articolazioni con la lingua e le labbra come fanno gli uomini. Negli uomini, infatti, entrambi questi [organi] sono morbidi, in funzione del parlare, mentre negli animali sono duri e rigidi, perché fatti soprattutto per afferrare il cibo. Inoltre, gli uomini hanno in comune cogli animali il fatto che le articolazioni umane, in quanto lettere, sono naturali e si formano con strumenti naturali, e sono le medesime in tutti gli umani. Così, un italiano, un caldeo e uno spagnolo formeranno M, B e P allo stesso modo, e con mezzi non diversi, ossia accostando le labbra; analogamente, ciascuna specie di animali e, in ogni specie, ciascun individuo proferirà sempre e naturalmente e allo stesso modo le sue articolazioni. Fra uomo e animali vi è però questa differenza, che il linguaggio degli animali è tutto naturale, e sempre lo stesso; mentre quello umano è in parte naturale e in parte arbitrario (ad placitum) e artificiale. E naturale per quanto riguarda le lettere o articolazioni, ma è arbitrario quanto alle locuzioni e al discorso: dato che gli Italiani, i Francesi, gli Ebrei, i Sarmati e gli altri popoli combinano le lettere ciascuno a modo proprio, risultano diverse sia i vocaboli sia il discorso. Ecco perché fra gli uomini c è tanta varietà di idiomi; ed ecco perché, viceversa, gli animali si capiscono all interno della propria specie, mentre gli uomini no: infatti l italiano non capisce il tedesco, il tedesco non capisce il greco, né gli altri capiscono gli altri [popoli], malgrado che tutti facciano parte della specie umana. Tuttavia il linguaggio umano va considerato arbitrario nel senso che esso stesso ha certi limiti definiti, e non è affatto infinito e immenso. Infatti, dato che tutte le lettere, come ho detto, sono naturali e vengono formate naturalmente, in un solo e simile modo, per mezzo di strumenti naturali, è
15 evidente che quanti sono i modi di comporle, tante sono le locuzioni che ne risultano. Tuttavia questa combinazione ha limiti definiti, come anche è definito il numero delle lettere. Pertanto alcuni uomini di chiara reputazione, prendendo talvolta su di sé questo compito, e mettendo assieme solo alcune delle prime lettere, inventavano ora una locuzione caldea, ora una italiana, ora una latina, ora una greca e [poi] ripetutamente si imbattevano in una locuzione siffatta. Diversamente, tutto il linguaggio degli animali è naturale in ogni sua parte, e pertanto ciascuna specie al suo interno e ciascun individuo di ciascuna specie allo stesso modo realizza il linguaggio e forma e proferisce le articolazioni: laddove la specie umana lo fa in tanti modi differenti. Stando così le cose, necessariamente vi sono tante differenze di linguaggio quante sono le specie animali, e ciascuna specie di animale possiede un proprio linguaggio non somigliante ad alcun altro in tutta la natura: il sommo creatore ha disposto ciò, affinché tutti i membri di una stessa specie reciprocamente si ascoltino, si capiscano, si chiamino, si prestino aiuto, riescano a riprodursi, fuggano i nemici, si difendano. Infatti, se il linguaggio di tutti gli animali fosse uno solo, le specie si confonderebbero una con l altra, e al loro interno i singoli individui: facilmente l agnello o la pecora accorrerebbero dal lupo, la lepre dal cane, e l uccellino dal falco. Nel libro De abstinentia ab esu carnium Porfirio porta l esempio della iena indiana, quella che gli indigeni chiamano corocotta. Questa [fiera] parla a tal punto al modo umano che talvolta gli uomini, ingannati dalla somiglianza con la voce di un amico, escono allo scoperto, vengono presi dalla iena e restano uccisi. A questo proposito si svela e si coglie facilmente una certa superiorità dell uomo, che in certo qual modo sembra superare la natura. Quest ultima infatti, se da una parte tutela sempre la salvezza di tutti gli animali grazie alla differenza della voce e dell articolazione, d altra parte viene ingannata dall uomo, che fa avvicinare a sé gli animali allo scopo di ucciderli: c è chi con un fischio emesso dalla bocca richiama i tordi e i merli, chi con uno strumento adatto, detto popolarmente il quagliarolo, attira a sé le quaglie (ovvero le coturnici), e [chi] con la buccia o involto dei lupini [attira] i passerotti; altri acchiappano gli uccelli servendosi di uccelli chiusi in piccole gabbie; altri, infine, imitano con la bocca il linguaggio degli animali e in certo modo costringono gli animali a venire da loro, ingannati dal desiderio di ricevere qualcosa di buono. In questo modo un tale, salito su un albero, imitava alla perfezione l ululato dei lupi e li chiamava a sé per ucciderli. Esistono moltissime altre tecniche di caccia, grazie alle quali l uomo domina su tutti gli animali con l arte e l intelligenza: tuttavia una parte non piccola ne include il linguaggio, che l arte riesce a emulare. Somiglianza [questa], per cui, come è stato detto, l uomo costante vince, oppure inganna, perfino l eterno istituto della natura. Se sia l uomo a superare la natura o questa a sbagliare non oserei dire; diremo con più verità che Dio Ottimo Massimo ha dato all uomo una prerogativa cui tutti gli animali soggiacciono, senza riguardo alla propria vita e salvezza. Ma prima di concludere questo capitolo, giova da ultimo considerare un punto sollevato in precedenza e che occorre discutere in modo più preciso. Dato, dunque, che esistono tanti linguaggi degli animali quante sono le specie, ci si chiede perché gli animali di una medesima specie conversando l uno con l altro si capiscono, mentre non è così per l uomo, che non comprende un uomo di un altra nazione, malgrado appartengano entrambi alla stessa specie. Si risponde che ciò dipende dal fatto che il linguaggio umano è arbitrario, mentre quello degli animali è tutto naturale. Infatti ogni linguaggio si compone di articolazioni: ogni volta, dunque, che la combinazione delle articolazioni è naturale, essa è uguale per tutti, e viene intesa da tutti i membri della stessa specie, come è il caso del linguaggio degli animali; ma dove la combinazione delle articolazioni è arbitraria, ad esempio [quando è] artificiale e opera dell intelletto, se la costruzione delle lettere e delle locuzioni è opera dell intelligenza di una sola nazione, certamente tutti gli individui di quella nazione si comprenderanno fra loro. E così che gli Italiani, i Sarmati e tutte le persone delle singole nazioni si capiscono a vicenda. Ma se un solo uomo di una certa nazione combina le articolazioni (vale a dire le lettere o i caratteri) in modo arbitrario, cioè a modo suo, certamente lui solo, e non la nazione intera, comprenderà una combinazione e una scrittura siffatte. Così, coloro che inventano quelli che comunemente si chiamano caratteri cifrati capiscono solamente se stessi; si spiega, tuttavia, che questa modalità di scrittura si basi sui caratteri, e non sul parlato e sulla voce articolata, perché la sua terminazione è arbitraria, mentre le lettere sono naturali per tutti. L assoluta verità del fatto che un linguaggio naturale è compreso da tutti i membri
16 della stessa specie si può provare per mezzo della voce, che è naturale a tutti, sicché tutti la capiscono. Infatti, se qualcuno uomo o altro animale - proferisce una voce triste, tutti gli uomini e anche gli animali la capiranno e avvertiranno (dato che la voce è naturale per tutti) che l affezione dell animo [corrispondente] è la tristezza. Che se Alessandro il Macedone fu spinto a prendere le armi da una musica eseguita in un certo modo, lo stesso, spinto da una tale musica, avrebbe fatto un romano assennato, o un sarmata, ché necessariamente una medesima affezione dell animo sarebbe penetrata in entrambi. Ma basti così di questo secondo capitolo.
17 Descartes 1637 Discorso sul metodo (da Stancati ed., Cartesio, Segno e linguaggio, Roma 2000)
18 In sintesi, per Descartes, gli animali (come le macchine) (1) Non possono usare la parola (anche quando ne dispongano, come nel caso dei pappagalli) per comunicare ad altri il pensiero; il pensiero è infatti il prodotto dell esprit, carattere esclusivo degli esseri umani; (2) Non possono fare uso di mezzi comunicativi in risposta a contesti diversi, mancano cioè di flessibilità, dote che persino gli ebeti possiedono; (3) Possono esprimere solo passioni, e ciò in modo naturale, senza intervento di una controparte cosciente. In tal caso è la loro macchina corporea a manifestare all esterno i propri stati fisici.
Thomas Hobbes
 588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva
 Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,
Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,
Insiemi di numeri reali
 Capitolo 1 1.1 Elementi di teoria degli insiemi Se S è una totalità di oggetti x, si dice che S è uno spazio avente gli elementi x. Se si considerano alcuni elementi di S si dice che essi costituiscono
Capitolo 1 1.1 Elementi di teoria degli insiemi Se S è una totalità di oggetti x, si dice che S è uno spazio avente gli elementi x. Se si considerano alcuni elementi di S si dice che essi costituiscono
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814)
 Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
Norme redazionali per la tesi di laurea
 Norme redazionali per la tesi di laurea Dipartimento di Italianistica Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Spalato Norme di massima per redigere la tesi triennale e quiquennale. Formattazione
Norme redazionali per la tesi di laurea Dipartimento di Italianistica Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Spalato Norme di massima per redigere la tesi triennale e quiquennale. Formattazione
Filosofia del linguaggio (i) (3 cr.)
 Filosofia del linguaggio (i) (3 cr.) Docente: Giuseppe Spolaore Orario: Martedì ore 17.20 aula T4, mercoledì ore 17.20 aula 1.4, giovedì ore 14.00 aula 1.4 (per un totale di circa 10 lezioni). Ricevimento:
Filosofia del linguaggio (i) (3 cr.) Docente: Giuseppe Spolaore Orario: Martedì ore 17.20 aula T4, mercoledì ore 17.20 aula 1.4, giovedì ore 14.00 aula 1.4 (per un totale di circa 10 lezioni). Ricevimento:
LOCKE. Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza:
 LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
SCHEDA DI PRESENTAZIONE
 SCHEDA DI PRESENTAZIONE TITOLO: LA RIFORMA PROTESTANTE BREVE DESCRIZIONE DELL UNITÀ DI APPRENDIMENTO: in questa unità di apprendimento si vuole introdurre le novità portate da Lutero DIDATTIZZAZIONE e
SCHEDA DI PRESENTAZIONE TITOLO: LA RIFORMA PROTESTANTE BREVE DESCRIZIONE DELL UNITÀ DI APPRENDIMENTO: in questa unità di apprendimento si vuole introdurre le novità portate da Lutero DIDATTIZZAZIONE e
BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta
 BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta corretto e vero. Un ragionamento è corretto se segue uno
BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta corretto e vero. Un ragionamento è corretto se segue uno
Italiano Funzioni del linguaggio.
 Italiano 2012 Funzioni del linguaggio http://www.federicopellizzi.it/custodi/terze/funzioni_linguaggio.pdf 1 Il linguaggio Il linguaggio complesso è una prerogativa degli esseri umani. Solo noi possiamo
Italiano 2012 Funzioni del linguaggio http://www.federicopellizzi.it/custodi/terze/funzioni_linguaggio.pdf 1 Il linguaggio Il linguaggio complesso è una prerogativa degli esseri umani. Solo noi possiamo
Il senso del mistero. Gabriella A. Ferrari
 Il senso del mistero L esperienza più bella che possiamo avere è il senso del mistero. E l emozione fondamentale che accompagna la nascita dell arte autentica e della vera scienza. Colui che non la conosce,
Il senso del mistero L esperienza più bella che possiamo avere è il senso del mistero. E l emozione fondamentale che accompagna la nascita dell arte autentica e della vera scienza. Colui che non la conosce,
ANSELMO D AOSTA
 Prova ontologica (argomento a priori ) Lo stolto afferma: Qualcun altro, invece, afferma: DIO NON ESISTE (proposizione A) DIO È CIÒ DI CUI NON SI PUÒ PENSARE IL MAGGIORE (proposizione B) A questo punto
Prova ontologica (argomento a priori ) Lo stolto afferma: Qualcun altro, invece, afferma: DIO NON ESISTE (proposizione A) DIO È CIÒ DI CUI NON SI PUÒ PENSARE IL MAGGIORE (proposizione B) A questo punto
BENEDETTO SPINOZA a cura di Pietro Gavagnin con il contributo degli alunni di 4AOL as
 BENEDETTO SPINOZA 1632-1677 a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net con il contributo degli alunni di 4AOL as 2014-2015 OPERE: TRATTATO TEOLOGICO - POLITICO (1670) Scopo fondamentale del trattato è la
BENEDETTO SPINOZA 1632-1677 a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net con il contributo degli alunni di 4AOL as 2014-2015 OPERE: TRATTATO TEOLOGICO - POLITICO (1670) Scopo fondamentale del trattato è la
Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo
 Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo mirco.fasolo@unimib.it Bibliografia Testi obbligatori - D amico, Devescovi (2003). Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci: Roma.
Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo mirco.fasolo@unimib.it Bibliografia Testi obbligatori - D amico, Devescovi (2003). Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci: Roma.
GOTTFRIED WILHEM LEIBNIZ
 GOTTFRIED WILHEM LEIBNIZ Breve dimostrazione di un errore notevole di Cartesio ed altri a proposito di una legge di natura, secondo la quale essi vogliono che da Dio sia sempre conservata la stessa quantità
GOTTFRIED WILHEM LEIBNIZ Breve dimostrazione di un errore notevole di Cartesio ed altri a proposito di una legge di natura, secondo la quale essi vogliono che da Dio sia sempre conservata la stessa quantità
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli
 FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642)
 Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642) In tutte e tre le prove delle Meditazioni Descartes parte dall idea di Dio: III Meditazione: 2 prove a posteriori che procedono dall effetto
Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642) In tutte e tre le prove delle Meditazioni Descartes parte dall idea di Dio: III Meditazione: 2 prove a posteriori che procedono dall effetto
Es. quadrilatero: specie di poligono, genere di quadrato. La specie ha più caratteristiche, il genere è riferito a più elementi.
 La logica di Aristotele La logica non si trova tra le scienze dell enciclopedia aristotelica, poiché essa ha per oggetto la forma comune a tutte le scienze, cioè il procedimento dimostrativo, o le varie
La logica di Aristotele La logica non si trova tra le scienze dell enciclopedia aristotelica, poiché essa ha per oggetto la forma comune a tutte le scienze, cioè il procedimento dimostrativo, o le varie
Epicureismo e stoicismo
 Epicureismo e stoicismo per una ricapitolazione a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Tutto il pensiero greco si sviluppa intorno al problema del divenire Divenire = l uscire e il rientrare nel nulla
Epicureismo e stoicismo per una ricapitolazione a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Tutto il pensiero greco si sviluppa intorno al problema del divenire Divenire = l uscire e il rientrare nel nulla
TRACCIA PER LA BIOGRAFIA SCOLASTICA E LINGUISTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI IN USCITA
 TRACCIA PER LA BIOGRAFIA SCOLASTICA E LINGUISTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI IN USCITA Anno scolastico ( Classe quinta Scuola Primaria e Classe terza Scuola Secondaria di primo grado) Dati personali - Cognome:..
TRACCIA PER LA BIOGRAFIA SCOLASTICA E LINGUISTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI IN USCITA Anno scolastico ( Classe quinta Scuola Primaria e Classe terza Scuola Secondaria di primo grado) Dati personali - Cognome:..
ARISTOTELE ( a.c) Metafisica, libro I
 Tutti gli uomini desiderano per natura di conoscere : ne è prova il piacere che provano per le sensazioni che essi amano per se stesse, soprattutto quelle della vista questo perché la vista, tra i sensi,
Tutti gli uomini desiderano per natura di conoscere : ne è prova il piacere che provano per le sensazioni che essi amano per se stesse, soprattutto quelle della vista questo perché la vista, tra i sensi,
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Jean-Marc Lévy-Leblond La velocità dell ombra Torino, Codice edizioni, 2007 Traduzione di F. Niola e V. Roncarolo [Editions du Seuil, 2006].
![Jean-Marc Lévy-Leblond La velocità dell ombra Torino, Codice edizioni, 2007 Traduzione di F. Niola e V. Roncarolo [Editions du Seuil, 2006]. Jean-Marc Lévy-Leblond La velocità dell ombra Torino, Codice edizioni, 2007 Traduzione di F. Niola e V. Roncarolo [Editions du Seuil, 2006].](/thumbs/70/63692369.jpg) Jean-Marc Lévy-Leblond La velocità dell ombra Torino, Codice edizioni, 2007 Traduzione di F. Niola e V. Roncarolo [Editions du Seuil, 2006]. M. Squillacciotti Anche per chi ha seguito le lezioni senesi
Jean-Marc Lévy-Leblond La velocità dell ombra Torino, Codice edizioni, 2007 Traduzione di F. Niola e V. Roncarolo [Editions du Seuil, 2006]. M. Squillacciotti Anche per chi ha seguito le lezioni senesi
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre
Richiami teorici ed esercizi di Logica
 Facoltà di ingegneria Università della Calabria Corsi di Potenziamento Matematica e Logica A. A. 2008-2009 Richiami teorici ed esercizi di Logica Proposizioni logiche: Ogni espressione matematica alla
Facoltà di ingegneria Università della Calabria Corsi di Potenziamento Matematica e Logica A. A. 2008-2009 Richiami teorici ed esercizi di Logica Proposizioni logiche: Ogni espressione matematica alla
Il canto liturgico. Espressione dell anima e mezzo di relazione con Dio
 Il canto liturgico Espressione dell anima e mezzo di relazione con Dio Editing curato dal Sig. Alessandro Amendola. Immagini dell autrice. Ogni riferimento a fatti realmente accaduti o luoghi e/o a persone
Il canto liturgico Espressione dell anima e mezzo di relazione con Dio Editing curato dal Sig. Alessandro Amendola. Immagini dell autrice. Ogni riferimento a fatti realmente accaduti o luoghi e/o a persone
CHE COS è L INTELLIGENZA ARTIFICIALE? Si può definire l intelligenza artificiale (IA) l insieme di studi e tecniche che tendono alla realizzazione di
 CHE COS è L INTELLIGENZA ARTIFICIALE? Si può definire l intelligenza artificiale (IA) l insieme di studi e tecniche che tendono alla realizzazione di macchine in grado di risolvere problemi e di riprodurre
CHE COS è L INTELLIGENZA ARTIFICIALE? Si può definire l intelligenza artificiale (IA) l insieme di studi e tecniche che tendono alla realizzazione di macchine in grado di risolvere problemi e di riprodurre
Corso di Informatica Modulo T2 1 - Linguaggi e macchine
 Corso di Informatica Modulo T2 1 - Linguaggi e macchine 1 Prerequisiti Principi della comunicazione Rappresentazione simbolica Calcolo delle combinazioni di n oggetti a gruppi di k Dati e istruzioni Utilizzo
Corso di Informatica Modulo T2 1 - Linguaggi e macchine 1 Prerequisiti Principi della comunicazione Rappresentazione simbolica Calcolo delle combinazioni di n oggetti a gruppi di k Dati e istruzioni Utilizzo
Marco Barbiani. Larlun. Tracce di una via filosofica tra Oriente e Occidente
 Marco Barbiani Larlun Tracce di una via filosofica tra Oriente e Occidente ... proprio in questa perfezione della sapienza ci si deve addestrare ed esercitare Astasāhasrikā Prajñāpāramitā [1]... una vita
Marco Barbiani Larlun Tracce di una via filosofica tra Oriente e Occidente ... proprio in questa perfezione della sapienza ci si deve addestrare ed esercitare Astasāhasrikā Prajñāpāramitā [1]... una vita
Guido Alliney Trento, 4 dicembre Libera volontà. Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto
 Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE
 IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE Per
IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE Per
La voce. Dal suono alla parola. voce suoni musica parole
 La voce. Dal suono alla parola voce suoni musica parole la voce è una specie di vento che fa uscire le parole piano piano Chiara Pubblicazione a cura dei bambini e delle bambine della sezione 5 anni A
La voce. Dal suono alla parola voce suoni musica parole la voce è una specie di vento che fa uscire le parole piano piano Chiara Pubblicazione a cura dei bambini e delle bambine della sezione 5 anni A
Introduzione alla storia lezione 7. Prof. Marco Bartoli
 Introduzione alla storia lezione 7 Prof. Marco Bartoli Le fonti Le fonti sono le prime testimonianze dei fatti storici. La ricerca delle fonti è tradizionalmente chiamata euristica. Quanto alla forma le
Introduzione alla storia lezione 7 Prof. Marco Bartoli Le fonti Le fonti sono le prime testimonianze dei fatti storici. La ricerca delle fonti è tradizionalmente chiamata euristica. Quanto alla forma le
F. Va bene, ma che specie di relazione? P. Non so. Una relazione metaforica?
 Perché un cigno? Figlia. Perché un cigno? Padre. Sì, e perché una marionetta in Petruska? F. No... è diverso. Dopo tutto una marionetta è una specie di essere umano... e quella particolare marionetta è
Perché un cigno? Figlia. Perché un cigno? Padre. Sì, e perché una marionetta in Petruska? F. No... è diverso. Dopo tutto una marionetta è una specie di essere umano... e quella particolare marionetta è
Darwiniana Evoluzione e comunicazione
 Darwiniana Evoluzione e comunicazione Dai vermi all intelligenza artificiale a cura di Sergio Bucchi e Stefano Gensini Edizioni ETS www.edizioniets.com Questo volume viene stampato grazie a un contributo
Darwiniana Evoluzione e comunicazione Dai vermi all intelligenza artificiale a cura di Sergio Bucchi e Stefano Gensini Edizioni ETS www.edizioniets.com Questo volume viene stampato grazie a un contributo
HEGEL Fenomenologia dello spirito. Stoccarda Berlino 1831
 HEGEL Fenomenologia dello spirito Stoccarda 1770- Berlino 1831 L assoluto e le parti Le singole cose sono parti o manifestazioni dell assoluto che è inteso come un organismo unitario. Queste parti non
HEGEL Fenomenologia dello spirito Stoccarda 1770- Berlino 1831 L assoluto e le parti Le singole cose sono parti o manifestazioni dell assoluto che è inteso come un organismo unitario. Queste parti non
IL METODO DI STUDIO COME SI STUDIA (VERAMENTE)?
 IL METODO DI STUDIO COME SI STUDIA (VERAMENTE)? PREMESSA: SAPERE PERCHÉ Sempre è fondamentale una domanda: perché si studia? È una bella domanda con la quale iniziare insieme l anno di scuola! Avremo tempo
IL METODO DI STUDIO COME SI STUDIA (VERAMENTE)? PREMESSA: SAPERE PERCHÉ Sempre è fondamentale una domanda: perché si studia? È una bella domanda con la quale iniziare insieme l anno di scuola! Avremo tempo
Limiti di successioni
 Capitolo 5 Limiti di successioni 5.1 Successioni Quando l insieme di definizione di una funzione coincide con l insieme N costituito dagli infiniti numeri naturali 1, 2, 3,... talvolta si considera anche
Capitolo 5 Limiti di successioni 5.1 Successioni Quando l insieme di definizione di una funzione coincide con l insieme N costituito dagli infiniti numeri naturali 1, 2, 3,... talvolta si considera anche
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è
 Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
Alcune nozioni preliminari di teoria elementare di insiemi e funzioni
 Alcune nozioni preliminari di teoria elementare di insiemi e funzioni Alberto Pinto Corso Propedeutico - METS A.A. 2013/2014 1 Insiemi 1.1 Generalità Diamo la definizione di insieme secondo Georg Cantor,
Alcune nozioni preliminari di teoria elementare di insiemi e funzioni Alberto Pinto Corso Propedeutico - METS A.A. 2013/2014 1 Insiemi 1.1 Generalità Diamo la definizione di insieme secondo Georg Cantor,
UNITÀ DIDATTICA 5 LA RETTA
 UNITÀ DIDATTICA 5 LA RETTA 5.1 - La retta Equazione generica della retta Dalle considerazioni emerse nel precedente capitolo abbiamo compreso come una funzione possa essere rappresentata da un insieme
UNITÀ DIDATTICA 5 LA RETTA 5.1 - La retta Equazione generica della retta Dalle considerazioni emerse nel precedente capitolo abbiamo compreso come una funzione possa essere rappresentata da un insieme
Fonologia dei segni. Fonologia delle lingue segniche? Analisi di un segno BANCA
 Fonologia delle lingue segniche? Università degli Studi di Milano Fonologia dei segni Sandro Zucchi 2016-2017 Nel discutere il primo mito sulle lingue segniche ho detto che lingue segniche diverse possono
Fonologia delle lingue segniche? Università degli Studi di Milano Fonologia dei segni Sandro Zucchi 2016-2017 Nel discutere il primo mito sulle lingue segniche ho detto che lingue segniche diverse possono
Gli animali hanno una COSCIENZA, intesa come ESPERIENZA SOGGETTIVA?
 Gli animali hanno una COSCIENZA, intesa come ESPERIENZA SOGGETTIVA? Riflessioni scaturite in seguito alla lettura e all approfondimento del pensiero di Cartesio. CARTESIO riteneva che gli animali fossero
Gli animali hanno una COSCIENZA, intesa come ESPERIENZA SOGGETTIVA? Riflessioni scaturite in seguito alla lettura e all approfondimento del pensiero di Cartesio. CARTESIO riteneva che gli animali fossero
Il corvo e la volpe. Primo testo
 PROVA DI ITALIANO 1 Il corvo e la volpe Ti vengono presentati due testi che raccontano una storia molto antica. Il primo è di Esopo, uno scrittore greco vissuto nel V secolo a.c.: qui lo puoi leggere in
PROVA DI ITALIANO 1 Il corvo e la volpe Ti vengono presentati due testi che raccontano una storia molto antica. Il primo è di Esopo, uno scrittore greco vissuto nel V secolo a.c.: qui lo puoi leggere in
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica. La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio. L articolo
 Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
Paolo Jedlowski. (2002) Il mondo in questione. Introduzione alla storia del pensiero sociologico. Carocci. capitolo 4.
 Paolo Jedlowski (2002) Il mondo in questione. Introduzione alla storia del pensiero sociologico Carocci capitolo 4 su Emile Durkheim Emile Durkheim (1858-1917) Quali domande si faceva Durkheim ci sono
Paolo Jedlowski (2002) Il mondo in questione. Introduzione alla storia del pensiero sociologico Carocci capitolo 4 su Emile Durkheim Emile Durkheim (1858-1917) Quali domande si faceva Durkheim ci sono
Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna. Introduzione
 Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna Introduzione alla Sacra Scrittura appunti per gli studenti a cura del prof. don Gianni Passarella anno 2011/2012 I LEZIONE L ignoranza delle Scritture
Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna Introduzione alla Sacra Scrittura appunti per gli studenti a cura del prof. don Gianni Passarella anno 2011/2012 I LEZIONE L ignoranza delle Scritture
NOZIONI DI LOGICA PROPOSIZIONI.
 NOZIONI DI LOGICA PROPOSIZIONI. Una proposizione è un affermazione che è vera o falsa, ma non può essere contemporaneamente vera e falsa. ESEMPI Sono proposizioni : 7 è maggiore di 2 Londra è la capitale
NOZIONI DI LOGICA PROPOSIZIONI. Una proposizione è un affermazione che è vera o falsa, ma non può essere contemporaneamente vera e falsa. ESEMPI Sono proposizioni : 7 è maggiore di 2 Londra è la capitale
6 Fiducia uno perde la fiducia, con che cosa potrà ancora salvarsi?» e ancora: «La fiducia è comunque sempre necessaria, anche quando essa ti ha abban
 Prefazione Nel i secolo a.c. viveva a Roma un liberto di nome Publilio Siro. Era originario della Siria ed era stato deportato a Roma come schiavo. Grazie alla sua intelligenza e alla sua arguzia fu dichiarato
Prefazione Nel i secolo a.c. viveva a Roma un liberto di nome Publilio Siro. Era originario della Siria ed era stato deportato a Roma come schiavo. Grazie alla sua intelligenza e alla sua arguzia fu dichiarato
Certezza e Verità. Per una introduzione a Cartesio. a cura di Pietro Gavagnin
 Certezza e Verità Per una introduzione a Cartesio a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Certezza e Verità significato Certezza = ciò che è saputo è uno stato del pensare Verità = ciò che è (determinazione
Certezza e Verità Per una introduzione a Cartesio a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Certezza e Verità significato Certezza = ciò che è saputo è uno stato del pensare Verità = ciò che è (determinazione
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI A. MARTINI Castelfranco Veneto (TV) Elementi di Logica
 settembre 008 Elementi di Logica 1. Nozioni preliminari La logica studia come funziona il pensiero e il ragionamento espresso attraverso degli enunciati Il ragionamento è un sistema di enunciati che permette
settembre 008 Elementi di Logica 1. Nozioni preliminari La logica studia come funziona il pensiero e il ragionamento espresso attraverso degli enunciati Il ragionamento è un sistema di enunciati che permette
PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA. ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B
 PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B La ricerca del pensiero Storia, testi e problemi della filosofia Volume 1B UNITA 5 SOCIETA E CULTURA NELL ETA ELLENISTICA CAPITOLO
PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B La ricerca del pensiero Storia, testi e problemi della filosofia Volume 1B UNITA 5 SOCIETA E CULTURA NELL ETA ELLENISTICA CAPITOLO
DIDATTICA DELL ITALIANO (L1-L2) PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL INFANZIA. Dott.ssa Fallea Floriana
 DIDATTICA DELL ITALIANO (L1-L2) PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL INFANZIA LE CONDIZIONI PER L'APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA Tecnicamente saper leggere significa essere capaci di discriminare
DIDATTICA DELL ITALIANO (L1-L2) PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL INFANZIA LE CONDIZIONI PER L'APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA Tecnicamente saper leggere significa essere capaci di discriminare
ho letto sui giornali di questa lettera che 600 docenti universitari hanno scritto per denunciare il fatto che i ragazzi non sanno più scrivere.
 di ALESSANDRA NEGLIA Che anche i Prof non sono poi tanto geni! Caro Governo, ho letto sui giornali di questa lettera che 600 docenti universitari hanno scritto per denunciare il fatto che i ragazzi non
di ALESSANDRA NEGLIA Che anche i Prof non sono poi tanto geni! Caro Governo, ho letto sui giornali di questa lettera che 600 docenti universitari hanno scritto per denunciare il fatto che i ragazzi non
FUNZIONI BOOLEANE. Vero Falso
 FUNZIONI BOOLEANE Le funzioni booleane prendono il nome da Boole, un matematico che introdusse un formalismo che opera su variabili (dette variabili booleane o variabili logiche o asserzioni) che possono
FUNZIONI BOOLEANE Le funzioni booleane prendono il nome da Boole, un matematico che introdusse un formalismo che opera su variabili (dette variabili booleane o variabili logiche o asserzioni) che possono
Pubblicato per. da Mondadori Libri S.p.A. Proprietà letteraria riservata 2018 Mondadori Libri S.p.A., Milano ISBN
 Pubblicato per da Mondadori Libri S.p.A. Proprietà letteraria riservata 2018 Mondadori Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-17-09823-6 Prima edizione: febbraio 2018 Realizzazione editoriale: Studio Editoriale
Pubblicato per da Mondadori Libri S.p.A. Proprietà letteraria riservata 2018 Mondadori Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-17-09823-6 Prima edizione: febbraio 2018 Realizzazione editoriale: Studio Editoriale
Studio Biblico. La Croce di Cristo
 La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
Introduzione all analisi logica. Prof. Stefano Maroni
 Introduzione all analisi logica Prof. Stefano Maroni Analisi Analisi = parola greca che significa esame l analisi grammaticale esaminare le parole e classificarle, riconducendole al proprio gruppo (sostantivi,
Introduzione all analisi logica Prof. Stefano Maroni Analisi Analisi = parola greca che significa esame l analisi grammaticale esaminare le parole e classificarle, riconducendole al proprio gruppo (sostantivi,
La logica della finzione
 Formalizzazione Nella lezione precedente, abbiamo visto qual è l idea di fondo della teoria di Lewis: La logica della finzione Sandro Zucchi 2013-14 Un enunciato della forma Nell opera di finzione f, p
Formalizzazione Nella lezione precedente, abbiamo visto qual è l idea di fondo della teoria di Lewis: La logica della finzione Sandro Zucchi 2013-14 Un enunciato della forma Nell opera di finzione f, p
Traccia di analisi della competenza linguistica e comunicativa. Usa il linguaggio verbale sì no. Usa il corpo per esprimere le sue emozioni sì no
 Traccia di analisi della competenza linguistica e comunicativa a cura di Francesco De Renzo (Facoltà di Studi Orientali, Sapienza-Università di Roma) Comunicazione Interazione In che modo comunica e interagisce:
Traccia di analisi della competenza linguistica e comunicativa a cura di Francesco De Renzo (Facoltà di Studi Orientali, Sapienza-Università di Roma) Comunicazione Interazione In che modo comunica e interagisce:
Scongiurare un pericolo
 http://italianosemplicemente.com/ Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente Scongiurare un pericolo Buongiorno amici. Buona giornata a tutti gli amici di Italiano Semplicemente. Oggi per la sezione
http://italianosemplicemente.com/ Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente Scongiurare un pericolo Buongiorno amici. Buona giornata a tutti gli amici di Italiano Semplicemente. Oggi per la sezione
La conoscenza si fonda sulla ragione o sull'e sperienza?
 La conoscenza si fonda sulla ragione o sull'e sperienza? Platone e Aristotele La luce del sole illumina il mattino, filtrando attraverso le fronde degli alberi Lo scultore francese Auguste Rodin è all'o
La conoscenza si fonda sulla ragione o sull'e sperienza? Platone e Aristotele La luce del sole illumina il mattino, filtrando attraverso le fronde degli alberi Lo scultore francese Auguste Rodin è all'o
Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015
 Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca
Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca
Capire i media. QUINTA lezione. prof. Peppino Ortoleva.
 QUINTA lezione prof. Peppino Ortoleva peppino.ortoleva@gmail.com Capire i media, Understanding Media, il titolo di questo corso è ispirato all opera di un altro autore classico, il canadese Marshall McLuhan.
QUINTA lezione prof. Peppino Ortoleva peppino.ortoleva@gmail.com Capire i media, Understanding Media, il titolo di questo corso è ispirato all opera di un altro autore classico, il canadese Marshall McLuhan.
L'ETÀ ELLENISTICA ED IL NEOPLATONISMO
 L'ETÀ ELLENISTICA ED IL NEOPLATONISMO Argomenti L'età ellenistica Lo Stoicismo Epicuro e l'epicureismo Lo scetticismo Plotino ed il neoplatonismo L'ETÀ ELLENISTICA Influssi della cultura orientale sul
L'ETÀ ELLENISTICA ED IL NEOPLATONISMO Argomenti L'età ellenistica Lo Stoicismo Epicuro e l'epicureismo Lo scetticismo Plotino ed il neoplatonismo L'ETÀ ELLENISTICA Influssi della cultura orientale sul
IMMANUEL KANT. (1724 Germania-1804) INTRODUZIONE
 IMMANUEL KANT (1724 Germania-1804) INTRODUZIONE ILLUMINISMO ROMANTICISMO SAPERE AUDE (Ultimo periodo della sua vita) USCIRE DALLO STATO DI MINORITA Nella CRITICA DEL GIUDIZIO CONDIZIONE DELL UOMO CHE NON
IMMANUEL KANT (1724 Germania-1804) INTRODUZIONE ILLUMINISMO ROMANTICISMO SAPERE AUDE (Ultimo periodo della sua vita) USCIRE DALLO STATO DI MINORITA Nella CRITICA DEL GIUDIZIO CONDIZIONE DELL UOMO CHE NON
1 Combinazioni lineari.
 Geometria Lingotto LeLing5: Spazi Vettoriali Ārgomenti svolti: Combinazioni lineari Sistemi lineari e combinazioni lineari Definizione di spazio vettoriale Ēsercizi consigliati: Geoling 6, Geoling 7 Combinazioni
Geometria Lingotto LeLing5: Spazi Vettoriali Ārgomenti svolti: Combinazioni lineari Sistemi lineari e combinazioni lineari Definizione di spazio vettoriale Ēsercizi consigliati: Geoling 6, Geoling 7 Combinazioni
Complementi di Analisi Matematica Ia. Carlo Bardaro
 Complementi di Analisi Matematica Ia Carlo Bardaro Capitolo 1 Elementi di topologia della retta reale 1.1 Intorni, punti di accumulazione e insiemi chiusi Sia x 0 IR un fissato punto di IR. Chiameremo
Complementi di Analisi Matematica Ia Carlo Bardaro Capitolo 1 Elementi di topologia della retta reale 1.1 Intorni, punti di accumulazione e insiemi chiusi Sia x 0 IR un fissato punto di IR. Chiameremo
SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: FRANCESE CLASSE SECONDA
 Fonti di legittimazione : Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: FRANCESE CLASSE SECONDA
Fonti di legittimazione : Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: FRANCESE CLASSE SECONDA
CONGIUNZIONI COORDINANTI
 COPULATIVE E, anche, inoltre, pure, e anche, né, neanche, neppure CONGIUNZIONI COORDINANTI accostandoli Corro/ e canto DISGIUNTIVE O, oppure, altrimenti, ovvero AVVERSATIVE Ma, tuttavia, però, eppure,
COPULATIVE E, anche, inoltre, pure, e anche, né, neanche, neppure CONGIUNZIONI COORDINANTI accostandoli Corro/ e canto DISGIUNTIVE O, oppure, altrimenti, ovvero AVVERSATIVE Ma, tuttavia, però, eppure,
Articoli determinativi Articoli indeterminativi Articoli partitivi. Gli articoli determinativi sono:
 L articolo Il termine articolo deriva dal latino articulus e vuol dire arto, articolazione. L articolo è quindi quella piccola parte variabile del discorso che ha la funzione di inserire il nome nella
L articolo Il termine articolo deriva dal latino articulus e vuol dire arto, articolazione. L articolo è quindi quella piccola parte variabile del discorso che ha la funzione di inserire il nome nella
Percorso su LIM da Kant all idealismo
 Percorso su LIM da Kant all idealismo CRITICA DELLA RAGION (PURA) PRATICA NON EMPIRICA VOLONTA Massime «SE.. Devi> Imperativi Imperativi ipotetici Imperativo categorico «Tu devi» Formulazioni dell imperativo
Percorso su LIM da Kant all idealismo CRITICA DELLA RAGION (PURA) PRATICA NON EMPIRICA VOLONTA Massime «SE.. Devi> Imperativi Imperativi ipotetici Imperativo categorico «Tu devi» Formulazioni dell imperativo
Sommario. 1. Approccio logico-filosofico. 2. Approccio linguistico. 3. Pragmatica LEZIONE 7
 Sommario LEZIONE 7 1. Approccio logico-filosofico 2. Approccio linguistico 3. Pragmatica Concezione logico-filosofica referente (significato) significato (senso) segno Nota: fra parentesi la terminologia
Sommario LEZIONE 7 1. Approccio logico-filosofico 2. Approccio linguistico 3. Pragmatica Concezione logico-filosofica referente (significato) significato (senso) segno Nota: fra parentesi la terminologia
Paul Grice teoria dell implicatura conversazionale
 Paul Grice teoria dell implicatura conversazionale significato naturale e significato non naturale Grice attira l attenzione su due differenti modi in cui il verbo significare è usato. quelle macchie significano
Paul Grice teoria dell implicatura conversazionale significato naturale e significato non naturale Grice attira l attenzione su due differenti modi in cui il verbo significare è usato. quelle macchie significano
RITI DI INTRODUZIONE
 RITI DI INTRODUZIONE Canto d ingresso: esprime la gioia di incontrare il Signore Il canto serve ad entrare nella celebrazione e a sentirci tutti uniti Segno di croce Nel nome del.... del... e dello.. Saluto:
RITI DI INTRODUZIONE Canto d ingresso: esprime la gioia di incontrare il Signore Il canto serve ad entrare nella celebrazione e a sentirci tutti uniti Segno di croce Nel nome del.... del... e dello.. Saluto:
ELLENISMO STOICISMO- EPICUREISMO- SCETTICISMO FONTI: MASSARO-ABBAGNANO FORNERO-SINI
 ELLENISMO STOICISMO- EPICUREISMO- SCETTICISMO FONTI: MASSARO-ABBAGNANO FORNERO-SINI LE SCUOLE DOPO ARISTOTELE NASCONO VARIE SCUOLE DI ISPIRAZIONE SOCRATICA CHE INSEGNANO LA VIRTU ANCHE CONTRO I VALORI
ELLENISMO STOICISMO- EPICUREISMO- SCETTICISMO FONTI: MASSARO-ABBAGNANO FORNERO-SINI LE SCUOLE DOPO ARISTOTELE NASCONO VARIE SCUOLE DI ISPIRAZIONE SOCRATICA CHE INSEGNANO LA VIRTU ANCHE CONTRO I VALORI
Critica del Giudizio
 Critica del Giudizio Dalle due Critiche ( Critica della Ragion pura e Critica della Ragion pratica) emerge l opposizione tra il mondo naturale, dominato dalla necessità ed estraneo alla morale e allo spirito,
Critica del Giudizio Dalle due Critiche ( Critica della Ragion pura e Critica della Ragion pratica) emerge l opposizione tra il mondo naturale, dominato dalla necessità ed estraneo alla morale e allo spirito,
G.W.F. Hegel. Filosofia dello Spirito. Spirito Assoluto: Arte. Religione. Filosofia
 G.W.F. Hegel Filosofia dello Spirito. Spirito Assoluto: Arte. Religione. Filosofia Spirito Assoluto Spirito Assoluto Negli stati e nella storia lo Spirito trova un incarnazione che resta sempre determinata
G.W.F. Hegel Filosofia dello Spirito. Spirito Assoluto: Arte. Religione. Filosofia Spirito Assoluto Spirito Assoluto Negli stati e nella storia lo Spirito trova un incarnazione che resta sempre determinata
INDICE. Introduzione 9. Funzioni comunicative 52 Come comunicare la frequenza delle azioni Posso Voglio Devo
 INDICE Introduzione 9 1 Essere e Avere 11 Funzioni comunicative 12 Presentarsi 2 I nomi 17 3 Gli articoli determinativi 23 4 Gli articoli indeterminativi 27 5 Gli aggettivi 31 Aggettivi della I classe:
INDICE Introduzione 9 1 Essere e Avere 11 Funzioni comunicative 12 Presentarsi 2 I nomi 17 3 Gli articoli determinativi 23 4 Gli articoli indeterminativi 27 5 Gli aggettivi 31 Aggettivi della I classe:
Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente È la morte sua
 http://italianosemplicemente.com/ Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente È la morte sua Ciao ragazzi, benvenuti su italiano semplicemente. Io sono Giovanni e oggi parliamo di una espressione particolare
http://italianosemplicemente.com/ Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente È la morte sua Ciao ragazzi, benvenuti su italiano semplicemente. Io sono Giovanni e oggi parliamo di una espressione particolare
Primo Anno Terza Lingua Tedesco/Spagnolo
 Nuclei Fondanti Primo Anno Terza Lingua Tedesco/Spagnolo Salutare e presentare se stessi e gli altri in modo formale ed informale; Descrivere se stessi, aspetti del carattere e caratteristiche fisiche;
Nuclei Fondanti Primo Anno Terza Lingua Tedesco/Spagnolo Salutare e presentare se stessi e gli altri in modo formale ed informale; Descrivere se stessi, aspetti del carattere e caratteristiche fisiche;
Presso la nuova civiltà così delineatasi, l arte assunse significati e finalità prima sconosciuti configurandosi come LIBERA ESPRESSIONE DELL
 Quadro di sintesi L origine della civiltà greca si fa risalire ai fenomeni migratori dell XI secolo a.c., quando la popolazione dei Dori calò sulle civiltà già insediatesi nel territorio greco La popolazione
Quadro di sintesi L origine della civiltà greca si fa risalire ai fenomeni migratori dell XI secolo a.c., quando la popolazione dei Dori calò sulle civiltà già insediatesi nel territorio greco La popolazione
Appunti di geometria euclidea
 Appunti di geometria euclidea Il metodo assiomatico Appunti di geometria Euclidea Lezione 1 Prima di esaminare nel dettaglio la Geometria dal punto di vista dei Greci è opportuno fare unrichiamo di Logica.
Appunti di geometria euclidea Il metodo assiomatico Appunti di geometria Euclidea Lezione 1 Prima di esaminare nel dettaglio la Geometria dal punto di vista dei Greci è opportuno fare unrichiamo di Logica.
CURRICOLO DI FRANCESE
 ASCOLTO (comprensione orale A1) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe Prima L allievo/a comprende semplici espressioni e frasi di uso quotidiano e identifica il tema generale di un discorso in cui si
ASCOLTO (comprensione orale A1) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe Prima L allievo/a comprende semplici espressioni e frasi di uso quotidiano e identifica il tema generale di un discorso in cui si
COME FACCIAMO A PARLARE?
 COME FACCIAMO A PARLARE? Caterina Caterina Burcin Vanessa Burcin Vanessa Proviamo tutti a pensare a cosa succede dentro di noi quando parliamo Secondo voi, come facciamo a parlare? Parliamo perché ci sono
COME FACCIAMO A PARLARE? Caterina Caterina Burcin Vanessa Burcin Vanessa Proviamo tutti a pensare a cosa succede dentro di noi quando parliamo Secondo voi, come facciamo a parlare? Parliamo perché ci sono
Sistemi di numerazione
 Sistemi di numerazione Sistema di numerazione decimale Sapete già che il problema fondamentale della numerazione consiste nel rappresentare con un limitato numero di segni particolari, detti cifre, tutti
Sistemi di numerazione Sistema di numerazione decimale Sapete già che il problema fondamentale della numerazione consiste nel rappresentare con un limitato numero di segni particolari, detti cifre, tutti
RELATIVISMO. OPINIONE Doxa. Sensi. Conoscenza. relativa. Molteplice varia nello Spazio RELATIVISMO. Impossibilità verità Universale e Immutabile
 RELATIVISMO OPINIONE Doxa Sensi Conoscenza relativa Mutevole varia nel Tempo Molteplice varia nello Spazio Soggettiva varia nei diversi soggetti RELATIVISMO Impossibilità verità Universale e Immutabile
RELATIVISMO OPINIONE Doxa Sensi Conoscenza relativa Mutevole varia nel Tempo Molteplice varia nello Spazio Soggettiva varia nei diversi soggetti RELATIVISMO Impossibilità verità Universale e Immutabile
NOZIONI DI LOGICA. Premessa
 NOZIONI DI LOGICA Premessa Il compito principale della logica è quello di studiare il nesso di conseguenza logica tra proposizioni, predisponendo delle tecniche per determinare quando la verità di una
NOZIONI DI LOGICA Premessa Il compito principale della logica è quello di studiare il nesso di conseguenza logica tra proposizioni, predisponendo delle tecniche per determinare quando la verità di una
Gli Angeli della Cupola della Creazione di San Marco a Venezia
 Iconografia B Gli Angeli della Cupola della Creazione di San Marco a Venezia La Cupola della Creazione si trova nel nartece della Basilica di San Marco a Venezia. La decorazione, interamente a mosaico,
Iconografia B Gli Angeli della Cupola della Creazione di San Marco a Venezia La Cupola della Creazione si trova nel nartece della Basilica di San Marco a Venezia. La decorazione, interamente a mosaico,
Sacra Scrittura e Simbolo
 Sacra Scrittura e Simbolo La pagina biblica è un «grande codice» La Bibbia è costituita da tre lingue: 1. ebraico; 2. Aramaico; 3. Greco. Due mondi: 1. Semitico; 2. Greco. La Bibbia è CONTEMPORANEAMENTE
Sacra Scrittura e Simbolo La pagina biblica è un «grande codice» La Bibbia è costituita da tre lingue: 1. ebraico; 2. Aramaico; 3. Greco. Due mondi: 1. Semitico; 2. Greco. La Bibbia è CONTEMPORANEAMENTE
Pregiudizio logocentrico
 Pregiudizio logocentrico L idea infinite volte ripetuta o presupposta nella storia occidentale, e quasi solo nella storia occidentale, che la parola sia condizione di ogni pensare e quindi di ogni agire
Pregiudizio logocentrico L idea infinite volte ripetuta o presupposta nella storia occidentale, e quasi solo nella storia occidentale, che la parola sia condizione di ogni pensare e quindi di ogni agire
Introduzione. - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare
 Falsiroli Simonetta 1 Introduzione Scopi: - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare - Focalizzare l attenzione ai riferimenti matematici contenuti nel testo 2 1 L opera:
Falsiroli Simonetta 1 Introduzione Scopi: - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare - Focalizzare l attenzione ai riferimenti matematici contenuti nel testo 2 1 L opera:
Funzioni dell apostrofo
 L apostrofo Funzioni dell apostrofo L elisione di una lettera nel caso di vocali contigue che si trovano in due parole in sequenza Il troncamento i finali Po L imperativo Anticamente (poesia) si troncava
L apostrofo Funzioni dell apostrofo L elisione di una lettera nel caso di vocali contigue che si trovano in due parole in sequenza Il troncamento i finali Po L imperativo Anticamente (poesia) si troncava
Morfologia e sintassi
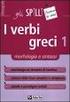 Morfologia e sintassi Organizzando la biblioteca in seconda Agli alunni sono stati consegnati piccoli gruppi di libri affinché ne leggano il titolo e individuino la prima lettera del titolo, per poter
Morfologia e sintassi Organizzando la biblioteca in seconda Agli alunni sono stati consegnati piccoli gruppi di libri affinché ne leggano il titolo e individuino la prima lettera del titolo, per poter
Cerchiamo di capire che cosa questo significa
 http://filosofia.dipafilo.unimi.it/~paganini/index.html A tutti appare chiaro che Quando leggiamo una frase ambigua facciamo molto fatica a cogliere l ambiguità, noi leggiamo la frase in base a una certa
http://filosofia.dipafilo.unimi.it/~paganini/index.html A tutti appare chiaro che Quando leggiamo una frase ambigua facciamo molto fatica a cogliere l ambiguità, noi leggiamo la frase in base a una certa
PASSI BIBLICI DIFFICILI
 Anselm Grün PASSI BIBLICI DIFFICILI Interpretati in chiave spirituale Queriniana Introduzione La Bibbia è la base essenziale del cristianesimo. E a volte non è per niente facile. Nel l Antico Testamento,
Anselm Grün PASSI BIBLICI DIFFICILI Interpretati in chiave spirituale Queriniana Introduzione La Bibbia è la base essenziale del cristianesimo. E a volte non è per niente facile. Nel l Antico Testamento,
Stile personale di apprendimento
 Stile personale di apprendimento Come scoprire il proprio stile di apprendimento attraverso l analisi dei diversi tipi di intelligenza A cura della Dott.ssa Eleonora Crestani Come scoprire il proprio stile
Stile personale di apprendimento Come scoprire il proprio stile di apprendimento attraverso l analisi dei diversi tipi di intelligenza A cura della Dott.ssa Eleonora Crestani Come scoprire il proprio stile
PARMENIDE-ZENONE LA SCUOLA ELEATICA
 PARMENIDE-ZENONE LA SCUOLA ELEATICA Antonia D Aria Dispensa ad uso degli studenti del Liceo Natta di Milano BIBLIOGRAFIA: MASSARO Il pensiero che conta SINI I filosofi e le opere ALTRO MATERIALE SCARICATO
PARMENIDE-ZENONE LA SCUOLA ELEATICA Antonia D Aria Dispensa ad uso degli studenti del Liceo Natta di Milano BIBLIOGRAFIA: MASSARO Il pensiero che conta SINI I filosofi e le opere ALTRO MATERIALE SCARICATO
Esercizi di rappresentazione
 Esercizi di rappresentazione Sandro Zucchi 2013-14 Primo esercizio (connettivi vero-funzionali - Bonevac) Quale dei connettivi seguenti è vero-funzionale? (Se classifichi un connettivo come vero-funzionale,
Esercizi di rappresentazione Sandro Zucchi 2013-14 Primo esercizio (connettivi vero-funzionali - Bonevac) Quale dei connettivi seguenti è vero-funzionale? (Se classifichi un connettivo come vero-funzionale,
L uomo immagine di Dio in Salita e Notte di san Giovanni della Croce
 SAVERIO FINOTTI L uomo immagine di Dio in Salita e Notte di san Giovanni della Croce prefazione di LUIGI BORRIELLO, OCD 2010 Prefazione L uomo immagine di Dio in Salita e Notte di Giovanni della Croce
SAVERIO FINOTTI L uomo immagine di Dio in Salita e Notte di san Giovanni della Croce prefazione di LUIGI BORRIELLO, OCD 2010 Prefazione L uomo immagine di Dio in Salita e Notte di Giovanni della Croce
