CORSO DI LIS Linguaggio Italiano dei Segni. La grammatica Fonologia, morfologia e sintassi
|
|
|
- Carlo Roberto
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CORSO DI LIS Linguaggio Italiano dei Segni La grammatica Fonologia, morfologia e sintassi
2 FONOLOGIA MORFOLOGIA E SITASSI DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 1. Fonologia della LIS I primi studi sulla fonologia della lingua dei segni risalgono agli anni sessanta, quando William Stokoe2, osservando i segni dell American Sign Language (ASL), individuò tre parametri di formazione dei segni3: configurazione, luogo e movimento; in un secondo momento, ulteriori analisi hanno condotto all individuazione della posizione delle mani, scomponibile in orientamento del palmo e direzione del metacarpo4. Anche se nel corso degli ultimi decenni le ricerche sulla fonologia delle lingue dei segni hanno suggerito ulteriori modelli di analisi fonologica5, in Italia le indagini svolte sulla LIS hanno privilegiato la suddivisione in parametri di formazione dei segni, opportunamente adattata alla LIS. In questo paragrafo riepilogherò le analisi dei quattro parametri di formazione dei segni nella versione indicata per lo studio della fonologia della 40
3 LIS, in quanto propedeutici alla comprensione dei capitoli successivi. Per quanto riguarda la notazione della LIS, gli studi realizzati fin ora6 non hanno condotto ancora ad una definizione sufficientemente agevole ed univoca di una forma scritta; le varie forme di notazione, che per la maggior parte utilizzano programmi software, sono state ideate partendo dalle necessità contingenti dettate dalla ricerca che si stava conducendo. Infatti, i vari sistemi vengono utilizzati soprattutto dagli studiosi. Il modello fonologico proposto qui ha una sua notazione, schematizzato nelle tavole 1 e 2 per la quale rimandiamo a Radutzky (1992). I parametri di formazione dei segni della LIS Come per l American Sign Language, ogni segno della LIS può essere scomposto in quattro parametri di formazione dei segni: configurazione (che corrisponde alla posizione assunta dalla mano), luogo (che sarebbe il punto, del corpo o dello spazio, in cui 41
4 il segno viene articolato), movimento (che descrive il tipo di movimento che la mano esegue durante l articolazione del segno) e infine posizione delle mani (la disposizione delle mani rispetto al segnante e dell una rispetto all altra). I tratti distintivi dei segni sono stati individuati sulla base di coppie minime, vale a dire di una coppia di segni che ha in comune tutti i parametri eccetto uno; ad esempio la coppia di segni AFRICA e SODDISFAZIONE hanno in comune configurazione, movimento e posizione delle mani; cambia però il luogo di articolazione che per il primo è davanti al volto, per il secondo sul petto. Ogni lingua dei segni seleziona solo alcuni tipi di parametri tra quelli anatomicamente possibili che la caratterizzano rispetto alle altre. Ad esempio la configurazione W (indice, medio e anulare stesi) che è molto diffusa in ASL perchè corrispondente all iniziale di molti termini americani, non viene utilizzata nella LIS. 42
5 La configurazione Per le configurazioni manuali della LIS si veda la tavola n.1, allegata, dove sono indicate tutte quelle possibili eccetto le forme allofone7 che generalmente ricorrono in seguito a fenomeni di coarticolazione. Luoghi In LIS sono stati individuati 16 luoghi di articolazione dei segni8 (tavola 2): sorprende vedere come 15 di essi siano collocati sul corpo mentre lo spazio neutro, che corrisponde allo spazio antistante il corpo del segnante, è uno solo. Se fonologicamente lo spazio è un parametro indistinto, per questo è neutro, esso non lo è dal punto di vista morfologico e sintattico, nei capitoli successivi si chiarirà che se da un lato lo spazio neutro ha la funzione di luogo dell indifferenziato, dell impersonalità, dall altro le relazioni morfosintattiche si stabiliscono in punti ben precisi 43
6 determinando così la specificità dello spazio morfosintattico che si oppone alla neutralità dello spazio fonologico. Per quanto riguarda i segni articolati sul corpo occorre precisare che le mani non devono essere necessariamente in contatto con il punto identificato. È sufficiente che siano molto prossime ad esso: le articolazioni su determinati punti del viso, come occhio, naso e bocca, tendono a spostarsi più in basso o al lato per consentire una maggiore visibilità di movimenti labiali ed espressioni del volto (Radutzky 1990, 2000). La localizzazione dei segni sul corpo e nello spazio neutro determina una serie di regolarità morfologiche e sintattiche poiché i primi subiscono delle restrizioni su movimento e spostamento mentre i secondi sono liberi di muoversi e di spostarsi nello spazio neutro determinando così flessioni e concordanze. 44
7 Movimenti Il parametro del movimento è il più difficile da descrivere: un segno contemporaneamente può incorporare più tipi di movimento; inoltre può essere eseguito lentamente, velocemente, può essere bloccato o allungato (per i particolari si rimanda ai vari tipi di movimento schematizzati nella tavola 2). Per questo motivo più studiosi si sono interessati all argomento9 e, come è stato accennato all inizio del capitolo, sono stati proposti modelli fonologici diversi. Friedman (1978) suddivide i tratti di movimento in quattro categorie: Direzione, Maniera, Contatto, Interazione. Osservando questo parametro alla luce dei citati studi sull ASL, Radutzky (1987) ripropone la stessa suddivisione della Friedman e la rivisita per la LIS fissando così le categorie e individuando per ognuna di esse dei simboli per i quali si rimanda alla tabella allegata10. 45
8 Posizione delle mani Per posizione delle mani si considera quella precedente all inizio del movimento. Essa è data dalla combinazione di orientamento del palmo (che può essere rivolto in avanti, o verso il segnante, o verso il lato destro o quello sinistro, verso l alto o il basso) e direzione della mano rispetto al corpo del segnante. Ciò che viene riferito a direzione della mano è l asse che va dal polso al metatarso; anche quest asse può avere gli stessi sei orientamenti del palmo appena descritti; anatomicamente però non tutte le combinazioni sono possibili o comode. Ad esempio con il palmo della mano sinistra rivolto verso il segnante, la direzione dell asse polso-metatarso può essere orientata verso l alto, verso destra e, se si coinvolge il sollevamento del gomito, anche verso il basso. La mano destra, con lo stesso orientamento del palmo potrà essere direzionata in maniera speculare alla prima: in alto, a sinistra e in basso. Nei segni a due mani va considerata anche la posizione di una mano rispetto all altra. 46
9 47
10 48
11 49
12 2. I tratti sovrasegmentali I tratti sovrasegmentali in LIS sono costituiti da un complesso di espressioni, coinvolgenti il volto (dall'inarcamento delle sopracciglia alla direzione dello sguardo), il corpo (come la postura della testa o del busto) e i movimenti delle labbra, che accompagnano la produzione di segni manuali. Diversi studi sulle lingue dei segni (Neidle ed altri 1997, 2002, Bahan1996, Corina Bellugi e Reily 1999 per l ASL e Franchi 1987, Pizzuto ed altri 1990, Cecchetto Geraci e Zucchi, 2004a, 2004b per la LIS) hanno mostrato che tali tratti costituiscono un complemento importante del sistema fonologico, morfologico e sintattico, il loro ruolo è paragonabile a quello dell intonazione nelle lingue verbali. In morfologia i tratti sovrasegmentali assolvono a varie funzioni: ad esempio la torsione della testa e del busto, insieme alla direzione dello sguardo contribuiscono alla specificazione dei ruoli tematici del verbo; specifiche espressioni del volto e posture contribuiscono alla definizione dei gradi dell aggettivo. 50
13 Alterazioni di alcuni tratti di movimento come l accelerazione, l interruzione improvvisa o il rallentamento, non solo modificano il significato dei verbi ma assumono anche una connotazione espressiva: un segnato ampio, fatto di gesti grandi, equivale all urlato delle lingue orali, un segnato ristretto e poco marcato ha la stessa valenza del bisbigliato. In sintassi i tratti sovrasegmentali coadiuvano la definizione del significato e della funzione di alcuni tipi di preposizioni poichè sono coestensive sia all articolazione manuale del segno, corrispondente alla testa della categoria funzionale considerata, sia al suo dominio di c-comando. In altre parole è l espressione che caratterizza i tipi di preposizioni. Alcuni studi sulla LIS hanno dimostrato che i tratti sovrasegmentali caratterizzano le frasi interrogative sì/no e Wh- (Cecchetto, Geraci e Zucchi 2004b), la frase relativa (Branchini e Donati 2005) e la frase negativa Geraci (2006). In questo studio verranno illustrate le espressioni del volto e le posture coinvolte nel sintagma determinante. 51
14 In LIS specifiche marcature, che coinvolgono posture e direzioni dello sguardo, sono state identificate come body markers, la loro funzione è stata considerata come parte del fenomeno dell impersonamento (Aiello 1997; Pizzuto e altri 1990). L impersonamento può essere accostato al discorso diretto delle lingue orali in quanto il segnante impersona il soggetto (animato) della frase. Esso viene attivato da due parametri: la collocazione nello spazio immaginario dei personaggi e lo spostamento dello sguardo che astrae la conversazione dall interlocutore reale e la rivolge ad un interlocutore immaginario. La collocazione nello spazio è sempre esplicita. Durante la narrazione lo spostamento dello sguardo verso un punto è già un segnale di impersonamento: è il body marker che indica che non si sta più parlando all interlocutore, ma si sta assumendo il ruolo del soggetto della narrazione. Questo cambiamento di ruolo del narratore non è introdotto da espressioni, avviene senza locuzioni particolari. Il cambiamento di espressione e la direzione dello sguardo, sono gli elementi che 52
15 introducono il soggetto del discorso e il suo interlocutore collocato nel punto in cui si direziona lo sguardo. In questa maniera vengono stabiliti i punti dello spazio che marcano i ruoli e ogni qualvolta ci si vuole riferire ad uno di essi, occorre ruotare il busto o le spalle e collocarsi nella sua direzione. In questo senso l impersonamento è grammaticalizzato in quanto direzionando sguardo e postura vengono indicati i ruoli assunti dai soggetti della narrazione. L impersonamento, quindi, è consentito solo con le entità animate. L uso dei body markers consente un diverso ordine dei segni nella frase. E stato notato (Pizzuto ed altri 1990) che alcuni tipi di frasi, che nella forma non marcata avrebbero come ordine Soggetto-Verbo-Oggetto, con l uso dei body markers possono avere un ordine diverso. Inoltre sembra che la forma passiva dei verbi sia resa possibile solo attraverso l impersonamento. 53
16 3. Morfologia In LIS, come in altre lingue dei segni, le variazioni morfologiche dei processi flessivi si manifestano nello spazio. Il segnante arbitrariamente individua dei punti ai quali associa le diverse entità del discorso, ciascun punto individuato è impiegato per stabilire le concordanze con l elemento ad esso associato. Gli studi condotti fin ora sulla LIS (Volterra 1987; Pizzuto ed altri, 1995 per citarne alcuni) individuano le classi nominali e verbali dei segni sulla base del punto di articolazione dei segni. Poiché la flessione è legata a variazioni dei tratti di movimento, luogo e orientamento, un segno articolato su una parte del corpo non offre molte possibilità di variazioni perché i punti di articolazione sul corpo sono parametrizzati, vale a dire che ogni punto del corpo costituisce un tratto fonologico distintivo del segno per cui variando il luogo di articolazione e direzione del movimento, cambia il suo significato. Nello spazio, invece, non sono state individuate coppie minime di segni. Per questa ragione esso è neutro. Tuttavia dal punto di vista morfosintattico lo 54
17 spazio non è neutro, infatti è il luogo dove si realizzano le variazioni grammaticali. Le flessioni perciò vengono effettuate attraverso le seguenti alterazioni: Luogo: i punti di articolazione dei segni, essendo legati agli argomenti collocati nello spazio, variano in funzione di questi. Il luogo è anche il parametro delle informazioni riguardanti il tempo: la prossimità dal segnante segnala la prossimità dell evento (verso il futuro in avanti e verso il passato sulle spalle). Orientamento e della direzione: il verso di un verbo stabilisce relazioni di reciprocità, le direzioni (ad esempio nei verbi di movimento) marcano agente e paziente o agente e beneficiario. Nelle espressioni di tempo il palmo orientato verso avanti segnala posteriorità mentre orientato verso il segnante segnala anteriorità. Numero: la ripetizione di un segno assumere diversi significati: se si accompagna anche ad una variazione dei punti di articolazione, ha un senso di pluralità o distribuzionalità; se la 55
18 ripetizione mantiene inalterati gli altri tratti, indica ripetitività o abitualità dell evento. L articolazione con due mani, per i segni ad una mano, assume valore rafforzativo o significato di numerosità o di impersonalità. Durata e dell ampiezza del segno: questo tipo di alterazione veicola modalità e aspettualità; essa segnala un evento abituale, un atto lento o repentino o veloce o improvviso. Postura e delle componenti non manuali: questo tipo di alterazioni sono abbastanza complesse in quanto in esse vanno distinte quelle che determinano una variazione morfosintattica (come i body markers, espressioni legate a particolari proposizioni, flessioni) e quelle che sono legate ad espressioni tipiche del dialogo (come l intonazione e l espressività in genere). La flessione per aspetto, come ad esempio l iterazione che veicola ripetitività o abitualità, oppure la l ampiezza del segno che veicola la dimensione di un elemento11, caratterizzano i nomi, i verbi e gli aggettivi. Ad esempio il segno per tondo, articolato in maniera ampia significa un grande tondo, il segno 56
19 per malato ripetuto significa sempre ammalato. Il segno uovo ripetuto significa tante uova. L iterazione però non veicola tanto il senso di quantità, essa ha più propriamente il senso della numerosità, vale a dire che il plurale non richiede necessariamente la ripetizione di nome verbo e aggettivo, che sembra essere determinata per lo più da un valore enfatico, né richiede concordanza. Infatti una frase può presentare il verbo al plurale ed il nome al singolare (frase 1) il nome al plurale ed il verbo al singolare (frase 2) nome e verbo al singolare ed il plurale veicolato da un aggettivo di quantità (frase 3). Gli elementi che veicolano pluralità sono in neretto, la numerosità è contrassegnata dal simbolo + al pedice. 57
20 La flessione per aspetto merita uno studio approfondito che non è possibile affrontare in questa sede, mi limiterò solo a coglierne alcuni aspetti necessari a spiegare alcuni fenomeni grammaticali. La distinzione in diverse classi dei nomi e dei verbi realizzata da Volterra ad altri (1987) poggia le sue basi proprio sul tipo di variazione che ognuna di esse consente: più è possibile variare la posizione, il verso e l orientamento del palmo più il sistema flessivo è aperto. Il criterio di distinzione delle classi nominali e verbali quindi è legato al tipo di flessività. Nei prossimi paragrafi considererò le classi nominali e verbali e il tipo di flessione che ognuna di esse ammette. 58
21 4. La flessione nominale Le ricerche realizzate sulla LIS (Pizzuto, 1987; Pizzuto ed altri, ) hanno individuato due classi di nomi: la prima, invariabile, nella quale vengono raggruppati i nomi articolati sul corpo (dalla testa al tronco); la seconda, flessiva, raccoglie i nomi articolati nello spazio neutro. La flessione dei nomi considerata da Pizzuto ed altri (1997) è quella per numero. Nei prossimi capitoli vedremo che la flessione non riguarda solo la possibilità di iterazione del nome e quindi di pluralizzazione, ma riguarda anche la concordanza con un verbo attraverso la localizzazione in un luogo specifico dello spazio e la concordanza di specifici tratti di forma. Per quanto riguarda il genere, se molte in molte lingue il genere o la classe viene marcato dal nome stesso, o dall articolo, o da un morfema (come accade per l italiano in cui i nomi marcano i due generi: maschile e femminile), ci sono molte lingue in cui la categorizzazione dei nomi è affidata ai classificatori (Aikehnvald, 2000). 59
22 La LIS è una lingua di quest ultimo tipo, infatti, i classificatori categorizzano i nomi numerabili e concreti. Nel capitolo 4 si chiarirà il tipo di categorizzazione che i classificatori operano sui nomi. I nomi articolati nello spazio consentono concordanze del nome con il verbo attraverso l articolazione del segno da un punto generico ad uno specifico, inoltre consentono all articolazione del nome di essere spostata, di essere ripetuta nello stesso luogo, di essere ripetuta nello spazio, di subire alterazioni quali l ampiezza del segno o il movimento nello spazio. I nomi articolati sul corpo non permettono tutte queste variazioni, molte di esse infatti vengono assunte dai classificatori i quali perciò non solo categorizzano i nomi, ma costituendo delle proforme del nome, ne assumono anche le variazioni di articolazione. Ad esempio il nome città è articolato nello spazio. L articolazione può essere localizzata in un punto specifico dello spazio, concordando ad esempio con un predicato, oppure può essere modificata nell ampiezza così da incorporare i tratti di dimensione: città 60
23 grande sarà articolato con un segno ampio, città piccola con un segno ristretto; infine l articolazione può essere iterata in diversi punti dello spazio veicolando significato di numerosità. Un nome articolato sul corpo, come pecora, non può essere modificato nelle dimensioni quindi richiede un aggettivo di dimensione, espresso in forma lessicale e non sottoforma di tratti. Un nome segnato sul corpo per essere localizzato nello spazio richiede un classificatore o un indicazione, per essere iterato richiede un classificatore. Nel paragrafo seguente vedremo che l uso dei classificatori rende omogeneo il comportamento morfologico delle due classi di nomi e che ci sono ulteriori elementi da considerare per una diversa sottocategorizzazione dei nomi. Nel paragrafo successivo esporrò molto brevemente alcune caratteristiche dei classificatori nominali, che ci aiuteranno a comprendere l uso che se ne fa in LIS. 61
24 I classificatori in LIS Il termine classificatore generalmente è utilizzato per indicare un sistema di categorizzazione dei nomi, per questo motivo i classificatori possono essere distinti in diverse tipologie a seconda del significato, dello status, delle condizioni di uso, della funzione. La definizione del ruolo (o dei molteplici ruoli) dei classificatori in LIS è un compito molto complesso, perché essi interagiscono con differenti tipi di elementi linguistici assumendo di volta in volta un valore diverso. Sulla base della descrizione dei classificatori operata da Aikhenvald (2000), in LIS sono individuabili classificatori nominali, numerali, locativi, deittici e verbali. Ogni tipo di classificatore richiederebbe uno studio approfondito e monotematico. Poiché, per ovvie ragioni, non è possibile affrontarlo in questa sede e, poiché il sintagma determinante, che è il filo conduttore 62
25 degli argomenti trattati, non può prescindere dalla sua trattazione, sebbene con molti limiti perché non esistono studi sul suo status grammaticale, discuterò del classificatore solo quando è importante per completare un quadro di riferimento. In questo paragrafo fornirò alcuni elementi necessari per comprendere la modalità di selezione del classificatore, in seguito si chiariranno alcuni contesti di uso. La descrizione non è esauriente tuttavia fornisce alcuni elementi utili alla comprensione del DP in LIS; essa ha lo scopo di tracciare alcuni sentieri di ricerca. Innanzitutto osserveremo i tratti morfologici dei classificatori sulla cui base viene operata una prima sottocategorizzazione dei nomi, poi daremo un rapido sguardo ai contesti d uso e vedremo che attraverso l incorporazione di tratti semantici i classificatori, originariamente nominali possono diventare locativi, deittici, numerali e verbali. Infine daremo un ultimo sguardo ad altre forme di sottocategorizzazione dei nomi. 63
26 Elementi di morfologia dei classificatori In LIS la sottocategorizzazione dei nomi è stabilita dalla tipologia di classificatore che il nome seleziona. La selezione dei classificatori avviene su base semantica e generalmente si riferisce alle caratteristiche esteriori del nome. Corazza (1990) ha individuato gli elementi semantici sulla cui base viene selezionato il classificatore e ha distinto i classificatori in cinque categorie principali. a. Classificatori di presa. Sono stabiliti dalla posizione e dalla forma che la mano deve assumere per tenere in mano l entità considerata. Ad esempio tenere in mano un bicchiere fa assumere alla mano una posizione ed una configurazione diversa che tenere mano una canna da pesca oppure un foglio. Ognuna delle posizioni che la mano assume costituisce un classificatore di presa diverso. b. Classificatore di superficie. In questa categoria la forma che la manoassume, rappresenta la superficie dell oggetto che intende rappresentare. 64
27 Ad esempio un foglio avrà una configurazione idonea a designare una superficie ampia, compatta e liscia (conf. B), mentre un nastro avrà una configurazione (H) 12 con superficie più ristretta. c. Classificatore descrittivo. In cui la mano assume la forma idonea a descrivere un entità, ad esempio descrivere una linea nello spazio richiede la punta dell indice, descrivere una striscia richiede la punta dell intera mano. d. Classificatore di perimetro. In questa categoria la mano assume la forma del perimetro dell entità che rappresenta, ad esempio un perimetro circolare viene realizzato con due mani che assumono la configurazione C: in questo modo si possono designare le forme cilindriche; oppure l angolo retto viene realizzato con la configurazione L.: la forma assunta dalla mano rimanda a referenti come il perimetro di una cornice o di un quadro. e. Classificatore di volume/quantità. La configurazione della mano in questa categoria dà informazioni circa il peso e il 65
28 volume. Questo tipo di classificatore è utilizzato anche per designare i liquidi. Ad esempio la sigaretta che si accorcia o il liquido in un bicchiere. Corazza (1990) nell individuare la morfologia dei classificatori ha specificato anche alcune restrizioni, soprattutto di tipo morfologico, sul loro uso. Da un punto di vista semantico ciò che emerge da quest analisi è che tutti i tipi di classificatori individuati sono riconducibili alla forma del nome. Il classificatore nominale, selezionato sulla base della forma del nome, può incorporare altri tratti semantici. Parte del capitolo 4 sarà dedicato a questo argomento. Contesti di uso dei classificatori Ai fini dell analisi sintattica, oltre a comprendere come avviene la selezione del classificatore, ci interessa chiarire i contesti d uso del classificatore. 66
29 Le principali circostanze in cui si osserva l utilizzo dei segni classificatori sono legate a diversi contesti linguistici, ad esempio vengono utilizzati come morfemi per creare alcuni neologismi. In questa sede individuerò quelli che ci aiutano a comprendere alcuni fenomeni sintattici. I classificatori co-occorrono con il nome e sono elementi semanticamente legati al nome in quanto fungono da proforma del nome, sintatticamente però occorre indagare quando sono più assimilabili agli elementi anaforici, quando ai pronominali e quando alle espressioni referenziali. I contesti di uso sono i seguenti: Proprio perché specificano le proprietà esteriori di un entità, i classificatori ricorrono nelle descrizioni, che riguardano la forma. I classificatori, incorporando i tratti di luogo, aiutano a stabilire alcune relazioni spaziali tra gli elementi di una frase. Sostituendosi al nome, ne indicano la posizione nello spazio e la relazione di prossimità che intrattiene con gli altri elementi 67
30 (sopra sotto di fianco eccetera) La disposizione spaziale può alludere anche ad una prossimità di tipo concettuale come il grado di parentela ad esempio. Le relazioni spaziali sono la base della costruzione di molti sintagmi preposizionali. I classificatori, come proforma del nome, vengono largamente adoperati nella flessione dei nomi non flessivi e, come vedremo nel capitolo 4, anche di molti nomi flessivi. Quando utilizzati per i plurali, codificano informazioni sulla disposizione nello spazio. Nell uso comune della LIS spesso i classificatori si comportano da verbi: la radice lessicale, data dalla configurazione manuale, incorpora i morfemi costituiti dai tratti di movimento che sono di matrice verbale.13 I classificatori, incorporando i tratti di numero, veicolano informazioni sul duale per tutti i classificatori numerabili, oppure con numerazioni fino a quattro se l elemento nominale ha una forma lunga, cioè assimilabile alla forma di un dito della mano. 68
31 I Classificatori Nominali Poiché l interesse principale di questo studio è la categoria del nome, illustrerò principalmente i classificatori nominali in quanto essi hanno un ruolo importante nella costituzione del DP perché veicolano diversi tratti. Ci sono numerose prove empiriche a sostegno dell ipotesi che alcuni tipi di classificatori appartengono al DP. Un primo fatto è costituito dagli elementi prosodici: il tratto sovrasegmentale che caratterizza il DP occorre anche sul classificatore. Ad esempio: Nella frase 4 si può osservare come il tratto sovrasegmentale del DP è coestensivo al nome e al classificatore. La seconda prova è costituita dal fatto i tratti del classificatore, selezionato sulla base della forma del nome, codificano la modificazione del nome. Ad esempio i tratti di 69
32 forma e di volume del classificatore della frase 4 qualificano la forma e la dimensione nome. Il classificatore è una proforma del nome e lo sostituisce nelle flessioni. Ad esempio molti plurali vengono realizzati attraverso la ripetizione nello spazio del classificatore che con il quale ricorre con il nome che non può essere reduplicato. Nella frase 5 il classificatore oltre a specificare forma e posizione del nome specifica anche il numero perché è ripetuto nello spazio (segnalato nella glossa dai simboli ++). La quarta prova empirica è data dal fatto che i tratti di luogo del classificatore costituiscono la referenzialità del nome. In seguito si chiarirà che attraverso il classificatore è possibile definire i tratti dello spazio che costituiscono la referenzialità del nome. In presenza di un nome accompagnato dal classificatore nominale, il verbo concorda con il classificatore. ad esempio nella 70
33 frase 6 il l nome è al singolare, il verbo viene ripetuto nello spazio in corrispondenza dei luoghi in cui sono statiarticolati rispettivamente i classificatori. In questo modo si osserva come la flessione verbale concordi con il classificatore nominale. Incorporazione dei tratti di numero e luogo nel classificatore. Fin ora abbiamo visto la morfologia dei classificatori e, in base al contesto d uso, abbiamo visto che in LIS i classificatori nominali, assimilando vari tratti possono trasformarsi in classificatori numerali, verbali, locativi. Più avanti, nel capitolo 6, vedremo come essi assumono anche una funzione deittica. Per il momento guardiamo i tipi di tratti che incorporano. 71
34 Ho già affermato che la selezione può essere riconducibile alla forma del nome; il classificatore di forma che utilizza le dita può incorporare anche i tratti di numero occorre però che le dita siano rappresentative della forma dell entità rappresentata, vale a dire che in LIS le entità strette e lunghe (persone, fili, tubi, alberi eccetera) che possono essere rappresentate dalle dita di una mano possono selezionare una classificatore numerale fino quattro. Ad esempio quattro alberi in fila. Gli altri nomi possono solo selezionare il classificatore numerale duale costituito da un classificatore di forma per ogni mano. Ad esempio il classificatore per libro, articolato da ognuna delle due mani, significa due libri, con lo stesso tipo di classificatore non è possibile incorporare un numero maggiore a due. Nel capitolo 4 esaminerò nel dettaglio questo aspetto. Il classificatore di forma può incorporare anche i tratti di luogo diventando così classificatore locativo come si può osservare nella frase 7. 72
35 La categoria del luogo è data dalla posizione degli elementi nello spazio e dalla loro relazione (avanti, dietro eccetera). In LIS, se occorre stabilire la relazione tra gli elementi, l uso dei classificatori locativi è sempre necessario. Il classificatore deittico è associato alla deissi, la modalità di incorporazione dei tratti non differisce da quella illustrata per il classificatore locativo. Un classificatore (selezionato sempre sulla base della forma) è deittico quando la sua localizzazione identifica una specifica entità rispetto ad un altro oppure assume un valore anaforico. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 6. Benché sia riconosciuto che i classificatori sono elementi lessicali che fanno parte della lingua, essi non hanno ancora un posto nei dizionari LIS questo perché essendo elementi che incorporano più tratti è difficile cristallizzarli in una forma definita citazionalmente. 73
36 I classificatori come elementi di categorizzazione dei nomi Abbiamo osservato che una prima sottocategorizzazione dei nomi è costituita dalla suddivisione in nomi numerabili e concreti da non contabili e astratti che non selezionano affatto un classificatore. Una successiva sottocategorizzazione è costituita dalla forma del nome (Corazza 1990). Un attenta osservazione dei classificatori consente di verificare l esistenza di altre forme di sottocategorizzazione, ad esempio esistono classificatori che, benché selezionati per forma, designano particolari entità. Un gruppo di questi è costituito dalle parti del corpo. Esiste un classificatore per la testa, uno per gli occhi, uno per la bocca e uno per le gambe. Questi classificatori hanno la funzione di descriverne, nei dettagli i movimenti e possono essere usati solo per riferirsi alle entità umane. Ad esempio il classificatore V (indice e medio stesi) designa le gambe degli umani, esso può assumere varie posizioni, (seduto, in piedi a testa in giù, in ginocchio) può diventare classificatore verbale come correre, ma può essere utilizzato solo con gli esseri umani. 74
37 Un'altra forma di sottocategorizzazione è data dal fenomeno dell impersonamento, descritto nel paragrafo 2 di questo capitolo, infatti poiché, come abbiamo visto, tale forma di flessione è possibile solo con gli esseri animati, essa sottocategorizza i nomi in esseri animati e no. Indagare su questi aspetti può essere molto importante. Benedico e Brentari (2004) ad esempio, per l ASL, hanno individuato che i classificatori verbali di parti del corpo avendo un soggetto esterno, quindi con un interpretazione agentiva, sono del tipo ergativo, mentre i classificatori verbali che si riferiscono all intera entità (ad esempio il dito indice che si riferisce ad un uomo) hanno un argomento interno per cui sono 75
38 del tipo in accusativo. I classificatori verbali di presa (handling) sono del tipo transitivo. Le tre classi verbali L accordo verbale si esprime attraverso l associazione tra i punti dello spazio e gli argomenti del verbo: l articolazione del verbo marca i punti in cui sono stati localizzati gli argomenti per cui l accordo si manifesta con l identificazione dei tratti dello spazio. Nel capitolo successivo, chiarirò come tali tratti siano associati alle persone verbali, per il momento, per discutere l accordo verbale e la legittimazione degli argomenti nulli, mi limiterò a definirli argomenti del verbo. Come per i nomi, le classi verbali sono state distinte sulla base dei loro tratti flessivi. Ricerche compiute sulla LIS (Pizzuto 1987, Caselli ed altri 1994)14 hanno individuato tre classi di verbi. Quelli della prima classe, avendo come punto di articolazione un punto specifico del corpo, possiedono maggiori restrizioni perché non consentono alterazioni di orientamento 76
39 della mano e verso del movimento; i verbi della seconda classe sono quelli che consentono maggiori variazioni in quanto marcano soggetto e complemento; i verbi della terza classe invece marcano solo un argomento. Per la realizzazione dell accordo manuale, è necessario che i punti dello spazio segnico siano associati agli argomenti del verbo. Questa forma di marcatura manuale può ricorrere con un altra marcatura, non manuale, che si serve della direzione dello sguardo, della rotazione della testa e/o delle spalle che, puntando in direzione del complemento diretto, individuano soggetto e oggetto del verbo. L accordo non manuale è più evidente con i verbi non flessivi ed è possibile solo con alcune persone verbali, ad esempio non è possibile (oppure non è fonologicamennte realizzato) con la prima e la seconda persona. Quando è coinvolta la terza persona, sia come soggetto sia come oggetto, la realizzazione dell accordo non manuale è manifesta. Ad un primo sguardo sembra che ciò che viene definito impersonamento per la LIS (Pizzuto ed altri 1990) è stato 77
40 riconosciuto come un sistema di flessione dei verbi non flessivi dell ASL (Bahan ed altri 2000, Neidle ed altri 2000) e della LIS (Zucchi 2004). A corroborare questa ipotesi c è il fatto che i verbi della prima classe sembrano essere pertinenti delle entità animate, anche i pronomi di prima persona sono caratterizzati dal tratto +animato, per cui la loro flessione viene resa possibile attraverso specifiche marcature dei tratti sovrasegmentali (body markers) caratteristici dell impersonamento che, non per caso, è possibile solo con le entità animate. In realtà la questione andrebbe approfondita per stabilire se si tratta di discorso diretto e quindi di reale impersonamento, oppure, seguendo la tesi di Bahan ed altri (2000), si tratti di una forma di flessione o se le due posizioni coincidono. Il fatto che questa forma di flessione è possibile solo con esseri animati, induce a considerare anche l ipotesi di logoforicità15 come ha illustrato Lillo-Martin per l ASL (1990, 1995). Questo tema va certamente approfondito per la sua 78
41 particolarità, ad esempio anche le costruzioni impersonali possono essere coinvolte in questa forma di flessione: La particolarità di questa frase sta nel fatto che il pronome soggetto della secondaria o non è coreferenziale con l antecedente, si tratta cioè di un pronome forte con un pieno ruolo di soggetto. Questo sistema di flessione è molto comune nelle lingue dei segni in quanto oltre che per la LIS e per l ASL, è stato descritto anche per la lingua dei segni danese DSL (Engberg- Pedersen 1995) e per la lingua dei segni del Quebec (QSL) (Poulin e Miller 1995). Prima di descrivere i modi in cui le diverse classi verbali marcano gli argomenti, è opportuno specificare che tutti i verbi, nella forma non marcata, partono dalla prima persona e si realizzano nello spazio non marcato. Bahan (1996) e Supalla (1996) 79
42 ritengono che la forma non marcata in ASL corrisponde alla prima persona invece che alla terza, come avviene per molte lingue orali. In LIS tale forma non marcata ricorre molto spesso non solo come forma impersonale, ma anche con soggetto e/o oggetto specificato. Nei paragrafi successivi descriverò le tre classi verbali della LIS e il loro comportamento in relazione alla marcatura degli argomenti e alla luce di quanto detto, mi soffermerò sulla discussione degli argomenti nulli che ha meritato un interessante dibattito per l ASL. 80
43 La flessione dei verbi della prima classe. La flessione manuale (attraverso l orientamento del palmo e le variazioni di direzione del segno) dei verbi della prima classe, ovvero quelli localizzati sul corpo (fig.1), non consente variazioni di direzione o verso, ragione per cui rimane invariata. Esempi di verbi della prima classe sono pensare, mangiare, bere, credere, volere, ideare, amare, sentire, ricordare, preoccuparsi, telefonare, dimenticare. Il soggetto di un verbo intransitivo, nella forma non marcata, è necessario che venga specificato. Nella forma marcata l individuazione del soggetto avviene per effetto delle espressioni del viso che estraneano la conversazione dall interlocutore; il parlante, assumendo postura ed espressioni idonee, assume il ruolo del soggetto. In tal caso è possibile omettere il soggetto anche se è necessario che esso sia il topic del discorso. Es. frase
44 In presenza di un complemento diretto, le espressioni non manuali di accordo marcano soggetto e complemento diretto sul quale sono orientati la direzione dello sguardo o della testa o delle spalle. Vale a dire che le spalle e/o la testa marcano la posizione del soggetto, la direzione dello sguardo si orienta verso l oggetto realizzando così gli accordi per soggetto ed oggetto. Un verbo articolato sul corpo che prende due argomenti è CONOSCERE. Il soggetto (Gianni) e il complemento diretto (Pietro), vengono articolati e localizzati nello spazio. Durante l articolazione del verbo, la rotazione delle spalle e la direzione dello sguardo, partendo dal soggetto (j), si dirigono verso il complemento 82
45 diretto (k). La marcatura dei ruoli da parte del verbo è possibile anche attraverso l inclinazione della testa durante la sua articolazione. Il principio generale è che la direzione dello sguardo, la rotazione della testa e/o delle spalle parte dal soggetto e si direziona verso il complemento diretto. In taluni casi si assiste ad uno spostamento del verbo nello spazio segnico. Ad esempio il verbo conoscere viene spostato dalla posizione iniziale (in questo caso sul lato della fronte) allo spazio antistante il punto di articolazione del corpo, in modo tale che il verso della mano possa essere puntato sul complemento diretto. L acquisizione, da parte del verbo, di una sorta di direzionalità, costituita dall articolazione nello spazio o anche solo dalla direzione dello sguardo, lo rende assimilabile ai verbi flessivi. Anche in questo caso, è possibile avere la forma non marcata da espressioni non manuali, occorre però occorre specificare soggetto e oggetto e l ordine degli elementi nella frase sarà Soggetto Verbo Oggetto. 83
46 Nel caso in cui i nomi sono articolati sul corpo, quindi sono non flessivi, l associazione con i punti dello spazio avviene attraverso altre modalità. Nella prima modalità durante l articolazione del nome la testa si inclina su un lato (in direzione del soggetto) e guarda nella direzione opposta, in questa maniera ad ogni lato vine associato un argomento (es.n.16); nella seconda modalità, il nome viene collocato nello spazio attraverso un indicazione (es. n.17); nella terza il nome viene collocato nello spazio con un classificatore (es. n.18). 84
47 La flessione dei verbi della seconda classe In questa classe vengono raggruppati i verbi articolati nello spazio neutro con due punti di articolazione (fig.2). Questi verbi prendono due o tre argomenti, ma ne marcano due. In essi possiamo distinguere due sottoclassi di verbi: quelli che nel punto di articolazione iniziale marcano il soggetto e nel punto finale il fine o il beneficiario16 (spedire, insegnare, dare, uccidere, aiutare, pagare) quelli che nel punto iniziale marcano la provenienza e nel punto finale l agente (prendere, sfruttare, copiare, ricevere sceglire). I punti di articolazione di questi verbi marcano i ruoli grammaticali. Vediamo alcuni esempi del primo gruppo di verbi 85
48 Semanticamente questa tipologia di verbi esprime una direzione, per questo motivo, come è mostrato dagli esempi, il primo punto di articolazione marca l agente (io, Gianni), il secondo il complemento diretto (Pietro nella frase 19). Dove non è espresso esplicitamente un complemento diretto il secondo punto di articolazione del verbo concorda o con un argomento nullo (tu nella frase 20) con un punto non marcato dello spazio neutro (0 nella frase21). Il secondo gruppo di verbi marca prima il complemento diretto, costituito dal tema-provenienza, e poi l agente. Anche in questo caso, quando il nome è articolato sul corpo, esso viene collocato nello spazio da un indicazione oppure da un classificatore che ne chiarisce la collocazione. 86
49 Nella forma non marcata, con i nomi articolati sul corpo, il primo punto di articolazione del verbo coincide con il segnante. Ad esempio il nome mamma è articolato sul corpo, nella forma non marcata, il primo punto di articolazione del verbo, che marca il soggetto, parte dal segnante e si flette come se fosse alla prima persona. Nella forma marcata invece, occorre collocare il nome nello spazio secondo le modalità già descritte per i verbi della prima classe, ovvero tramite l inclinazione della testa durante l articolazione del segno mamma, per questo un lato viene associato al soggetto articolato sul corpo (frase 26), oppure con un classificatore che diventa proforma del nome (frase 27) o, infine, con una deissi, associarvi un punto dello spazio (frase 28). I tratti non manuali sul verbo non sono obbligatori. 87
50 La flessione dei verbi della terza classe In questa classe vengono raggruppati i verbi articolati nello spazio neutro che marcano un solo argomento (fig.3). Questo gruppo di verbi si divide in due sottoclassi: la prima, composta da verbi intransitivi, marca il soggetto, la seconda raggruppa verbi transitivi che marcano o il soggetto o il paziente semantico, così se sono usati transitivamente concordano con l oggetto, se sono usati intransitivamente concordano con il soggetto. Del primo gruppo fanno parte verbi come dubitare, divorziare, lavorare, crescere, verbi posturali come alzarsi, stare in piedi eccetera. Del secondo gruppo fanno parte i verbi affittare, cucinare, migliorare, rinviare, stampare, spostare, tradurre. Vediamo alcuni esempi con i due sottogruppi. 88
51 L accordo verbale si esprime attraverso specifiche marcature del soggetto o del complemento diretto, attraverso l articolazione del verbo nel punto dello spazio associato all argomento. Le marcature degli spazi costituiscono un argomento che necessita di ulteriori studi perché esse sono evidenti nelle frasi elicitate, nelle conversazioni spontanee, invece tale marcatura non è evidenziabile. La frase 29 ad esempio ha il soggetto articolato sul corpo, il verbo non marca uno specifico punto ma è articolato nello spazio neutro, come evidenziato dall indice 0 al pedice. Con questo tipo di verbi le forme marcate possono essere: manuali, non manuali, oppure ricorrere insieme. 89
52 Vale la pena osservare che nelle forme di flessione non marcate la costruzione privilegiata è SVO, soprattutto per i verbi che non vengono flessi manualmente mentre, nelle forme con flessione marcata dai tratti sovrasegmentali, la costruzione privilegiata è SOV. Il raggruppamento dei verbi nelle tre classi suddette è il frutto di ricerche che si basano su analisi morfo-fonologiche. In realtà il comportamento di molti verbi cambia anche se hanno gli stessi luoghi di articolazione, sono necessarie ulteriori analisi finalizzate all individuazione dell omogeneità delle regole di comportamento di specifici gruppi verbali. Ad esempio all interno della seconda classe sono individuabili i verbi di movimento che marcano innanzitutto gli spazi (se non sono specificati marcano le persone), e la funzione del luogo può essere assimilato a quello della preposizione, un altro esempio è costituito dall inaccusatività di molti verbi della terza classe, invece i verbi della prima classe sono pertinenti degli esseri animati. Questo 90
53 solo per citare qualche spunto di ulteriore analisi che è necessario compiere. Argomenti nulli La differenza di comportamento di verbi flessivi e non flessivi non è solo una peculiarità della LIS, anche l American Sign Language (ASL) presenta dei comportamenti analoghi. Questa caratteristica ha portato ad un dibattito sulla questione del parametro del pro-drop per L ASL. I dati sul soggetto nullo sono interessanti perché ci permettono di determinare la natura e la distribuzione di argomenti, come le categorie vuote, assenti foneticamente ma sintatticamente presenti. Lillo-Martin (1991) considerando gli studi sulla legittimazione del soggetto ed oggetto nullo per le lingue con una ricca morfologia di accordo da una parte (Chomsky 1981, 1982, Rizzi 1982, 1986 tra gli altri), e della legittimazione attraverso il topic nelle lingue che mancano di accordo dall altra (Huang 1982,1984 Jaeggli e Safir 1989), ha proposto un analisi per l ASL che prevede, per i verbi flessivi, la 91
54 legittimazione degli argomenti nulli dovuta alla presenza di una ricca morfologia di accordo mentre, per i verbi non flessivi, gli argomenti nulli sarebbero legittimati dalla presenza di un topic poiché essi, più che essere argomenti nulli, costituirebbero delle variabili legate dal movimento dell argomento in posizione di topic. gli argomenti nulli per i verbi non flessivi sarebbero così legittimati dalla catena di topic. In altre parole con i verbi non flessivi sarebbero ammessi dei topic nulli perchè in ASL quando i topic nulli non legano una variabile, gli argomenti nulli dei verbi non flessivi non sono permessi. A sostegno di quanto affermato, Lillo- Martin fornisce prove del fatto che l ASL, come il cinese, è una lingua discourse oriented piuttosto che sentence oriented. Bahan e altri (2000) criticano questa posizione affermando che in letteratura le strategie di legittimazione degli argomenti nulli sono da ricondurre o alla ricca morfologia di accordo o alla legittimazione del topic nelle lingue che mancano di accordo, l analisi proposta da Lillo-Martin (1991) costituirebbe un sistema 92
55 ibrido di legittimazione degli argomenti nulli. La proposta di Bahan et al. (2000) per l ASL si fonda sulla rilevazione dei marcatori di accordo non manuali che determinerebbero così una evidente flessione sia per i verbi manualmente flessivi, sia per i verbi manualmente non-flessivi. In questo senso gli argomenti nulli per l ASL verrebbero legittimati dal sistema flessivo. Poiché, come è stato già illustrato, il sistema di accordo dei verbi della LIS è analogo all ASL, i ragionamenti condotti per L ASL possono essere applicati anche alla LIS. Alla luce delle considerazioni fatte per l ASL, vale la pena osservare l applicazione della lista delle proprietà delle lingue pro-drop (Rizzi 1982, 1986; Jaeggli e Safir 1989) alla LIS e tentare una discussione sull argomento. Qui di seguito verificherò ogni singola proprietà del pro-drop. a. IL SOGGETTO NELLE FRASI TEMPORALIZZATE PUÒ ESSERE NON ESPRESSO. 93
56 In LIS, come per l ASL, tale affermazione è vera con i verbi che marcano gli argomenti in maniera manuale, le marcature non manuali sostituiscono le marcature manuali con i verbi non flessivi ma, come vedremo, non sempre sono possibili. Riprendiamo gli esempi per ogni classe di verbi: l esempio 32 per la classe non flessiva, l esempio 33 per la classe flessiva che marca due argomenti, le frasi 33 e 34 per la classe flessiva che marca un solo argomento. 94
57 Come si può osservare, tutti i verbi sia i flessivi sia i non flessivi con i tratti sovrasegmentali, marcano specifici punti dello spazio a cui sono associati specifici argomenti. La risposta alla frase 32 non richiede accordo non manuale e l esplicitazione di soggetto o di oggetto non è obbligatoria. Allo stesso modo il verbo bruciare nelle frasi 34 e 35 può rimanere non marcato se il soggetto è espresso (frase 34) oppure è noto (frase 35b). I dati rilevati non sono del tutto omogenei: se è vero che in presenza di un verbo flesso il soggetto può essere omesso, è anche vero che con un verbo non flesso, il soggetto può essere omesso se riconducibile ad un topic. Inoltre i tratti sovrasegmentali, che consentono la flessione dei verbi non flessivi, non sono ammessi con la flessione della prima e della seconda persona verbale le quali, in assenza di topic, necessitano 95
58 dell esplicitazione del soggetto e dell oggettoncome si può osservare dalle frasi In entrambe le frasi non è necessario esprimere un soggetto anche se il verbo viene flesso in un luogo specifico localizzato più 96
59 in alto dello spazio cosiddetto neutro. Nel capitolo 7 fornirò alcune ipotesi in proposito. c. IL SOGGETTO SI PUÒ TROVARE IN POSIZIONE POSTVERBALE Tale affermazione sembra non essere valida per la LIS Sull impossibilità di invertire il soggetto le posizioni non sono del tutto concordi: le frasi con inversione soggetto-verbo, più che essere completamente escluse, sembrano essere accettate come influenza della lingua italiana, cioè si tratta di italiano segnato. d. POSSIBILITÀ DI ESPRIMERE IL SOGGETTO DELLA FRASE SECONDARIA NELLA PRINCIPALE, E ATTRAVERSO UN COMPLEMENTATORE, INTRODURRE LA SECONDARIA. In LIS, come del resto in ASL, mancando di complementatori come il che dell italiano non è possibile spiegare questa generalizzazione del parametro. 97
60 e. ESTRAZIONE LUNGA DALLA POSIZIONE DI SOGGETTO LASCIANDO VUOTA LA POSIZIONE ORIGINARIA. L applicazione di questo test non è semplice: I pareri degli informanti sono contrastanti perché l indicazione coinvolta come pronome di ripresa è appena accennata, infatti è possibile coglierla solo nei filmati delle frasi spontanee. Nelle frasi non spontanee la tendenza è quella di omettere il pronome di ripresa in presenza della flessione, anche solo non manuale. Nel capitolo 7 si chiarirà che questo genere di indicazioni è un pronome clitico. Nelle frasi seguenti propongo la versione data nelle conversazioni spontanee, in esse si può notare che del soggetto estratto dalla sua posizione di base per la topicalizzazione, nonostante la flessione, manuale o non manuale, del verbo, deve essere necessariamente riempita da un pronome costituito dall indicazione (IX) che è coreferenziale con il soggetto estratto. Il soggetto estratto è caratterizzato da una marcatura non manuale generalmente costituita dall inarcamento delle sopracciglia, la stessa espressione caratterizza il topic e il DP. In questa sede non mi soffermerò sugli aspetti non manuali che meritano osservazioni sistematiche per una discussione approfondita per stabilire se il loro ruolo ha anche un valore grammaticale. 98
61 verbi non flessivi: verbi flessivi che marcano soggetto e complemento: verbi flessivi che marcano l argomento interno: 99
62 Dalle frasi si può osservare che comunque venga espressa la flessione17, il verbo richiede un soggetto esplicito, le frasi con il pro sono considerate non grammaticali (frasi 47, 53 e 55) o dubbie (frasi 49 e 51). Se si hanno dei dubbi sulla grammaticalità del pro con la terza persona, la prima e la seconda persona verbale richiedono sempre la presenza di un pronome di ripresa L estrazione dell oggetto ci da la possibilità di verificare che la flessione nonmanuale non è sufficiente a legittimare la categoria vuota. 100
63 In realtà Jaeggli e Safir (1989), data la diversità dei sistemi flessivi che legittimano il soggetto nullo, propongono di guardare oltre la condizione della ricca morfologia di accordo ed esplorare proprietà flessive differenti come l Uniformità Morfologica che verrà chiarita qui di seguito. I SOGGETTI NULLI SONO CONSENTITI IN TUTTE E SOLO LE LINGUE CON PARADIGMI FLESSIVI MORFOLOGICAMENTE UNIFORMI. Un paradigma è uniforme se tutte le sue forme sono complesse, ovvero formate da una radice più un morfema flessivo, oppure nessuna di esse è complessa. In LIS, se si escludono i tratti sovrasegmentali, possiede dei paradigmi uniformi per la prima e la seconda classe verbale: la classe dei verbi non flessivi è espressa sempre nella sua forma citazionale (paradigma uniformemente non derivato), la classe 101
64 dei verbi flessivi ha, in tutte le persone verbali, specificato un verso e una direzione, per cui è uniformemente morfologicamente complessa. La terza classe, è uniformemente complessa se marca l argomento interno, è uniformemente non complessa se marca l argomento esterno. Se però consideriamo anche i parametri non manuali, il discorso cambia. Le marcature non manuali, sono espresse nella flessione della terza persona ma non della prima e della seconda persona. In tal caso il paradigma della LIS non è più uniforme ma è misto. Il quadro delineato fin ora non consente ancora di trarre conclusioni univoche sul parametro del soggetto nullo. Prima di addentrarsi in ulteriori analisi occorre fare chiarezza sulle indicazioni coinvolte come il pronome di ripresa. Nel capitolo 7 tenterò un primo approccio all identificazione delle forme pronominali. Si spera che questi argomenti vengano approfonditi ulteriormente nella prospettiva dell identificazione delle categorie vuote in LIS. 102
65 Uno sguardo al sintagma nominale in LIS In questo paragrafo discuterò una procedura con la quale i termini di una frase possono essere distinti in nomi, verbi, o aggettivi. Partendo da alcuni esempi è possibile osservare diversi fenomeni, quali l assenza fonologica della copula, la posizione degli aggettivi, la distinzione tra il sintagma nominale e il sintagma verbale, il valore sintattico dei tratti sovrasegmantali. Esaminiamo due frasi in cui la parola antico nella frase n.60 è un predicato e nella n. 61 un aggettivo: I tratti sovrasegmentali, che distinguono il costituente verbale dal costituente nominale, non sono sempre uguali; fatta eccezione per la tensione delle guance, che veicola il significato di un referente familiare, tutti gli altri tratti, consistenti 103
66 principalmente dall inarcamento delle sopracciglia e dallo spostamento della testa indietro, non ricorrono in una maniera omogenea tale da classificarli come identificativi del DP o del VP, tuttavia durante l articolazione della frase è possibile osservare una cesura tra il primo e il secondo costituente. Attraverso la glossatura con il programma Sign Steam 18, è possibile determinare, con maggiore chiarezza, tutti i tratti sovrasegmentali che si interrompono e cambiano tra i due costituenti. La frase n.60 è una frase principale, specifici tratti sovrasegmentali, coestensivi all intera frase, fungono da marcatori argomentali così che da frase compiuta diventa un argomento del predicato verbale rotto della frase n.61. Higginbotham (1987) distingue sintagmi nominali di tipo argomentale che supportano un ruolo tematico e sintagmi nominali di tipo predicativo che mancano di ruolo tematico. Gli esempi 60 e 61 mostrano in maniera evidente questo contrasto. 104
67 Essi possono essere accostati a quelli che fa Longobardi (1994: ) per l italiano con le frasi 62 e 63 (rispettivamente 19a e 19 b in Longobardi). Il fatto che nella frase 62 il termine medico è un predicato nominale, è supportato dall prova empirica che non può costituire la testa di una frase relativa come invece può esserlo la corrispondente espressione nominale della frase 63. Anche in LIS la frase 64 non può essere testa di una relativa, mentre il corrispondente costituente nominale della frase 65 ospita una frase relativa. 105
68 Da ciò si evince che se in italiano l inserimento dell articolo trasforma un predicato NP in un argomento DP, in LIS ciò che trasforma un predicato NP in argomento DP sono i tratti sovrasegmentali. Gli elementi prosodici, costituiti dai tratti sovrasegmentali, permettono di distinguere se un elemento appartiene allo stesso costituente nominale. Ad esempio I due DP sono separati da una pausa e da un movimento della testa che consiste in un cenno della testa tra i due sintagmi. L indicazione può distribuirsi solo sul primo sintagma, solo sul secondo, oppure su ambedue i sintagmi con una breve interruzione come nella frase 66. A questo punto risulta chiaro che i tratti sovrasegmentali ci aiutano a distinguere le proprietà dei costituenti, le loro funzioni possono essere assimilate agli elementi funzionali che in altre lingue, come l italiano, possono essere espressi foneticamente. 106
69 1. Proprietà morfologiche degli aggettivi in LIS Gli aggettivi in LIS sono caratterizzati da alcune proprietà morfologiche e che verranno descritte rispettivamente nel paragrafo 1.1 e 1.2. Prima descriverò i tratti di accordo degli aggettivi i quali possono essere astratti o manifesti. Poi rivolgerò la mia l attenzione ad altre proprietà morfologiche dell aggettivo in LIS che coinvolgono la sua modificazione. La concordanza degli aggettivi Come i nomi e i verbi, anche gli aggettivi vanno distinti in due classi: quelli flessivi, segnati nello spazio (alto, nuovo, blu) e quelli non flessivi, segnati sul corpo (bello, rosso, vecchio). L accordo morfologico degli aggettivi implica la modifica dei tratti di luogo e orientamento del segno che devono essere orientati verso il nome, cioè nome e modificatori devono avere lo stesso luogo di articolazione. Con gli aggettivi non flessivi (quelli articolati sul corpo, che non consentono variazioni di luogo), l accordo viene realizzato con la direzione della postura, che 107
70 talvolta coinvolge anche lo sguardo, che si rivolge verso il punto indicato dal determinante o dal nome articolato in uno specifico punto dello spazio1. L accordo tra aggettivo e nome non è obbligatorio: spesso anche gli aggettivi flessivi non vengono articolati nel punto in cui è localizzato il nome al quale si riferiscono ma vengono articolati nello spazio neutro. Lo spostamento dell aggettivo, dallo spazio neutro ad uno spazio specifico, diventa obbligatorio nelle forme marcate, ad esempio in presenza di una congiunzione in cui ogni nome, con l aggettivo corrispondente, viene marcato in uno spazio distinto (frase 1 e 2), oppure nelle forme in cui l aggettivo assume anche un valore anaforico, vale a dire che la localizzazione in uno specifico punto dello spazio è associata ad un referente appena menzionato (frase 3). Nella frase 3 possiamo anche notare come l'articolazione nello spazio dell'aggettivo blu non richiede l'indicazione che invece è obbligatoria con l'aggettivo non flessivo rosso (gli indici al pedice delle glosse segnalano le concordanze). 108
71 Ad esempio: Nelle forme non marcate, come quelle che non richiedono una distinzione di due referenti, come le frasi 1, 2, e 3, ma il referente è unico (es. frase 5), più che di concordanza si potrebbe parlare di assimilazione nel senso indicato da Mac Laughlin per l ASL (1997:206). In ASL l indicazione che ricorre con il nome è un avverbio di luogo se è postnominale, è un articolo se prenominale (Mac Lauglin 1997, Neidle ed altri 2000). Per comprendere meglio il fenomeno dell assimilazione considerariamo la distinzione tra la seguente coppia di frasi: 109
72 Durante l articolazione del sintagma l indicazione (che localizza nello spazio il referente rendendo manifesto l accordo) è l elemento che compare nel luogo più esterno al segnante. Gli altri segni vengono assimilati lungo la direttrice spaziale che va dal segnante al punto indicato. Quando l indicazione è post nominale, i segni si dispongono dal segnante fino al punto indicato (Assimilazione Spaziale Regressiva Fig.1), quando invece l indicazione è prenominale i segni partono dal punto più esterno fino al segnante (Assimilazione Spaziale Progressiva Fig. 2) Nelle figure 1 e 2, l immagine in grigio rappresenta il segnante (visto dall alto) con lo spazio antistante rappresentato dal semicerchio. All interno del semicerchio ogni cerchietto rappresenta il punto di articolazione dei corrispondenti segni. Come si può osservare i luoghi di articolazione di ogni segno non coincidono ma sono dislocati lungo una direzione (indicata dalla freccia) che, nel primo esempio (Assimilazione Spaziale Regressiva), va dal primo segno (blue) del sintagma, che è 110
73 articolato più vicino al segnante, e arriva all indicazione (IX), ultimo segno del sintagma; nel secondo esempio (Assimilazione Spaziale Progressiva), la direzione della variazione dei luoghi parte dal primo segno del sintagma, che questa volta è l indicazione (IX) con valore di determinante e, come per l avverbio, è più lontana dal segnante, e arriva all ultimo segno del sintagma (blue) che è più vicino al segnante. In sostanza invertendo l ordine dei segni si inverte anche la direzione della freccia. Mac Laughlin (1997) osserva che il punto davanti al segnante è neutro, per questo motivo si tratta di forme che non operano accordo. Esse vanno distinte da altre due forme che operano accordo perché il punto di articolazione più vicino al segnante non è di fronte ad esso bensì orientato verso l indicazione, vale a 111
74 dire che nell Assimilazione Spaziale Regressiva la mano parte da una posizione già orientata verso l indicazione, nell Assimilazione Spaziale Progressiva la mano arriva in un punto prossimo al segnante ma orientato sulla direttrice indicazione-segnante. In LIS le indicazioni, sia che veicolino avverbi sia veicolino determinati, sono tutte postnominali per cui possiamo trovare solo l Assimilazione Spaziale Regressiva per i segni i cui punti di articolazione sono tutti nello spazio. Ad esempio i luoghi in cui si articolano i segni della frase: corrispondono ai punti indicati nello schema nella figura 3: In questo tipo di assimilazioni non si distinguono, come per l ASL, forme che prevedono un accordo rispetto a forme che non lo 112
75 prevedono. Se c è un indicazione i segni partono tutti da un luogo non marcato (che nello schema corrisponde al luogo dove viene segnato auto, esso può stare, indifferentemente, davanti al segnante o nella direzione della freccia). Viceversa, se non c è indicazione ed è necessario operare una distinzione tra un referente ed un altro, i segni hanno una localizzazione ben definita come nelle frasi 1, 2, 3. Riepilogando, in LIS gli aggettivi hanno forme di accordo che sono manifeste solo in alcune forme marcate ovvero quando un aggettivo diventa un proforma del nome nello spazio (fig.3). In presenza di un indicazione, la funzione dell accordo viene assunto da quest ultima, mentre nome e aggettivo subiscono gli effetti dell assimilazione. La modificazione degli aggettivi Come è già stato osservato per L ASL (Mac Lauhlin 1997) gli aggettivi in LIS posseggono due tipi di flessione: aspetto e intensità. Nel capitolo 2 abbiamo visto che la modificazione 113
76 consiste in variazioni dell ampiezza e della durata dell articolazione, variazioni delle componenti non manuali, ripetizione dell articolazione del segno. La combinazione della variazione di questi tratti veicola la modificazione dell aggettivo. La modificazione aspettuale degli aggettivi è simile alla modificazione aspettuale propria dei verbi, come è già stato notato da Klima e Bellugi (1979) e poi ripreso da Mac Lauhlin (1997), può essere applicata alla classe di aggettivi che si riferiscono a qualità che possono cambiare (ammalato, felice). Tali aggettivi, attraverso l iterazione del segno, possono essere flessi per aspetto continuativo. Ad esempio: Come già ha notato da Mac Lauglin (1997), gli aggettivi flessi per aspetto ricorrono nelle costruzioni frasali e non all interno di NP per cui solo quando gli aggettivi si comportano da predicati con una copula vuota. 114
77 L intensità di un aggettivo viene modificata da variazioni del segno costituite dalle espressioni del volto, dall ampiezza del segno, dalla durata dell articolazione e dalla tensione del movimento. Tali modificazioni, incorporandosi agli aggettivi, contribuiscono anche a definire i gradi dell aggettivo e altri tipi di modificazione (ad esempio la frase 7). Con gli aggettivi di forma può essere specificata anche la dimensione, come è dimostrato nella frase 8. Su questi aspetti, ulteriori dettagli verranno forniti nel paragrafo 6: Proprietà distribuzionali Nel capitolo2 abbiamo visto che il DP è caratterizzato da specifici tratti sovrasegmentali che si distribuiscono su tutta la sua estensione, all interno di questa estensione troviamo il nome seguito dagli aggettivi. A differenza di molte lingue (ad esempio 115
78 italiano, ASL, inglese) in cui la posizione degli aggettivi rispetto al nome opera una distinzione tra predicativi ed attributivi, in LIS tutti i tipi di modificazioni seguono il nome. Tuttavia, come vedremo nel paragrafo successivo, la differenza tra i tipi di modificazione è determinata dai tratti prosodici che caratterizzano gli aggettivi. Aggettivi attributivi e predicativi Gli aggettivi attributivi non possono essere marcati diversamente dal nome a cui si riferiscono. Inoltre, tra nome e aggettivo, non può interporsi nessun materiale lessicale (D Este, 2003). Invece gli aggettivi predicativi evidenziano una maggiore marcatura attraverso un maggiore inarcamento delle sopracciglia rispetto al resto del DP. Oltre alla marcatura data dalle espressioni del volto, alla fine dell'aggettivo predicativo sembra essere necessario un particolare gesto costituito dalla configurazione 5 (mano aperta con le dita stese e aperte) oppure dalla configurazione F (mano aperta con i polpastrelli di pollice 116
79 ed indice che si toccano)., oppure da 8una pausa dopo la pronuncia dell aggettivo predicativo. Il fatto che possono essere possibili ulteriori configurazioni manuali, induce a ritenere che si tratti di un gesto che ha la funzione di marcare anche manualmente l'aggettivo, anziché un segno con un suo valore grammaticale. Nelle frasi 9 e 10 quindi, l'aggettivo in neretto è prosodicamente più marcato e tra i due aggettivi c è una breve pausa. L indicazione, che nella forma non marcata si trova alla fine del DP, non può stare in nessun modo tra il nome e il suo modificatore diretto. 117
80 Quindi aggettivi sia attributivi che predicativi sono postnominali. Tuttavia in LIS esistono alcune eccezioni rispetto alla posizione dell aggettivo attributivo che in alcuni casi precede il nome. Tra queste eccezioni sono attestate primo ministro e ex studente. Il fatto che la parola ex, che viene realizzata con la dattilologia, riprende ma non traduce la corrispondente parola italiana, induce a ritenere che la posizione prenominale sia dovuta ad un prestito dall italiano che, da modificazione diretta, ha determinato in LIS la formazione di un nome composto. Questo fatto attesta che la modificazione diretta contribuisce alla formazione di nomi comuni (Sproat e Shih 1988) così potrebbe trattarsi un nome composto, derivato direttamente da attributo + nome dell italiano, anche la parola primo ministro. Le regole che presiedono all intonazione, in LIS costituita dai tratti sovrasegmentali, sembrano seguire la stessa sorte della 118
81 modificazione diretta e indiretta indicata da Sproat e Shih (1991) per il cinese mandarino. In LIS la modificazione diretta, costituita dall assegnazione diretta del ruolo tematico da parte dell aggettivo al nome, è caratterizzata dall estensione dello stesso tratto sovrasegmentale, senza interruzioni, su tutto il dominio di c-comando di un proiezione funzionale che domina il nome e il suo modificatore. Ci sono numerose prove a sostegno dell ipotesi che nella frase 9 l aggettivo marcato costituisce una modificazione indiretta: innanzitutto la presenza di una pausa intonativa tra i due aggettivi con l intensificazione del tratto sovrasegmentale che rende marcato il secondo aggettivo; in secondo luogo la presenza dell aggettivo marcato (quello in neretto) dagli stessi tratti sovrasegmentali di una frase relativa. 119
82 Nella frase 12 possiamo osservare che la frase relativa non ha un pronome relativo inoltre, i tratti sovrasegmentali che la caratterizzano sono identici al sintagma marcato delle frasi 10 e 11. Questi indizi, seguendo le tesi di Chomsky (1955), Kayne (1994), Larson (2004) tra gli altri, che vogliono gli aggettivi predicativi derivanti da relative ridotte, ci fanno dedurre che l aggettivo marcato è equivalente ad una frase relativa ridotta. Un terzo elemento a favore dell ipotesi che l aggettivo marcato è un tipo di modificazione indiretta, è il fatto che in entrambe le frasi è possibile introdurre un segno, glossato come PE che caratterizza le frasi relative in LIS. La lettura delle due frasi relative è restrittiva. Il significato dell aggettivo italiano nella frase 9 e dell aggettivo buono nella 120
83 frase 10 è ambigua tra una lettura restrittiva o non restrittiva (più avanti si chiarirà anche questo aspetto). Gli aggettivi delle frasi 9 e 10, poichè sono marcati, e poiché sono aggettivi derivati da frasi relative ridotte, non sono oggetti alle restrizioni di ordine prevista per modificazione diretta (Sproat e Shih 1991, Scott 2002). L ordine non marcato della stessa frase è il seguente: Questi cinque indizi (pausa intonativa, tratti sovrasegmentali uguali alle relative, possibilità di inserzione del PE, significato restrittivo dell aggettivo marcato, libertà di ordine degli aggettivi) ci inducono a concludere che questi aggettivi siano predicativi e che la differenza del tipo di modificazione del nome è affidata ai tratti prosodici. 121
84 Da un punto di vista semantico in LIS, come già accennato per le frasi 9 e 10, risulta molto chiara la lettura restrittiva degli aggettivi marcati rispetto a quella non restrittiva degli aggettivi non marcati. Cinque (2005) individua negli aggettivi prenominali delle lingue romanze una lettura non restrittiva opposta alla lettura ambigua tra restrittiva e non restrittiva degli aggettivi postnominali. In LIS, poiché gli aggettivi sono tutti postnominali, la differenza tra le proprietà semantiche relative alla distribuzione degli aggettivi è affidata alle marcature prosodiche. Come è stato già detto, gli aggettivi attributivi sono legati al nome dallo stesso tratto sovrasegmentale, ragion per cui la loro lettura è non restrittiva, quando invece sono marcati la loro lettura è ambigua. 122
85 In LIS è piuttosto complicato rilevare le altre caratteristiche semantiche evidenziate da Cinque (2005b) riguardo all ordine speculare degli aggettivi attributivi e predicativi nelle lingue romanze rispetto alla distribuzione degli stessi aggettivi nelle lingue germaniche, però, poiché in LIS, aggettivi attributivi e predicativi sono tutti postnominali, gli esempi riportati dimostrano che la modificazione diretta è quella più vicina al nome mentre la modificazione indiretta, derivata dalla frase relativa, è quella più lontana dal nome, ciò concorda con le posizioni di Cinque (2005a, 2005b). Aspetti della modificazione diretta La descrizione degli aggettivi delle LIS merita un discorso più ampio rispetto a quello fatto in questa sede in cui, come primo lavoro sull argomento, ho privilegiato gli aspetti sintattici di tutta la proiezione del sintagma determinante. Prima di analizzare la distribuzione dei modifiatori diretti del nome all interno del DP mi sembra opportuno chiarire alcuni 123
86 aspetti che riguardano gli aggettivi relazionali per due motivi: innanzitutto sono molto diffusi e costituiscono un capitolo importante della modificazione diretta, poi perché non sono marcati da specifici morfemi che rendono possibile una categorizzazione quando viene espresso nella forma citazionale: in LIS un aggettivo che deriva da un nome è omofono al nome corrispondente, ad es: finanziario e finanza hanno un segno identico, ciò che rende possibile l identificazione della categoria sintattica dell aggettivo è la sua posizione di contiguità al nome con gli stessi tratti sovrasegmentali e con nessun elemento che si può interporre tra nome e modificatore diretto. Il ruolo tematico viene assegnato all aggettivo in maniera diretta, nome e aggettivo quindi appartengono allo stesso 124
87 dominio di c-comando, tale evidenza è data anche dal tratto sovrasegmentale che rimane invariato durante l articolazione di nome e aggettivo. Seguendo Cinque (1994, 2000, 2005a, 2005b) e Scott (2002) esiste una proiezione FP che costituisce la proiezione che domina l AP e l NP. In questa maniera è possibile ottenere una modificazione diretta tra i due nodi. Gli aggettivi relazionali in LIS sono molto diffusi tanto da sostituire il sintagma preposizionale in tutte le situazioni in cui esso caratterizza fortemente il nome. Ad esempio in LIS abbiamo i seguenti sintagmi aggettivali: 125
88 Riguardo agli aggettivi di provenienza occorre precisare che se la caratterizzazione non è pragmaticamente forte, è necessaria una marcatura di possesso. Se invece il nome è plausibilmente proveniente dal luogo indicato, la marcatura non è necessaria6; ad esempio: 126
89 Restrizioni nella gerarchia degli aggettivi non marcati Stabilito che la modificazione diretta è tale quando non è marcata, e che essa è unita al nome dallo stesso tratto sovrasegmentale, diamo ora uno sguardo alla gerarchia degli aggettivi attributivi che, come previsto da Sproat e Shih (1988,1991), sono caratterizzati da un ordine fisso che è il seguente: Quality > Size > Shape > Colour > Provenance. La gerarchia proposta dai due studiosi si riferisce alle restrizioni dell ordine degli aggettivi in inglese e in cinese mandarino, in queste lingue il nome segue gli aggettivi. In LIS, in cui il nome precede il gruppo di aggettivi, vediamo che l ordine non marcato è esattamente speculare, ovvero: PROVENIENZA, COLORE, DIMENSIONE, QUALITÀ. Riguardo agli ordini che coinvolgono la forma, i pareri dei segnanti sono discordi probabilmente perché viene coinvolto un classificatore che potrebbe conferire all aggettivo una posizione diversa. Tratteremo questo argomento nel paragrafo che riguarda i classificatori (parg.6) e nel capitolo
90 Per il momento limitiamo la nostra osservazione alle restrizioni sugli aggettivi che non coinvolgono classificatori: il primo ordine di aggettivi è quello più naturale, gli altri ordini sono meno naturali anche se ad alcuni parlanti possono sembrare possibili. Tutti i casi in cui il nome si interpone tra gli aggettivi o si trova in posizione finale, sono sicuramente agrammaticali 128
La Lingua dei Segni Italiana La comunicazione visivo-gestuale dei sordi Aspetti morfo-sintattici pp
 Tratti di morfologia lessicale e flessiva della LIS Le classi dei nomi e dei verbi Indagini su coppie nome-verbo semanticamente correlati Distinzioni tra nomi e verbi non marcate morfologicamente: - nomi
Tratti di morfologia lessicale e flessiva della LIS Le classi dei nomi e dei verbi Indagini su coppie nome-verbo semanticamente correlati Distinzioni tra nomi e verbi non marcate morfologicamente: - nomi
Fonologia dei segni. Fonologia delle lingue segniche? Analisi di un segno BANCA
 Fonologia delle lingue segniche? Università degli Studi di Milano Fonologia dei segni Sandro Zucchi 2016-2017 Nel discutere il primo mito sulle lingue segniche ho detto che lingue segniche diverse possono
Fonologia delle lingue segniche? Università degli Studi di Milano Fonologia dei segni Sandro Zucchi 2016-2017 Nel discutere il primo mito sulle lingue segniche ho detto che lingue segniche diverse possono
Morfologia della LIS
 Morfologia della LIS La LIS possiede meccanismi morfologici attraverso i quali le parole possono essere modificate DERIVAZIONE: aggiungendo un suffisso ad un segno si modifica il suo significato. In LIS
Morfologia della LIS La LIS possiede meccanismi morfologici attraverso i quali le parole possono essere modificate DERIVAZIONE: aggiungendo un suffisso ad un segno si modifica il suo significato. In LIS
Tipi di verbo. Marco Svolacchia
 Tipi di verbo Marco Svolacchia In questa sezione si mostra come la categoria di intransitività sia insufficiente a rendere conto dei fenomeni che riguardano i verbi non transitivi e che è necessario distinguere
Tipi di verbo Marco Svolacchia In questa sezione si mostra come la categoria di intransitività sia insufficiente a rendere conto dei fenomeni che riguardano i verbi non transitivi e che è necessario distinguere
Cos'è la LIS? Corso LIS - Diventa Lis..Abile - a cura della Dott.ssa Judy Esposito
 Cos'è la Lis Cos'è la LIS? Forma di comunicazione visivo gestuale, diversa da quella acustico vocale abitualmente utilizzata tra le persone udenti; Lingua a tutti gli effetti, costituita da un registro
Cos'è la Lis Cos'è la LIS? Forma di comunicazione visivo gestuale, diversa da quella acustico vocale abitualmente utilizzata tra le persone udenti; Lingua a tutti gli effetti, costituita da un registro
Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo
 Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo mirco.fasolo@unimib.it Bibliografia Testi obbligatori - D amico, Devescovi (2003). Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci: Roma.
Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo mirco.fasolo@unimib.it Bibliografia Testi obbligatori - D amico, Devescovi (2003). Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci: Roma.
LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 3
 LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 3 Lezioni Martedì 14:00-15:30 San Basilio 1B Ricevimento Martedì 16-18 Ca Bembo Contatto chiara.branchini@unive.it RECUPERO Data: Sabato 7 aprile 2018 Orario: 12:15-13:45 Luogo:
LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 3 Lezioni Martedì 14:00-15:30 San Basilio 1B Ricevimento Martedì 16-18 Ca Bembo Contatto chiara.branchini@unive.it RECUPERO Data: Sabato 7 aprile 2018 Orario: 12:15-13:45 Luogo:
Traccia di analisi della competenza linguistica e comunicativa. Usa il linguaggio verbale sì no. Usa il corpo per esprimere le sue emozioni sì no
 Traccia di analisi della competenza linguistica e comunicativa a cura di Francesco De Renzo (Facoltà di Studi Orientali, Sapienza-Università di Roma) Comunicazione Interazione In che modo comunica e interagisce:
Traccia di analisi della competenza linguistica e comunicativa a cura di Francesco De Renzo (Facoltà di Studi Orientali, Sapienza-Università di Roma) Comunicazione Interazione In che modo comunica e interagisce:
2 LE PARTI DEL DISCORSO Le nove parti del discorso Caratteristiche delle parti del discorso 48 ESERCIZI 50 INDICE
 1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
La padronanza linguistica, Academia Universa Press 2011 PARTE PRIMA FARE GRAMMATICA 1. INSEGNARE ANCORA LA GRAMMATICA?
 La padronanza linguistica, Academia Universa Press 2011 PARTE PRIMA FARE GRAMMATICA 1. INSEGNARE ANCORA LA GRAMMATICA? 2. LA TRADIZIONE Analisi grammaticale Analisi logica Analisi del periodo Analisi testuale
La padronanza linguistica, Academia Universa Press 2011 PARTE PRIMA FARE GRAMMATICA 1. INSEGNARE ANCORA LA GRAMMATICA? 2. LA TRADIZIONE Analisi grammaticale Analisi logica Analisi del periodo Analisi testuale
Fondamenti di Linguistica
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA Facoltà di Lettere e Filosofia Lingue e culture straniere occidentali e orientali LINGUISTICA GENERALE Modulo A (9 CFU) Fondamenti di Linguistica PROF.SSA CLARA FERRANTI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA Facoltà di Lettere e Filosofia Lingue e culture straniere occidentali e orientali LINGUISTICA GENERALE Modulo A (9 CFU) Fondamenti di Linguistica PROF.SSA CLARA FERRANTI
3. Dalla linearità alla struttura La dipendenza dalla struttura La ricorsività 31
 Indice Parte I Fare grammatica 9 1. Insegnare ancora la grammatica? 9 2. La tradizione 15 2.1. Analisi grammaticale 16 2.2. Analisi logica 19 2.3. Analisi del periodo 22 2.4. Analisi testuale 24 2.5. Verso
Indice Parte I Fare grammatica 9 1. Insegnare ancora la grammatica? 9 2. La tradizione 15 2.1. Analisi grammaticale 16 2.2. Analisi logica 19 2.3. Analisi del periodo 22 2.4. Analisi testuale 24 2.5. Verso
Indice generale. L organizzazione della frase PARTE I. 1 Che cos è la frase 12 Frasi senza verbo 13
 PARTE I L organizzazione della frase CAPITOLO 1 La frase 12 1 Che cos è la frase 12 Frasi senza verbo 13 Proviamo insieme 13 2 La frase come struttura predicativa 14 La frase minima 15 La frase semplice
PARTE I L organizzazione della frase CAPITOLO 1 La frase 12 1 Che cos è la frase 12 Frasi senza verbo 13 Proviamo insieme 13 2 La frase come struttura predicativa 14 La frase minima 15 La frase semplice
La Morfologia. L aggettivo. Pag. 164 CLASSE II C
 La Morfologia L aggettivo Pag. 164 CLASSE II C 2016-2017 L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Gli aggettivi
La Morfologia L aggettivo Pag. 164 CLASSE II C 2016-2017 L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Gli aggettivi
La Morfologia. L aggettivo
 La Morfologia L aggettivo L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Esso concorda in genere e numero con il
La Morfologia L aggettivo L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Esso concorda in genere e numero con il
Val più la pratica della grammatica? Daniela Notarbartolo Convegno nazionale Giscel 4 marzo 2010
 Val più la pratica della grammatica? Daniela Notarbartolo Convegno nazionale Giscel 4 marzo 2010 punto di attacco Grammatica come crocevia del rapporto conoscenze-competenze Necessità di superare la divisione
Val più la pratica della grammatica? Daniela Notarbartolo Convegno nazionale Giscel 4 marzo 2010 punto di attacco Grammatica come crocevia del rapporto conoscenze-competenze Necessità di superare la divisione
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
 PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 4^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE 1a) Ascolto del contenuto di una conversazione o di un testo letto. 1b) Intuizione in un messaggio orale
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 4^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE 1a) Ascolto del contenuto di una conversazione o di un testo letto. 1b) Intuizione in un messaggio orale
Comunicazione Vs. Linguaggio
 Comunicazione Vs. Linguaggio Comunicazione: rete di scambi di informazioni e di relazioni sociali sirealizzaall internodiungruppo(naturasociale) ne costituisce la base dell interazione e delle relazioni
Comunicazione Vs. Linguaggio Comunicazione: rete di scambi di informazioni e di relazioni sociali sirealizzaall internodiungruppo(naturasociale) ne costituisce la base dell interazione e delle relazioni
Leggere per studiare
 Leggere per studiare A cura di Silvana Loiero Che cosa vuol dire leggere per studiare? Quando si legge un testo per studiare si devono fare diverse operazioni per capire il testo letto: rielaborare le
Leggere per studiare A cura di Silvana Loiero Che cosa vuol dire leggere per studiare? Quando si legge un testo per studiare si devono fare diverse operazioni per capire il testo letto: rielaborare le
AMICI SEMPRE IN ACCORDO NOME, ARTICOLO E AGGETTIVO
 AMICI SEMPRE IN ACCORDO NOME, ARTICOLO E AGGETTIVO Parte prima ISC "BETTI" FERMO PROGETTO PON INCLUSIONE Modulo 6 Miglioramento delle competenze di base di lingua e grammatica italiana Esperto prof.ssa
AMICI SEMPRE IN ACCORDO NOME, ARTICOLO E AGGETTIVO Parte prima ISC "BETTI" FERMO PROGETTO PON INCLUSIONE Modulo 6 Miglioramento delle competenze di base di lingua e grammatica italiana Esperto prof.ssa
Val più la pratica della grammatica?
 Val più la pratica della grammatica? Daniela Notarbartolo Convegno nazionale Giscel 4 marzo 2010 in www.insegnaregrammatica.it punto di attacco Grammatica come crocevia del rapporto conoscenze-competenze
Val più la pratica della grammatica? Daniela Notarbartolo Convegno nazionale Giscel 4 marzo 2010 in www.insegnaregrammatica.it punto di attacco Grammatica come crocevia del rapporto conoscenze-competenze
Linguistica generale. a.a Federica Da Milano
 Linguistica generale a.a.2014-2015 Federica Da Milano La sintassi: frasi e enunciati La frase intesa come modulo di un testo è chiamata enunciato, per differenziarla dalla frase intesa come costruzione
Linguistica generale a.a.2014-2015 Federica Da Milano La sintassi: frasi e enunciati La frase intesa come modulo di un testo è chiamata enunciato, per differenziarla dalla frase intesa come costruzione
Sviluppo del linguaggio MG Baglietto
 Sviluppo del linguaggio MG Baglietto Neuropsichiatria Infantile Istituto G. Gaslini Genova Componenti del Linguaggio 1) Componente fonologica: uso dei suoni, delle vocali e delle consonanti La FONOLOGIA
Sviluppo del linguaggio MG Baglietto Neuropsichiatria Infantile Istituto G. Gaslini Genova Componenti del Linguaggio 1) Componente fonologica: uso dei suoni, delle vocali e delle consonanti La FONOLOGIA
CORSO DI LIS Linguaggio Italiano dei Segni
 CORSO DI LIS Linguaggio Italiano dei Segni La grammatica Le indicazioni come pronomi LE INDICAZIONI COME PRONOMI 1. La categoria dei pronomi in LIS Il concetto dello spazio come elemento di accordo non
CORSO DI LIS Linguaggio Italiano dei Segni La grammatica Le indicazioni come pronomi LE INDICAZIONI COME PRONOMI 1. La categoria dei pronomi in LIS Il concetto dello spazio come elemento di accordo non
QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009
 QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009 RIFERIMENTI NORMATIVI INDICAZIONI NAZIONALI 2003 (OSA) L. n 53/2003 e D. Lgs 59/2004 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO 2007 QUADRO DI RIFERIMENTO
QUADRO DI RIFERIMENTO DI ITALIANO PROVE INVALSI 2009 RIFERIMENTI NORMATIVI INDICAZIONI NAZIONALI 2003 (OSA) L. n 53/2003 e D. Lgs 59/2004 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO 2007 QUADRO DI RIFERIMENTO
ISTITUTO: Liceo Classico CLASSE: I MATERIA: Italiano
 ISTITUTO: Liceo Classico CLASSE: I MATERIA: Italiano Modulo n 1 La comunicazione e il testo U.D. 1 La lingua: uno strumento per comunicare - La lingua e le lingue: varietà dell italiano; - La comunicazione
ISTITUTO: Liceo Classico CLASSE: I MATERIA: Italiano Modulo n 1 La comunicazione e il testo U.D. 1 La lingua: uno strumento per comunicare - La lingua e le lingue: varietà dell italiano; - La comunicazione
Struttura sintagmatica. Strutture. Alberi, o indicatori sintagmatici. Categorie grammaticali
 Struttura sintagmatica Strutture Le parole si organizzano in sintagmi (gruppi, costituenti) gerarchizzati gli uni rispetto agli altri (1) [la signora ] [ legge [il giornale ]] (2) la signora legge il giornale
Struttura sintagmatica Strutture Le parole si organizzano in sintagmi (gruppi, costituenti) gerarchizzati gli uni rispetto agli altri (1) [la signora ] [ legge [il giornale ]] (2) la signora legge il giornale
1 PARTE I - IL PERIMETRO DELLA GRAMMATICA: LA LINGUA NELLA COMUNICA- ZIONE
 Indice generale XI XV XIX XX XXIII XXV XXVII XXVHI XXX Indice dei box e delle tabelle notevoli Introduzione Premessa. La grammatica: regole e scelte, strutture e funzioni 1. Regole e scelte 2. Strutture
Indice generale XI XV XIX XX XXIII XXV XXVII XXVHI XXX Indice dei box e delle tabelle notevoli Introduzione Premessa. La grammatica: regole e scelte, strutture e funzioni 1. Regole e scelte 2. Strutture
Il verbo, sottocategorizzazione, valenza
 Il verbo, sottocategorizzazione, valenza Suddivisione interna delle singole parti del discorso All interno della categoria nome si devono distinguere varie specie di nomi, all interno della categoria verbo
Il verbo, sottocategorizzazione, valenza Suddivisione interna delle singole parti del discorso All interno della categoria nome si devono distinguere varie specie di nomi, all interno della categoria verbo
COMPETENZE IN ITALIANO L2 DELL ALUNNO/ A..
 COMPETENZE IN ITALIANO L2 DELL ALUNNO/ A.. IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Anno Scolastico Anno di nascita Anno di arrivo in Italia Scuola media frequentata Insegnante facilitatore L alunn
COMPETENZE IN ITALIANO L2 DELL ALUNNO/ A.. IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Anno Scolastico Anno di nascita Anno di arrivo in Italia Scuola media frequentata Insegnante facilitatore L alunn
SINTASSI E L E M E N T I I N T R O D U T T I V I 2. Francesca Forza - Nozioni Generali di Sintassi
 SINTASSI 1 E L E M E N T I I N T R O D U T T I V I 2 Perché la sintassi? 2 Il significato di una frase (e quindi più in generale la semantica) non dipende solo dalle sue componenti (il lessico) ma anche
SINTASSI 1 E L E M E N T I I N T R O D U T T I V I 2 Perché la sintassi? 2 Il significato di una frase (e quindi più in generale la semantica) non dipende solo dalle sue componenti (il lessico) ma anche
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLO DI SERRAVALLE - SAVIGNO
 ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLO DI SERRAVALLE - SAVIGNO via XXV Aprile,52 VALSAMOGGIA 40050 loc. Castello di Serravalle (BO) C.F:91171010373 - Tel. 051 670 48 24 Sito internet www.icccastellodiserravalle.gov.it
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLO DI SERRAVALLE - SAVIGNO via XXV Aprile,52 VALSAMOGGIA 40050 loc. Castello di Serravalle (BO) C.F:91171010373 - Tel. 051 670 48 24 Sito internet www.icccastellodiserravalle.gov.it
BIENNIO LICEO SCIENTIFICO (indirizzo tradizionale) CLASSE PRIMA
 LICEO SCIENTIFICO STATALE ALFRED NOBEL Torre del greco ( Na) DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE PER COMPETENZE DI LATINO BIENNIO anno scolastico 2016/17 1 ASSE CULTURALE DEI
LICEO SCIENTIFICO STATALE ALFRED NOBEL Torre del greco ( Na) DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE PER COMPETENZE DI LATINO BIENNIO anno scolastico 2016/17 1 ASSE CULTURALE DEI
Linguaggi di Programmazione
 Linguaggi di Programmazione 1 Linguaggio naturale e linguaggio macchina La comunicazione uomo-macchina avviene attraverso formalismi che assumono la forma di un linguaggio. Caratteristiche del Linguaggio
Linguaggi di Programmazione 1 Linguaggio naturale e linguaggio macchina La comunicazione uomo-macchina avviene attraverso formalismi che assumono la forma di un linguaggio. Caratteristiche del Linguaggio
Griglia di complessità del testo in simboli
 Dicembre 2016 Agg. febbraio 2017 Agg. maggio 2017 Griglia di complessità del testo in simboli Un progetto di Fare Leggere Tutti La presente griglia di complessità si rivolge a genitori o educatori che
Dicembre 2016 Agg. febbraio 2017 Agg. maggio 2017 Griglia di complessità del testo in simboli Un progetto di Fare Leggere Tutti La presente griglia di complessità si rivolge a genitori o educatori che
CURRICOLO DI ITALIANO Ore settimanali: 4 Monte ore annuali: 132
 I.T.T. L. da Vinci Foligno A.s. 2016-17 CURRICOLO DI ITALIANO Ore settimanali: 4 Monte ore annuali: 132 COMPETENZE ATTESE A CONCLUSIONE DEL BIENNIO Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
I.T.T. L. da Vinci Foligno A.s. 2016-17 CURRICOLO DI ITALIANO Ore settimanali: 4 Monte ore annuali: 132 COMPETENZE ATTESE A CONCLUSIONE DEL BIENNIO Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente, beneficiario, strumento, ecc.
 Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
Comunicare e parlare
 Lo sviluppo del lessico Fase I Fase II 12-16 mesi circa 17-22 mesi circa L ampiezza del vocabolario si attesta in media sulle 10 parole Maggiore rapidità nell acquisire nuove parole Può assumere la forma
Lo sviluppo del lessico Fase I Fase II 12-16 mesi circa 17-22 mesi circa L ampiezza del vocabolario si attesta in media sulle 10 parole Maggiore rapidità nell acquisire nuove parole Può assumere la forma
SINTASSI E L E M E N T I I N T R O D U T T I V I 3 E 4. Francesca Forza - Nozioni Generali di Sintassi
 SINTASSI 1 E L E M E N T I I N T R O D U T T I V I 3 E 4 Reggenza Relazione sintattica altamente astratta che sussiste tra un elemento reggente ed uno che viene retto. Gli elementi reggenti sono tutti
SINTASSI 1 E L E M E N T I I N T R O D U T T I V I 3 E 4 Reggenza Relazione sintattica altamente astratta che sussiste tra un elemento reggente ed uno che viene retto. Gli elementi reggenti sono tutti
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME. Competenze specifiche Abilità Conoscenze ABILITÀ MORFO-SINTATTICHE
 OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013
 ISIS VINCENZO MANZINI PIANO DI LAVORO ANNUALE CLASSE : 1 A LL DISCIPLINA : LATINO DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013 Situazione della classe. La classe 1^ALL è formata da 22 allievi,
ISIS VINCENZO MANZINI PIANO DI LAVORO ANNUALE CLASSE : 1 A LL DISCIPLINA : LATINO DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013 Situazione della classe. La classe 1^ALL è formata da 22 allievi,
Grammatica valenziale
 Grammatica valenziale Un modello di analisi unitario La grammatica tradizionale divide l analisi degli enunciati in tre livelli separati: Morfologia - strumento d analisi: analisi grammaticale Sintassi
Grammatica valenziale Un modello di analisi unitario La grammatica tradizionale divide l analisi degli enunciati in tre livelli separati: Morfologia - strumento d analisi: analisi grammaticale Sintassi
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica. La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio. L articolo
 Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA
 APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? I sistemi di comunicazione distinzione tra sistemi comunicativi verbali e non - verbali; i sistemi di scrittura sono strettamente
APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? I sistemi di comunicazione distinzione tra sistemi comunicativi verbali e non - verbali; i sistemi di scrittura sono strettamente
I.I.S. De Amicis Cattaneo. Programmazione di istituto Classi prime Italiano A.s 2018/19
 I.I.S. De Amicis Cattaneo Programmazione di istituto Classi prime Italiano A.s 2018/19 FINALITA E OBIETTIVI GENERALI Il percorso didattico mira all acquisizione delle competenze relative alla lettura,
I.I.S. De Amicis Cattaneo Programmazione di istituto Classi prime Italiano A.s 2018/19 FINALITA E OBIETTIVI GENERALI Il percorso didattico mira all acquisizione delle competenze relative alla lettura,
SINTASSI E L E M E N T I I N T R O D U T T I V I. Francesca Forza - Nozioni Generali di Sintassi 1
 SINTASSI 1 E L E M E N T I I N T R O D U T T I V I LINGUISTICA 2 La linguistica è costituita da più discipline che hanno oggetti di studio diversi: 1. FONETICA (che studia i foni) 2. FONOLOGIA (che studia
SINTASSI 1 E L E M E N T I I N T R O D U T T I V I LINGUISTICA 2 La linguistica è costituita da più discipline che hanno oggetti di studio diversi: 1. FONETICA (che studia i foni) 2. FONOLOGIA (che studia
Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione. Introduzione ai Linguaggi di Programmazione. Linguaggio (1) Linguaggio (2)
 Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione 1 2 Linguaggio (1) Linguaggio (2) Insieme di sequenze di simboli,
Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione 1 2 Linguaggio (1) Linguaggio (2) Insieme di sequenze di simboli,
Istituto Comprensivo Statale di Goito (MN) Via D. Alighieri, Goito (MN) a.s PROGRAMMAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE
 Istituto Comprensivo Statale di Goito (MN) Via D. Alighieri, 49-46044 Goito (MN) a.s. 2014-2015 PROGRAMMAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE OBIETTIVO GENERALE L obiettivo generale sarà quello di fornire ai bambini
Istituto Comprensivo Statale di Goito (MN) Via D. Alighieri, 49-46044 Goito (MN) a.s. 2014-2015 PROGRAMMAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE OBIETTIVO GENERALE L obiettivo generale sarà quello di fornire ai bambini
Il tubo del tempo. Dalla descrizione grammaticale alla cognizione della grammatica
 Il tubo del tempo Dalla descrizione grammaticale alla cognizione della grammatica Parte prima: La situazione attuale Il posto della grammatica cognitiva A che cosa serve la grammatica? Tante risposte:
Il tubo del tempo Dalla descrizione grammaticale alla cognizione della grammatica Parte prima: La situazione attuale Il posto della grammatica cognitiva A che cosa serve la grammatica? Tante risposte:
PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA. Classe quarta
 PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA Classe quarta ASCOLTARE E PARLARE 1. Strategie essenziali dell'ascolto. 2. Processi di controllo da mettere in atto durante l'ascolto. 3. Interazioni fra testo e contesto.
PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA Classe quarta ASCOLTARE E PARLARE 1. Strategie essenziali dell'ascolto. 2. Processi di controllo da mettere in atto durante l'ascolto. 3. Interazioni fra testo e contesto.
P I A N O D I L A V O R O A N N O S C O L A S T I C O 2018/2019
 P I A N O D I L A V O R O A N N O S C O L A S T I C O 2018/2019 M A T E R I A: LATINO D O C E N T E: RICCI MARTA C L A S S E: 1 sez. A 1) FINALITA' DELLA SCUOLA (confronta il P.O.F.) 2) FINALITA' SPECIFICHE
P I A N O D I L A V O R O A N N O S C O L A S T I C O 2018/2019 M A T E R I A: LATINO D O C E N T E: RICCI MARTA C L A S S E: 1 sez. A 1) FINALITA' DELLA SCUOLA (confronta il P.O.F.) 2) FINALITA' SPECIFICHE
B. Comprendere le informazioni essenziali di un esposizione e di istruzioni sempre più complesse
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA ITALIANO A ) ASCOLTARE 1 1. Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui 1. Conoscere ed applicare le strategie essenziali dell ascolto attivo
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA ITALIANO A ) ASCOLTARE 1 1. Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui 1. Conoscere ed applicare le strategie essenziali dell ascolto attivo
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA
 CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA Conoscere l ordine alfabetico; Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico; Riconoscere e isolare le vocali nelle parole che le contengono; Riconoscere
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA Conoscere l ordine alfabetico; Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico; Riconoscere e isolare le vocali nelle parole che le contengono; Riconoscere
PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO. Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto. Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia
 PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO Docenti Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto Insegnamento LINGUISTICA GENERALE Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia 1.1. Alfabeti e corrispondenza biunivoca;
PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO Docenti Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto Insegnamento LINGUISTICA GENERALE Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia 1.1. Alfabeti e corrispondenza biunivoca;
Curricolo di Italiano- classe prima. Competenze Descrittori di competenza descrittori minimi I Testi tematiche portanti
 Curricolo di Italiano- classe prima Competenze Descrittori di competenza descrittori minimi I Testi tematiche portanti Ascoltare 1. Presta attenzione per il tempo necessario alla situazione di ascolto
Curricolo di Italiano- classe prima Competenze Descrittori di competenza descrittori minimi I Testi tematiche portanti Ascoltare 1. Presta attenzione per il tempo necessario alla situazione di ascolto
Il codice linguistico
 Laboratorio Linguistico Il Testo narrativo Il codice linguistico www.nicolanapolitano.altervista.org App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM Le funzioni e la
Laboratorio Linguistico Il Testo narrativo Il codice linguistico www.nicolanapolitano.altervista.org App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM Le funzioni e la
PROGRAMMAZIONE CLASSI TERZE A.S. 2018/19 ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE CLASSI TERZE A.S. 2018/19 ITALIANO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Competenza digitale. Imparare ad imparare. COMPETENZE TRASVERSALI Comprendere
PROGRAMMAZIONE CLASSI TERZE A.S. 2018/19 ITALIANO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Competenza digitale. Imparare ad imparare. COMPETENZE TRASVERSALI Comprendere
Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione. Introduzione ai Linguaggi di Programmazione. Linguaggio. Messaggio
 Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione 1 2 Linguaggio Messaggio Insieme di sequenze di simboli, le parole,
Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione 1 2 Linguaggio Messaggio Insieme di sequenze di simboli, le parole,
VIII. Indice. Unità 2 La semantica 20
 Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
184 Il dialetto arzaghese
 INDICE PREFAZIONE...3 Prefazione alla seconda edizione...8 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA...9 Fonemi...9 Alfabeto IPA...10 Alfabeto arzaghese e sua corrispondenza col sistema fonologico...17 Ortografia...18 Scrittura
INDICE PREFAZIONE...3 Prefazione alla seconda edizione...8 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA...9 Fonemi...9 Alfabeto IPA...10 Alfabeto arzaghese e sua corrispondenza col sistema fonologico...17 Ortografia...18 Scrittura
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO
 ASCOLTARE E PARLARE Istituto Comprensivo Rignano Incisa PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe V 1 Quadrimestre Obiettivi Attività Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; Prendere la parola
ASCOLTARE E PARLARE Istituto Comprensivo Rignano Incisa PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe V 1 Quadrimestre Obiettivi Attività Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; Prendere la parola
PROGRAMMAZIONE ITALIANO - CLASSI 4 a 5 a A.S. 201_/201_ pag. 1. Prestare attenzione in situazioni comunicative diverse, Prestare attenzione A.
 A.1 A.2 A.3 A.4 PROGRAMMAZIONE ITALIANO - CLASSI 4 a 5 a A.S. 201_/201_ pag. 1 COMPETENZA: ASCOLTARE E PARLARE CLASSE BIMESTRE CLASSE BIMESTRE Acquisire strategie essenziali all ascolto finalizzato all
A.1 A.2 A.3 A.4 PROGRAMMAZIONE ITALIANO - CLASSI 4 a 5 a A.S. 201_/201_ pag. 1 COMPETENZA: ASCOLTARE E PARLARE CLASSE BIMESTRE CLASSE BIMESTRE Acquisire strategie essenziali all ascolto finalizzato all
Unità Didattica 2 I Linguaggi di Programmazione
 Unità Didattica 2 I Linguaggi di Programmazione 1 Linguaggio naturale e linguaggio macchina La comunicazione uomo-macchina avviene attraverso formalismi che assumono la forma di un linguaggio. Caratteristiche
Unità Didattica 2 I Linguaggi di Programmazione 1 Linguaggio naturale e linguaggio macchina La comunicazione uomo-macchina avviene attraverso formalismi che assumono la forma di un linguaggio. Caratteristiche
COMPETENZE DI ITALIANO DA PROVE INVALSI
 COMPETENZE DI ITALIANO DA PROVE INVALSI COMPETENZE DI ITALIANO TRATTE DAL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA DI ITALIANO DELL INVALSI AGGIORNATO AL 28 FEBBRAIO 2011. 1. LETTURA. PREMESSA: tipo di testo
COMPETENZE DI ITALIANO DA PROVE INVALSI COMPETENZE DI ITALIANO TRATTE DAL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA DI ITALIANO DELL INVALSI AGGIORNATO AL 28 FEBBRAIO 2011. 1. LETTURA. PREMESSA: tipo di testo
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
Principi di analisi>>>del livello sintattico Prof.ssa Maria Catricalà
 Principi di analisi>>>del livello sintattico Prof.ssa Maria Catricalà Funzioni sintattiche> Ruoli semantici> Struttura dell informazione valenza significato tema/rema Cap. 11 Struttura tematica e Struttura
Principi di analisi>>>del livello sintattico Prof.ssa Maria Catricalà Funzioni sintattiche> Ruoli semantici> Struttura dell informazione valenza significato tema/rema Cap. 11 Struttura tematica e Struttura
Progettazione annuale per competenze disciplinari Italiano-classe terza ottobre-novembre Nucleo tematico
 Progettazione annuale per competenze disciplinari Italiano-classe terza ottobre-novembre La narrazione Testo narrativo realistico e fantastico Semplici testi narrativi, connessi a situazioni quotidiane
Progettazione annuale per competenze disciplinari Italiano-classe terza ottobre-novembre La narrazione Testo narrativo realistico e fantastico Semplici testi narrativi, connessi a situazioni quotidiane
Classi. Meccanismi di Rappresentazione e Scoperta. Andrea Polini
 Classi Meccanismi di Rappresentazione e Scoperta Andrea Polini Laboratorio di Ingegneria del Software Corso di Laurea in Informatica L31 Univesità di Camerino (Laboratorio di Ingegneria del Software) Classi
Classi Meccanismi di Rappresentazione e Scoperta Andrea Polini Laboratorio di Ingegneria del Software Corso di Laurea in Informatica L31 Univesità di Camerino (Laboratorio di Ingegneria del Software) Classi
1 CORSO DI DIZIONE 1
 1 CORSO DI DIZIONE 1 DIZIONE: POSTURA E RESPIRAZIONE Dizione: Introduzione Postura e rilassamento Respirazione diaframmatica 2 DIZIONE: INTRODUZIONE Lo scopo di un corso di dizione è quello di imparare
1 CORSO DI DIZIONE 1 DIZIONE: POSTURA E RESPIRAZIONE Dizione: Introduzione Postura e rilassamento Respirazione diaframmatica 2 DIZIONE: INTRODUZIONE Lo scopo di un corso di dizione è quello di imparare
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO INCISA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO
 ASCOLTARE E PARLARE ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO INCISA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classi QUARTE Primo quadrimestre Obiettivi Attività - Interagire in una conversazione formulando domande e dando
ASCOLTARE E PARLARE ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO INCISA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classi QUARTE Primo quadrimestre Obiettivi Attività - Interagire in una conversazione formulando domande e dando
PIANO DI LAVORO ANNUALE
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA Via Ada Negri, 14 10024 MONCALIERI (TO) Codice fiscale 84511990016 Sezione Liceale E.Majorana Sezione Tecnico Economica Scientifico - Linguistico A.Marro Via Ada
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA Via Ada Negri, 14 10024 MONCALIERI (TO) Codice fiscale 84511990016 Sezione Liceale E.Majorana Sezione Tecnico Economica Scientifico - Linguistico A.Marro Via Ada
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ITALIANO Programmazione Primo anno Docente Margherita Margarita
 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ITALIANO Programmazione Primo anno Docente Margherita Margarita COMPETENZE (asse dei linguaggi) ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI TEMPI - un testo Caratteristiche del mito e dell epica
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ITALIANO Programmazione Primo anno Docente Margherita Margarita COMPETENZE (asse dei linguaggi) ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI TEMPI - un testo Caratteristiche del mito e dell epica
LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE
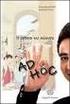 Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
5 Motivazioni funzionali
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 5 Motivazioni funzionali [Materiale di riferimento per questa parte: Croft 1990: capp. 3 (traduzione italiana in Cristofaro and Ramat 1999: cap.1) e 4; Cristofaro
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 5 Motivazioni funzionali [Materiale di riferimento per questa parte: Croft 1990: capp. 3 (traduzione italiana in Cristofaro and Ramat 1999: cap.1) e 4; Cristofaro
ATTIVITA. Conversazioni collettive guidate su argomenti di comune interesse o su esperienze vissute
 ITALIANO Classe quarta a.s. 2018/2019 PERIODO: 1 quadrimestre da Ottobre a Gennaio NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA OBIETTIVI MINIMI PROVE MINIME 1) ASCOLTARE E COMPRENDER E a) Prestare
ITALIANO Classe quarta a.s. 2018/2019 PERIODO: 1 quadrimestre da Ottobre a Gennaio NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA OBIETTIVI MINIMI PROVE MINIME 1) ASCOLTARE E COMPRENDER E a) Prestare
SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE. Anno scolastico
 SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Anno scolastico 2017-2018 Istituto Docente Materia Classe GESU - MARIA ROLLETTA CHIARA LATINO I LICEO CLASSICO Numero di studenti 3 1. COMPETENZE IN USCITA 1. L alunno
SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Anno scolastico 2017-2018 Istituto Docente Materia Classe GESU - MARIA ROLLETTA CHIARA LATINO I LICEO CLASSICO Numero di studenti 3 1. COMPETENZE IN USCITA 1. L alunno
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
 PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 3^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE I Q. II Q. CONTENUTI /ATTIVITA 1a) Ascolto e comprensione di ciò che l insegnante e i compagni comunicano
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO classe 3^ PER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE I Q. II Q. CONTENUTI /ATTIVITA 1a) Ascolto e comprensione di ciò che l insegnante e i compagni comunicano
ITALIANO. CONOSCENZE (i saperi)
 Classe quarta ITALIANO NUCLEI ESSENZIALI ASCOLTO Strategie d ascolto Traguardi di SVILUPPO di COMPETENZA Comprende testi orali diretti o trasmessi cogliendone il senso, le informazioni principali e lo
Classe quarta ITALIANO NUCLEI ESSENZIALI ASCOLTO Strategie d ascolto Traguardi di SVILUPPO di COMPETENZA Comprende testi orali diretti o trasmessi cogliendone il senso, le informazioni principali e lo
Fonologia e ortografia
 Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
La grammatica dello spazio nella LIS
 La grammatica dello spazio nella LIS Carmela Bertone Università Ca Foscari di Venezia 1. Lo spazio come categoria grammaticale delle lingue segnate Gli studi condotti finora sulla LIS hanno definito lo
La grammatica dello spazio nella LIS Carmela Bertone Università Ca Foscari di Venezia 1. Lo spazio come categoria grammaticale delle lingue segnate Gli studi condotti finora sulla LIS hanno definito lo
Istituto Comprensivo Campagnola-Galilei. Area Didattica
 Sezione Competenze Contenuti/attività Scuola dell Infanzia Sezione 3 anni 1. Essere in grado di esprimersi in modo comprensibile. 2. Essere in grado di ascoltare. Narrazioni orali Letture Comprensioni
Sezione Competenze Contenuti/attività Scuola dell Infanzia Sezione 3 anni 1. Essere in grado di esprimersi in modo comprensibile. 2. Essere in grado di ascoltare. Narrazioni orali Letture Comprensioni
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO AREE DA SVILUPPARE. Riflettere sulla lingua
 1 CONTENUTI, ATTIVITÁ COMPETENZE IN USCITA Riflettere sulla lingua 1. Consolidare le principali convenzioni ortografiche. 2. Approfondire la conoscenza di: - articolo (partitivo) - nome (classificazione
1 CONTENUTI, ATTIVITÁ COMPETENZE IN USCITA Riflettere sulla lingua 1. Consolidare le principali convenzioni ortografiche. 2. Approfondire la conoscenza di: - articolo (partitivo) - nome (classificazione
Indice. 1. Pittogrammi e ideogrammi Ilogogrammi 35. Premessa 11. Le origini del linguaggio 13. II. Gli animali e il linguaggio umano 21
 Indice Premessa 11 Le origini del linguaggio 13 1. L'origine divina 13 2. La teoria dei suoni naturali 14 3. La teoria dell'adattamento fisico 15 4. Denti, labbra, bocca, laringe e faringe 16 5. Il cervello
Indice Premessa 11 Le origini del linguaggio 13 1. L'origine divina 13 2. La teoria dei suoni naturali 14 3. La teoria dell'adattamento fisico 15 4. Denti, labbra, bocca, laringe e faringe 16 5. Il cervello
MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
 MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE ISTITUTO : Maffeo Pantaleoni, via Brigida Postorino, 27, 00044 Frascati (Roma) ANNO SCOLASTICO 2016-2017 INDIRIZZO : servizi commerciali CLASSE I SEZIONE
MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE ISTITUTO : Maffeo Pantaleoni, via Brigida Postorino, 27, 00044 Frascati (Roma) ANNO SCOLASTICO 2016-2017 INDIRIZZO : servizi commerciali CLASSE I SEZIONE
Programma Italiano I BIO
 Programma Italiano I BIO 1. Grammatica La grammatica La morfologia Parti variabili Parti invariabili La sintassi Sintassi della frase semplice Sintassi del periodo L analisi Grammaticale Logica Del periodo
Programma Italiano I BIO 1. Grammatica La grammatica La morfologia Parti variabili Parti invariabili La sintassi Sintassi della frase semplice Sintassi del periodo L analisi Grammaticale Logica Del periodo
ITALIANO UNITÀ DIDATTICA N. 1 ASCOLTARE E PARLARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ABILITÀ
 UNITÀ DIDATTICA N. 1 ASCOLTARE E PARLARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ABILITÀ 1. Adeguare la comunicazione, prestando attenzione all interlocutore, alla situazione,all argomento. 2. Esprimersi
UNITÀ DIDATTICA N. 1 ASCOLTARE E PARLARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ABILITÀ 1. Adeguare la comunicazione, prestando attenzione all interlocutore, alla situazione,all argomento. 2. Esprimersi
CURRICOLO DISCIPLINARE di LATINO
 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" Rosolini (SR) a.s. 2018/2019 CURRICOLO DISCIPLINARE di LATINO LICEO SCIENTIFICO, SCIENZE UMANE, LINGUISTICO DIPARTIMENTO DI LETTERE, DISEGNO E STORIA
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" Rosolini (SR) a.s. 2018/2019 CURRICOLO DISCIPLINARE di LATINO LICEO SCIENTIFICO, SCIENZE UMANE, LINGUISTICO DIPARTIMENTO DI LETTERE, DISEGNO E STORIA
Sintassi (Linguistica e Glottologia 2012) Jacopo Garzonio
 Sintassi (Linguistica e Glottologia 2012) Jacopo Garzonio (j.garzonio@gmail.com) Analisi sintattica La sintassi è il livello di analisi delle frasi. Come per 'parola', adottiamo un concetto ad hoc di 'frase',
Sintassi (Linguistica e Glottologia 2012) Jacopo Garzonio (j.garzonio@gmail.com) Analisi sintattica La sintassi è il livello di analisi delle frasi. Come per 'parola', adottiamo un concetto ad hoc di 'frase',
Il significato. Anno accademico 2017/2018 Psicologia della Comunicazione Prof.ssa Serino. Quinta Lezione
 Il significato Anno accademico 2017/2018 Psicologia della Comunicazione Prof.ssa Serino Quinta Lezione Quinta lezione: Il significato Sommario Universalità vs. Relatività Capitolo 3 «Comunicazione e Significato»
Il significato Anno accademico 2017/2018 Psicologia della Comunicazione Prof.ssa Serino Quinta Lezione Quinta lezione: Il significato Sommario Universalità vs. Relatività Capitolo 3 «Comunicazione e Significato»
Linguaggi, Traduttori e le Basi della Programmazione
 Corso di Laurea in Ingegneria Civile Politecnico di Bari Sede di Foggia Fondamenti di Informatica Anno Accademico 2011/2012 docente: Prof. Ing. Michele Salvemini Sommario Il Linguaggio I Linguaggi di Linguaggi
Corso di Laurea in Ingegneria Civile Politecnico di Bari Sede di Foggia Fondamenti di Informatica Anno Accademico 2011/2012 docente: Prof. Ing. Michele Salvemini Sommario Il Linguaggio I Linguaggi di Linguaggi
Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione
 Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione 1 2 Linguaggio (1) Linguaggio (2) Insieme di sequenze di simboli,
Sommario Linguaggi, messaggi e comunicazione Traduzione di programmi Interpreti e compilatori Introduzione al processo di compilazione 1 2 Linguaggio (1) Linguaggio (2) Insieme di sequenze di simboli,
