Omoinnesti vascolari: strategia e tattica operatoria
|
|
|
- Renzo Martina
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Omoinnesti vascolari: strategia e tattica operatoria Ann. Ital. Chir., LXXII, 2, 2001 C. NOVA L I Primario Divisione di Chirurgia Vascolare Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Cuneo Introduzione Recentemente è stato riproposto l uso di omoinnesti arteriosi, dopo l interessante e positiva esperienza di numerosi Centri Europei di Chirurgia Vascolare, mediante la rimozione completa del graft infetto e l innesto in situ di segmenti arteriosi di arterie prelevate da donatore cadavere (a cuore battente e non). Il rationale di questa procedura è supportato dall esperienza maturata nell utilizzo di omoinnesti in chirurgia cardiaca, dove si è chiaramente dimostrata la buona resistenza alle infezioni, degli omoinnesti, nel trattamento delle endocarditi valvolari aortiche. La resistenza dell omoinnesto alla infezione è stata documentata da Kieffer et. al., che ha impiegato omoinnesti aorto-bifemorali nel trattamento di infezioni protesiche nell area addominale fin dal 1988 e in Italia dall esperienza del Gruppo Collaborativo sui trapianti di Tessuto coordinati dal NIT (3-8). Il rinnovato interesse di questa metodica, rispetto ai deludenti risultati degli anni cinquanta è supportato sostanzialmente da due motivazioni: (a) la selezione dei donatori resi idonei da protocolli della donazione multiorgano e (b) le tecnologie di supporto al prelievo e alla conservazione, attraverso la Banca di Crioconservazione, che attua i tests sulla qualità dei segmenti arteriosi prelevati sotto il profilo istologico meccanico, biochimico e virologico - batteriologico. Scelta dei pazienti e strategia operatoria L opzione dell utilizzo dell omoinnesto nella terapia chirurgica di una infezione protesica deve porre il chirurgo Riassunto L Autore nel presente lavoro propone una analisi di dettaglio di tutti quei particolari che devono essere tenuti in conside - razione quando per il trattamento di una infezione protesi - ca si decide di optare per l uso di un omoinnesto arterioso. Vengono presi in considerazione i tipi di pazienti conside - rati idonei a tale procedura, gli aspetti clinici e diagnosti - ci dell infezione protesica oltre alle caratteristiche proprie del materiale prelevato dal donatore (congruità morfo-dimen - sionale dell omoinnesto). Pa rt i c o l a re attenzione viene dedicata alla tattica opera t o r i a d ove è attuata una analisi dei tempi relativi (a) alla pre p a - razione del paziente, (b) ai problemi della rimozione del gra f t infetto e (c) alle problematiche dell impianto dell o m o i n n e s t o. Molta attenzione è stata posta ai problemi del decorso postoperatorio dei pazienti trattati, alle caratteristiche e alla rigorosità del follow-up. Questa esperienza è il frutto di un lavo ro avviato presso il cen - t ro di di Chirurgia Va s c o l a re dell ospedale di Busto Arsizio (Va ), d ove dal Ma rzo 1994 al Se t t e m b re 1996 sono stati impian - tati 21 omoinnesti in 20 pazienti (19 nell a rea aort i c a ). Sono analizzate in dettaglio le caratteristiche della popola - zione in esame e i risultati ottenuti specie in relazione alla mortalità precoce del 15%. Parole chiave: Omoinnesti vascolari tecnica chirurgica. Abstract VASCULAR HOMOGRAFT: TECHNICAL PROCE- DURE The author propose a detailed analysis of all the critical aspects that must be kept in mind when, in case of graft infection,the choice is to utilize an arterial homograft. Patient suitable to this procedure, as well as clinical and diagnostical relevances of graft infection and characteristics of the donor s material are widely examinated. The surgical techniques about a) patient preparation and management, b) infected graft removal and c) homograft implant are specifically discussed and analyzed. Post-operative care and follow-up are discussed and planned. This experience is the result of a aspecific trial begun in Busto Arsizio Vascular Surgery Dept.-Busto Arsizio Hospital-Varese Italy, where, starting from March 1994 until September homograft have been implanted in 20 patients (19 in aortic district). Population characteristics and results are critically examined, whith particular attention to the death rate of 15%. Key words: Vascular homografts surgical technique. Ann. Ital. Chir., LXXII, 2,
2 C. Novali di fronte alla soluzione di una serie di problemi preliminari che rivestono grande importanza ai fini di un buon risultato finale. La chirurgia dei trapianti di tessuto arterioso rientra nella complessa chirurgia dei Reinterventi (redo), nell area aortica, su pazienti spesso defedati o immunodepressi e ad alto rischio chirurgico - anestesiologico. È pertanto necessario: Avere la certezza e se possibile documentare l entità e l estensione dell infezione protesica. Quantizzare le reali riserve biologiche (stato clinico), le attese di vita e di socialità del paziente (stato psicologico). Documentare lo stato anatomo - morfologico dell albero arterioso da ricostruire, al fine di procurare segmenti arteriosi più rispondenti alle esigenze del paziente, riducendo al minino le procedure di tailoring dell omoinnesto. Clinica e diagnostica delle infezioni protesiche La comparsa di una infezione di protesi pone severi problemi clinici e diagnostici: può essere difficile da diagnosticare, richiede prolungati tempi di ospedalizzazione offre, scarse possibilità di guarigione con la sola terapia medica, implica spesso decisioni terapeutiche impopolari che inficiano totalmente i primitivi obiettivi di miglioramento funzionale. L infezione infatti si associa ad alto rischio di perdita d arto ed è gravata da una elevata mortalità per complicanze quali: Emorragia massiva (da deiscenza dell anastomosi oppure da fistole ed erosioni aorto - enteriche); Sepsi generalizzata; Interventi chirurgici ripetuti. Malgrado in letteratura l incidenza è valutata tra l 1-6%, è presumibile che questi valori sottostimino il problema per l eventualità di un lungo periodo di latenza (possono insorgere anche a distanza di 10 anni), oppure per la possibilità di morte improvvisa dovuta al distacco della protesi, senza segni premonitori, ma anche perché pazienti con tali complicanze vengono frequentemente ricoverati in ospedali lontani e diversi da quello dove è stato fatto l intervento primitivo. Il materiale alloplastico protesico, qualsiasi esso sia, deve essere considerato un corpo estraneo, sotto il profilo biologico. Una sua contaminazione provoca il permanere dell agente infettante nelle porosità del materiale costituente la protesi e in un secondo tempo la crescita e distribuzione del germe lungo tutta la protesi fino alle anastomosi o al contrario a partenza da esse, come con maggior frequenza si verifica. La produzione di materiale essudativo infetto può provocare o la formazione di uno sbocco fistoloso superficiale con conseguente cronicizzazione e spesso delimitazione dell infezione oppure la propagazione di tale materiale lungo tutta la protesi (fra questa e il tessuto periprotesico). In questo ultimo caso l ulteriore evoluzione può determinare: a) la trombosi protesica; b) la formazione di uno pseudoaneurisma anastomotico; c) l erosione di un viscere contiguo con formazione di una fistola (caso più frequente la fistola aorto - enterica). Negli ultimi anni si è assistito ad una variazione della incidenza dei vari agenti etiologici nelle infezioni delle protesi vascolari, con una riduzione significativamente statistica di quelle dovute allo Staphilococcus aureus e Pseudomonas, mentre si è visto un aumento di quelle dovute allo Staphilococcus epidermidis, Enterococco, le infezioni Polimicrobiche e quadri di non crescita batterica. Comparando le statistiche riportate da Liekweg (1977) e di Lorentzen (1988) si osserva che la vera emergenza in questo tipo di chirurgia è l infezione da St. Epidermidis (47.4%). L isolamento di questo germe, considerato un opportunista, è diventato negli anni sempre più frequente, non perché sia aumentato in assoluto, ma perché ha acquistato nel tempo nuove caratteristiche di patogenicità e perché vengono sempre più operati individui con resistenze minori e in condizioni sempre più precarie. L aumento di infezioni da Enterococco (14.5%) è stato in gran parte favorito dall uso massiccio prima delle Cefalosporine ed ora dei fluorochinolonici, verso cui questo germe è resistente. La mancata crescita batterica (41.3%) da pus di fistola o da raccolte periprotesiche è spiegata dalla produzione, da parte di alcuni germi, di una matrice anionica sulla superficie della protesi (Slime), che favorisce la crescita in biofilms di microcolonie di batteri, letteralmente sepolti in questa matrice viscosa. A conferma di ciò, se si coltivano frammenti di protesi infetta espiantata (ma con colture negative da fistola o da raccolta), la positività di crescita batterica, in questi casi, aumenta fino all 85%. Le manifestazioni cliniche principali di una infezione protesica possono essere distinte in: Infezioni periprotesiche; Fistole aorto-enteriche. Le prime sono caratterizzate da una elevata percentuale di coinvolgimento della ferita inguinale (77% circa) con formazione di fistola cutanea e o presenza di falso aneurisma (10-13%). In misura minore si possono presentare emorragie, trombosi della protesi, sepsi e manifestazione di emboli settici migrati in periferia. Gli aspetti clinici della infezione di protesi aortica, caratterizzata da fistola aorto-enterica, sono molto diversi e si manifestano essenzialmente con un sanguinamento gastrointestinale, che si verifica nel 60-70% dei casi (può essere acuto nel 66% circa delle volte ed in metà di queste è massivo, mentre nel rimanente gruppo è cronico) Ann. Ital. Chir., LXXII, 2, 2001
3 Omoinnesti vascolari: strategia e tattica operatoria Si può formare una fistola senza sanguinamento, ma è una evenienza del tutto rara. I segni indiretti di fistola aorto-enterica sono abbastanza importanti e possono manifestarsi con malessere, febbre moderata, leucocitosi, aumento della VES ed anemizzazione. La diagnosi può pertanto essere o di semplice attuazione, quando interessa una zona superficiale (inguine) con evidenti segni della sua presenza come: arrossamento cutaneo, dilatazione pseudoaneurismatica, secrezione persistente, oppure di difficile valutazione, specie quando il primitivo interessamento della protesi sia in sede endoaddominale o toracica. In ogni caso va sempre pensata quando un paziente, sottoposto in un tempo variabile ad intervento protesico vascolare manifesti segni anche generici o aspecifici di malattia come: anemia, astenia, febbricola. La diagnosi di fistola aorto-enterica è difficile da stabilire preoperatoriamente: si fonda essenzialmente sull accertamento Endoscopico, che è in grado talora di visualizzare direttamente il tramite intestinale o la protesi sottostante oppure anche la sede e la causa del sanguinamento. Sono presenti frequentemente sintomi sistemici. L a c c e rtamento diagnostico delle infezioni periprotesiche si a v vale dell u t i l i z zodell Ecografia, con possibilità di eseguire agoaspirato per l esame colturale del materiale pre s e n t e in forma saccata o distribuita lungo il corpo pro t e s i c o. È di fondamentale importanza, indipendentemente dalla scelta terapeutica, non solo la certezza diagnostica di infezione, ma la necessità, quando possibile, di isolare preventivamente l agente etiologico che l ha determinata. Testare la sensibilità degli antibiotici specifici per i germi isolati può condizionare positivamente tutta la condotta terapeutica medica futura. La TAC o la RMN sono di particolare aiuto nello studio del retroperitoneo e dello spazio periprotesico evidenziando anche modeste raccolte distribuite lungo la protesi e la eventuale presenza di bolle di gas in tale posizione, segno patognomonico di infezione e l alterata densità dei tessuti molli. Inoltre possono darci un quadro più dettagliato sul rapporto della protesi con gli organi viciniori, la posizione della protesi rispetto alle arterie native e il suo grado di pervietà. La Fistolografia è utile per definire l estensione in profondità dell infezione protesica e può occasionalmente evidenziare la presenza e il livello di una fistola protesiintestino. Le indagini Scintigrafiche (Gallio-67, Leucociti Marcati con Indium 111 o Tecnezio 99, Avidina e Biotina marcati con Indium 111) pur con i limiti determinati da numerosi falsi positivi restano dei markers fondamentali da attuarsi nel work-up di una infezione protesica. Il valore di tali metodiche è tanto maggiore quando è inserito nel contesto di una serie di altri dati per supportare l ipotesi di alto valore sospetto di infezione precoce. L Angiografia di per sé non serve a porre diagnosi di infezione, ma valutando lo stato delle anastomosi può dimostrare la presenza di pseudoaneurismi. Serve comunque a pianificare il timing chirurgico (7-9). Il paziente L età, il rapporto di socialità, le attese di vita, le condizioni clinico biologiche, con particolare riguardo allo stato di ridotte difese immunitarie, l obiettività cardio respiratoria, l entità e la tipologia del quadro di infezione protesica sono elementi che, alla luce della nostra esperienza, rivestono una importanza fondamentale per decidere di attuare un trattamento chirurgico mediante l utilizzo di ricostruzione in situ con omoinnesti arteriosi con la speranza di ottenere un buon risultato clinico. Un paziente anziano (età maggiore di anni), con rischio anestesiologico aumentato (ASA IV), con una infezione protesica a bassa virulenza (low grade) e attese sociali ridotte o per patologie concomitanti o per un habitus psicologico di demotivazione, può beneficiare di soluzioni terapeutiche meno aggressive e che se anche gravate da risultati meno soddisfacenti, consentono di dosare gli sforzi economico gestionali, nel rispetto di una etica del ottenere il miglior risultato facendo correre loro il minor rischio possibile. Pazienti con una età cronologica o biologica accettabile, disposti ad affrontare e a superare un rischio chirurgico elevato (durata media intervento 4-5 ore), con possibili abbondanti perdite ematiche (media sui casi da noi trattati di cc), una degenza in terapia intensiva (media 5-6 gg), la possibilità di interventi associati gastroenterologici o urologici, una terapia antibiotica importante e prolugata per alcuni mesi dopo l intervento e per ultima, ma non meno importante, una forte motivazione personale, (consapevoli che la scelta attuata può essere considerata tappa intermedia intervento bridge, della soluzione di una complicanza drammatica) sono i candidati ideali, se vi è la certezza diagnostica, all uso degli omoinnesti. Congruità morfo-dimensionale dell omoinnesto Un aspetto da non trascurare e sottovalutare è dato dal problema della tipologia dell omoinnesto arterioso disponibile e dal suo utilizzo nel paziente ricevente. Il superamento, attraverso l uso di segmenti crioconservati prelevati da una Banca, della prima fase che prevedeva anche l utilizzo di omoinnesti conservati a fresco, per i quali vi era da parte del chirurgo, il tentativo al banco di rendere idoneo quanto in quel momento era disponibile, ha reso teoricamente meno pressante la soluzione di questo problema. Gli aspetti pratici e teorici devono poter prevedere: Il rispetto di una compatibilità ABO e HLA (che sebbene non documentata in letteratura come significativa Ann. Ital. Chir., LXXII, 2,
4 C. Novali per la riduzione del fenomeno di rigetto cronico, è da noi consigliata); La necessità di utilizzare segmenti di aorta con carrefour indenne e segmenti iliaco - femorali più o meno estesi; L opportunità di superare il problema del diametro dell aorta del ricevente rispetto a quello dell omoinnesto evitando l uso di aorta toracica (più facilmente degenerabile); Ridurre le manovre di tailoring dell omoinnesto evitando plastiche di allargamento, patch o altro; Privilegiare l uso di segmenti unici; Usare segmenti di buona qualità (vedi classi di idoneità dell omoinnesto sotto il profilo anatomo-macroscopico) e negativi per quanto concerne la sierologia e la battereologia (periodo di quarantena). Questi presupposti possono essere rispettati, in tutto o in parte, solo se si attua una diagnostica preliminare del paziente ricevente mediante studio angiografico digitale di tutto l albero arterioso, e TAC tradizionale o spirale, facendo particolare attenzione al segmento aortico infrarenale (possibilità di clampaggio aortico sovrarenale), ai circoli di compenso mesenterico-ipogastrico e della situazione a livello del tripode femorale (stato della femorale profonda e pervietà della femorale superficiale. I due esami in associazione ci consentiranno, come si fa per lo studio preliminare delle endoprotesi aortiche, di caratterizzare le dimensioni del diametro aortico e la lunghezza ipotetica del segmento da utilizzarsi. Nel timing diagnostico preoperatorio conoscere la posizione e lo stato degli ureteri e del segmento intestinale duodeno-digiunale è importante. La possibilità, poi, di far riferimento ad una Banca di crioconservazione, per la scelta del materiale idoneo, che possa rispondere ai nostri requisiti, renderà più sicura ed efficace la procedura di innesto. Tattica operatoria L intervento deve poter prevedere la possibilità di essere gestito da due equipé. Mentre da un lato ci si avvia alla rimozione del graft infetto, un altro gruppo di lavoro procede alla preparazione dell omoinnesto (sutura e legatura dei collaterali, anastomosi a banco di più segmenti per rendere idoneo il materiale procurato) (Fig. 1). Preparazione del paziente. Il paziente viene posizionato sul tavolo in decubito supino, monitorizzato da un punto di vista anestesiologico come per ogni intervento importante nell area aortica. Almeno due accessi venosi, di cui uno venoso centrale, una via arteriosa, il SNG e il catetere vescicale. Può essere opportuno il posizionamento preliminare di cateteri ureterali per il riconoscimento degli stessi in fase operatoria ed evitarne lesioni o sezioni. Il campo operatorio dovrà prevedere la più ampia area di accesso sia a livello addominale, toracico e agli arti Fig. 1: Omoinnesto arterioso: segmento di aorta toracica e aorta addominale, con carrefuor indenne. inferiori e relativa copertura delle stesse mediante teli adesivi trasparenti. Benchè controindicato sotto il profilo teorico, noi abbiamo sempre provveduto ad installare in Sala Operatoria un device per il recupero del sangue, da utilizzarsi in condizioni di estrema emergenza. Una adeguata quantità di sangue intero fresco, plasma e fattori della coagulazione, sono comunque condizione preliminare di sicurezza. L avvio di una terapia antibiotica specifica o ad ampio spett ro, nel caso non sia stato isolato il germe contaminante, p re e intraoperatoria, l uso di gastro p rotettori e la opportunità di sostenere l emodinamica del paziente mediante l uso equilibrato di Dopaminergici e Vasodilatatori, fanno p a rte del programma di gestione di un intervento stre s s a n- te da un punto di vista biologico per il paziente. Il cont rollo della diuresi e il suo efficace mantenimento completano il quadro di gestione anestesiologica. Rimozione del graft infetto Attraverso una laparotomia mediana xifo-pubica e due incisioni inguinali, estese, al triangolo di Scarpa, si controllano le anastomosi distali (nella evenienza più frequente di infezione di by-pass aorto-bifemorale), e si procede alla preparazione di un segmento di aorta nativa e della anastomosi prossimale del graft. Particolare attenzione dovrà essere posta alla lisi delle numerose aderenze intestinali, per evitare problemi di difficoltà di canalizzazione post-operatoria. I punti critici nella fase di isolamento sono: il passaggio, spesso difficoltoso, attraverso il tessuto cicatriziale retroperitoneale, l isolamento del segmento aortico infrasoprarenale, per la necessità in alcuni casi di un clampaggio aortico soprarenale. Molto dipende dal livello della primitiva anastomosi e se si trattava di una anastomosi termino-terminale o termino-laterale. Utile può essere l utilizzo di un occlusore aortico endoluminale (tipo Pruitt), nel caso di impossibilità di isolamento ade Ann. Ital. Chir., LXXII, 2, 2001
5 Omoinnesti vascolari: strategia e tattica operatoria guato dell aorta nativa. Da non trascurare i siti di passaggio delle branche protesiche e il loro contatto con, a sinistra, il segmento colon-sigma, a destra con il cieco, possibili aree di lesione pregressa e di contaminazione infettiva. Attuata la preparazione anatomica dei segmenti arteriosi e del graft, si procede, senza eparinizzazione, al clampaggio aortico e femorale. Il controllo della emostasi da sangue refluo a questo livello può essere ottenuto mediante l uso di Fogarty montati su rubinetto. La rimozione del graft deve essere completa, senza lasciare materiale alloplastico residuo. Verranno eseguite colture sul graft, sui tessuti periprotesici e sull eventuale pus presente. Si dovrà eseguire un courettage il più ampio possibile su tutto quanto in questa fase può apparire sospetto di infezione residua. Nel caso di fistole protesico-intestinali, si dovrà procedere, prima dell innesto, ad una ricostruzione la più fisiologica e definitiva dei segmenti intestinali coinvolti. Se sono necessari ampi interventi demolitivi con resezione del segmento duodenale, digiunale, sigma-colon o del cieco, una temporanea decompressione, mediante stomia derivativa può ridurre le complicanze di deiscenza delle anastomosi intestinali. Le raffie dirette possono essere una soluzione quando il chirurgo consideri il tessuto intestinale non particolarmente compromesso e capace di rispondere positivamente alla guarigione senza determinare problemi funzionali post-operatori. Impianto dell omoinnesto Dopo aver completato la prima fase chirurgica, è prudente rifare il campo operatorio, cambiare gli strumenti chirurgici e il vestiario dell équipe. Previo lavaggio ripetuto dell omoinnesto, con soluzione fisiologica eparinata fredda, controllo della sua preparazione al banco e pre l i e vo di una o più piccole parti da inviare in m i c robiologia per esami colturali, si procede all i n n e s t o. Il primo step prevede l esecuzione della anastomosi prossimale aortica, da eseguirsi con monofilamento non riassorbibile (polipropilene), 3-4/0, avendo l accortezza di anastomizzare l omoinnesto tenendo la sua parte dorsale verso il chirurgo, così da poter controllare che tutte le arterie lombari (o intercostali) suturate tengano adeguatamente dopo il declampaggio. In alcune circostanze l esecuzione di un vrapping con lo stesso materiale biologico in sede di raffia sull anastomosi prossimale, può essere di ulteriore protezione per quest ultima. Nella eventualità di aree di lesione sull omoinnesto che possano richiedere suture dirette, può essere utile interporre al filo un piccolo pladget dello stesso materiale biologico. Tutto questo al fine di evitare al minimo la presenza di materiale alloplastico, che potrebbe comportare un punto di minor resistenza all insulto infettivo. Si procede quindi al declampaggio sull omoinnesto, per controllarne la tenuta, clampandone le estremità con degli angiostati protetti (tipo Fogarty-Klemmer). Da un punto di vista emodinamico e del risultato della rivascolarizzazione in situ, è necessario privilegiare a livello aortico anastomosi termino-terminali. La tunnellizzazione delle sue branche, potrà avvenire nelle sedi di passaggio delle precedenti branche del graft e per evitare torsioni o verificare la presenza di compressioni estrinseche sarà opportuno attuarla a branche pulsanti. Per evitare trombosi dell innesto, in questa fase, può essere utile iniettare distalmente, in contro-flusso, un po di soluzione fisiologica eparinata. La fase successiva prevede la realizzazione delle anastomosi distali, che verranno eseguite sulla femorale comune o profonda, associando se necessario una rivascolarizzazione del segmento femoro-popliteo secondo procedure che evitino l uso di materiali sintetici (vena safena o TEA). Le anastomosi potranno essere o termino-terminali o termino-laterali. Anche in questo caso si privilegierà l utilizzo di un monofilamento non riassorbibile (polipropilene), 5-6/0, con una sutura a filo unico a paracadute. Il rationale dell utilizzo degli omoinnesti deve prevedere una rivascolarizzazione, la più completa possibile, anatomica e in situ (Fig. 2). Controllata l efficacia della procedura e dopo aver eseguito una emostasi assolutamente rigorosa (le perdite ematiche medie nel post - operatorio, sono state, nel nostro gruppo di pazienti operati, circa 1500 cc.), si procede alla chiusura. Non potendo ricostruire il retroperitoneo è da noi consigliata una ricopertura dell omoinnesto mediante l utilizzo di omento (omentoplastica) a livello addominale e se necessario a livello inguinale una plastica di rotazione (flap) muscolare. Il posizionamento di uno o più drenaggi addominali e Fig. 2: Omoinnesto aorto-bifemorale, unico, con plastica di allargamento a triangolo del sito di anastomosi prossimale per una maggiore congruità dei diametri. Ann. Ital. Chir., LXXII, 2,
6 C. Novali Fig. 3: Tac spirale di omoinnesto aorto-bifemorale. inguinali completerà la procedura chirurgica (a caduta o in lieve aspirazione). Decorso post - operatorio e controlli. La gestione rianimatoria in terapia intensiva si è re s a necessaria nel 90% dei casi (con un minimo di 2 gg. e fino ad un massimo di 55 gg., per un paziente affetto da candidosi polmonare e sistemica), con s u p p o rto ventilatorio, stabilizzazione dell e m o d i n a m i c a c a rd i o - c i rcolatoria, controllo della diuresi e delle p e rdite, continuazione della terapia antibiotica, pre f e r i - bilmente mirata, anche sulla scorta dei tamponi e dei c o n t rolli eseguiti sul materiale pre l e vato intraoperat o r i a m e n t e. Molta attenzione deve essere posta al controllo di eventuali infezioni opportunistiche di tipo micotico. Prima della dimissione verrà eseguita una TAC spirale ed eventuale angiografia e scintigrafia con leucociti marcati, che saranno poi da ripetersi a 3, 6, 12 mesi, e poi almeno due volte l anno (Fig. 3). I pazienti sono stati tutti posti in terapia con antiaggreganti piastrinici. Un controllo clinico (visita e Doppler), ed ematologico, controllando il quadro emopoietico, la coagulazione, la immunologia, compresi i test di flogosi e la funzionalità epato - renale, sono consigliati ogni 3 mesi per i primi due anni. Allo stato attuale, sulla base dei dati in nostro possesso, sul g ruppo di pazienti trattati e controllati, sotto il profilo strumentale (spiral CT) è emerso come compaia in una fase p recoce: una stratificazione all interno del lume dell o m o i n- nesto di un film trombotico regolarmente distribuito, e una reazione flogistica periavventiziale (Fig. 4). Nel nostro gru p- po di controllo vi è stata una sola stenosi iperplastica (a l i vello di una anastomosi T-T fra due segmenti di omoinnesto in sede iliaca), che è esitata in una trombosi di branca, nessuna iperplasia anastomotica, un caso di dilatazione aneurismatica a 45 mesi (primo paziente operato, su un omoinnesto a segmento unico, conservato a fresco da donat o re di 68 anni), tale ancora da non dover essere trattata e modeste, non significative, calcificazioni intramurali in 3 omoinnesti (2 freschi e 1 crioconservato). Pazienti Fig. 4: Controllo Di Omoinnesto Con Ct-Scan. Per supportare le considerazioni attuate, sia di carattere metodologico che esperienziale, è necessario fare riferimento, come già espresso più volte nel testo, al contributo personale maturato presso il centro di Chirurgia Vascolare dell Ospedale di Busto Arsizio, diretto dal Prof. Sandro Costantini (6), dove dal Marzo 1994 al Settembre 1996 sono stati impiantati 21 omoinnesti, (in 20 paz.) di cui 19 nell area aortica. In 8 pazienti la diagnosi di ricovero è stata di fistola o erosione aorto-enterica. In tutti i casi si è proceduto ad un trattamento secondo quanto descritto nel testo e la mortalità precoce è stata di 3 pazienti (15%), per rottura di omoinnesto, recidiva di fistola, complicanze cardio-polmonari e tardiva in un caso (5%), per infarto miocardico. Solo in 13 casi l omoinnesto era pervenuto dalla Banca di crioconservazione, mentre nei rimanenti era stato utilizzato a fresco. I segmenti unici sono stati 7, mentre in 14 pazienti si sono dovuti utilizzare omoinnesti compositi. Le complicanze tardive su questo gruppo di controllo sono state: una recidiva di fistola aorto -enterica, che ha richiesto la rimozione dell omoinnesto e l esecuzione di sutura aortica e by-pass axillo e una trombosi di branca risoltasi con trombectomia dell omoinnesto. Il follow up medio è di 41 mesi per i pazienti con Ann. Ital. Chir., LXXII, 2, 2001
7 Omoinnesti vascolari: strategia e tattica operatoria omoinnesti a fresco e di 26 mesi per quelli crioconservati. In entrambi i gruppi abbiamo assistito alla regressione dell infezione, una normalizzazione degli indici di flogosi e una guarigione delle fistole cutanee. Conclusioni Avendo trattato in questo lavoro aspetti puramente tecnico - chirurgici di una scelta metodologica già data come presupposto, lasciamo in altra sede la discussione sulla sua validità, i limiti, gli elementi migliorativi e le inevitabili perplessità che questo trattamento può evocare (2-4). A nostro parere la scelta dell uso dell omoinnesto arterioso, trova ancora delle indicazioni limitate a situazioni cliniche estreme, dove le alternative terapeutiche proposte da altri Autori, sono comunque discutibili e non particolarmente brillanti. In questo ambito l uso degli omoinnesti arteriosi nel trattamento delle infezioni protesiche (anche se come intervento bridge), ha un suo rationale per la documentata capacità di questo a resistere alla infezione stessa, permettendo una ricostruzione in situ, anatomica e funzionale. La tecnica operatoria, inoltre, se correttamente eseguita, nel rispetto di indicazioni precise e in un ambito dove vi sia una capacità gestionale di interventi di chirurgia vascolare maggiore (attuati con una certa routinarietà), consente di ottenere risultati immediati e a distanza, al momento, allineabili a quelli ottenuti con soluzioni diverse. L approfondimento di molte tematiche relative ai meccanismi del rigetto cronico dell omoinnesto, al suo trattamento in fase di prelievo, conservazione e innesto, la possibilità di associare terapie immunodepressive e l eventuale allargamento delle indicazioni chirurgiche, potranno offrire nel prossimo futuro risultati ancora migliori e stabili nel tempo (1-6-11). Bibliografia 1) Allaire E., Guettier C., Bruneval P., Plissonier D., Michel J.B.: Cell-free arterial grafts: morphologic characteristics of aortic isografts, allografts, and xenografts in rats. J Vasc Surg, (3): , ) Callow A.D.: Arterial Homografts. Eur J Vasc Endovasc Surg, 12: , ) Chiesa R. e coll.: Fresh and criopreserved arterial homografts in the treatment of prosthetic graft infections: Experience of Italian Collaborative Vascular Homograft Group. Ann Vasc Surg, 12(5): , ) Desgranges P., Beaujan Ph. F., Brunet S. et al.: Criopreserved arterial allografts used for the treatment of infected vascular grafts. Ann Vasc Surg, 12(6): , ) Locati P.M., Socrate A.M., Costantini E., Campanacci B.: Homograft arteriosi: confronto preliminare fra conservati a fresco e crioconservati nelle infezioni del distretto aortobifemorale. Arch Chir Torac Cardiovasc, 20:64-70, ) Magne J.L., Farah I., Roux J.J., Voirin L. et al.: Below knee bypass using fresh arterial allografts for limb salvage: early results. Ann Vasc Surg, 11(3): , ) Merrel S.W., Lawrence P.F.: Diagnosis of graft infection: anatomic and functional imaging techniques. Sem Vasc Surg, 3:89-100, ) Novali C., Locati P.M., Costantini S.: Infezioni protesiche: trat - tamento mediante sostituzione in situ di omoinnesti arteriosi. Esperienza preliminare. Arch Chir Tor Cardiovasc, 16: , ) Remly L.M., Stoney R.S., Goldstone J.: Improved management of aortic graft infection: the influence of operation sequence and staging. J Vasc Surg, 5: , ) Ruotolo C., Plissonier D., Bahnini A., Koskas F., Kieffer E.: In situ arterial allografts: a new treatment for aortic prosthetic infec - tion. Eur J Vasc Endovasc Surg, 14(A): , ) Schmitz-Rixen T., Megerman J., Colvin R.B. et al.: Immunosupressive treatment of aortic allografts. J Vasc Surg, 7:82-92, Ann. Ital. Chir., LXXII, 2,
Lovisetti L., Lovisetti G., Catagni M.A. Divisione di Ortopedia Ospedale A.Manzoni Lecco Primario Prof.M.A.Catagni
 Infezioni di gamba associate a perdite massive di sostanza ossea e tessuti molli : trattamento ricostruttivo con trasporto peroneale con metodica di Ilizarov, associato ad O.T.I. Lovisetti L., Lovisetti
Infezioni di gamba associate a perdite massive di sostanza ossea e tessuti molli : trattamento ricostruttivo con trasporto peroneale con metodica di Ilizarov, associato ad O.T.I. Lovisetti L., Lovisetti
INFEZIONE PRECOCE DOPO EVAR
 I^ meeting euganeo di chirurgia vascolare Trattamento endovascolare degli aneurismi dell aorta addominale INFEZIONE PRECOCE DOPO EVAR U.O. 2^ chirurgia Dr. G. Tosolini U.O. radiologia interventistica Dr.
I^ meeting euganeo di chirurgia vascolare Trattamento endovascolare degli aneurismi dell aorta addominale INFEZIONE PRECOCE DOPO EVAR U.O. 2^ chirurgia Dr. G. Tosolini U.O. radiologia interventistica Dr.
scaricato da
 ANEURISMI DELL AORTA ADDOMINALE Aneurisma arterioso Aorta addominale - Definizione Definizione Diametro (età > 50 aa) Dilatazione permanente di una arteria che presenta un incremento di almeno il 50% del
ANEURISMI DELL AORTA ADDOMINALE Aneurisma arterioso Aorta addominale - Definizione Definizione Diametro (età > 50 aa) Dilatazione permanente di una arteria che presenta un incremento di almeno il 50% del
CONSENSO INFORMATO PER INTERVENTO CHIRURGICO DI AMPUTAZIONE DEL PENE E LINFOADENECTOMIA INGUINALE
 CONSENSO INFORMATO PER INTERVENTO CHIRURGICO DI AMPUTAZIONE DEL PENE E LINFOADENECTOMIA INGUINALE PREMESSE L amputazione del pene è un intervento chirurgico demolitivo con la finalità di asportartazione
CONSENSO INFORMATO PER INTERVENTO CHIRURGICO DI AMPUTAZIONE DEL PENE E LINFOADENECTOMIA INGUINALE PREMESSE L amputazione del pene è un intervento chirurgico demolitivo con la finalità di asportartazione
Complicanze FAV. Dott. T. Fidelio. S.C. Nefrologia ASLTO4 Ciriè
 Complicanze FAV Dott. T. Fidelio S.C. Nefrologia ASLTO4 Ciriè La gestione infermieristica della FAV è fondamentale Gestione complicanze o malfunzionamento Cattivo funzionamento responsabile di una terapia
Complicanze FAV Dott. T. Fidelio S.C. Nefrologia ASLTO4 Ciriè La gestione infermieristica della FAV è fondamentale Gestione complicanze o malfunzionamento Cattivo funzionamento responsabile di una terapia
CRITERI GENERALI DI GRADUALITA DI APPRENDIMENTO
 CRITERI GENERALI DI GRADUALITA DI APPRENDIMENTO Primo anno: Piccola e media chirurgia generale. Laparotomie. Safenectomie. Ablazione laser. Diagnostica EcocolorDoppler. Saper gestire il reparto. Secondo
CRITERI GENERALI DI GRADUALITA DI APPRENDIMENTO Primo anno: Piccola e media chirurgia generale. Laparotomie. Safenectomie. Ablazione laser. Diagnostica EcocolorDoppler. Saper gestire il reparto. Secondo
scaricato da
 Corso Integrato di Malattie Cardiovascolari Coordinatore: Prof. M. Cotrufo LE PATOLOGIE DELL AORTA L AORTA E UNA STRUTTURA ESTREMAMENTE VULNERABILE perche la tunica media e povera di fibrocellule muscolari
Corso Integrato di Malattie Cardiovascolari Coordinatore: Prof. M. Cotrufo LE PATOLOGIE DELL AORTA L AORTA E UNA STRUTTURA ESTREMAMENTE VULNERABILE perche la tunica media e povera di fibrocellule muscolari
Laparoscopia in Chirurgia di Parete: Quali Evidenze? Carlo Feo
 Laparoscopia in Chirurgia di Parete: Quali Evidenze? Carlo Feo Clinica Chirurgica Direttore: Prof. A. Liboni Ferrara, 11/05/2015 Indice Evidenze chirurgia laparoscopica vs. open Ernie inguinali Plastiche
Laparoscopia in Chirurgia di Parete: Quali Evidenze? Carlo Feo Clinica Chirurgica Direttore: Prof. A. Liboni Ferrara, 11/05/2015 Indice Evidenze chirurgia laparoscopica vs. open Ernie inguinali Plastiche
R. Tasinato, M. Dei Negri, S. Pillirone, E. Biral, E. Tiso, F. Meggiolaro, P. Da Pian
 R. Tasinato, M. Dei Negri, S. Pillirone, E. Biral, E. Tiso, F. Meggiolaro, P. Da Pian Unita Operativa Complessa di Chirurgia Generale A.s.l.13 Presidio Ospedaliero di Mirano (Venezia) Direttore: Dott.
R. Tasinato, M. Dei Negri, S. Pillirone, E. Biral, E. Tiso, F. Meggiolaro, P. Da Pian Unita Operativa Complessa di Chirurgia Generale A.s.l.13 Presidio Ospedaliero di Mirano (Venezia) Direttore: Dott.
Allo stato attuale la casistica consta di 60 casi trattati con peritonectomia e chemioipetermia intraoperatoria.
 I dati sintetizzati nella tabella sopra riportata nel contesto delle esperienze internazionali sono relativi alla casistica di 47 casi relativa al periodo 2000-20007 analizzata nell articolo: Cytoreductive
I dati sintetizzati nella tabella sopra riportata nel contesto delle esperienze internazionali sono relativi alla casistica di 47 casi relativa al periodo 2000-20007 analizzata nell articolo: Cytoreductive
INSUFFICIENZA RENALE ACUTA
 INSUFFICIENZA RENALE ACUTA Sindrome clinico-metabolica caratterizzata da una rapida (ore, giorni) riduzione del filtrato glomerulare (VFG) con conseguente ritenzione dei prodotti del catabolismo azotato
INSUFFICIENZA RENALE ACUTA Sindrome clinico-metabolica caratterizzata da una rapida (ore, giorni) riduzione del filtrato glomerulare (VFG) con conseguente ritenzione dei prodotti del catabolismo azotato
ASCESSO MEDIASTINICO TRATTATO IN URGENZA IN VIDEOTORACOSCOPIA
 LA CHIRURGIA MINI INVASIVA NELLE URGENZE TORACO ADDOMINALI COSA C È DI NUOVO? POTENZA, 25 MAGGIO 2012 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO POTENZA ASCESSO MEDIASTINICO TRATTATO IN URGENZA IN VIDEOTORACOSCOPIA
LA CHIRURGIA MINI INVASIVA NELLE URGENZE TORACO ADDOMINALI COSA C È DI NUOVO? POTENZA, 25 MAGGIO 2012 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO POTENZA ASCESSO MEDIASTINICO TRATTATO IN URGENZA IN VIDEOTORACOSCOPIA
LINEE-GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL MRSA
 AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE COMITATO INFEZIONI OSPEDALIERE LINEE-GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL MRSA (STAFILOCOCCO AUREO METICILLINO RESISTENTE) aggiornate ad Agosto 2001 DEFINIZIONE
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE COMITATO INFEZIONI OSPEDALIERE LINEE-GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL MRSA (STAFILOCOCCO AUREO METICILLINO RESISTENTE) aggiornate ad Agosto 2001 DEFINIZIONE
L articolazione sacro-iliaca può dare origine al dolore cronico lombare
 L articolazione sacro-iliaca può dare origine al dolore cronico lombare Schwarzer AC. Spine 1995 13-3 % Maigne JY et al. Spine 1996 Manchikanti L et al. Pain Physician 21 Irwin RW et al. Am J Phys Med
L articolazione sacro-iliaca può dare origine al dolore cronico lombare Schwarzer AC. Spine 1995 13-3 % Maigne JY et al. Spine 1996 Manchikanti L et al. Pain Physician 21 Irwin RW et al. Am J Phys Med
Embolia polmonare Ostruzione di uno o più vasi arteriosi polmonari, determinata dalla presenza di
 Embolia polmonare Ostruzione di uno o più vasi arteriosi polmonari, determinata dalla presenza di coaguli ematici di natura embolica trombosi locale o cardiaca emboli non trombotici (settici, neoplastici)
Embolia polmonare Ostruzione di uno o più vasi arteriosi polmonari, determinata dalla presenza di coaguli ematici di natura embolica trombosi locale o cardiaca emboli non trombotici (settici, neoplastici)
IL PERCORSO DEL TUMORE DEL COLON-RETTO
 IL PERCORSO DEL TUMORE DEL COLON-RETTO ACOI Piemonte Torino, marzo 2010 Enzo C. Farina enzo.farina@aress.piemonte.it AR2010_ACOI_PDTA_colret 2 TRiPSS 2 Trasferire i Risultati (della Ricerca Sanitaria)
IL PERCORSO DEL TUMORE DEL COLON-RETTO ACOI Piemonte Torino, marzo 2010 Enzo C. Farina enzo.farina@aress.piemonte.it AR2010_ACOI_PDTA_colret 2 TRiPSS 2 Trasferire i Risultati (della Ricerca Sanitaria)
INSUFFICIENZA CELIACO MESENTERICA CRONICA (ICM). www.fisiokinesiterapia.biz
 INSUFFICIENZA CELIACO MESENTERICA CRONICA (ICM). www.fisiokinesiterapia.biz La Ischemia Celiaco Mesenterica Cronica (ICM) è stata descritta ai primi del 900 come: Sindrome caratterizzata dalla comparsa
INSUFFICIENZA CELIACO MESENTERICA CRONICA (ICM). www.fisiokinesiterapia.biz La Ischemia Celiaco Mesenterica Cronica (ICM) è stata descritta ai primi del 900 come: Sindrome caratterizzata dalla comparsa
PATOLOGIE DELL AORTA
 PATOLOGIE DELL AORTA LE ISCHEMIE MESENTERICHE EMBOLIA: Occlusione acuta soprattutto in pazienti cardiopatici con disturbi del ritmo o alterazioni valvolari reumatiche. L'EMBOLO si arresta dove il calibro
PATOLOGIE DELL AORTA LE ISCHEMIE MESENTERICHE EMBOLIA: Occlusione acuta soprattutto in pazienti cardiopatici con disturbi del ritmo o alterazioni valvolari reumatiche. L'EMBOLO si arresta dove il calibro
Casistica operatoria Attività Cardiovascolare Dott. Michele F. Roesler giugno1987- aprile 2012
 Casistica operatoria Attività Cardiovascolare Dott. Michele F. Roesler giugno1987- aprile 2012 La casistica operatoria allegata si riferisce all attività cardiovascolare svolta in Italia dal Dott. M.F.
Casistica operatoria Attività Cardiovascolare Dott. Michele F. Roesler giugno1987- aprile 2012 La casistica operatoria allegata si riferisce all attività cardiovascolare svolta in Italia dal Dott. M.F.
Foglio informativo per il paziente
 DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO-VASCOLARE E DI AREA CRITICA STRUTTURA COMPLESSA DI CHIRURGIA VASCOLARE DOTT. ENRICO VECCHIATI - DIRETTORE TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ANEURISMA DELL AORTA ADDOMINALE Foglio informativo
DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO-VASCOLARE E DI AREA CRITICA STRUTTURA COMPLESSA DI CHIRURGIA VASCOLARE DOTT. ENRICO VECCHIATI - DIRETTORE TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ANEURISMA DELL AORTA ADDOMINALE Foglio informativo
Quando eseguire l ecografia dell aorta? Perché durante un ecocardiogramma?
 Quando eseguire l ecografia dell aorta? Perché durante un ecocardiogramma? A. Sulla e R. Lumare Unità Operativa di Cardiologia UTC P.O. San Giovanni di Dio Crotone ncontri Pitagorici di Cardiologia 2012
Quando eseguire l ecografia dell aorta? Perché durante un ecocardiogramma? A. Sulla e R. Lumare Unità Operativa di Cardiologia UTC P.O. San Giovanni di Dio Crotone ncontri Pitagorici di Cardiologia 2012
TRAUMI DEL TORACE Strutture potenzialmente interessate
 I TRAUMI DEL TORACE TRAUMI DEL TORACE Il 25% della mortalità da cause traumatiche è dovuta a traumi del torace Il 66% dei decessi per trauma toracico avviene dopo il ricovero in ospedale L 85% dei pazienti
I TRAUMI DEL TORACE TRAUMI DEL TORACE Il 25% della mortalità da cause traumatiche è dovuta a traumi del torace Il 66% dei decessi per trauma toracico avviene dopo il ricovero in ospedale L 85% dei pazienti
U.O. Urologia Ospedale San Donato - Arezzo
 , Michele De Angelis Giuseppe Romano U.O. Urologia Ospedale San Donato - Arezzo Associazione Toscana di Urologia Convegno Annuale Regionale Sovigliana Vinci 12 dicembre 2009 Stenosi ed incontinenza dopo
, Michele De Angelis Giuseppe Romano U.O. Urologia Ospedale San Donato - Arezzo Associazione Toscana di Urologia Convegno Annuale Regionale Sovigliana Vinci 12 dicembre 2009 Stenosi ed incontinenza dopo
Un caso di endocardite
 Un caso di endocardite G. Paternoster, N. Stigliano Reparto di Terapia Intensiva Cardiochirurgica, Casa di cura Villa Verde, Taranto Anamnesi patologica remota Paziente di sesso femminile, 82 anni, anamnesi
Un caso di endocardite G. Paternoster, N. Stigliano Reparto di Terapia Intensiva Cardiochirurgica, Casa di cura Villa Verde, Taranto Anamnesi patologica remota Paziente di sesso femminile, 82 anni, anamnesi
CATETERISMO CARDIACO, CORONAROGRAFIA, ANGIOGRAFIA PERIFERICA CONSENSO INFORMATO CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA PER EMODINAMICA E
 Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e Area Critica Cardiologia Interventistica Dott. Antonio Manari - Direttore CONSENSO INFORMATO PER EMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA CATETERISMO CARDIACO, CORONAROGRAFIA,
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e Area Critica Cardiologia Interventistica Dott. Antonio Manari - Direttore CONSENSO INFORMATO PER EMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA CATETERISMO CARDIACO, CORONAROGRAFIA,
ECMO : ExtraCorporeal Membrane Oxygenation Tecnica di supporto cardiopolmonare per pz con insufficienza i cardiaca potenzialmente t reversibile ma non
 Paziente con ECMO veno-arterioso Caso assistenziale in cardiochirurgia terapia intensiva Airoldi Barbara Infermiera Cchti Ospedale Maggiore della Carità Novara ECMO : ExtraCorporeal Membrane Oxygenation
Paziente con ECMO veno-arterioso Caso assistenziale in cardiochirurgia terapia intensiva Airoldi Barbara Infermiera Cchti Ospedale Maggiore della Carità Novara ECMO : ExtraCorporeal Membrane Oxygenation
LE STENOSI ANASTOMOTICHE DIGESTIVE TRATTAMENTI A CONFRONTO
 LE STENOSI ANASTOMOTICHE DIGESTIVE TRATTAMENTI A CONFRONTO Dr. Giorgio Benedetti SSD Gastroenterologia OC PN Riunione SIED/AIGO Udine, 12 Aprile 2010 LE STENOSI ANASTOMOTICHE DIGESTIVE LE STENOSI DELLE
LE STENOSI ANASTOMOTICHE DIGESTIVE TRATTAMENTI A CONFRONTO Dr. Giorgio Benedetti SSD Gastroenterologia OC PN Riunione SIED/AIGO Udine, 12 Aprile 2010 LE STENOSI ANASTOMOTICHE DIGESTIVE LE STENOSI DELLE
Cos è un CVC( catetere venoso centrale)
 Cos è un CVC( catetere venoso centrale) A cura del Dott. Pierpaolo Casalini U.O. Rianimazione P.O. Faenza Cos è un CVC? E una porta aperta ( soluzione di continuo) fra il torrente venoso in prossimità
Cos è un CVC( catetere venoso centrale) A cura del Dott. Pierpaolo Casalini U.O. Rianimazione P.O. Faenza Cos è un CVC? E una porta aperta ( soluzione di continuo) fra il torrente venoso in prossimità
SINDROME DA ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI
 SINDROME DA ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI Malattia caratterizzata da trombosi arteriose e/o venose ricorrenti, aborti ripetuti, trombocitopenia,, in associazione a titoli medio-alti di anticorpi anti-fosfolipidi
SINDROME DA ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI Malattia caratterizzata da trombosi arteriose e/o venose ricorrenti, aborti ripetuti, trombocitopenia,, in associazione a titoli medio-alti di anticorpi anti-fosfolipidi
La Chirurgia Flebologica in Day-Surgery
 La Chirurgia Flebologica in Day-Surgery Day-surgery e Chirurgia Ambulatoriale... La parola Day-Surgery viene utilizzata per indicare la possibilità di eseguire interventi chirurgici o procedimenti diagnostici
La Chirurgia Flebologica in Day-Surgery Day-surgery e Chirurgia Ambulatoriale... La parola Day-Surgery viene utilizzata per indicare la possibilità di eseguire interventi chirurgici o procedimenti diagnostici
L impiego di sistemi protesici per l incontinenza urinaria e il descensus pelvico nella pratica clinica: l esperienza di Cesena
 Cesena, D. De Paoli -AOGOI- Marzo 2010 L impiego di sistemi protesici per l incontinenza urinaria e il descensus pelvico nella pratica clinica: l esperienza di Cesena Daniela De Paoli Cesena, D. De Paoli
Cesena, D. De Paoli -AOGOI- Marzo 2010 L impiego di sistemi protesici per l incontinenza urinaria e il descensus pelvico nella pratica clinica: l esperienza di Cesena Daniela De Paoli Cesena, D. De Paoli
Alessandro Pezzoli U.O di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva Az. Osp. Sant Anna Ferrara
 Alessandro Pezzoli U.O di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva Az. Osp. Sant Anna Ferrara Le emergenze-urgenze in endoscopia digestiva, Ferrara 3/12/2010 Sanguinamento: ematochezia e rettoragia Occlusione
Alessandro Pezzoli U.O di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva Az. Osp. Sant Anna Ferrara Le emergenze-urgenze in endoscopia digestiva, Ferrara 3/12/2010 Sanguinamento: ematochezia e rettoragia Occlusione
Ittero ostruttivo da causa iatrogena La strategia terapeutica: evidenze e controversie
 Università degli Studi di Trieste UCO di Chirurgia Generale Direttore Prof. Nicolò de Manzini Foto TRIESTE Ittero ostruttivo da causa iatrogena La strategia terapeutica: evidenze e controversie N. de Manzini
Università degli Studi di Trieste UCO di Chirurgia Generale Direttore Prof. Nicolò de Manzini Foto TRIESTE Ittero ostruttivo da causa iatrogena La strategia terapeutica: evidenze e controversie N. de Manzini
LE EMORRAGIE ADDOMINALI IN PRONTO SOCCORSO: DIAGNOSI E TERAPIA
 LE EMORRAGIE ADDOMINALI IN PRONTO SOCCORSO: DIAGNOSI E TERAPIA RUOLO DELLA TC ms NELLE EMORRAGIE PELVICHE Claudia Cecchi U.O.C. Radiologia Pronto Soccorso Dipartimento Emergenza Urgenza (Direttore: Dr.
LE EMORRAGIE ADDOMINALI IN PRONTO SOCCORSO: DIAGNOSI E TERAPIA RUOLO DELLA TC ms NELLE EMORRAGIE PELVICHE Claudia Cecchi U.O.C. Radiologia Pronto Soccorso Dipartimento Emergenza Urgenza (Direttore: Dr.
Occidentale P. O. Pordenone; (2) S. C. Ingegneria biomedicale e sistema informatico A. A. Sanitaria N.5 Friuli Occidentale P. O. Pordenone.
 COMPLICANZE INFETTIVE NEL PAZIENTE DIALIZZATO PORTATORE DI CVC LONG-TERM: L ESPERIENZA PORDENONESE Sandra De Roia (1), Mauro Presot (2) e Giacomo Panarello (1) (1) S. C. Nefrologia e Dialisi A. A. Sanitaria
COMPLICANZE INFETTIVE NEL PAZIENTE DIALIZZATO PORTATORE DI CVC LONG-TERM: L ESPERIENZA PORDENONESE Sandra De Roia (1), Mauro Presot (2) e Giacomo Panarello (1) (1) S. C. Nefrologia e Dialisi A. A. Sanitaria
PROFILASSI ANTITROMBOTICA IN CHIRURGIA GENERALE
 CHIRURGIA GENERALE MAGGIORE (tutti gli interventi di durata > 30 minuti o di chirurgia addominale) TIPO DI PATOLOGIA TIPO DI CHIRURGIA MIRE (tutti gli interventi di durata < 30 minuti, esclusa la chirurgia
CHIRURGIA GENERALE MAGGIORE (tutti gli interventi di durata > 30 minuti o di chirurgia addominale) TIPO DI PATOLOGIA TIPO DI CHIRURGIA MIRE (tutti gli interventi di durata < 30 minuti, esclusa la chirurgia
mucosa normale neoplasia
 mucosa normale neoplasia emicolectomia destra anastomosi ileo-colica (fra ultima ansa ileale e colon trasverso) emicolectomia destra Polipo del colon, cancerizzato Neoplasia del cieco o del colon ascendente
mucosa normale neoplasia emicolectomia destra anastomosi ileo-colica (fra ultima ansa ileale e colon trasverso) emicolectomia destra Polipo del colon, cancerizzato Neoplasia del cieco o del colon ascendente
Accettazione del paziente in U.O. di chirurgia
 ACCOGLIENZA DEL PAZIENTE IN U.O. di CHIRURGIA Accettazione del paziente in U.O. di chirurgia Ricovero in emergenza ed urgenza Ricovero ordinario programmato Day Hospital Day Surgery Il ricovero in U.O.
ACCOGLIENZA DEL PAZIENTE IN U.O. di CHIRURGIA Accettazione del paziente in U.O. di chirurgia Ricovero in emergenza ed urgenza Ricovero ordinario programmato Day Hospital Day Surgery Il ricovero in U.O.
Dott.. Giuseppe Di Mauro. (Caserta)
 Problematiche e prospettive dell antibioticoterapia in età pediatrica Dott.. Giuseppe Di Mauro (Caserta) Obiettivo Migliorare la prescrizione di farmaci in termini di efficacia e di efficienza tenendo
Problematiche e prospettive dell antibioticoterapia in età pediatrica Dott.. Giuseppe Di Mauro (Caserta) Obiettivo Migliorare la prescrizione di farmaci in termini di efficacia e di efficienza tenendo
CARTELLA STAMPA. Giovedì 12 gennaio 2006 ore 12 Via Manzoni 14 Savona
 CARTELLA STAMPA Giovedì 12 gennaio 2006 ore 12 Via Manzoni 14 Savona LA CURA DELLE MALATTIE VASCOLARI CON TECNICHE AVANZATE ALL OSPEDALE S.PAOLO DI SAVONA La cura delle malattie vascolari dal dopo guerra
CARTELLA STAMPA Giovedì 12 gennaio 2006 ore 12 Via Manzoni 14 Savona LA CURA DELLE MALATTIE VASCOLARI CON TECNICHE AVANZATE ALL OSPEDALE S.PAOLO DI SAVONA La cura delle malattie vascolari dal dopo guerra
COMPLICANZE STOMALI - 21 70 % - Rischio aumenta con il tempo - Incidenza > nei primi 5 anni dall intervento
 STOMIE: COMPLICANZE e TRATTAMENTO Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche Chirurgia Generale A Direttore: Prof. A. Guglielmi Struttura Semplice Organizzativa Chirurgia Coloproctologica
STOMIE: COMPLICANZE e TRATTAMENTO Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche Chirurgia Generale A Direttore: Prof. A. Guglielmi Struttura Semplice Organizzativa Chirurgia Coloproctologica
ISCHEMIE ACUTE DEGLI ARTI (Inferiori) www.fisiokinesiterapia.biz
 ISCHEMIE ACUTE DEGLI ARTI (Inferiori) www.fisiokinesiterapia.biz Definizione di Ischemia Acuta di un Arto Qualsiasi riduzione o peggioramento improvviso della perfusione della estremità in grado di causare
ISCHEMIE ACUTE DEGLI ARTI (Inferiori) www.fisiokinesiterapia.biz Definizione di Ischemia Acuta di un Arto Qualsiasi riduzione o peggioramento improvviso della perfusione della estremità in grado di causare
DISSEZIONE DISCRETA DELL AORTA ASCENDENTE: UNA DIAGNOSI DIFFICILE Emanuela Lanari 1, Pierpaolo Cannarozzo 1, Fabio Chirillo 2, Pietro Delise 1 1
 DISSEZIONE DISCRETA DELL AORTA ASCENDENTE: UNA DIAGNOSI DIFFICILE Emanuela Lanari 1, Pierpaolo Cannarozzo 1, Fabio Chirillo 2, Pietro Delise 1 1 UO Cardiologia, Ospedale Civile, Conegliano Veneto 2 UO
DISSEZIONE DISCRETA DELL AORTA ASCENDENTE: UNA DIAGNOSI DIFFICILE Emanuela Lanari 1, Pierpaolo Cannarozzo 1, Fabio Chirillo 2, Pietro Delise 1 1 UO Cardiologia, Ospedale Civile, Conegliano Veneto 2 UO
Complicanze in chirurgia laparoscopica
 Università degli Studi di Trieste UCO di Chirurgia Generale Direttore Prof. Nicolo de Manzini Complicanze in chirurgia laparoscopica Trieste Complicanze generali Introduzione dei trocar Emorragie maggiori
Università degli Studi di Trieste UCO di Chirurgia Generale Direttore Prof. Nicolo de Manzini Complicanze in chirurgia laparoscopica Trieste Complicanze generali Introduzione dei trocar Emorragie maggiori
ANEURISMA PRIMITIVO DELLA VENA FEMORALE COMUNE
 llegio Italiano di Flebologia 8 Congresso Nazionale Roma 6 9 ottobre 20 ANEURISMA PRIMITIVO DELLA VENA FEMORALE COMUNE F.D Angelo M. Pace F.Abbritti M.Borsetto C.Zorzoli Azienda Ospedaliera G. Salvini
llegio Italiano di Flebologia 8 Congresso Nazionale Roma 6 9 ottobre 20 ANEURISMA PRIMITIVO DELLA VENA FEMORALE COMUNE F.D Angelo M. Pace F.Abbritti M.Borsetto C.Zorzoli Azienda Ospedaliera G. Salvini
L intervento è stato preceduto da un briefing formativo con l equipe per illustrare la nuova tecnologia e tecnica chirurgica.
 Alla Fondazione Giovanni Paolo II l equipe di cardiochirurgia ha eseguito un intervento miniinvasivo impiantando un innovativa valvola aortica di ultimissima generazione 17 novembre 2015 - Il dottor Mario
Alla Fondazione Giovanni Paolo II l equipe di cardiochirurgia ha eseguito un intervento miniinvasivo impiantando un innovativa valvola aortica di ultimissima generazione 17 novembre 2015 - Il dottor Mario
Complicanze locali in esiti di osteotomia antivalgo. Allergia ai metalli?
 Complicanze locali in esiti di osteotomia antivalgo. Allergia ai metalli? Paolo GHIGGIO Patrizia MACCHIERALDO ASLTO4 S.O.C. Ortopedia e Traumatologia IVREA Direttore: dott. P.Ghiggio CASO CLINICO Paziente
Complicanze locali in esiti di osteotomia antivalgo. Allergia ai metalli? Paolo GHIGGIO Patrizia MACCHIERALDO ASLTO4 S.O.C. Ortopedia e Traumatologia IVREA Direttore: dott. P.Ghiggio CASO CLINICO Paziente
George J. Chang, MD, MS, FACS, FASCRS
 Follow-up does not improve cancer-related survival, is resource-inefficient, and does not improve quality of life, but may be a frequent source of inconvenience and anxiety [for patients]. George J. Chang,
Follow-up does not improve cancer-related survival, is resource-inefficient, and does not improve quality of life, but may be a frequent source of inconvenience and anxiety [for patients]. George J. Chang,
Percorso scompenso cardiaco secondo Chronic Care nella zona montana: a che punto siamo, quali sono i problemi e quali le prospettive di sviluppo.
 Percorso scompenso cardiaco secondo Chronic Care nella zona montana: a che punto siamo, quali sono i problemi e quali le prospettive di sviluppo. Scompenso cardiaco Lo scompenso cardiaco rappresenta una
Percorso scompenso cardiaco secondo Chronic Care nella zona montana: a che punto siamo, quali sono i problemi e quali le prospettive di sviluppo. Scompenso cardiaco Lo scompenso cardiaco rappresenta una
CASO CLINICO. Tutto per un calcolo. R.Bassu, A. Alessandrì, M. Checchi, I. Lucchesi, L. Teghini, G. Panigada
 CASO CLINICO Tutto per un calcolo R.Bassu, A. Alessandrì, M. Checchi, I. Lucchesi, L. Teghini, G. Panigada - G.F. Uomo di 47 aa - In anamnesi: storia di poliposi nasale e nefrolitiasi per cui nel 2001
CASO CLINICO Tutto per un calcolo R.Bassu, A. Alessandrì, M. Checchi, I. Lucchesi, L. Teghini, G. Panigada - G.F. Uomo di 47 aa - In anamnesi: storia di poliposi nasale e nefrolitiasi per cui nel 2001
Gli accessi venosi e il posizionamento del CVC. Pier Mario Giugiaro
 Gli accessi venosi e il posizionamento del CVC Pier Mario Giugiaro LE COMPLICANZE LEGATE AI CVC COMPLICANZE DEL POSIZIONAMENTO CONDIZIONI PRELIMINARI Scelta accurata dell accesso venoso Colloquio con il
Gli accessi venosi e il posizionamento del CVC Pier Mario Giugiaro LE COMPLICANZE LEGATE AI CVC COMPLICANZE DEL POSIZIONAMENTO CONDIZIONI PRELIMINARI Scelta accurata dell accesso venoso Colloquio con il
Regolamento Didattico. Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare
 Regolamento Didattico Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare Piano degli studi I anno S.S.D. CFU Patologia clinica dell apparato cardiovascolare MED/07, MED/15, MED/08, BIO/16, 5 BIO/09, BIO/14,
Regolamento Didattico Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare Piano degli studi I anno S.S.D. CFU Patologia clinica dell apparato cardiovascolare MED/07, MED/15, MED/08, BIO/16, 5 BIO/09, BIO/14,
Foglio informativo per il paziente
 DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO-VASCOLARE E DI AREA CRITICA STRUTTURA COMPLESSA DI CHIRURGIA VASCOLARE DOTT. ENRICO VECCHIATI - DIRETTORE TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE ARTERIOPATIE AORTO-ILIACO-FEMORALI Foglio
DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO-VASCOLARE E DI AREA CRITICA STRUTTURA COMPLESSA DI CHIRURGIA VASCOLARE DOTT. ENRICO VECCHIATI - DIRETTORE TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE ARTERIOPATIE AORTO-ILIACO-FEMORALI Foglio
Zenith Alpha ABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT
 Pianificazione e determinazione delle dimensioni idonee Zenith Alpha ABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT www.cookmedical.com D19676-IT-F Pianificazione e determinazione delle dimensioni idonee Effettuare la scansione
Pianificazione e determinazione delle dimensioni idonee Zenith Alpha ABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT www.cookmedical.com D19676-IT-F Pianificazione e determinazione delle dimensioni idonee Effettuare la scansione
Il rischio clinico nel processo di donazione e trapianto di organi e tessuti
 Il rischio clinico nel processo di donazione e trapianto di organi e tessuti Le indagini neuroradiologiche nell accertamento della morte cerebrale Piero Floridi Azienda Ospedaliera Perugia Più di 100 persone
Il rischio clinico nel processo di donazione e trapianto di organi e tessuti Le indagini neuroradiologiche nell accertamento della morte cerebrale Piero Floridi Azienda Ospedaliera Perugia Più di 100 persone
Regolamento Didattico. Scuola di Specializzazione in Chirurgia toracica
 Regolamento Didattico Scuola di Specializzazione in Chirurgia toracica Piano degli studi I anno S.S.D. CFU Materie di base, inglese scientifico e ricerca BIO/16, MED/08, BIO/09, MED/07, BIO/14, MED/15,
Regolamento Didattico Scuola di Specializzazione in Chirurgia toracica Piano degli studi I anno S.S.D. CFU Materie di base, inglese scientifico e ricerca BIO/16, MED/08, BIO/09, MED/07, BIO/14, MED/15,
Le certezze e i dubbi del medico d urgenza
 GESTIONE IN DEA DEL PAZIENTE CON DOLORE ADDOMINALE Torino, 20 febbraio 2010 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano Le certezze e i dubbi del medico d urgenza Luisa Arnaldi SC Medicina d Urgenza Ospedale
GESTIONE IN DEA DEL PAZIENTE CON DOLORE ADDOMINALE Torino, 20 febbraio 2010 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano Le certezze e i dubbi del medico d urgenza Luisa Arnaldi SC Medicina d Urgenza Ospedale
DIV:chirurgia. Approccio attraverso la tricuspide. Monza, 23 marzo
 DIV:chirurgia Approccio attraverso la tricuspide Monza, 23 marzo 2013 28 DIV:chirurgia Approccio attraverso la polmonare Monza, 23 marzo 2013 29 DIV: chirurgia Risultati Mortalità 1-3% - Prematuri, DIV
DIV:chirurgia Approccio attraverso la tricuspide Monza, 23 marzo 2013 28 DIV:chirurgia Approccio attraverso la polmonare Monza, 23 marzo 2013 29 DIV: chirurgia Risultati Mortalità 1-3% - Prematuri, DIV
Malattia diverticolare del colon
 Malattia diverticolare del colon la diverticolosi è molto frequente anche in individui asintomatici ma soprattutto nelle fasce d età più avanzata rara sotto i 40 anni, 5% nei cinquantenni, oltre il 75%
Malattia diverticolare del colon la diverticolosi è molto frequente anche in individui asintomatici ma soprattutto nelle fasce d età più avanzata rara sotto i 40 anni, 5% nei cinquantenni, oltre il 75%
CASI CLINICI. dott. Luigi Monaco
 CASI CLINICI dott. Luigi Monaco Caso n 1 Paziente maschio di 77 anni. Ricovero in urologia per idronefrosi sinistra secondaria a calcolosi ureterale. Richiesta ecografia per valutazione urologica. Le
CASI CLINICI dott. Luigi Monaco Caso n 1 Paziente maschio di 77 anni. Ricovero in urologia per idronefrosi sinistra secondaria a calcolosi ureterale. Richiesta ecografia per valutazione urologica. Le
CPAP-scafandro post operatoria nei pazienti cardiochirurgici. Confronto tra pazienti trattati e storico pazienti non trattati
 CPAP-scafandro post operatoria nei pazienti cardiochirurgici. Confronto tra pazienti trattati e storico pazienti non trattati Inf. Barletta Claudia Inf. Annoni Alice Dipartimento di Medicina Perioperatoria
CPAP-scafandro post operatoria nei pazienti cardiochirurgici. Confronto tra pazienti trattati e storico pazienti non trattati Inf. Barletta Claudia Inf. Annoni Alice Dipartimento di Medicina Perioperatoria
CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO U.O. DI ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CLINICAL AUDIT 2000
 CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO U.O. DI ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CLINICAL AUDIT 2000 CLINICAL AUDIT Analisi critica sistematica della qualità dell assistenza sanitaria, incluse le procedure utilizzate
CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO U.O. DI ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CLINICAL AUDIT 2000 CLINICAL AUDIT Analisi critica sistematica della qualità dell assistenza sanitaria, incluse le procedure utilizzate
1/5 MD - CHVASC Vers. 2
 CONSENSO INFORMATO SICVE TRATTAMENTO PATOLOGIA VARICOSA Lei è affetto da patologia varicosa DEFINIZIONE: per patologia varicosa si intende una affezione delle vene superficiali degli arti inferiori (vv.
CONSENSO INFORMATO SICVE TRATTAMENTO PATOLOGIA VARICOSA Lei è affetto da patologia varicosa DEFINIZIONE: per patologia varicosa si intende una affezione delle vene superficiali degli arti inferiori (vv.
Importante!! I m.o. patogeni responsabili di I.O. sono nel 70% dei casi resistenti a uno o più antibiotici
 La maggior parte delle infezioni della ferita chirurgica viene acquisita durante l intervento: se una ferita è pulita e asciutta, infatti, nell arco di poche ore dall intervento non è più suscettibile
La maggior parte delle infezioni della ferita chirurgica viene acquisita durante l intervento: se una ferita è pulita e asciutta, infatti, nell arco di poche ore dall intervento non è più suscettibile
VALUTAZIONE PER IMMAGINI
 VALUTAZIONE PER IMMAGINI PERIN B., L. DAVI DIPARTIMENTO IMMAGINI Imaging aneurismi Angio-TC Angiografia Ecografia Angio-RM AORTA ADDOMINALE: PATOLOGIA ANEURISMATICA Contributo ecografia Eco (color-doppler)
VALUTAZIONE PER IMMAGINI PERIN B., L. DAVI DIPARTIMENTO IMMAGINI Imaging aneurismi Angio-TC Angiografia Ecografia Angio-RM AORTA ADDOMINALE: PATOLOGIA ANEURISMATICA Contributo ecografia Eco (color-doppler)
N cartella N ricovero Cognome Nome Data di nascita
 Io sottoscritto/a, nato/a a_ il dichiaro di essere stata informata/o, sia durante la prima visita che durante il ricovero, in modo chiaro ed a me comprensibile dal Prof/Dr. che, la patologia riscontratami
Io sottoscritto/a, nato/a a_ il dichiaro di essere stata informata/o, sia durante la prima visita che durante il ricovero, in modo chiaro ed a me comprensibile dal Prof/Dr. che, la patologia riscontratami
Scuola di Scienze mediche e Farmaceutiche
 www.microbiologia.unige.it Scuola di Scienze mediche e Farmaceutiche DIAGNOSI DI OSTEOMIELITE: CASO CLINICO 2014 Sezione di Microbiologia Dipartimento di Scienze Chirurgiche R Diagnostiche Integrate (DISC)
www.microbiologia.unige.it Scuola di Scienze mediche e Farmaceutiche DIAGNOSI DI OSTEOMIELITE: CASO CLINICO 2014 Sezione di Microbiologia Dipartimento di Scienze Chirurgiche R Diagnostiche Integrate (DISC)
Dott. Massimo Giammaria Cardiologia Ospedale Maria Vittoria,
 Dott. Massimo Giammaria Cardiologia Ospedale Maria Vittoria, Torino Che cosa e il contropulsatore Il contropulsatore aortico o Intra-Aortic Balloon Pump o IABP e uno strumento di assistenza cardiaca temporanea
Dott. Massimo Giammaria Cardiologia Ospedale Maria Vittoria, Torino Che cosa e il contropulsatore Il contropulsatore aortico o Intra-Aortic Balloon Pump o IABP e uno strumento di assistenza cardiaca temporanea
SISTEMA VASCOLARE ARTERIOSO
 INDICE Introduzione... 1 SISTEMA VASCOLARE ARTERIOSO 1 Anatomia del sistema vascolare arterioso... 5 Aorta ascendente... 5 Aorta discendente... 11 2 Insufficienza cerebrovascolare... 17 Fisiopatologia
INDICE Introduzione... 1 SISTEMA VASCOLARE ARTERIOSO 1 Anatomia del sistema vascolare arterioso... 5 Aorta ascendente... 5 Aorta discendente... 11 2 Insufficienza cerebrovascolare... 17 Fisiopatologia
PBM in Pronto Soccorso gestione del paziente con frattura di femore. Marco Pavesi
 PBM in Pronto Soccorso gestione del paziente con frattura di femore Marco Pavesi Tempistica della chirurgia intervento il giorno stesso del ricovero o il successivo evidenze scientifiche dimostrano che
PBM in Pronto Soccorso gestione del paziente con frattura di femore Marco Pavesi Tempistica della chirurgia intervento il giorno stesso del ricovero o il successivo evidenze scientifiche dimostrano che
Accessi vascolari per pazienti in dialisi
 II^ parte Circuito extra-corporeo e accessi vascolari in dialisi Accessi vascolari per pazienti in dialisi OA 2.34 Accessi vascolari per emodialisi (I) Un accesso vascolare è una locazione dalla quale
II^ parte Circuito extra-corporeo e accessi vascolari in dialisi Accessi vascolari per pazienti in dialisi OA 2.34 Accessi vascolari per emodialisi (I) Un accesso vascolare è una locazione dalla quale
Seconda Parte Specifica di scuola - Radiodiagnostica - 31/10/2014
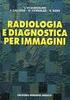 Domande relative alla specializzazione in: Radiodiagnostica Scenario 1: Una paziente di 84 anni altrimenti in buona salute viene accompagnata in Pronto Soccorso per forte addominalgia. L'esame obiettivo
Domande relative alla specializzazione in: Radiodiagnostica Scenario 1: Una paziente di 84 anni altrimenti in buona salute viene accompagnata in Pronto Soccorso per forte addominalgia. L'esame obiettivo
Training in Trombosi Società Italiana per lo Studio dell Emostasi e della Trombosi. Introduzione. Cremona settembre 2016
 Training in Trombosi Società Italiana per lo Studio dell Emostasi e della Trombosi Cremona 19-23 settembre 2016 Introduzione Anna Falanga Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo www.siset.org Chi Siamo S
Training in Trombosi Società Italiana per lo Studio dell Emostasi e della Trombosi Cremona 19-23 settembre 2016 Introduzione Anna Falanga Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo www.siset.org Chi Siamo S
Patrizio Farnelli Lucia Zazzeroni
 L esperienza riminese nell impiego dei sistemi protesici per il trattamento dell incontinenza urinaria e del descensus pelvico U.O. di Ostetricia e Ginecologia Ospedale Infermi AUSL Rimini Patrizio Farnelli
L esperienza riminese nell impiego dei sistemi protesici per il trattamento dell incontinenza urinaria e del descensus pelvico U.O. di Ostetricia e Ginecologia Ospedale Infermi AUSL Rimini Patrizio Farnelli
IL TRAPIANTO DI RENE DA DONATORE TRAUMATIZZATO
 IL TRAPIANTO DI RENE DA DONATORE TRAUMATIZZATO E. Zitelli, S. Zonta, M. Bardone, L. Cobianchi, A. Sgarella, M. Abelli*, M. Mensi**, M. Alessiani, P. Dionigi, A. Zonta CHIRURGIA GENERALE, DIPARTIMENTO DI
IL TRAPIANTO DI RENE DA DONATORE TRAUMATIZZATO E. Zitelli, S. Zonta, M. Bardone, L. Cobianchi, A. Sgarella, M. Abelli*, M. Mensi**, M. Alessiani, P. Dionigi, A. Zonta CHIRURGIA GENERALE, DIPARTIMENTO DI
Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia. AREA CHIRURGICA -Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari
 L/7 Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia AREA CHIRURGICA -Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari La classe delle CHIRURGIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI comprende le seguenti tipologie: 1. Cardiochirurgia
L/7 Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia AREA CHIRURGICA -Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari La classe delle CHIRURGIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI comprende le seguenti tipologie: 1. Cardiochirurgia
PUCCIO A.M. PUCE R. OLTREMARINI G. REBECCHI I. GIORDANO G. ISTITUTO PALAZZOLO FONDAZIONE DON GNOCCHI-MILANO PREMESSA:
 PUCCIO A.M. PUCE R. OLTREMARINI G. REBECCHI I. GIORDANO G. ISTITUTO PALAZZOLO FONDAZIONE DON GNOCCHI-MILANO PREMESSA: Le correnti elettriche, i campi elettrici ed elettromagnetici sono forme di energia
PUCCIO A.M. PUCE R. OLTREMARINI G. REBECCHI I. GIORDANO G. ISTITUTO PALAZZOLO FONDAZIONE DON GNOCCHI-MILANO PREMESSA: Le correnti elettriche, i campi elettrici ed elettromagnetici sono forme di energia
a cura della dott.ssa E. Orlando
 a cura della dott.ssa E. Orlando CHE COS E? Il Mammotome è uno strumento diagnostico, alternativo alla biopsia chirurgica, utilizzato per effettuare biopsie di lesioni non palpabili della mammella in maniera
a cura della dott.ssa E. Orlando CHE COS E? Il Mammotome è uno strumento diagnostico, alternativo alla biopsia chirurgica, utilizzato per effettuare biopsie di lesioni non palpabili della mammella in maniera
RUOLO DELLA CHIRURGIA ENDOVASCOLARE NEL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA ANEURISMATICA COMPLESSA DELL AORTA.
 RUOLO DELLA CHIRURGIA ENDOVASCOLARE NEL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA ANEURISMATICA COMPLESSA DELL AORTA. Introduzione La patologia aneurismatica dell aorta rappresenta un entità clinica di sempre maggior
RUOLO DELLA CHIRURGIA ENDOVASCOLARE NEL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA ANEURISMATICA COMPLESSA DELL AORTA. Introduzione La patologia aneurismatica dell aorta rappresenta un entità clinica di sempre maggior
Zenith Alpha ABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT
 Descrizione del dispositivo Zenith Alpha ABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT www.cookmedical.com Struttura flessibile La misura ottimale degli stent e la distanza tra gli stent del segmento prossimale del corpo
Descrizione del dispositivo Zenith Alpha ABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT www.cookmedical.com Struttura flessibile La misura ottimale degli stent e la distanza tra gli stent del segmento prossimale del corpo
Palliazione delle neoplasie maligne del pancreas
 Palliazione delle neoplasie maligne del pancreas ENDOPROTESI PERCUTANEE O ENDOSCOPICHE Prof. Fausto FIOCCA Unità di endoscopia chirurgica d urgenza Dip. Emergenza DEA - Policlinico Umberto I - Roma Sohendra
Palliazione delle neoplasie maligne del pancreas ENDOPROTESI PERCUTANEE O ENDOSCOPICHE Prof. Fausto FIOCCA Unità di endoscopia chirurgica d urgenza Dip. Emergenza DEA - Policlinico Umberto I - Roma Sohendra
N cartella N ricovero Cognome Nome Data di nascita
 Io sottoscritto/a, nato/a a il dichiaro di essere stata informata/o, sia durante la prima visita che durante il ricovero, in modo chiaro ed a me comprensibile dal Prof/Dr. che, per la patologia riscontratami:
Io sottoscritto/a, nato/a a il dichiaro di essere stata informata/o, sia durante la prima visita che durante il ricovero, in modo chiaro ed a me comprensibile dal Prof/Dr. che, per la patologia riscontratami:
Descrizione del dispositivo. (con Pro-Form )
 Descrizione del dispositivo (con Pro-Form ) Il maggior punto di forza di TX2: il controllo PER IL PAZIENTE - Ricoveri più brevi, ridotta perdita ematica durante la procedura, meno complicanze e meno interventi
Descrizione del dispositivo (con Pro-Form ) Il maggior punto di forza di TX2: il controllo PER IL PAZIENTE - Ricoveri più brevi, ridotta perdita ematica durante la procedura, meno complicanze e meno interventi
Endoprotesi per aorta toracica ( TEVAR )
 PROSPETTO LOTTI PROTESI ENDOVASCOLARI PER TUTTE LE ENDOPROTESI, NEL CASO CHE L OFFERTA PREVEDA UN ACCESSORIO ESCLUSIVO ED INDISPENSABILE, DOVRÀ ESSERE SPECIFICATO E COMPRESO NELL OFFERTA. Endoprotesi per
PROSPETTO LOTTI PROTESI ENDOVASCOLARI PER TUTTE LE ENDOPROTESI, NEL CASO CHE L OFFERTA PREVEDA UN ACCESSORIO ESCLUSIVO ED INDISPENSABILE, DOVRÀ ESSERE SPECIFICATO E COMPRESO NELL OFFERTA. Endoprotesi per
IRA POST EVAR. 1 meeting euganeo di Chirurgia Vascolare Trattamento Endovascolare degli aneurismi dell aorta addominale Este Monselice PD
 IRA POST EVAR SOC 2 Chir Direttore G.Tosolini. S.C di Radiologia ed interventistica Direttore P. Mancinelli Azienda Ospedaliera S.Maria degli Angeli PN. E.Vsintin, R.Bianchini, C.Ciancimino, M.Bonea. 1
IRA POST EVAR SOC 2 Chir Direttore G.Tosolini. S.C di Radiologia ed interventistica Direttore P. Mancinelli Azienda Ospedaliera S.Maria degli Angeli PN. E.Vsintin, R.Bianchini, C.Ciancimino, M.Bonea. 1
OPERATORIA ALLA DONNA SOTTOPOSTA A TAGLIO CESAREO D URGENZA E D ELEZIONE PO.AFMI.11
 Pag.: 1 di 7 PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA SORVEGLIANZA POST-OPERATORIA ALLA DONNA SOTTOPOSTA A TAGLIO REFERENTI DEL DOCUMENTO Roberta Leonetti Melissa Selmi- Lucia Carignani Rossella Peruzzi- Leandro Barontini
Pag.: 1 di 7 PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA SORVEGLIANZA POST-OPERATORIA ALLA DONNA SOTTOPOSTA A TAGLIO REFERENTI DEL DOCUMENTO Roberta Leonetti Melissa Selmi- Lucia Carignani Rossella Peruzzi- Leandro Barontini
CASO CLINICO. Come una PCI diventa ad alto rischio B. Castiglioni Cardiologia Interventistica U.O. Cardiologia II Varese -
 CASO CLINICO PCI in recente IMA Come una PCI diventa ad alto rischio B. Castiglioni Cardiologia Interventistica U.O. Cardiologia II Varese - MP, uomo, anni 63 Diabete mellito ID Cerebropatia infantile
CASO CLINICO PCI in recente IMA Come una PCI diventa ad alto rischio B. Castiglioni Cardiologia Interventistica U.O. Cardiologia II Varese - MP, uomo, anni 63 Diabete mellito ID Cerebropatia infantile
TERAPIA CHIRURGIA del DEFICIT ERETTILE e delle MALFORMAZIONI del PENE
 TERAPIA CHIRURGIA del DEFICIT ERETTILE e delle MALFORMAZIONI del PENE TERAPIA CHIRURGIA del DEFICIT ERETTILE e delle MALFORMAZIONI del PENE Chirurgia del deficit erettile Chirurgia deficit arterioso Chirurgia
TERAPIA CHIRURGIA del DEFICIT ERETTILE e delle MALFORMAZIONI del PENE TERAPIA CHIRURGIA del DEFICIT ERETTILE e delle MALFORMAZIONI del PENE Chirurgia del deficit erettile Chirurgia deficit arterioso Chirurgia
TRATTAMENTO CHIRURGICO/ENDOVASCOLARE DEGLI ANEURISMI DELL AORTA ADDOMINALE (AAA)
 TRATTAMENTO CHIRURGICO/ENDOVASCOLARE DEGLI ANEURISMI DELL AORTA ADDOMINALE (AAA) DEFINIZIONE: l aneurisma è una dilatazione permanente di un tratto arterioso; normalmente si considera aneurismatico un
TRATTAMENTO CHIRURGICO/ENDOVASCOLARE DEGLI ANEURISMI DELL AORTA ADDOMINALE (AAA) DEFINIZIONE: l aneurisma è una dilatazione permanente di un tratto arterioso; normalmente si considera aneurismatico un
Domenico Careddu, Milena Lo Giudice. Le infezioni delle vie urinarie
 Domenico Careddu, Milena Lo Giudice Le infezioni delle vie urinarie Banche dati utilizzate Valutazione AGREE Cosa fare nel sospetto di IVU? Nel sospetto clinico di IVU, è necessario raccogliere un campione
Domenico Careddu, Milena Lo Giudice Le infezioni delle vie urinarie Banche dati utilizzate Valutazione AGREE Cosa fare nel sospetto di IVU? Nel sospetto clinico di IVU, è necessario raccogliere un campione
ANTIBIOTICO PROFILASSI IN CHIRURGIA GENERALE
 ANTIBIOTICO PROFILAS IN CHIRURGIA GENERALE 0. Indice 0. Indice... 1 1. Scopo e campo di applicazione... 1 2. Riferimenti...1 2.2 Documentali... 1 3. Modalità operative... 2 3.2 Classificazione degli interventi
ANTIBIOTICO PROFILAS IN CHIRURGIA GENERALE 0. Indice 0. Indice... 1 1. Scopo e campo di applicazione... 1 2. Riferimenti...1 2.2 Documentali... 1 3. Modalità operative... 2 3.2 Classificazione degli interventi
ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE CONTROPULSATO
 ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE CONTROPULSATO CPS infermiera AIROLDI BARBARA CPS infermiera MONICA ZANI CARDIOCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA AOU NOVARA NURSING DEL PZ CONTROPULSATO ASSISTENZA INFERMIERISTICA
ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE CONTROPULSATO CPS infermiera AIROLDI BARBARA CPS infermiera MONICA ZANI CARDIOCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA AOU NOVARA NURSING DEL PZ CONTROPULSATO ASSISTENZA INFERMIERISTICA
CAPITOLO 5. LA CARDIOLOGIA RIABILITATIvA
 CAPITOLO 5 LA CARDIOLOGIA RIABILITATIvA Che cos è la cardiologia riabilitativa? Un tempo la cura dell infarto miocardico comprendeva periodi prolungati di riposo a letto e di ricovero in ospedale. Il recupero
CAPITOLO 5 LA CARDIOLOGIA RIABILITATIvA Che cos è la cardiologia riabilitativa? Un tempo la cura dell infarto miocardico comprendeva periodi prolungati di riposo a letto e di ricovero in ospedale. Il recupero
ELENCO MODALITA ACCADIMENTO DELL EVENTO ICD9 CM 2007
 ELENCO MODALITA ACCADIMENTO DELL EVENTO DA CLASSIFICAZIOONE DELLE MALATTIE E DEI TRAUMATISMI DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI E DELLE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE ICD9 CM 2007 Allegato alla banca dati
ELENCO MODALITA ACCADIMENTO DELL EVENTO DA CLASSIFICAZIOONE DELLE MALATTIE E DEI TRAUMATISMI DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI E DELLE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE ICD9 CM 2007 Allegato alla banca dati
Zenith Alpha ABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT
 Pianificazione e determinazione delle dimensioni idonee Zenith Alpha ABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT AI-D23546-IT-F Pianificazione e determinazione delle dimensioni idonee Effettuare la scansione TC e l angiograa
Pianificazione e determinazione delle dimensioni idonee Zenith Alpha ABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT AI-D23546-IT-F Pianificazione e determinazione delle dimensioni idonee Effettuare la scansione TC e l angiograa
Programma Tutor training pratico
 Pagina 1 di 5 Carissimo Dott. ti comunico che il/la corsista Dott. ti ha indicato quale suo Tutor per il training pratico finalizzato alla Certificazione di Competenza in Ecografia Vascolare Generale.
Pagina 1 di 5 Carissimo Dott. ti comunico che il/la corsista Dott. ti ha indicato quale suo Tutor per il training pratico finalizzato alla Certificazione di Competenza in Ecografia Vascolare Generale.
Il CAMPIONE BIOLOGICO
 LE INFEZIONI DEL TORRENTE CIRCOLATORIO Montebelluna, 28 Ottobre 2014 La Fase Preanalitica come Garanzia di Qualità Dr.ssa Stefania Schiavon Responsabile Preanalitica -Laboratorio di Analisi Il CAMPIONE
LE INFEZIONI DEL TORRENTE CIRCOLATORIO Montebelluna, 28 Ottobre 2014 La Fase Preanalitica come Garanzia di Qualità Dr.ssa Stefania Schiavon Responsabile Preanalitica -Laboratorio di Analisi Il CAMPIONE
Seconda sessione: I risultati del progetto della regione Emilia-Romagna IMPATTO DELLA CARDIO-TC NEL PERCORSO ASSISTENZIALE.
 Seconda sessione: I risultati del progetto della regione Emilia-Romagna IMPATTO DELLA CARDIO-TC NEL PERCORSO ASSISTENZIALE Vincenzo Russo Dottorato in scienze pneumo-cardio cardio-toraciche Dipartimento
Seconda sessione: I risultati del progetto della regione Emilia-Romagna IMPATTO DELLA CARDIO-TC NEL PERCORSO ASSISTENZIALE Vincenzo Russo Dottorato in scienze pneumo-cardio cardio-toraciche Dipartimento
ENDOCARDITE INFETTIVA
 ENDOCARDITE INFETTIVA E NDOCARDITE INFETTIVA Infezione dell endocardio endocardio causata da microorganismi patogeni. Nella grandissima maggioranza dei casi l endocardio l interessato è l endocardio valvolare.
ENDOCARDITE INFETTIVA E NDOCARDITE INFETTIVA Infezione dell endocardio endocardio causata da microorganismi patogeni. Nella grandissima maggioranza dei casi l endocardio l interessato è l endocardio valvolare.
ISMETT UPMC: DATI DELLA QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ CLINICHE
 ISMETT UPMC: DATI DELLA QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ CLINICHE TRAPIANTI I dati della qualità dei trapianti (risultati clinici) sono pubblici e sono consultabili sul sito del Centro Nazionale Trapianti (CNT).
ISMETT UPMC: DATI DELLA QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ CLINICHE TRAPIANTI I dati della qualità dei trapianti (risultati clinici) sono pubblici e sono consultabili sul sito del Centro Nazionale Trapianti (CNT).
